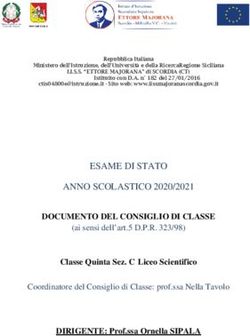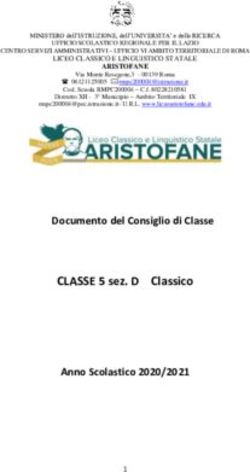DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - 15 maggio 2019
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA”
Via Nazario Sauro, 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (Piacenza)
Tel. 0523843616 – Fax: 0523843647 – C.F. 80020290336 – C.M. PCIS001003
E-mail: pcis001003@istruzione.it – P.E.C.: PCIS001003@PEC.ISTRUZIONE.IT – www.polovoltacasali.gov.it
Liceo Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Applicate “A.Volta” (Castel San Giovanni)
Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “A. Volta” (Borgonovo V.T.)
Istituto Professionale Servizi Commerciali “A. Casali” (Castel San Giovanni)
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
15 maggio 2019
CLASSE 5C
Liceo linguistico
Castel San Giovanni, 15 maggio 2019
1INDICE
1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
1.1 Quadro Orario
2 DOCENTI DELLA CLASSE
3 ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO
3.1 Relazione sulla classe
4 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
5 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5.1 Competenze in uscita individuate dal Consiglio di Classe
5.1.1 Competenze trasversali metodologiche
5.1.2 Competenze disciplinari per aree: area linguistica e comunicativa
5.1.3 Competenze disciplinari per aree: area storico-umanistica
5.1.4 Competenze disciplinari per aree: area scientifica, matematica e tecnologica
6 METODOLOGIA E STRUMENTI CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
6.1 Metodologia utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento
6.2 Strumenti utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento
6.3 Spazi utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento
7 STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
7.1. Metodi di verifica degli apprendimenti
8 CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI
CLASSE
9 PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
10 NUCLEI TEMATICI DEDUCIBILI DALLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
11 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
12 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
13 ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF
14 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
15 MODULI CLIL
16 ALUNNI DSA - DVA
17 SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
18 SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO
219 ALLEGATI
20 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI
Dal Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133)
Le finalità del nostro Polo scolastico, comprendente nella parte liceale gli indirizzi scientifico,
linguistico, delle scienze applicate e delle scienze umane, sono le seguenti:
- promuovere e realizzare la formazione dello studente nell'ambito della tradizione culturale
storicamente operante, attraverso una metodologia problematico-dialogica che combini
sapientemente classicità e modernità, umanesimo e sapere tecnico-scientifico, istruzione e mondo
del lavoro;
- fornire una struttura articolata, con un’ampia varietà di indirizzi di studio, tra cui lo studente potrà
optare secondo i propri interessi e attitudini;
- garantire la flessibilità dei curriculum scolastici e della struttura, al fine di riorientare gli allievi
durante tutto il percorso di studi, specialmente in occasione di una modifica della scelta iniziale;
- mettere in atto tutte le strategie perché lo studente possa padroneggiare più lingue comunitarie
per operare nella nuova realtà socio-economica, fare esperienza di diverse occasioni di
apprendimento anche fuori dal sistema scolastico (stage aziendali, scambi culturali, collegamenti
con il mondo del lavoro e delle professioni), sviluppare la conoscenza delle moderne tecnologie
informatiche e multimediali, acquisire una preparazione eclettica, atta al proseguimento degli studi
presso qualsiasi facoltà universitaria.
L'obiettivo del Dirigente scolastico e degli insegnanti dei vari istituti è, in sintesi, operare le scelte
più idonee per favorire accoglienza, motivazione, relazionalità, prassi didattica, metodologia attiva,
e per portare ciascuno studente a esprimere al meglio le proprie capacità cognitive e raggiungere
risultati massimamente proficui.
Risultati di apprendimento del percorso liceale linguistico
In particolare lo studente del Liceo linguistico è stato formato perché al termine della sua
esperienza scolastica:
- legga e analizzi testi letterari, articoli di giornale e istruzioni tecniche;
- comprenda i messaggi generali e i dettagli specifici di un discorso su argomenti familiari,
quotidiani e specialistici nelle lingue straniere studiate;
- comunichi in lingua straniera in modo scorrevole e spontaneo per esprimere opinioni e scambiare
informazioni di interesse personale su una vasta gamma di argomenti anche di ambito storico,
letterario filosofico, artistico e scientifico; analogamente rediga testi di vario genere;
- utilizzi le competenze linguistiche con l'adeguato stile e registro richiesti dalle differenti situazioni
comunicative e sociali;
- possieda una solida competenza linguistico-espressiva e una preparazione culturale, che gli
permettano di interagire nella comunicazione sia in ambito universitario che lavorativo, con un
approccio critico e costruttivo, con sensibilità verso una dimensione multiculturale e il supporto di
un'adeguata preparazione nell'area scientifica e tecnologica.
31.1 QUADRO ORARIO
PIANO DEGLI biennio biennio Triennio Triennio triennio
STUDI LICEO
LINGUISTICO 1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua e
letteratura 4 4 4 4 4
italiana
Lingua e cultura 2 2 0 0 0
latina
Storia e 2+1 2+1 2 2 2
geografia
Filosofia 0 0 2 2 2
Lingua e cultura 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1
inglese
Lingua e cultura 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1
tedesca
Lingua e cultura 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1
francese
Matematica con 3 3 2 2 2
informatica
Fisica 0 0 2 2 2
Biologia,
chimica, scienze 2 2 2 2 2
della terra
Storia dell’arte 0 0 2 2 2
Scienze motorie
e sportive 2 2 2 2 2
Religione
cattolica o 1 1 1 1 1
attività
alternative
Totale ore 27 27 30 30 30
42. DOCENTI DELLA CLASSE
Disciplina Docenti Continuità didattica
Lingua e letteratura italiana GANDOLFI TAMARA dalla 2°
Lingua e cultura inglese ROCCHI ANGIOLA dalla 5°
Lingua e cultura francese FALSINI EMMA dalla 1°
Lingua e cultura tedesca TAGLIAFERRI BARBARA dalla 5°
Storia RIZZI FRANCESCO dalla 3°
Filosofia RIZZI FRANCESCO dalla 3°
Matematica con informatica BARBIERI PATRIZIA dalla 2°
Fisica BARBIERI PATRIZIA dalla 2°
Scienze naturali, chimica, MORETTI ALFREDA dalla 1°
scienze della terra
Storia dell’arte BAIA DARIO dalla 3°
Scienze motorie e sportive PIVA ANTONELLA dalla 4°
Religione cattolica LUPPI FRANCESCO dalla 1°
53. ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO
La classe risulta composta da 19 studenti di cui 2 ragazzi e 17 ragazze.
Tutti gli alunni provengono dalla 4C di questo Istituto. Durante il triennio la composizione iniziale della classe
ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella.
Anno Classe Iscritti Provenienti da Ammessi Ammessi Non Ritirati
scolastico altro istituto
senza con debito ammessi
debito
2016/17 3a 22 1 17 4 7 0
2017/18 4a 20 0 19 1 1 0
2018/19 5a 19 0 14 5 1 1
Per quanto riguarda il livello di merito, la situazione della classe è riassunta nelle seguenti tabelle, riferite agli
studenti attualmente frequentanti la classe quinta, con l'esclusione degli alunni ripetenti.
Crediti scolastici
CREDITO A.S. 2016/17 A.S 2017/2018
SCOLASTICO riclassificato n. alunni n. alunni
6< M ≤7 4 3
7< M ≤8 9 7
8< M ≤9 7 6
9< M ≤10 1 3
Debiti formativi
MATERIA A.S. 2016/17n. alunni A.S. 2017/2018n. alunni
Matematica 5
Tedesco 1
Inglese 1
Fisica 1
3.1 RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe 5C è composta da 19 alunni, tutti provenienti dal nostro Istituto; non ci sono alunni
ripetenti, e un ragazzo è stato qualificato come BES. Una studentessa, dopo aver svolto il quarto
6anno a Bielefeld, si è reinserita brillantemente nella classe recuperando le parti di programma non
svolte. Il comportamento degli studenti è sempre stato sostanzialmente corretto e il clima
relazionale molto buono: nel corso degli anni gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento
disponibile e collaborativo nei confronti di compagni e insegnanti e hanno partecipato con
crescente interesse al dialogo educativo, solo in casi sporadici l'impegno profuso da parte di
qualche allievo non è stato costante o adeguato. La maggior parte della classe ha comunque
lavorato in modo solerte e proficuo, manifestando una buona motivazione e il possesso di brillanti
capacità di riflessione e di rielaborazione personale. Globalmente, la classe dimostra di aver
acquisito competenze di esposizione, analisi e argomentazione soddisfacenti. Una parte degli alunni
in particolare ha maturato un metodo di studio efficace e ha lavorato sempre con responsabilità e
determinazione (talvolta con ansie assolutamente ingiustificate), raggiungendo un ottimo livello di
autonomia e risultati decisamente apprezzabili con diverse punte di eccellenza. Un altro gruppo ha
raggiunto risultati mediamente discreti, mentre un esiguo numero di studenti presenta una
preparazione meno omogenea e pur raggiungendo risultati complessivamente sufficienti, in alcune
discipline, e soprattutto nell’area scientifica, evidenzia fragilità dovute a lacune pregresse o a un
impegno non sempre adeguato.
4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti i
seguenti criteri, inseriti nel PTOF 2019-2022.
Criteri per attribuzione CREDITO SCOLASTICO: L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR
62/2017 come indicato nel comma precedente secondo la tabella sotto riportata
a. la media dei voti conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico, ivi compresa la valutazione
relativa al comportamento, consente il suo inserimento in una banda di oscillazione secondo la tabella
dell’allegato A del Dlgs 62/2017 [cfr. art.15, comma 2 dello stesso Dlgs], per gli allievi frequentanti il
triennio conclusivo di studi.
Media
PUNTI TABELLARI
voti
Fasce di Fasce di Fasce di
credito credito credito
III anno IV anno V anno
MSi assegna la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano i seguenti
elementi:
- assiduità della frequenza scolastica;
- interesse ed impegno al dialogo educativo;
- partecipazione alla vita scolastica comprese le attività complementari ed integrative ed apporto costruttivo
all’attività di progetto: certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti
specifici, certificati di attività in cui si attesti lo svolgimento minimo pari al 70% del numero di ore
complessive previste; peer tutoring, attività di orientamento, organizzazione di eventi, partecipazione
costruttiva alla vita della scuola rappresentanza negli Organi Collegiali, sostegno alle attività scolastiche e a
progetti di ogni genere;
- esperienze lavorative: ossia stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 gg;
- attività sportiva: ossia impegno annuale presso una Associazione Sportiva sufficientemente documentata.
Attività di Volontariato: ossia impegno continuativo, annuale, documentato presso enti di volontariato,
formazione o assistenza del privato – sociale;
- promozione senza sospensione di giudizio.
Negli scrutini conseguenti alla sospensione del giudizio
- in presenza della sola sufficienza in tutte le discipline verificate viene assegnato, per gli studenti del
triennio, il credito scolastico nel voto più basso nella fascia di riferimento;
- in presenza di voti superiori alla sufficienza, il Consiglio di classe può assegnare anche un credito più alto
per valorizzare l’impegno e consistenti miglioramenti nella preparazione.
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola o alle esperienze
di partecipazione alle attività integrative valide per il punto aggiuntivo sono agli atti della Commissione.
5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
- la pratica dell’argomentazione e del confronto;
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
85.1 COMPETENZE IN USCITA INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Si segnala il raggiungimento delle seguenti competenze, con livelli diversificati:
5.1.1 Competenze trasversali metodologiche
- aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita;
- essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare
i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;
- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;
- utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e nella produzione, orali e scritte, commisurati
alle esigenze comunicative;
- orientarsi all’interno del patrimonio letterario e culturale in rapporto anche alle altre manifestazioni
artistiche;
- comprendere un documento in lingua inglese, sostenere conversazioni adeguate alle situazione di
comunicazione, produrre semplici scritti, sostenere una comunicazione anche tecnica nella stessa lingua;
- inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici nazionali e internazionali;
- operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune;
- utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, un linguaggio specifico;
- organizzare la propria attività sia sul piano personale che sul piano interattivo;
- analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio operato;
- saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui;
- acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni;
- essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
Competenze disciplinari per aree
5.1.2 area linguistica e comunicativa
- padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da
quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
- aver acquisito, in almeno due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
95.1.3 area storico-umanistica
- conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini;
- conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri;
- conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture;
- essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano,
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della conservazione;
- collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee;
- saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le
arti visive;
- conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5.1.4. area scientifica
- comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà;
- possedere i contenuti essenziali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della
terra).
6. METODOLOGIA E STRUMENTI CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
6.1 METODOLOGIA utilizzata nel processo di insegnamento-apprendimento
10Matematica
METODOLOGIA
francese
Filosofia
motoria
naturali
tedesco
Italiano
scienze
st. arte
inglese
Storia
Fisica
IRC
Lezione frontale X X X X X X X X X X X X
Lezione dialogata finalizzata X X X X X X X X X X X X
ad analizzare processi /
fenomeni o a chiarire aspetti
critici del problema / tematica
affrontati
Gruppi di lavoro X X X X X X
Lettura e commento di brani X X X X X
(letterari/scientifici etc..)
mediante griglie di analisi
preordinate
Approccio pluridisciplinare X X X
(ad esempio metodologia
CLIL, specie nelle classi
quinte)
Esercitazione di laboratorio X X
Impostazione laboratoriale X X
delle lezioni in aula
Lezione con utilizzo strumenti X X X X X X X X X
multimediali e metodologie
coerenti [ad esempio flipped
classroom] - Produzione di
materiali fruibili dagli studenti
anche a distanza
Esame,decodifica, X X X X
Interpretazione e
contestualizzazione di testi
iconografici
Attività di recupero-sostegno X X X X X
e integrazione
Attività di potenziamento X X X X X X X X X
Attività di alternanza
scuola/lavoro, IFS o project
work
Altro ( specificare)
6.2 STRUMENTI utilizzati nel processo di insegnamento-apprendimento
11Matematica
francese
Filosofia
STRUMENTI
Tedesco
motoria
naturali
italiano
scienze
st. arte
inglese
storia
Fisica
IRC
X X X X X
Dispense
Documenti X X X X X X X X
Software X X X X X X
Appunti X X X X X X X X X
LIM X X X X X X X X X
Notebook X
Smartphone X
Riviste – giornali cartacei e X X X X
digitali
Statistiche / grafici / tabelle X
/carte tematiche
Testi letterari, scientifici, X X X X X X X X
storici ed in generale saggi
divulgativi di varia natura
Internet (ricerca guidata dal X X X X X X X X X X X
docente su siti selezionati)
Piattaforme varie X X X
6.3. SPAZI utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento
12Matematica
francese
Filosofia
SPAZI-AMBITI
Tedesco
motoria
naturali
italiano
scienze
st. arte
inglese
Storia
Fisica
IRC
Aula scolastica X X X X X X X X X X X
Laboratorio X
Aula Magna/Auditorium
(conferenze – cicli di incontri
con esperti )
Palestra e spazi all’aperto X
Altro ( specificare)
7. STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
7.1. Metodi di verifica degli apprendimenti
Materie voto scritto voto orale
prove oggettive (test di vario
produzioni scritte di diversa
Risoluzione di problemi
produzione di gruppo
esercitazioni grafiche
Trattazione sintetica
Trattazione sintetica
Esercizi tradizionali
analisi testuali
interrogazioni
Questionari
saggi brevi
genere)
natura
test
italiano X X X X X X X X X X X
storia X X X X X X X X
filosofia X X X X X X X
inglese X X X X X X X X
francese X X X X X X X
tedesco X X X X X X X
matematica X X X
fisica X X X X
Scienze X X X X
Storia arte X X X X X X X
sc. motorie X X X X X X X X
IRC X X X X
138. CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI CLASSE
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione, e
tutti gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione
scolastica/ formativa. Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione:
- i risultati raggiunti nelle prove somministrate;
- la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo;
- il metodo di lavoro utilizzato;
- la progressione rispetto alla situazione iniziale;
- le competenze raggiunte.
Per la corrispondenza tra obiettivi raggiunti e voto, viene adottata la griglia approvata in Collegio Docenti e
contenuta nel PTOF, di seguito riportata ( aggiornata con le valutazioni previste dal DM 62-2017).
1415
9. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Premessa
Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dei
Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel presente documento.
In allegato al presente documento si trova l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare,
rispetto a:
- competenze
- contenuti.
Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati
alla data del termine delle lezioni.
10. NUCLEI TEMATICI DEDUCIBILI DALLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Il Consiglio di classe non ha formalizzato alcun percorso interdisciplinare o multidisciplinare; tuttavia, in vista
dell’esame di Stato, si è riunito in data 20 marzo 2019, per stilare alcuni nuclei significativi per le diverse
discipline, individuando i seguenti temi: il potere dietro le quinte, il darwinismo e i suoi sviluppi, la patria tra
identità nazionale e nazionalismo, la libertà e i suoi molteplici significati, il doppio e le sue declinazioni, la
notte come situazione temporale e condizione interiore, il progresso e i problemi che ne derivano, l'eroismo
nel mondo moderno e contemporaneo, la maschera e la finzione teatrale, il tempo cosmologico e il tempo
coscienziale, la guerra nel mondo contemporaneo, la distruzione delle certezze, il senso della vita, il denaro e
la civiltà borghese, il ricordo e la nostalgia del passato, l'eterna lotta tra bene e male, il dolore come
condizione esistenziale, l'estraneità rispetto alla società contemporanea, la natura tra sguardo scientifico e
poesia, lo sfruttamento nella civiltà industriale, la malattia e la follia, le vertigini dell'uomo contemporaneo, la
gabbia nelle sue declinazioni, il trionfo della morte.
11. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il consiglio di classe in vista della preparazione all’esame di Stato ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:
16percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del Discipline Anno di Percorso di Studenti coinvolti (se
percorso coinvolte svolgimento classe/individuale individuale)
Diritto del lavoro Terza Classe
Il mercato del Quarta Classe
lavoro in UE
Istituzioni dell’UE quinta Classe
Brexit: da cosa Quinta Classe
nasce, processo,
conseguenze
possibili
Politiche Quinta Classe
economiche e
monetarie degli
stati. Misuratore
di crescita e
debito pubblico.
Competenze di cittadinanza raggiunte: le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di
Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 22 agosto 2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli
accordi di “Europa 2020” sono state riviste il 22maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE ha adottato una
nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, riformulando le
competenze del 2006. Tuttavia sono state utilizzate per le classi in uscita nel 2018-2019 le prime
competenze chiave e precisamente:
Imparare ad imparare
X Progettare
X Comunicare
X Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
X Individuare collegamenti e relazioni
X Acquisire ed interpretare l’informazione
12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ( EX ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO)
La classe ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore che
erano previste obbligatorie di alternanza scuola lavoro. Tutti gli studenti hanno svolto almeno il 75% delle
ore di alternanza scuola lavoro (almeno 200 ore) . Con la diminuzione delle ore obbligatorie e il cambio di
17denominazione gli studenti hanno svolto le attività come riportato nella relazione di progetto allegata al
presente documento.
Viene allegata anche una tabella riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro che ogni studente
della classe ha svolto e una scheda per ogni singolo alunno riepilogativa delle attività svolte e delle
valutazioni del consiglio di classe.
Secondo quanto stabilito dal collegio dei docenti nella valutazione complessiva dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento ( ex alternanza scuola lavoro ) il consiglio di classe ha tenuto
conto dei seguenti indicatori:
• Livello di competenze professionali raggiunte ( scheda di valutazione tutor aziendale)
• Livello di competenze trasversali ( soft skills) ( scheda valutazione tutor aziendale)
• Consapevolezza raggiunta (es: relazione, autovalutazione)
• Ore svolte dallo studente
Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate in
maniera dettagliata nelle “ cartelline degli studenti” che contengono
• Port-folio triennale delle attività svolte
• Valutazione complessiva
• Certificazione delle competenze in alternanza
• Certificato delle ore sulla sicurezza
Le cartelline sono a disposizione della commissione.
Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà una breve relazione anche in formato multimediale che
presenterà alla commissione durante la prova orale.
ORIENTAMENTO
La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università:
- Partecipazione a Campus Universitari
- Partecipazione ad Open day universitari
- Progetto in tedesco di orientamento al mondo del lavoro “Meintraumberuf” in 4 sup.
- Incontro con psicologo professionista.
13. ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL
PTOF
ATTIVITA’INTEGRATIVE:
ANNO 2016/17
18- progetto Coming sull’educazione alla sessualità tenuto da una ginecologa e una psicologa
- conferenza in lingua inglese sulla ballata medievale
- concerto in tedesco in un locale di Milano (Alcatraz)
ANNO 2017/18
- progetto Traumberuf del Goethe Institut di Milano seguito da alcuni esperti
- spettacolo in lingua francese al President: Saint-Germain-des-Prés
- progetto Martina legato ai Lions con la presenza di medici di varie specializzazioni focalizzato sulla
prevenzione dei tumori
- orientamento e incontro con le professioni: Il lavoro del neuropsicologo con il dottor Murgia
- incontro con persone non-vedenti di un Istituto di Milano: Dialogo al buio
- iscrizione alla convenzione Coni per due ragazze
- conferenza del giornalista Negri sull’articolo di opinione
- stage di orientamento presso l’Università tedesca di Reutlingen per un gruppo di studenti
ANNO 2018/19
- spettacolo in lingua francese al President: Révolution
- spettacolo in lingua italiana al Teatro Municipale: Sei personaggi in cerca d’autore
- stage di orientamento presso l’Università tedesca di Reutlingen per due studentesse
- incontro con il dottor Fiordaliso si temi dell’andrologia e le possibili forme tumorali
- attività di orientamento presso varie Università
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF:
- partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi di atletica leggera, corsa campestre, nuoto, sci
- lotta al doping in collaborazione con la Fidal
- certificazioni linguistiche: 4 studentesse hanno conseguito il First, due il Trinity, una il B1 di
francese, 2 il B1 di tedesco e una il B2.
14. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE:
3°. viaggio studio a Montpellier (5.3.2017-11.3.2017)
4°. viaggio studio ad Augsburg (4.4.2018-10.4.2018)
5°. viaggio di istruzione a Salzburg e Munchen (26.2.2019-2.3.2019)
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2016-2017
Rimini e Ravenna: L’arte romana e bizantina
Mantova: il ducato dei Gonzaga
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2017-2018
Torino: i luoghi sabaudi e risorgimentali
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2018-2019
Rovereto: il Mart e il museo della prima guerra mondiale
1915. MODULI CLIL
Nel corso del triennio sono stati svolti i seguenti moduli CLIL
TITOLO MODULO DISCIPLINA NON DOCENTE CLIL EVENTUALE DOCENTE Numero ORE CLIL
LINGUISTICA ESTERNO O DI
COINVOLTA SUPPORTO
3. The Tudors STORIA RIZZI 4
4. La France du STORIA RIZZI 4
dix-neuvième
siècle
5. Physics and FISICA BARBIERI 8
Technology -
Application of
electric energy and
electromagnetic
induction
16. ALUNNI DSA - DVA
Per l’alunno BES viene allegata la relazione predisposta per la commissione con il PDP, gli strumenti
compensativi e dispensativi utilizzati.
17. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame utilizzando
quelle pervenute dal MIUR:
Simulazioni 1 prova: 19/2 e 26/3;
Simulazioni 2 prova: 28/2 e 2/4.
La prima simulazione della seconda prova non è stata effettuata perché le classi quinte erano in gita a fine
febbraio. Le singole prove (comprensione, analisi e produzione) sono state effettuate dalle docenti di lingua
inglese (1) e lingua francese (3) sotto forma di esercitazioni. Le altre tre simulazioni sono state eseguite nelle
date nazionali e corrette dai docenti referenti (Gandolfi e Gazzola per la prima, Rocchi e Falsini per la
seconda).
2018. SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO
Il consiglio di classe decide che non saranno effettuate simulazioni ufficiali del colloquio d’esame,
ma rimanda le modalità alla discrezione dei singoli docenti, che potranno valutare i ragazzi
utilizzando alcuni dei nuclei tematici come quesiti per l’interrogazione.
19 ALLEGATI
• Elenco degli studenti
• griglia di valutazione ministeriale utilizzate per la correzione delle prove scritte con proposta di
descrittori
• proposta di griglia di valutazione del colloquio
• Relazione di progetto percorsi per le competenze e orientamento (ex ASL)
• Tabella riepilogativa percorsi per le competenze e orientamento ( ex ASL)
• Schede individuale riepilogativa di valutazione percorsi per le competenze e orientamento ( ex ASL)
• Relazioni disciplinari e programmi svolti ( una copia del programma svolto deve essere sottoscritta
dagli studenti ) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina.
20 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
-
1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ( disponibile sul sito web della scuola)
2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI
3 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI
4 PDP E PEI PER STUDENTI BES
5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E ORIENTAMENTO
( ex ASL)
6 MATERIALI VARI ( progetti particolari svolti, altro )
21Il consiglio di classe della classe QUINTA sezione C
N. MATERIA DOCENTE FIRME
1 ITALIANO GANDOLFI
2 STORIA RIZZI
3 FILOSOFIA RIZZI
4 INGLESE ROCCHI
5 FRANCESE FALSINI
6 TEDESCO TAGLIAFERRI
7 MATEMATICA BARBIERI
8 FISICA BARBIERI
9 SCIENZE MORETTI
10 ARTE BAIA
11 SCIENZE MOTORIE PIVA
12 RELIGIONE LUPPI
Castel San Giovanni, 15 Maggio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella Fumi
2223
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi ___________________________________
TIPOLOGIA A
AMBITI INDICATORI INDICATORI PUNTI
GENERALI SPECIFICI
(PUNTI 60) (PUNTI 40)
Grav. Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo
Insuf.
ADEGUATEZ- Rispetto dei 2-4 5 6 7 8 9-10
ZA vincoli posti nella
consegna
ORGANIZZA- Ideazione, 2-4 5 6 7 8 9-10
ZIONE DEL pianificazione e
TESTO organizzazione
del testo; coesione
e coerenza
testuale
COMPRENSIO Comprensione del 2-4 5 6 7 8 9-10
NE E ANALISI testo
Puntualità 2-4 5 6 7 8 9-10
nell’analisi
sintattica,
lessicale, stilistica
e retorica
Interpretazione 2-4 5 6 7 8 9-10
corretta e
articolata del testo
LIVELLO Ampiezza e 2-4 5 6 7 8 9-10
CRITICO precisione delle
VALUTATIVO conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
FORMA Correttezza 2-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20
STILISTICA grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi) e uso
corretto della
punteggiatura
Ricchezza e 2-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20
padronanza
lessicale
TOTALE DELLA PROVA: pp. __________/100 pp. ________________/20Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi ___________________________________
TIPOLOGIA B
AMBITI INDICATORI INDICATORI PUNTI
GENERALI SPECIFICI
(PUNTI 60) (PUNTI 40)
Grav. Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo
Insuf.
ADEGUATEZ- Individuazione 2-4 5 6 7 8 9-10
ZA corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
ORGANIZZA- Ideazione, 2-4 5 6 7 8 9-10
ZIONE DEL pianificazione e
TESTO organizzazione
del testo; coesione
e coerenza
testuale
Capacità di 2-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20
sostenere con
coerenza un
discorso usando
connettivi
adeguati
LIVELLO Correttezza e 2-4 5 6 7 8 9-10
CRITICO congruenza dei
VALUTATIVO riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione
Ampiezza e 2-4 5 6 7 8 9-10
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
FORMA Correttezza 2-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20
STILISTICA grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi) e uso
corretto della
punteggiatura
Ricchezza e 2-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20
padronanza
lessicale
TOTALE DELLA PROVA: pp. __________/100 pp. ________________/20Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi ___________________________________
TIPOLOGIA C
AMBITI INDICATORI INDICATORI PUNTI
GENERALI SPECIFICI
(PUNTI 60) (PUNTI 40)
Grav. Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo
Insuf.
ADEGUATEZ- Pertinenza del 2-7 8-9 10 11-12 13 14-15
ZA testo rispetto alla
traccia ed
eventuale
coerenza nella
formulazione del
titolo o nella
divisione in
paragrafi
ORGANIZZA- Ideazione, 2-4 5 6 7 8 9-10
ZIONE DEL pianificazione e
TESTO organizzazione
del testo; coesione
e coerenza
testuale
Sviluppo ordinato 2-4 5 6 7 8 9-10
e lineare
dell’esposizione
LIVELLO Correttezza e 2-7 8-9 10 11-12 13 14-15
CRITICO articolazione delle
VALUTATIVO conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Ampiezza e 2-4 5 6 7 8 9-10
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
FORMA Correttezza 2-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20
STILISTICA grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi) e uso
corretto della
punteggiatura
Ricchezza e 2-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-20
padronanza
lessicale
TOTALE DELLA PROVA: pp. __________/100 pp. ________________/20GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA LICEO LINGUISTICO
A.S. 2018-2019
CANDIDATO---------------------------------------------------
A. COMPRENSIONE SCRITTA: INDICATORE DI LIVELLO
OBIETTIVO/DESCRITTORE
Comprensione del testo 1.in modo nullo, solo qualche parola
Il candidato riconosce le informazioni 2.solo in minima parte
3.nelle sue linee fondamentali anche se sfugge qualche dettaglio
rilevante
4.in modo abbastanza completo, trovando nel testo espliciti
elementi di giustificazione
5.nei dettagli, cogliendone inferenze ed elementi impliciti
Capacità espositiva 1.in modo incoerente con errori morfosintattici frequenti e gravi
Il candidato formula la risposta 2.in modo adeguato ma limitandosi a trascrivere parti del testo
3.non molto articolata ma nel complesso coerente, qualche errore
morfosintattico che tuttavia non impedisce la comprensione
4.in modo chiaro e nel complesso ben articolato con padronanza
delle strutture morfosintattiche globalmente buona
5.in modo personale e ben articolato con un buon uso delle strutture
morfosintattiche e registro ricco e adeguato
B. PRODUZIONE SCRITTA: INDICATORE DI LIVELLO
OBIETTIVO/DESCRITTORE
Conoscenze linguistiche 1.in modo gravemente scorretto
(correttezza formale e proprietà di 2.errori morfosintattici a volte gravi, lessico limitato e impreciso
3.in modo impreciso ma comprensibile, lessico sufficientemente
linguaggio) ampio
Il candidato si esprime applicando le 4.in modo chiaro e nel complesso corretto, lessico abbastanza
proprie conoscenze ortografiche, ampio e preciso
morfosintattiche e lessicali 5.n modo chiaro, corretto e scorrevole con un uso appropriato della
lingua
Conoscenze relative all'argomento 1.contenuto molto limitato e non pertinente
2.superficiali e generiche e non sempre pertinenti
3.essenziali ma nel complesso pertinenti
4.pertinenti e articolate nel complesso
5.contenuto ricco, approfondito, pertinente e originale
TOTAL SCORE.................../20
I CommissariPROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI LICEO LINGUISTICO VOLTA 5C ANNO 2018-19 Premessa Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel presente documento. Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: - competenze disciplinari - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI Le discipline sono suddivise in due aree tematiche : AREA UMANISTICO COMUNICATIVA ( italiano, storia, filosofia, inglese, francese, tedesco, storia dell’arte, educazione fisica, religione) AREA SCIENTIFICO ( matematica, fisica, scienze).
1. AREA UMANISTICA 1.1. Lingua e Letteratura Italiana DOCENTE: Prof.ssa Tamara Gandolfi Libri di testo adottati: Letteratura.it, volume 3a e 3b. Langella, Frare, Gresti, Motta. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Pearson. Competenze disciplinari raggiunte: Padroneggiare la lingua italiana in rapporto alle varie situazioni comunicative. Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. Saper leggere ed interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici, retorici e stilistici, l’intertestualità e la relazione tra temi e generi letterari, l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. Competenze trasversali raggiunte:
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e culturale in rapporto anche alle altre manifestazioni
artistiche.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
CONTENUTI:
GIACOMO LEOPARDI:
- Vita, opere principali con temi e caratteristiche stilistiche: Zibaldone, Idilli, Grandi Idilli, Ciclo di
Aspasia, La Ginestra, Operette Morali
- Poetica dell’autore (Pessimismo storico, Teoria del piacere, Poetica del Vago e dell’indefinito,
Poetica della rimembranza, Pessimismo cosmico, Social catena)
- Testi: da Zibaldone
“La teoria del piacere” (p G 482)
“La poetica e lo stile del vago e della rimembranza” (p G 487)
“Il giardino della sofferenza” (p G 485)
- Testi: da Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese (p G 466)
- Testi: da Canti
L’infinito(p G 418)
Il passero solitario (p G 414)
A Silvia (p G 429)
La quiete dopo la tempesta (p G 440)
Il sabato del villaggio (p G 445)
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p G 434)
A se stesso (p G 454)
La Ginestra (p G 456)
APPROFONDIMENTO: Leopardi in Montale (saggio fornito dalla docente)L’età postunitaria
Inquadramento storico-letterario; la frattura tra intellettuali e società; il Positivismo
LA SCAPIGLIATURA:
- caratteristiche, tematiche e principali esponenti. Cenni al modello di Baudelaire.
- Testi: Baudelaire
Albatros, Les fleurs du mal (p H 52)
Spleen, Les fleurs du mal ( fotocopia)
Correspondences, Les fleurs du mal (p H 55)
La perdita dell’aureola, Spleen di Parigi (fotocopia)
- Boito
Dualismo (passi) (p H 57)
- Tarchetti, da Fosca
“Fosca, o della malattia personificata”: brani da cap. XII, XIII e XV (p H 68)
IL NATURALISMO
- Nascita del movimento
- Fondamenti teorici: Taine, Balzac, Flaubert e i fratelli Goncourt
- Il romanzo sperimentale di Zola; il ciclo Rougon-Macquart
- Tematiche e ruolo dell’intellettuale
IL VERISMO
- Nascita del movimento, caratteristiche e principali esponenti
- Confronti con il Naturalismo (visione del mondo; ruolo della letteratura; ambientazione; tecniche
narrative)
GIOVANNI VERGA
- Vita
- Esordi letterari: i romanzi mondani (cenni a Eva, Eros, Tigre reale) e i richiami alla Scapigliatura
- La svolta verista e le dichiarazioni di poetica
- Tecniche letterarie: Impersonalità, Eclissi dell’autore, Regressione, Straniamento
- “Vita dei campi”: caratteri generali; particolarità della novella Fantasticheria;
Fantasticheria (fotocopia)
Lettera a Farina: prefazione all’”Amante di Gramigna” (p H 236)
Documento: estratto dall’inchiesta Franchetti Sonnino sui carusi (fotocopia)
Rosso Malpelo ( p H 245)
La lupa (p H 257)
- Il “Ciclo dei vinti”
- “I Malavoglia”: trama, struttura bipolare, coralità, tecniche narrative, cronotopo idilliaco, la
circolarità della struttura, il linguaggio Prefazione de “I Malavoglia” ( p H 263)
Cap. 1 ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini ( p H 266)
Cap. 11 Pasta e carne tutti i giorni ( p H 273)
Cap. 15 La conclusione del romanzo: L’espiazione dello zingaro (p H 278)
- “Mastro Don Gesualdo”: trama e caratteri principali
- “ Novelle rusticane”:
La roba ( p H 281)
GIOSUE’ CARDUCCI tra Classicismo e rinnovamento
- Cenni alla vita. Lettura di testi esemplari:
Davanti San Guido (p H 180)
Traversando la Maremma toscana (fotocopia)
Pianto Antico (fotocopia)
IL DECADENTISMO
- Nascita del movimento
- Origine del termine e Decadentismo francese
- Cenni: Verlaine, Languore
- Caratteri principali del Decadentismo italiano: irrazionalismo, figura del poeta-mago, tecniche
espressive ricorrenti (musicalità, metafora, analogia, sinestesia), estetismo
- Cenni: “Ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde e “A Rebours” di Huysmans
GIOVANNI PASCOLI
- Accenni alla vita, formazione positivista, svolta verso l’irrazionalismo e il simbolismo
- Il mito del nido, la poetica e lo stile
- Saggio “Il fanciullino”:
La poetica del fanciullino, lettura di alcuni passi: cap. I-VI; VIII-IX e XIII (p H 362)
- “Myricae”: poetica e soluzioni formali. Testi:
X Agosto ( p H 372)
Temporale (fotocopia)
Il lampo (fotocopia)
Il tuono ( p H 369)
Novembre (fotocopia)
L’assiuolo (p H 375)
- I “Canti di Castelvecchio”: poetica e soluzioni formali. Testi:
Il gelsomino notturno (p H 384)
La mia sera (fotocopia)
- I “poemetti”: caratteri generali. Testi:
L’aquilone (p H 394)
Vertigine (fotocopia)
- “Poemi conviviali”: caratteristiche. Testi:
L’ultimo viaggio XXIII il vero: Ulisse ricerca le sirene (p H 404)
- Un discorso celebrativo: La grande proletaria si è mossa (lettura di passi). (fotocopia)- Collegamento interdisciplinare: Marcel Proust, “Alla ricerca del tempo perduto”, le intermittenze del
cuore.
GABRIELE D’ANNUNZIO
- Vita, mutamenti nel rapporto intellettuale-pubblico. Il “Dannunzianesimo”.
- Gli esordi: superamento dei modelli
- La fase estetica e la sua crisi: caratteri generali, cenni alle opere principali
- “Il Piacere”: struttura del romanzo, i personaggi, il narratore, impianto narrativo e allusioni
simboliche, stile. Testi:
Libro I, cap. II: “la vita come un’opera d’arte” (p. H466)
Libro “il ritratto allo specchio” (fotocopia)
Libro III, cap. III: “una sinfonia in bianco maggiore” (fotocopia)
- La fase della bontà: l’influenza del romanzo russo; “Giovanni Episcopo” e “L’Innocente”
- Il mito del superuomo, rapporti con Nietzsche, risvolti nell’ideologia politica, rapporti tra esteta e
superuomo, ruolo dell’intellettuale
- I romanzi del superuomo: “Trionfo della morte”, “Le Vergini delle rocce”, “Il fuoco”. Testo:
Da “Le vergini delle rocce”: il programma politico del Superuomo (fotocopia)
- I caratteri delle trilogie: rosa, giglio, melograno
- La lirica: il progetto delle Laudi; Maia, Elettra e Alcyone: caratteri generali, caratteri stilistici,
tematiche. Testi:
Maia: L’incontro con Ulisse (fotocopia)
Alcyone: La Sera Fiesolana ( p H 484)
Alcyone: La pioggia nel pineto (p H 488)
Alcyone: Meriggio (p H 492)
Alcyone: Ditirambo IV: Icaro (p H 517)
- Il periodo notturno. Testo:
Il notturno: “Il nuovo scriba” ( p H 503)
FUTURISMO
- Caratteri ideologici del movimento, caratteri tecnici della letteratura, i manifesti. Testi:
Marinetti, Manifesto del Futurismo (p L 34)
Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia)
Marinetti, Bombardamento(fotocopia)
CREPUSCOLARI
- Caratteristiche del movimento. Testo:
Gozzano, La signorina Felicita, ovvero la Felicità (p L 76)
GIUSEPPE UNGARETTI
- Vita e poetica. L’esperienza della guerra.
- L’importanza della parola e la metafora del porto sepolto.
- Visione di alcune interviste da Rai storia
- “L’allegria”: poetica ed aspetti stilistici. Testi:
In memoria (p M 418) Il porto sepolto (p M 421)
Veglia (p M 423)
I fiumi (p M 425)
San Martino del Carso (p M 429)
Sono una creatura (fotocopia)
Mattina (fotocopia)
Soldati (p M 433)
Fratelli (fotocopia)
- “Il sentimento del tempo”: caratteri generali tematici e stilistici
- “Il dolore”: poetica ed aspetti formali. Testo:
Non gridate più (fotocopia)
ERMETISMO: caratteristiche stilistiche e tematiche.
- Salvatore Quasimodo: da “Ed è subito sera”, testi:
Ed è subito sera (fotocopia)
Vento a Tindari (p M 99)
LUIGI PIRANDELLO
- Vita e formazione
- Poetica e opere principali: concezione vitalistica, la maschera, la negazione dell’identità personale,
la trappola famigliare ed economica, il forestiere della vita, il relativismo conoscitivo
- L’”Umorismo”: caratteri generali (avvertimento e sentimento del contrario, il carattere
contraddittorio del reale). Testo:
da l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale, l’esempio della vecchia
(fotocopia)
- Novelle per un anno: caratteri generali (novelle siciliane e novelle romane, l’umorismo, la
maschera). Testi:
Il treno ha fischiato (p M260)
La patente (p M 254)
- Il fu Mattia Pascal: trama, sistema dei personaggi, tecniche narrative; testi:
da “Il fu Mattia Pascal”: prefazione (p M272)
da “Il fu Mattia Pascal”: prefazione seconda, “Maledetto sia Copernico!”(p M275)
da “Il fu Mattia Pascal”: lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) (p M 278)
da “Il fu Mattia Pascal”: lanterninosofia (cap. XIII) (p M281)
- “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: trama e caratteristiche
- “Uno, nessuno e centomila”: trama, personaggi, temi, tecniche narrative; confronto tra Belluca,
Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda. Testo:
da “Uno, nessuno e centomila”: “Non conclude” (VIII, cap. IV) (p M299)
- Il teatro di Pirandello: il superamento del dramma borghese e il teatro grottesco: caratteri generali;
il motivo della pazzia: trame de “Così è (se vi pare)” ed “Enrico IV”
- La trilogia metateatrale. “Sei personaggi in cerca di autore”: struttura, caratteristiche
ITALO SVEVO
- Vita e formazione
- Il personaggio dell’inetto; modelli filosofici e letterari
- “Una vita”: trama, modelli, sistema dei personaggi, tecniche narrative
- “Senilità”: trama, modelli, sistema dei personaggi, tecniche narrative- “La coscienza di Zeno”: trama, modelli, sistema dei personaggi, tecniche narrative; la figura
dell'inetto consapevole: confronti con Freud, salute e malattia
- Testi:
da “La coscienza di Zeno”: Prefazione (fotocopia)
"L'ultima sigaretta" (cap. III); ( p M 173)
"La morte del padre" (cap. IV); (p M 176)
“La salute di Augusta” (cap. VI), (fotocopia)
EUGENIO MONTALE
- Vita e poetica. Importanza e costanti letterarie. Influenze letterarie e filosofiche. Tematiche e
visione del mondo.
- “Ossi di seppia”: struttura, poetica, soluzioni stilistiche. Il correlativo oggettivo. Testi:
I limoni (p M494)
Non chiederci la parola (p M498)
Meriggiare pallido e assorto (p M501)
Spesso il male di vivere ho incontrato (p M502)
Cigola la carrucola nel pozzo (p M505)
- “Le Occasioni”: struttura, la poetica degli oggetti, la donna salvifica, caratteri formali. Testi:
La casa dei doganieri (p M515)
- “Satura”: caratteristiche dell’opera. Testo:
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (p M534)
________________________________________________________
MODULO: INCURSIONI NELLA POESIA CONTEMPORANEA
- ALDA MERINI: cenni alla vita. Testi:
Il dottore agguerrito nella notte (fotocopia)
L’uccello di fuoco (fotocopia)
________________________________________________________
MODULO: LA LETTERATURA DEL DOPOGUERRA
NEOREALISMO, LETTERATURA DELLA RESISTENZA, MEMORIALISTICA BIOGRAFICA, POESIA CIVILE E
DELL’IMPEGNO
- Contestualizzazione storica: cenni alla Resistenza. Il clima culturale. L’editoriale “Il Politecnico”
- Neorealismo: caratteri generali e diversità nelle singole opere. Testi:
Prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno”, Italo Calvino (fotocopia)
- Memorialistica biografica: Primo Levi. Cenni alla vita. Caratteristiche e contenuti de “Se questo è
un uomo”, “La tregua”, “I sommersi e i salvati”. Testi:
“Se questo è un uomo”: poesia d’apertura (fotocopia)
“Se questo è un uomo”: prefazione (fotocopia) “Se questo è un uomo”: il canto di Ulisse (p. N22)
- Beppe Fenoglio: le caratteristiche e i contenuti de “Il partigiano Johnny” e de “I ventitré giorni
della città di Alba”
- Italo Calvino: le caratteristiche e i contenuti de “Il sentiero dei nidi di ragno”
- Cesare Pavese: le caratteristiche e i contenuti de “La luna e i falò” e de“La casa in collina”
- Elsa Morante: le caratteristiche e i contenuti de “La storia”
- Pier Paolo Pasolini: le caratteristiche e i contenuti de “Ragazzi di vita” e de “Una vita violenta”
- Poesia civile dell’impegno: Salvatore Quasimodo, Giorno dopo giorno. Testi:
Alle fronde dei salici (p N73)
Uomo del mio tempo (fotocopia)
Milano, agosto 1943 (fotocopia)
_____________________1.2 . storia DOCENTE: Francesco Rizzi Libro di testo: Desideri-Codovini: Storia e storiografia Competenze - capacità di collocazione cronologica dei fenomeni storici studiati e consapevolezza della loro importanza; - capacità di riferire i fenomeni storici al loro contesto, cogliendo e utilizzando le categorie fondamentali delle varie epoche; - proprietà lessicale nell’utilizzo del linguaggio della disciplina; - riconoscimento di codici e strutture di un testo (fonte o brano storiografico); capacità di comprenderlo, analizzarlo e commentarlo; - capacità di esporre in modo critico e personale le interpretazioni più consolidate dei fenomeni storici e di proporre chiavi di lettura originali degli eventi stessi; - capacità di interrogare gli eventi storici attraverso gli spunti forniti dalla attualità; - capacità di collegamento interdisciplinare. Indicatori di valutazione - conoscenza dei contenuti appresi e pertinenza delle risposte; - comprensione dei contenuti appresi e delle loro interrelazioni; - espressione corretta di quanto appreso e compreso sui piani lessicale e logico-sintattico, secondo forme adeguate al contesto comunicativo; - argomentazione coerente del discorso sul piano logico; - capacità di analisi del testo storico in ogni sua forma (fonte, testo storiografico, ecc.); - attenzione alle implicazioni attuali delle questioni trattate. PROGRAMMA DI STORIA 1. IL RISORGIMENTO Uno sguardo agli Stati preunitari: il regno delle due Sicilie sotto Ferdinando II di Borbone tra primati e critiche della stampa liberale; i tentativi di unificazione, napoleonico, carbonaro, mazziniano e sabaudo; il liberalismo di Cavour in politica interna, estera, religiosa ed economica; la seconda guerra di indipendenza e i plebisciti; la spedizione dei mille e il brigantaggio; il pontificato di Pio IX e la questione romana.
Puoi anche leggere