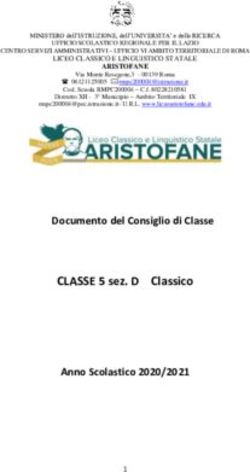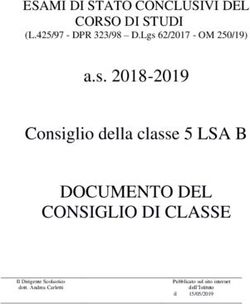CLASSE V sez. A DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - IIS Russell Milano
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B.
RUSSELL"
Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane “B. Russell” e Liceo Classico “Omero”
, Via Gatti, 16- 20161 Milano Tel. 02/6430051 -Fax 02/6437132
www.iis-russell.edu.it C.M. MIIS03900T C.F. 80125870156- Codice univoco UFO7CZ
e-mail iis.russell@tiscali.it - MIIS03900Tistruzione.it - MIIS03900T@pec.istruzione.it
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE V sez. A
LICEO SCIENZE UMANE
(Deliberato nel CdC dell’ 8 maggio 2019)
ESAME DI STATO
Anno scolastico 2018/2019FIRME - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5 A SCIENZE UMANE
DOCENTE
SARINI Ilaria
GIALLONGO Elena
CASADEI Osvaldo
BENAGLIO Maria Gabriella
sostituita dal 1/4/2019 da COLLICA Esther
VARANI Annamaria
INVERNIZZI Giusi M.
LUCCHINI Marta
DELFINO Alice
MARTINELLI Antonella
sostituita dal 6/5/2019 da SORRENTINO Andrea
Milano, 15 maggio 2019
INDICE
1❖ Composizione del Consiglio di Classe pag. 3
❖ Presentazione della classe e suo percorso storico pag. 4
❖ Profilo atteso in uscita pag. 6
❖ Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti pag. 8
❖ Attività curricolari ed extracurricolari pag. 11
❖ Attività di Cittadinanza e Costituzione pag. 12
❖ Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento pag. 15
❖ Progettazioni disciplinari pag. 24
❖ Simulazioni di prove d’esame elaborate dalla scuola pag. 79
❖ Esempi di percorsi elaborati dalla scuola pag. 80
❖ Griglie di valutazione della prima prova scritta pag. 91
❖ Griglia di valutazione della seconda prova scritta pag. 98
2COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE MATERIA
SARINI Ilaria Lingua e letteratura italiana e Lingua e cultura latina
GIALLONGO Elena Scienze Umane e Filosofia
CASADEI Osvaldo Storia
BENAGLIO Maria Gabriella Lingua straniera inglese
sostituita da COLLICA Esther
VARANI Annamaria Scienze naturali
INVERNIZZI Giusi M. Storia dell’arte
LUCCHINI Marta Matematica e fisica
DELFINO Alice Scienze motorie e sportive
MARTINELLI Antonella Religione
sostituita da SORRENTINO
Andrea
3PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO
La classe V A scienze umane è composta da 17 studentesse : nel corso del quinquennio ha
subito numerose variazioni nella composizione, poiché si sono verificati abbandoni, nuovi
inserimenti e alcune bocciature. In particolare, dalla terza alla quarta ci sono stati un
trasferimento e cinque bocciature, che hanno modificato in modo significativo la classe,
lasciandola tra l’altro senza componente maschile.
Si presenta come una classe fragile e complessa, per via delle diverse situazioni particolari
che presenta, come attestato dalla presenza dei PDP, che a inizio del quinto anno erano tre
e nel volgere della chiusura del I quadrimestre dello stesso sono diventati sette (due per
DSA, cinque per BES: vedasi documentazione relativa agli atti).
La maggioranza dei PDP è in qualche modo legata a problemi di salute che hanno
determinato un elevato numero di assenze e questo è uno degli elementi che ha reso
talvolta difficoltoso lavorare con continuità ed efficacia in questa classe, che per il resto è
tendenzialmente collaborativa e partecipe.
Possiamo al suo interno distinguere tre gruppi: uno solerte e molto partecipe alle attività, uno
meno appariscente e dedito a un apprendimento passivo ma costante e uno interessato in
modo intermittente.
Per quanto riguarda l’esperienza didattica realizzata, si può dire che la classe è stata
caratterizzata da alcuni problemi che hanno in parte ostacolato il pieno raggiungimento degli
obiettivi formativi e disciplinari individuati dal C.d.C : il percorso storico della classe risulta
caratterizzato da un costante avvicendarsi di professori all’interno del Consiglio e dalla
scarsa continuità didattica anche tra un anno e l’altro del triennio: ciò, insieme alle difficoltà
insite nella componente studentesca.
Ha costituito un particolare ostacolo a rispondere alle richieste del lavoro scolastico da parte
della classe, l’atteggiamento di alcune studentesse in fatto di puntualità e costanza nella
frequenza. A fronte di un interesse anche vivo dimostrato dalle studentesse durante le
lezioni per le problematiche affrontate, si coglievano dispersione di energie e scarsa
disponibilità a supportare l’ interesse con uno studio personale conseguente e
qualitativamente rispondente alle richieste, specialmente negli ultimi due anni.
Il C.d.C, preso atto della situazione, ha mostrato un’ attenzione e una disponibilità costanti
alle problematiche della classe, dedicando tempo e risorse ad esse: ha quindi aumentato le
richieste in modo graduale, adattandole progressivamente alle numerose esigenze
4specifiche di ogni studentessa, e, ove previsto, ha messo in atto puntualmente le
disposizioni contenute nei PDP.
Le ragazze hanno mostrato di tenere alla riuscita dei propri studi, sforzandosi costantemente
di adattarsi alle richieste via via più complesse e alle indicazioni di lavoro fornite anche ad
anno avviato .
I risultati così conseguiti sono stati in generale positivi, poiché una parte delle studentesse è
riuscita a trovare maggior interesse nello studio e, perciò, a impegnarsi in modo continuativo
e più costruttivo, colmando le proprie lacune e ottenendo risultati anche buoni.
Nel complesso, la classe ha mostrato un atteggiamento positivo e collaborativo, sempre
rispettoso nei confronti dei docenti e ha colpito positivamente gli esperti esterni che hanno
avuto modo di lavorare insieme alla classe, apprezzandone il coinvolgimento e il desiderio
autentico di dare il proprio contributo, specialmente nelle attività laboratoriali, di natura
pratica.
Composizione del Consiglio di Classe nel triennio
Materie Docente Continuità
3^ 4^ 5^
Lingua e letteratura italiana Sarini Ilaria si si si
e Lingua e cultura latina
Scienze Umane e Filosofia Giallongo no si si
Elena
Storia Casadei no no si
Osvaldo
Lingua straniera inglese Benaglio no si si
Maria
Gabriella
Scienze naturali Varani no no si
Annamaria
Storia dell’arte Invernizzi si si si
Giusi M.
Matematica e fisica Lucchini Marta no si si
Scienze motorie e sportive Delfino Alice no no si
Religione Martinelli si si si
Antonella
5PROFILO ATTESO IN USCITA
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Risultati di apprendimento per il Liceo delle Scienze Umane
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socioantropologica;
- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative,
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella
costruzione della civiltà europea;
- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e
pedagogico-educativo;
- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona,
al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
6- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.
7OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI
ASSE DI RIFERIMENTO COMPETENZA LIVELLO LIVELLO
PIENAMENTE PARZIALMENT
RAGGIUNTO E
RAGGIUNTO
Padroneggiare gli strumenti
ASSE DEI LINGUAGGI espressivi ed argomentativi X
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
Leggere, comprendere ed X
interpretare testi scritti di vario
tipo
Produrre testi di vario tipo in X
relazione ai differenti scopi
comunicativi
Utilizzare una lingua per i X
principali scopi comunicativi ed
operativi
Utilizzare gli strumenti X
fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio
artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi X
multimediali
ASSE MATEMATICO Utilizzare le tecniche e le X
procedure del calcolo aritmetico Permane una
ed algebrico acquisite, e fragilità, non grave
applicarle nel contesto dello ma diffusa,
studio di funzione. rispetto al calcolo
algebrico (errori
nella
scomposizione di
polinomi, nella
risoluzione di
disequazioni di
secondo grado,
esponenziali e
logaritmiche)
Confrontare e analizzare grafici X
di funzioni razionali intere fratte
e semplici funzioni trascendenti,
8individuando simmetrie e
relazioni.
Individuare le strategie X
appropriate per la soluzione di Non per tutte le
problemi nell’ambito dell’analisi studentesse è
matematica. immediata la
comprensione
della richiesta di
un problema e la
traduzione di tale
richiesta nel
linguaggio
matematico utile
alla soluzione.
Padroneggiare i principali X
concetti del calcolo
infinitesimale, in particolare la
continuità, la derivabilità e
l’integrabilità, sapendoli
collocare e applicare in
relazione alle problematiche in
cui sono nati (velocità
istantanea in meccanica,
tangente di una curva, calcolo
di aree e volumi).
ASSE Osservare, descrivere ed X
TECNOLOGICO-SCIENTI analizzare fenomeni
FICO appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle
sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e X
quantitativamente fenomeni Parzialmente
legati alle trasformazioni di raggiunto: la
energia a partire dall’esperienza padronanza del
e saperli descrivere e linguaggio
formalizzare con l’ausilio del specifico è in
linguaggio specifico di ciascuna alcuni casi non
disciplina scientifica pienamente
sufficiente.
Essere consapevole delle X
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale in
cui vengono applicate
ASSE STORICO- SOCIALE Comprendere il cambiamento e X
la diversità dei tempi storici in
9una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e
culturali.
Collocare l’esperienza X
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche X
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del territorio
10ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività :
- laboratorio antropologico
- visite a strutture scolastiche del primo ciclo di istruzione
- incontri con specialisti delle scienze umane (psicologo, educatore, esperti ABA,
CiEsseVi volontariato)
- incontri con giornalisti di Altreconomia
- uscita e incontro Istat
- incontro con gli Amici del Policlinico e della Mangiagalli per le donazioni del sangue
- stage linguistico in Irlanda, effettuato nella primavera del quarto anno. Ha avuto lo
scopo non solo di potenziare, soprattutto a livello orale, la competenza linguistica
della produzione orale e dell’ascolto ma anche quello di far conoscere e apprezzare
una nuova cultura e un nuovo stile di vita.
- Conferenza “La Poesia e l’articolo 27 della Costituzione”, con Maddalena Capalbi
(Ambrogino D’Oro 2015) e Paolo Barbieri (coordinatori del Laboratorio di Poesia
della II Casa di Reclusione di Bollate) e due detenuti che hanno partecipato al
Laboratorio di Poesia della II Casa di Reclusione di Bollate.
In particolare, durante il quinto anno, sono state effettuate le seguenti attività:
- all’interno del laboratorio antropologico, progettazione di una attività didattica da
proporre nelle scuole
- visita alla scuola primaria “Rinnovata-Pizzigoni”
- incontri coi giornalisti di Altreconomia sui seguenti temi: “come funziona la cosa
pubblica” e “finanza etica”
- incontro col Centro Buonarroti dal titolo “Demografia e migrazioni”
11ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Le competenze di cittadinanza intese come “capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale” si fondano sulla conoscenza dei concetti e
dei fenomeni di base riguardanti gli individui e la società, e non possono prescindere dalla
comprensione dei valori comuni dell’Europa e delle complesse dinamiche che interagiscono
nello scenario internazionale.
Per sviluppare tali competenze nel triennio sono state organizzate le seguenti attività:
- Laboratorio antropologico
- Visite a strutture scolastiche
- Incontri i giornalisti di Altreconomia
- incontro col Centro Buonarroti dal titolo “Demografia e migrazioni”
- uscita e incontro Istat
- approfondimenti interdisciplinari (scienze umane e inglese) sui temi: globalizzazione,
multiculturalità e media
- Approfondimenti interdisciplinari (Religione) sui temi: Il valore etico della vita umana:
la dignità della persona umana, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se
stessi, gli altri e il mondo, la giustizia sociale, il bene comune, la promozione della
pace. La scuola come esperienza di partecipazione; Il contributo della Chiesa allo
sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità; L’importanza del Cristianesimo
per la nascita e lo sviluppo della cultura Europea; Religione e sviluppo economico,
sociale, culturale, ambientale nel ‘900.
- Approfondimenti interdisciplinari: (Storia) “Una questione di genere: essere cittadina”.
Donne e sapere, donne alla guerra, mogli e madri del regime. La Resistenza.
Cittadine della Repubblica. Il ‘68.
Donne e Costituzioni: Fiume “La carta del Carnaro”, Repubblica di Weimar, donne e
fascismo. La Costituzione italiana.
- Approfondimenti interdisciplinari (Inglese): Emmeline Goulden Pankhurst “A lifelong
fight for women’s emancipation”. “I know why the Caged Bird sings” by Maya
Angelou.
- Nel corso dell’anno è stata organizzata un’attività di approfondimento alla quale
hanno partecipato alcune studentesse della classe durante la quale sono stati
presentati e discussi i seguenti film: “Selma” sul diritto di voto delle donne e uomini di
colori negli Stati Uniti d”America, “Iron Jawed Angels”, sulla conquista del voto delle
donne negli Stati Uniti e “Michael Collins”, sulla lotta di indipendenza di donne e
uomini in Irlanda.
In particolare, durante il quinto anno, sono state effettuate le seguenti attività:
Area di competenza Titolo Obiettivi conseguiti
Noi e gli altri: - Laboratorio - Acquisire ed interpretare
Antropologico: l’informazione in modo critico
- le relazioni umane
“Progettazione Attività
- i diritti umani Didattica”
- Elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie
- la parità di genere attività di studio, utilizzando le
12- Incontro con il centro conoscenze apprese per stabilendo
Buonarroti dal titolo: obiettivi significativi e realistici e
“Demografia e valutando i vincoli e le possibilità
migrazioni” esistenti, definendo strategie di azione
- Approfondimenti - Comunicare e comprendere messaggi
interdisciplinari (scienze di genere e complessità diversi e
umane e inglese) sui rappresentare fenomeni e, concetti
temi: “globalizzazione, utilizzando linguaggi diversi e diverse
multiculturalità e media” conoscenze disciplinari e mediante
- La poesia e l’articolo diversi supporti
27 della Costituzione
Progetto Religione,
- Acquisire maggior consapevolezza
relativamente alle dinamiche sociali
società e dialogo
differenze culturali, diritti e doveri
interculturale:
l’adolescente l’attività
creativa e l’educazione
alla cittadinanza:
preparazione e incontro
del 16 aprile 2018 con
Maddalena Capalbi e
Paolo Barbieri
(coordinatori del
Laboratorio di Poesia
della II Casa di
Reclusione di Bollate) e
con alcuni ex detenuti
che hanno partecipato al
Laboratorio di Poesia e
al Laboratorio di Teatro
della II Casa di
Reclusione di Bollate.
Noi e le istituzioni: - Altreconomia: - Acquisire maggior consapevolezza
relativamente al funzionamento dello
- Stato e Costituzione “Come funziona la
stato
cosa pubblica”
- Il Parlamento e le
- Acquisire ed interpretare
leggi - Approfondimenti
l’informazione in modo critico
disciplinari di scienze
- Il governo e la P.A.
umane - Comunicare e comprendere messaggi
- La magistratura di genere e complessità diversi
- L’Unione Europea
Noi e il rispetto delle - Visita alla scuola - Acquisire maggior consapevolezza
regole primaria relativamente alle dinamiche sociali ed
“Rinnovata-Pizzigoni” educative i diritti e doveri.
- Educazione alla
legalità - Altreconomia: - Acquisire ed interpretare
l’informazione in modo critico
“il Consumo Critico”
13- Educazione - Comunicare e comprendere messaggi
finanziaria di genere e complessità diversi.
- Educazione alla - Promuovere la solidarietà e la
partecipazione partecipazione riflettendo su un modello
di consumo critico e consapevole
14PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
Attività PCTO nel triennio
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, così ridimensionati dall’art. 1
comma 784 della legge 145 del 2018, sono stati articolati nel triennio, con una maggiore
concentrazione di ore in terza e in quarta, per un numero complessivo di ore che può
lievemente variare da studentessa a studentessa, ma comunque sempre superiore alle 200.
L’esperienza del PCTO è stata seguita in terza dalla Prof.ssa Isabella Fazio di Nasari e in
quarta e quinta dalla Prof.ssa Sarini secondo modalità e intenti comuni. Gli studenti hanno
svolto sia in terza sia in quarta attività presso strutture ospitanti, in genere suddivisi in piccoli
gruppi, prevalentemente nel mese di aprile, negli stessi giorni, per permettere uno
svolgimento quanto più possibile continuativo all'attività didattica. In linea con l'indirizzo di
studi di Scienze Umane si è optato in larga misura per esperienze nel settore della
formazione, in particolare in asili nidi e scuole dell'infanzia, secondo un percorso di
continuità che fornisse una visione ampia delle varie realtà educative. Altri tirocini si sono
svolti in strutture ospedaliere, in librerie, in biblioteche e in sedi giornalistiche, per cercare di
soddisfare le esigenze di tutti gli studenti.
Per tutto il triennio gli studenti hanno partecipato a incontri e attività laboratoriali organizzate
dal Dipartimento di Scienze Umane, che sono da considerarsi un complemento dei
programmi svolti nelle ore curricolari e che rappresentano un'importante possibilità per
conoscere le offerte lavorative attinenti all'indirizzo di studi e per avvicinarsi al mondo del
volontariato. Le ore in questione sono 35 per le terza, 20 per le quarta e 18 per la quinta.
Per tutti gli studenti della classe sono state conteggiate 6 ore di impresa simulata e 4 di
corso sulla sicurezza per le terza, 6 di restituzione in classe e di stesura delle relazioni per le
quarta e 5 di stesura del curriculum vitae e di questionario per la quinta.
Inoltre gli studenti hanno aderito a due progetti che si sono svolti a scuola con la
partecipazione di esperti esterni e che hanno coinvolto più classi. In quarta l'Associazione
Thumbs Up ha presentato il progetto “Un ponte verso il futuro” finanziato dalla Fondazione
Cariplo. Si tratta di un progetto di orientamento e di alternanza scuola-lavoro finalizzato a
rendere coscienti gli studenti dei loro punti di forza e a far conoscere il mercato del lavoro. Il
progetto, incentrato sul marketing e articolato in sei moduli con momenti di lavoro sia
individuale sia di gruppo, ha visto la partecipazione della Fondazione Dynamo e ha richiesto
la realizzazione di una proposta di marketing per la promozione Salvadynaio, con la
produzione di un powerpoint e di un video.
In quinta I volontari di VISES ONLUS hanno presentato il progetto GIOVANI&IMPRESA, in
convenzione con FONDAZIONE SODALITAS e con la collaborazione del MIUR, finalizzato a
potenziare le competenze digitali e favorire l’apprendimento di competenze trasversali e di
cittadinanza. Il progetto si è articolato in 25 ore, così ripartite: 20 ore di training con esperti
aziendali su temi che hanno fornito alle studentesse le basi per analizzare e rafforzare le
proprie competenze trasversali e le conoscenze dei principali passi da compiere per un
inserimento di successo nel mondo del lavoro; 5 ore: di preparazione al training attraverso
strumenti di autoanalisi delle proprie caratteristiche, stesura del proprio curriculum vitae e
preparazione a sostenere il colloquio di lavoro a fine corso. Attraverso lezioni multimediali,
con simulazioni, giochi di ruolo e lavori in squadra i volontari di VISES, manager in pensione
o in transizione, hanno spiegato quali siano le caratteristiche e le attitudini che le imprese
cercano nei candidati e quali meccanismi regolino la vita in azienda.
Entrambi i progetti sono stati perfezionati con un questionario di valutazione sull'esperienza.
15Nel corso dei tre anni l'impegno richiesto per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie
attività è stato notevole per tutte le componenti scolastiche e per gli enti esterni, che del
resto si sono sempre dimostrati disponibili. Indubbiamente si deve tenere in considerazione
il fatto che era il secondo anno in cui è stato affrontato l’obbligo di svolgere tali attività
secondo le disposizioni legislative previste dalla L.107/2015, poi ridimensionate dall’art. 1
comma 784 della legge 145 del 2018.
Nel complesso l'esperienza ha dato esiti positivi e ha saputo offrire una gamma di proposte
variegata nella sua omogeneità, così da sviluppare competenze trasversali e di abituare le
studentesse a rapportarsi con il mondo adulto del lavoro.
Le valutazioni da parte delle aziende o degli enti esterni sono sempre state positive, anche
molto positive; non ci sono mai state lamentele e non è mai stato necessario l'intervento
della tutor docente. Un gruppo della classe si è distinto tra quelli delle classi quarte di
Scienze Umane per aver presentato il miglior progetto per la Fondazione Dynamo. Inoltre, in
conclusione del progetto di Sodalitas una studentessa ha ricevuto un attestato di distinzione
con la seguente motivazione: «esprime, durante lo sviluppo del corso, comportamenti di
autonomia, responsabilità e spinta all'eccellenza e acquisisce competenze in merito alla
comunicazione e relazioni personali nel lavoro di gruppo, al problem solving e
all'orientamento al risultato». Al di là del caso specifico, in genere il livello della classe è
stato apprezzato dagli esperti di Sodalitas che si sono complimentati con i docenti.
Da parte loro le studentesse hanno apprezzato i momenti laboratoriali e le attività che le
rendevano attive e partecipi, preferendo la pratica alla teoria e non amando il ruolo di
“osservatrici” che spesso – per una serie di giustificati motivi – hanno dovuto ricoprire nelle
aziende ospitanti.
Si riporta di seguito un estratto della scheda di valutazione consegnata alle strutture
ospitanti, che riporta i criteri di valutazione in base ai quali ogni tutor aziendale ha valutato i
singoli studenti in riferimento alle attività svolte:
CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE IN relazione ALLE ATTIVITA’ ALLE
QUALI HA PARTECIPATO:
□ OTTIME
□ BUONE
□ DISCRETE
□ SUFFICIENTI
□ INSUFFICIENTI
GIUDIZIO DELL’AZIENDA SULLE CAPACITA’ PROFESSIONALI EVIDENZIATE DAL
TIROCINANTE ( ad es. autonomia, precisione, uso degli strumenti di supporto, flessibilità,
capacità di apprendimento)
□ OTTIMO
□ BUONO
□ DISCRETO
□ SUFFICIENTE
□ INSUFFICIENTE
GIUDIZIO DELL’AZIENDA SULL’ATTITUDINE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA:
□ OTTIMO
□ BUONO
□ DISCRETO
16□ SUFFICIENTE
□ INSUFFICIENTE
GIUDIZIO DELL’AZIENDA SULLA PUNTUALITA’ E RISPETTO DEGLI IMPEGNI
□ PIENAMENTE ADEGUATO
□ ADEGUATO
□ NON ADEGUATO
GIUDIZIO DELL’AZIENDA SUGLI ATTEGGIAMENTI E IL COMPORTAMENTO:
socializzazione, disponibilità e capacità di lavorare in gruppo
□ PIENAMENTE ADEGUATO
□ ADEGUATO
□ NON ADEGUATO
La valutazione complessiva dei PCTO confluirà nel voto di condotta, nel voto delle singole
discipline afferenti alle esperienze svolte e nei crediti formativi. Quando il C.d.C. procederà
alla valutazione degli esiti delle esperienze PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti
disciplinari e sul voto di condotta, le proposte di voto dei docenti del C.d.C. terranno conto
degli esiti attestati dagli enti ospitanti e sintetizzati, secondo i criteri di cui sopra,
nell’apposita scheda di valutazione.
Di seguito si riportano l’elenco delle strutture ospitanti nel corso del triennio e un quadro di
sintesi delle attività svolte da ciascuna studentessa anno per anno (comprensivo delle ore
certificate).
QUADRO DI SINTESI DEI PCTO NEL TRIENNIO 2016/19
Studentessa a.s. Azienda o Attività di Progetti Attività Ore
ente Scienze complemen totali
ospitante Umane tari
BRAMBILLA 16/17 Scuola Varie / Sicurezza e
dell'Infanzia relazione 237.3
Meleri
ore 58 35 10
17/18 MUBA Varie THUMBS Restituz. e
UP relazione
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
17BRASCA 16/17 Scuola Varie / Sicurezza e
dell'Infanzia relazione 247,3
Meleri e
laboratorio
per
conduzione
gruppi
ore 68 35 10
17/18 MUBA Varie THUMBS Restituz. e
UP relazione
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
CIARROCCA 16/17 Asilo nido La Varie / Sicurezza e
Valle relazione 227,3
ore 48 35 10
17/18 Libreria Varie THUMBS Restituz. e
Hellisbook UP relazione
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
DONADIO 16/17 Asilo nido La Varie / Sicurezza e
Valle relazione 227,3
ore 48 35 10
17/18 Fondazione Varie THUMBS Restituz. e
Infantile UP relazione
Carcano
Grassi
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
18FERRARI 16/17 Asilo Varie / Sicurezza e
infantile relazione 235,3
Affori
ore 56 35 10
17/18 Scuola Varie THUMBS Restituz. e
parrocchiale UP relazione
Maria
Immacolata
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.cu
rriculum
ore 18 20 5
FERRARO 16/17 Clinica Varie / Sicurezza e
privata San relazione 244
Carlo
ore 65,30 35 10
17/18 Libreria Varie THUMBS Restituz. e
Hellisbook UP relazione
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 19 5
FUMAGALLI 16/17 Asilo Varie / Sicurezza e
infantile relazione 243,3
Affori e
laboratorio
per
conduzione
gruppi
ore 64 35 10
17/18 AVO Varie THUMBS Restituz. e
(Ospedale UP relazione
Bassini)
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
19ore 18 20 5
GIORDANO 16/17 Clinica Varie / Sicurezza e
privata San relazione 231,3
Carlo
ore 64 35 10
17/18 Biblioteca Varie THUMBS Restituz. e
rionale UP relazione
Niguarda
ore 40 20 19,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
MAMELI 16/17 Asilo nido Varie / Sicurezza e
San relazione 235.3
Bernardo
ore 56 35 10
17/18 Fondazione Varie THUMBS Restituz. e
Infantile UP relazione
Carcano
Grassi
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
ORLANDO 16/17 Asilo nido De Varie / Sicurezza
SOFIA Curtis e 235.3
relazione
ore 56 35 10
17/18 MUBA Varie THUMBS Restituz. e
UP relazione
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
20ore 18 20 5
PACE 16/17 Clinica privata Varie / Sicurezza
San Carlo e 242.3
relazione
ore 64 35 10
17/18 Biblioteca Varie THUMBS Restituz. e
rionale UP relazione
Niguarda
ore 40 20 24,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
PELLEGRIN 16/17 Scuola Varie / Sicurezza
O dell'Infanzia e 229.3
Cabella relazione
ore 56 35 10
17/18 Associazione Varie THUMBS Restituz. e
“Amici di Zona UP relazione
Nove”
ore 40 20 19,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
PUGLISI 16/17 Celimondo Varie / Sicurezza
e 322.3
relazione
ore 143 35 10
17/18 Associazione Varie THUMBS Restituz. e
“Amici di Zona UP relazione
Nove”
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
21RADOGNA 16/17 Scuola Varie / Sicurezza
dell'Infanzia e 235.3
Sant'Agostino relazione
ore 56 35 10
17/18 Scuola Varie THUMBS Restituz. e
parrocchiale UP relazione
Maria
Immacolata
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
RAVIDÀ 16/17 Asilo nido San Varie / Sicurezza
Bernardo e 235.3
relazione
ore 56 35 10
17/18 Fondazione Varie THUMBS Restituz. e
Infantile UP relazione
Carcano
Grassi
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
RIGON 16/17 Asilo nido De Varie / Sicurezza
Curtis e 229.3
relazione
ore 56 35 10
17/18 MUBA Varie THUMBS Restituz. e
UP relazione
ore 40 20 24,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 15 5
22WU 16/17 Celimondo Varie / Sicurezza
e 320.3
relazione
ore 141 35 10
17/18 MUBA Varie THUMBS Restituz. e
UP relazione
ore 40 20 25,30 6
18/19 / Varie Sodalitas Question.
curriculum
ore 18 20 5
La docente tutor
Ilaria Sarini
……………………………………………………………………...
23PROGETTAZIONI DISCIPLINARI
DOCENTE Sarini Ilaria
MATERIA Lingua e letteratura italiana
DESTINATARI Classe 5^A Scienze Umane
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Conoscenze, abilità, competenze Raggiunto Motivazione dell’eventuale
si/no mancato raggiungimento
Conoscenze
• conoscere le norme ortografiche, sì
morfologiche e sintattiche
• conoscere il lessico adeguato al contesto sì
comunicativo e al tipo di testo letto o redatto
• conoscere la varietà dei registri linguistici sì
• conoscere le tipologie testuali proposte sì
all’esame di Stato
• consolidare le conoscenze acquisite nel sì
biennio
• conoscere le linee di sviluppo della letteratura
sì
italiana dai Promessi Sposi d i A. Manzoni al
Novecento
• conoscere le principali linee di sviluppo delle parzialm.
letterature europee
• conoscere il lessico specifico della disciplina sì
• conoscere vita e poetica degli autori più sì
rappresentativi di ciascuna epoca
• conoscere l’evoluzione dei generi letterari sì
• conoscere la struttura e i contenuti generali sì
della Divina Commedia
• conoscere i contenuti specifici dei singoli sì
canti del Paradiso studiati
• consolidare le conoscenze delle parzialm.
caratteristiche linguistiche dei testi trattati in
senso diacronico
• conoscere la specificità del linguaggio poetico sì
e della prosa del Novecento
• conoscere i lineamenti essenziali della storia
sì
della letteratura italiana del periodo
considerato a partire dai testi letti
24Abilità
• saper applicare le norme ortografiche, sì
morfologiche e sintattiche
• saper usare il lessico adeguato al contesto sì
comunicativo e al tipo di testo redatto
• saper selezionare il registro linguistico adatto
al contesto comunicativo
• saper comporre un testo secondo le tipologie sì
testuali proposte all’Esame di Stato
• potenziare le abilità linguistiche e
sì
argomentative
• saper analizzare testi letterari e non, per
comprenderne il senso
sì
• saper individuare i caratteri specifici di un
testo letterario, scientifico, tecnico, storico, sì
critico ed artistico
• saper riconoscere e identificare periodi e sì
linee di sviluppo della cultura letteraria italiana
• saper contestualizzare e attualizzare le sì
tematiche prese in esame
• saper rielaborare criticamente i contenuti parzialm.
appresi
• saper individuare le caratteristiche parzialm.
linguistiche dei testi trattati, in senso diacronico
• saper riconoscere un testo poetico o un testo sì
in prosa del Novecento dalle sue
caratteristiche stilistiche
25Competenze
• perfezionare le tecniche compositive relative sì
alle diverse tipologie testuali
• esporre i contenuti con coesione e chiarezza parzialm. obiettivo parzialmente
rielaborandoli autonomamente, e usando il raggiunto in quanto non tutte le
lessico specifico della disciplina studentesse sono in grado di
• utilizzare gli strumenti espressivi e sì interpretare in autonomia e
argomentativi indispensabili per gestire
criticamente un testo letterario
l’interazione verbale e scritta in vari contesti
• utilizzare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per studiare, fare ricerca,
sì
comunicare
• esporre e presentare l’esperienza dei PCTO sì
• analizzare testi non noti, comprenderli e sì
confrontarli
• eseguire le consegne in modo pertinente alle sì
richieste
• consolidare le capacità critiche e parzialm.
interpretative
• comprendere e decodificare un testo sì
• leggere e interpretare un testo cogliendone sì
tutti gli elementi tematici
• leggere, comprendere e interpretare varie sì
tipologie di testi afferenti sia al periodo trattato
nello studio della letteratura sia al mondo
contemporaneo
parzialm.
• leggere e interpretare un testo cogliendone
tutti gli aspetti retorico-stilistici
• acquisire un’autonoma capacità di parzialm.
interpretazione e di commento dei testi
• sapersi confrontare con interpretazioni parzialm.
critiche del testo
• acquisire l’abitudine a interrogarsi sul senso parzialm.
delle cose e a esercitare sempre un pensiero
critico
• elaborare in modo personale le conoscenze parzialm.
acquisite
- esercitando l’analisi consapevole della
propria esperienza
- stabilendo un costante collegamento con la
realtà in cui vive
- imparando a porsi le domande che portano
alla ricerca del senso delle cose
METODI
Lezioni frontali e dialogate; preparazione di mappe concettuali in digitale
VERIFICHE
Tipologie A, B e C del nuovo Esame di Stato per lo scritto; interrogazioni (programmate
26nel secondo quadrimestre), prove strutturate e domande aperte per l’orale
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI
d eventuale partecipazione ai corsi di potenziamento attivati dalla
Studio individuale e
scuola
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
● G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, L'attualità della letteratura, voll. 3.1-3.2,
Paravia
● Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione integrale a scelta
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
●● Letteratura
L'età del Romanticismo
Alessandro Manzoni (continua)
dai Promessi Sposi («La sventurata rispose», cap. X; La redenzione di Renzo e la funzione
salvifica di Lucia, cap. XVII; L’innominato: dalla storia al mito, cap. XIX; La conclusione del
romanzo: paradiso domestico e promozione sociale, cap. XXXVIII)
Giacomo Leopardi
dai Canti (L’infinito, XII; La sera del dì di festa, XIII; Alla luna, XV; A Silvia, XXI; La quiete dopo la
tempesta, XXIV; Il sabato del villaggio, XXV; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, XXIII; A
se stesso, XXVIII; La ginestra o il fiore del deserto, XXXIV, 297-317)
dalle Operette morali (Dialogo della Natura e di un Islandese, XIV; Dialogo di un venditore di
almanacchi e di un passeggere, XXIII)
dallo Zibaldone di pensieri (La teoria del piacere, 165-172; Il vago, L’indefinito e le rimembranze
della fanciullezza, 514-516; Indefinito e infinito, 1430-1431; Il vero è brutto, 1521-1522; Teoria
della visione, 1744-1747; Ricordanza e poesia, 1804-1805; Indefinito e poesia, 1982-1983; La
doppia visione, 4418; La rimembranza, 4426)
L'età del Realismo
La Scapigliatura
Igino Ugo Tarchetti
da Fosca (L'attrazione della morte, capp. XV, XXXII, XXXIII)
27Il Naturalismo francese e il Verismo
Edmond e Jules de Gouncourt
da Germinie Lacerteux, Prefazione (Un manifesto del Naturalismo)
Luigi Capuana
dalla Fanfulla della domenica, 1881 (Scienza e forma letteraria: l'impersonalità)
Giovanni Verga
da L'amante di Gramigna, Prefazione ( Impersonalità e regressione)
da Vita dei campi (Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa)
I Malavoglia (lettura individuale; in evidenza: Prefazione, I «vinti» e la «fiumana del progresso»; Il
mondo arcaico e l'irruzione della storia, cap. I; I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali
e interesse economico, cap. IV; La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno, cap.
XV)
da Novelle rusticane (La roba)
Dal Realismo al Simbolismo
Charles Baudelaire
dai Fiori del male (Corrispondenze; Spleen)
dai Poemetti in prosa (Perdita d'aureola)
Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé
Il Decadentismo e il Simbolismo
Gabriele D'Annunzio
Il piacere (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II; Una fantasia in
«bianco maggiore», libro III, cap. III)
*da Alcyone (La sera fiesolana; Le Stirpi canore; La pioggia nel pineto)
da Notturno (La prosa “notturna”)
Giovanni Pascoli
da Il fanciullino (Una poetica decadente)
da Myricae (L’assiuolo; Novembre)
dai Poemetti (Digitale purpurea; Italy I I-IV)
dai Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno)
28Il primo Novecento
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo (1909)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912)
Le avanguardie in Europa
Il Crepuscolarismo
Guido Gozzano
dai Colloqui ( Totò Merùmeni)
Italo Svevo
Senilità (lettura individuale a.s. 2017/2018)
La coscienza di Zeno ( lettura individuale; in evidenza: Il fumo, cap. III; La morte del padre, cap. IV;
La salute “malata” di Augusta, cap. VI; Psico-analisi, cap. VIII)
Luigi Pirandello
da L'umorismo (Un'arte che scompone il reale)
da Novelle per un anno (Il treno ha fischiato)
Il fu Mattia Pascal (lettura individuale; in evidenza: La costruzione della nuova identità e la sua crisi,
capp. VIII e IX; Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», capp. XII e XIII)
Uno, nessuno e centomila ( lettura individuale a.s. 2016/2017)
Tra le due guerre
Umberto Saba
dal Canzoniere (Trieste; Mio padre è stato per me «l'assassino»; Amai; Ulisse)
Giuseppe Ungaretti
dall’Allegria (In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; San Martino del Carso;
Mattina; Soldati; Girovago)
da Sentimento del tempo (Di l uglio)
L'Ermetismo
Salvatore Quasimodo
da Acque e terre (Ed è subito sera; Alle fronde dei salici)
29Alfonso Gatto
da L'isola (Carri d’autunno)
Eugenio Montale
da Ossi di seppia (I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un
mattino andando in un'aria di vetro)
da Le occasioni (Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri)
da La bufera e altro (Piccolo testamento)
da Satura (Ho sceso, dandoti il braccio...)
Guerra e dopoguerra
La poesia del secondo Novecento (linee guida)
Vittorio Sereni
da Diario d'Algeria (Non sa più nulla, è alto sulle ali)
da Gli strumenti umani (Dall'Olanda: Amsterdam)
Elio Pagliarani
La ragazza Carla ( lettura individuale a.s. 2017/2018)
Il Neorealismo (quadro d'insieme con particolare attenzione a Cesare Pavese)
La casa in collina di Cesare Pavese (lettura estate 2017)
i Cesare Pavese (lettura a.s. 2016/2017)
La luna e i falò d
L'Agnese va a morire di Renata Viganò (lettura a.s. 2017/2018)
●● Divina Commedia
Paradiso, canti I; III; VI; XI; XV, 97-135; XVI, 46-72; XVII, 46-142; XXXIII, 1-27,
115-145
●● Altre letture
Vittorio Alfieri, Mirra ( lettura a.s. 2017/2018)
Fëdor M. Dostoevskji, Il sosia (lettura a.s. 2016/2017)
Hermann Hesse, Narciso e Boccadoro (lettura a.s. 2016/2017)
orante, La storia (lettura estate 2017)
Elsa M
30Il Docente I Rappresentanti di classe
--------------------------------------------- --------------------------------------------
---------------------------------------------
Data
31PROGETTAZIONI DISCIPLINARI
DOCENTE Sarini Ilaria
MATERIA Lingua e cultura latina
DESTINATARI Classe 5^A Scienze Umane
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Conoscenze, abilità, competenze Raggiunto Motivazione dell’eventuale
si/no mancato raggiungimento
Conoscenze
● Individuare le coordinate storico-culturali del sì
periodo compreso tra la prima età imperiale e i
regni romano-barbarici
● Avere un quadro generale della storia della
sì
letteratura latina dall'età giulio-claudia al V
secolo d.C., con particolare attenzione a
Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano,
Giovenale, Tacito, Apuleio e alla letteratura
cristiana
● Avere una conoscenza diretta dei testi in
sì
latino o in traduzione degli autori studiati
● Conoscere il contenuto informativo dei testi
sì
in latino o in traduzione preparati
● Conoscere le opere della letteratura latina sì
con ampie letture in traduzione italiana
● Conoscere le principali strutture sì
morfosintattiche
● Conoscere il lessico specifico del genere parzialm.
letterario trattato
Abilità
sì
32● Leggere testi latini in modo scorrevole
● Individuare le strutture morfosintattiche note parzialm. Il lavoro sui testi latini (in ogni
caso esclusivamente quelli
e le figure retoriche caratterizzanti dei testi
svolti in classe), sia per quanto
latini preparati in classe o degli autori studiati riguarda l’individuazione delle
(in caso di testi analoghi a quelli preparati in strutture morfosintattiche sia
per quanto riguarda gli aspetti
classe)
stilistici, non è prerogativa di
● Tradurre testi latini preparati in classe o di parzialm. tutte le studentesse.
autori studiati (in caso di testi analoghi a quelli La traduzione è un’abilità che è
stata esercitata unicamente sui
preparati in classe)
testi preparati in classe.
● Analizzare e commentare testi latini scelti in sì
base a criteri tematici, linguistici e stilistici
● Contestualizzare e commentare testi latini
sì
con testo a fronte o in traduzione tra quelli
preparati in classe
● Collocare i testi all’interno della storia dei
sì
generi letterari trattati: prosa filosofica; epica
storica; satira; romanzo; trattatistica;
storiografia
● Esporre in modo chiaro gli argomenti di sì
studio
sì
● Utilizzare le tecniche argomentative
parzialm.
● Utilizzare il lessico tecnico e la terminologia
latina
Competenze
● Individuare le principali strutture parzialm.
morfosintattiche e retoriche all'interno di un
testo di autore noto
● Tradurre o avvalersi della traduzione di un
sì
testo per conoscere un'opera o un autore
● Analizzare e commentare un testo latino con
sì
testo a fronte o in traduzione tratto da un
autore noto
● Sviluppare una capacità critica e logica
parzialm.
nell’analisi dei testi
parzialm.
● Rielaborare argomenti sulla base di interessi
33personali
● Riconoscere la tipologia di un testo in base sì
alle caratteristiche peculiari del genere
letterario di appartenenza
sì
● Individuare le relazioni esistenti all’interno
della cultura latina stessa
● Individuare le relazioni che intercorrono tra sì
cultura latina e cultura moderna
● Individuare collegamenti intertestuali e sì
interdisciplinari
● Cogliere il carattere formativo di un testo sì
latino di autore noto
sì
● Riconoscere gli elementi di continuità e di
differenziazione tra passato e presente
● Ricercare le permanenze attraverso la sì
ricerca di temi, motivi e topoi parzialm.
Attualizzare l'antico
●
● Riconoscere le radici classiche nella cultura
parzialm.
di altre epoche o nella cultura contemporanea,
in ambito letterario, tecnico-scientifico o anche
nella comunicazione quotidiana
sì
● Padroneggiare le tecniche di scrittura dei
testi di tipo espositivo e argomentativo
● Utilizzare gli strumenti di comunicazione
sì
visiva e multimediale
METODI
Lezione frontale e dialogata; traduzione commentata dei passi d’autore scelti;
preparazione di mappe concettuali in digitale
VERIFICHE
Traduzione con note grammaticali o analisi del testo su passi d’autore preparati in classe
per lo scritto; interrogazioni (programmate nel secondo quadrimestre) o domande aperte
per l’orale
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI
Studio individuale
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
34G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti flos, Dall'età di Augusto ai regni romano-barbarici 2,
Paravia
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
●● Letteratura
Dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici
L’età giulio-claudia (14-96 d.C.)
Il contesto storico e culturale
Lineamenti dei generi poetici (Manilio, Germanico, Calpurnio Siculo)
Fedro
Fabulae I, prologus (Il prologo), I, 1 (Il lupo e l'agnello), IV, 3 (La volpe e l'uva); Appendix Perottina
15 (La vedova e il soldato)
Lineamenti dei generi in prosa (Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio Massimo,
Columella)
Seneca
De ira I, 1, 1-4 (L'ira), III, 1-3 (La lotta contro l'ira); De brevitate vitae (3, 3-4 Un esame di coscienza,
10, 2-5 Il valore del passato, 12, 1-7, 13, 1-3 La galleria degli occupati) ; De clementia (I, 1,1-4, 14,
2-3, 19, 2-3, pp. 776 ss.); De vita beata 16 (La felicità consiste nella virtù); De tranquillitate animi 2,
6-9 (Gli eterni insoddisfatti); De otio ( lettura integrale); Epistulae ad Lucilium 24, 19-21 (L'esperienza
quotidiana della morte)
Lucano
Bellum civile I, 1-32 (Il proemio), VI, 750-767, 776-820 (Una funesta profezia)
Persio
Satira III, 98-102 (La morte di un mangione); V, 14-18 (Spunti di poetica)
Petronio
Satyricon 32-3 (Trimalchione entra in scena), 37-38, 5 (La presentazione dei padroni di casa), 50.
3-7 (Trimalchione fa sfoggio di cultura), 71, 1-8, 11-12 (Il testamento di Trimalchione), 110, 6-112
(La matrona di Efeso)
35L’età dei Flavi (69-96 d.C.)
Il contesto storico e culturale
Lineamenti dei generi poetici (Silio Italico, Valerio Flacco, Cecilio Stazio)
Cenni alla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio
Marziale
Epigrammata I, 4 (Distinzione tra letteratura e vita), 10 (Gemello vuole sposare Maronilla); III, 26
(Tutto appartiene a Candido... tranne sua moglie!); V, 34 (Erotion); VIII, 79 (La “bella” Fabulla); X, 4
(Una poesia che “sa di uomo”), 8 (Matrimonio di interesse), 10 (Il console cliente), 43 (Il “campo” di
Filero); XI, 44 (Guàrdati dalle amicizie interessate); XII, 18 (La bellezza di Bilbili)
Quintiliano
Institutio oratoria I, 2, 4-8 (Anche a casa si corrompono i costumi), 2, 18-22 (Vantaggi
dell'insegnamento collettivo)
L’età degli imperatori per adozione (96-138 d.C.)
Il contesto storico e culturale
Lineamenti della poesia lirica (poetae novelli)
Cenni alla produzione biografica di Svetonio
Giovenale
Satira I , 79-80, 85-87 (L'indignatio per i vitia degli uomini); III, 190-222 (Roma «città crudele» con i
poveri)
Plinio il Giovane
1
Epistulae V 6, 4-20 (L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio); X, 96, 97 (Uno
scambio di pareri sulla questione dei cristiani)
Tacito
Agricola 3 (La prefazione); 30-31, 3 (Il discorso di Càlcago); Germania 4 (Purezza razziale e
aspetto fisico dei Germani), 11 (L'assemblea), 19 (La fedeltà coniugale); Historiae IV, 73-74 (Il
punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale); Annales I, 1 (Il proemio), IV, 34 (Libertà
36d'espressione e controllo politico, p. 795); XV, 38-39 (Nerone e l'incendio di Roma), 44, 2-5 (La
persecuzione dei cristiani), 62-64 (Il suicidio di Seneca, p. 718), XVI, 18-19 (Vita e morte di
Petronio, pp. 819 e 820)
L’età degli Antonini (96-192 d.C.)
Il contesto storico e culturale
Lineamenti dei generi letterari (Frontone e Aulo Gellio)
Apuleio
Metamorfosi III, 24-25 (Lucio diventa asino); IV, 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca); V,
22-23 (La trasgressione di Psiche); VI 20-21 (Psiche è salvata da Amore); XI, 1-2 (La preghiera a
Iside), 13-15 (Il ritorno alla fortuna umana e il significato delle vicende di Lucio)
La crisi dell'impero (III-V sec. d.C.)
Il contesto storico e culturale
Lineamenti di letteratura pagana (Ammiano Marcellino)
Lineamenti di letteratura cristiana (apologistica, Ambrogio, Gerolamo)
●● Autori
Seneca, De brevitate vitae 1, 1-4 (La vita è davvero breve?); Epistulae ad Lucilium 1
(Riappropriarsi del proprio tempo), 12, 1-5 (La visita di un podere suburbano), 47, 1-4 (Come
trattare gli schiavi)
Quintiliano, Institutio oratoria, proemium 9-12 (Retorica e filosofia nella formazione del perfetto
oratore); I, 3, 8-12 (L'importanza della ricreazione)
Tacito, Annales XIV, 8 (La tragedia di Agrippina)
Il Docente I Rappresentanti di classe
37--------------------------------------------- --------------------------------------------
---------------------------------------------
Data
PROGETTAZIONI DISCIPLINARI
DOCENTE Giallongo Elena
MATERIA Scienze Umane
DESTINATARI Classe 5^A Scienze Umane
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
OBIETTIVI Raggiunto Motivazione dell’eventuale
si/no mancato raggiungimento
CONOSCENZE si
ABILITA’
- saper individuare analogie e si
differenze fra il pensiero di autori
diversi ;
- partecipare ad una discussione; parzialmente una parte della classe rimane
sempre poco coinvolta
- enucleare le idee centrali di un si
testo
COMPETENZE
- possesso degli strumenti espressivi ed si
argomentativi indispensabili per gestire in
modo appropriato l'interazione;
comunicativa;
- saper leggere e comprendere semplici si
testi
- saper cogliere i tratti essenziali dei si
fenomeni culturali contemporanei;
- saper collegare autori e tematiche; si
- saper partecipare in modo guidato ad un parzialmente una parte della classe rimane
confronto dialogico nella pratica della sempre poco coinvolta
discussione razionale
38METODI
Lezione frontale, lezione dialogata, flipped-classroom
VERIFICHE
Un tema e una analisi di testo scientifico per gli scritti e una interrogazione orale per il
primo quadrimestre; un tema, la simulazione di seconda prova, una interrogazione orale
(anche in forma di dibattito o presentazione di approfondimento), un lavoro di gruppo, una
prova per competenze sul rapporto economia-politica, per il secondo quadrimestre.
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI
Recupero in itinere;
potenziamento nell’ambito della “Flessibilità”: la pubblicità dal punto di vista psicologico.
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
Libri di testo
Aime, L’uomo allo specchio, Loescher
Volontè, Lunghi, Magatti, Mora, Sociologia, Einaudi scuola
Giusti, Pedagogia, Marietti scuola
Sito https://unric.org/it/agenda-2030
Sito http://www.novecento.org/insegnare-leuropa-contemporanea/il-welfare-state-2873/
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
La diversità culturale
- sistemi di pensiero e forme espressive: religione, scienza, mito, magia ;
- potere e società: la diversità culturale rispetto all’organizzazione dell’economia e della
vita politica (teorie del conflitto e del mutamento);
- l’antropologia interpretativa di Geertz;
Spazio e tempo
- la percezione dello spazio e del tempo ;
-l’abbattimento delle barriere spazio-temporali tramite la Rete e i suoi effetti;
-la globalizzazione, le sue caratteristiche, la sua crisi;
Dalla modernità all’età contemporanea
-il concetto di secolarizzazione
-il welfare state:condizioni storiche del suo nascere, il suo sviluppo, crisi attuale;
-il terzo settore
- Il Positivismo: il contesto europeo, il rapporto tra educazione, psicologia e medicina, la
pedagogia speciale;
-Attivismo e Scuole nuove
-l’Attivismo americano: il pragmatismo di Dewey;
- appunti integrativi tratta da Etica protestante e spirito del capitalismo, di M.Weber;
- fotocopie tratte da Il mio credo pedagogico di Dewey;
- sito dell’Istat;
- sito di storia contemporanea italiana
Il Novecento e la società di massa
- il pensiero della Montessori;
39- gli effetti della decolonizzazione sullo studio della cultura;
- La globalizzazione nelle sue dimensioni economica,
politica e culturale e i suoi effetti dal punto di vista culturale;
- La società di massa e il consumismo
- Lettura tratta da La mente assorbente della Montessori;
- appunti integrativi su Bauman e sui teorici della Scuola di Francoforte, tratta dal capitolo
sulla Scuola di Francoforte trattato nel volume di filosofia, Abbagnano, Con-filosofare, vol.
3A
La comunicazione nella società attuale
- I mezzi di comunicazione di massa;
- La propaganda e i regimi totalitari;
- Media education (apocalittici vs integrati, la socializzazione a rovescio, uso critico della
Rete)
- lettura tratta dal testo di seconda prova del 2006 tratto da Cattiva maestra televisione di
K. Popper e da Apocalittici e integrati di U. Eco
- testo di P.C.Rivoltella su oralità e scrittura
Critica alla società attuale
- Critica alla società di massa: conflitto e mutamento sociale;
- critica alla globalizzazione: appunti integrativi su Bauman e sui teorici della Scuola di
Francoforte tratte dal capitolo sulla Scuola di Francoforte trattato nel volume di filosofia,
Abbagnano, Con-filosofare, vol. 3A
- Bruner
Tematiche pedagogiche attuali
-L’inclusività (soprattutto in riferimento al contesto italiano: BES, DSA, disagio,
disadattamento, handicap e disabilità);
- Documento dell’OMS del 1994 sul concetto di salute;
- riforma della scuola del 1977 (legge 104);
-L’intercultura (multicultura vs intercultura);
- Educazione permanente e degli adulti (contesti formali e non formali dell’educazione);
-Diritti umani (soprattutto in riferimento alle direttive europee e ai documenti internazionali)
- Lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti umani
-Lettura e commento degli articoli della Costituzione , dall’art.1 al 54
Il Docente I Rappresentanti di classe
--------------------------------------------- --------------------------------------------
---------------------------------------------
Data
40Puoi anche leggere