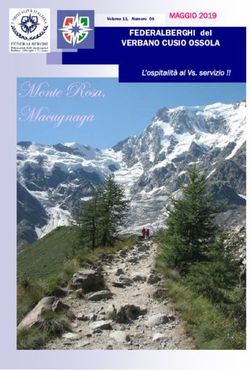La teologia tra devozione, dedizione e distrazione: Davide Zordan e il cinema - Davide Zordan Lecture 2018 - FBK-ISR
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Davide Zordan Lecture 2018 La teologia tra devozione, dedizione e distrazione: Davide Zordan e il cinema
Questo fascicolo contiene quattro riflessioni sul cinema di Davide Zordan, scelte e curate da Paolo Costa in occasione della terza edizione della Davide Zordan Lecture. L’evento, promosso e organizzato dal Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler, prevede quest’anno una lezione magistrale sul tema «Teologia e fioritura umana. Una riflessione sui modi di intendere la salvezza oggi» tenuta dal teologo inglese Clive Marsh. Trento, 17 dicembre 2018
Fondazione Bruno Kessler www.fbk.eu Progettazione e realizzazione Moira Osti FBK | Unità Supporto alla Ricerca | Polo delle Scienze Umane e Sociali In copertina Riccardo Schweizer, bozzetto dell’affresco di 75m2 realizzato per la sede FBK di Trento (particolare), 1986. Fly-56 | 12-2018_ISR ______________________________________________________________________________________ Copyright © 2018 by Fondazione Bruno Kessler, Trento. Tutti i diritti sono riservati
Sommario «Entrate: anche qui sono gli dèi», di Paolo Costa p. 5 Quello iato tra non morire e vivere, di Davide Zordan 9 La fede, l’abito e la maschera, di Davide Zordan 15 Prima del Verbo, l’immagine, di Davide Zordan 21 Il cinema, la fede e il visibile, di Davide Zordan 25 Profilo biografico di Davide Zordan 31
«Entrate: anche qui sono gli dèi» di Paolo Costa All’inizio del De partibus animalium (I. 5) Aristotele si serve di un aned- doto sulla vita di Eraclito per giustificare a monte l’investigazione approfondita che farà in quell’opera di un argomento apparentemente triviale: piante e animali, cioè enti caduchi che, a differenza dei corpi celesti, «partecipano della generazione e della corruzione». Non si deve […] nutrire un infantile disgusto verso lo studio dei viventi più umili: in tutte le realtà naturali v’è qualcosa di meraviglioso. E come Eraclito, a quanto si racconta, parlò a quegli stranieri che desideravano rendergli visita, ma che una volta arrivati, ristavano vedendo che si scaldava presso la stufa della cucina (li invitò ad entrare senza esitare: «anche qui, disse, vi sono dèi») – così occorre affrontare senza disgusto l’indagine su ognuno degli animali, giacché in tutti v’è qualcosa di naturale e di bello.1 La curiosità che Davide Zordan aveva per le forme anche più umili di devozione popolare, per esperienze di fede non convenzionali e, in un contesto secolare, per l’industria dell’intrattenimento (cinema, TV, fumetto, sport, ecc.) mi ha sempre ricordato questo celebre passo dell’opera aristotelica. Quella sua forma di apertura fiduciosa e non intellettualistica al mondo era sicuramente un tratto caratteriale: il segno esteriore di una personalità ben integrata, per nulla spaventata dalla contaminazione dell’«impuro». Per altro verso, però, era anche una mossa strategica nel suo itinerario intellettuale. Per formazione, Davide era consapevole del carattere controllato, «iper- mediato», del discorso teologico in ambito cattolico. Abbiamo a che fare qui con un sapere della fede che non ha nulla di spontaneo. I suoi vincoli interni sono la Scrittura, il Magistero, la comunità di fede con le sue varie incarnazioni storiche e, se vogliamo, anche la città «terrena», con le sue emergenze e le sue opportunità saldamente collocate nel tempo e nello spazio. Un giorno Davide mi ha riassunto questa sua visione realistica del rapporto tra la libertà intellettuale e le istituzioni utilizzando un’immagine cara al gesuita francese Michel de Certeau: bisogna fare i conti con la «legge del luogo» (loi du lieu)2.
6 Paolo Costa Un teologo, detto in parole semplici, non parla mai nel vuoto. Si de- termina, cioè, sempre in relazione a un’istituzione storica che limita la sua identità e al contempo definisce le condizioni per i suoi progressi accidentati. Ciò significa, evidentemente, venire a patti con una pres- sione costante all’adattamento, se non addirittura al conformismo. Ma è proprio a quel punto che la persona è chiamata a dimostrare il proprio valore. Questo valore, però, non ha nulla di cavalleresco. Non si manifesta cioè opponendo virilmente il petto alle frecce dei nemici. Il punto è trovare il giusto mix di prudenza, lentezza, tempestività, che consenta al numero più ampio possibile di ragioni di diffondersi nel mondo e di fecondarlo impercettibilmente, nell’attesa di una, per il momento imprevedibile, mietitura. La fede, tuttavia, è nel suo fondo anche nuda vita e, proprio come il fenomeno della vita, è sfuggente, sinuosa, imprevedibile. Se uno vuole afferrarne i contenuti ne deve cercare le manifestazioni e le tracce nei luoghi che le persone effettivamente frequentano nella loro epoca. Il teologo, per usare le categorie della psicologa Alison Gopnik, deve sicu- ramente avere una potente «coscienza-faro», ma non può prescindere dalla meno educata «coscienza-lanterna»3. Pur restando sempre vigile e accorto, deve cioè essere anche ricettivo, curioso e ingenuamente esplorativo. Non a caso oggi, quando ripenso all’intelligenza di Davide, prima ancora che i suoi scritti mi vengono in mente le conversazioni che facevamo, a voce o per email, sugli argomenti più disparati: l’ultima giornata del campionato di calcio, la differenza tra una canzone di Roberto Vecchioni e una di Eugenio Finardi, l’educazione dei figli, andare per funghi, la preghiera, i maestri del fumetto, la superstizione, l’anoressia. In effetti, quando nel 2013 ho tanto insistito perché scrivessimo un libro a quattro mani, quello che mi prefiggevo segretamente era tra- sferire sulla pagina scritta quell’atmosfera di pensosità spensierata che sperimentavo durante conversazioni informali che, per quanto mi riguarda, sarebbero potute durare in eterno. Ma, ovviamente, per come sono fatte le nostre disciplinatissime vite, quelle chiacchierate a ruota libera potevano esistere solo sotto forma di intermezzi della vita seria. Così anche nel nostro libro, il dialogo finale – che è la cosa più simile a quelle chiacchierate che siamo riusciti a produrre battendo i tasti del computer – fa un po’ la figura della glassa sopra la torta, anche se nelle nostre intenzioni il rapporto tra sostanza e accidente sarebbe dovuto essere esattamente l’opposto.4
«Entrate: anche qui sono gli dèi» 7 Nelle nostre conversazioni, infine, un posto speciale l’ha sempre avuto il cinema. Davide sapeva tutto di cinema – era un vero «cinofilo», come gli ha detto con un amabile solecismo un compagno di squadra nell’at- mosfera umida e scanzonata dello spogliatoio di una palestra trentina – ma, con la sua imperturbabile equanimità, accettava di parlarne anche con chi come me ne sapeva giusto quanto può saperne uno spettatore saltuario e disimpegnato. Che fosse l’ultimo film di Nanni Moretti o una vecchia pellicola dei fratelli Coen o magari un episodio della serie televisiva «Mad Men», era a Davide che mi rivolgevo puntualmente per chiarirmi le idee e, da quegli scambi, ne uscivo sempre con la testa zeppa di pensieri nuovi e brulicanti. Qualche volta, in queste occasioni, vincendo la sua proverbiale modestia, Davide mi spediva una recensione che aveva scritto per «Vita trentina» o «Munera» (giornali sui quali teneva una rubrica cinematografica) o, se voleva farmi un cadeau speciale, un articolo più impegnativo che aveva preparato per «Cabiria» o un paper presentato a qualche con- vegno in giro per il mondo. Io li leggevo sempre avidamente e non di rado li saccheggiavo per sciogliere un crampo mentale o nutrire la mia asfittica immaginazione teologica. Proprio per ricordare e onorare lo sforzo di Davide di entrare in dialogo con la contemporaneità, in occasione della terza edizione della Davide Zordan Lecture, il Centro per le Scienze Religiose di FBK ha deciso di raccogliere una selezione di recensioni scritte da Davide nell’ultimo periodo della sua vita. Riguardano film molto diversi per stile, contenuto e pubblico di riferimento, e tale varietà dovrebbe consentire al lettore di formarsi un’idea non troppo vaga di quale fosse il tipo di uso crea- tivo che egli riusciva a fare di oggetti culturali non meno effimeri delle creature al cui studio Aristotele ha dedicato tanto tempo ed energia. In sovrappiù, come è capitato spesso anche a me, il lettore paziente potrà ricavarne consigli utili per una serata piacevole o un regalo intelligente. La cosa che colpisce di più in questi scritti è il connubio tra densità di pensiero e chiarezza espositiva. In poche pagine il lettore si trova proiettato in un mondo in cui si viene sollecitati a confrontarsi con temi come l’evoluzione umana, il destino, il rapporto tra bellezza e santità morale, la religione in un’età secolare, senza però sentirsi intimiditi o, peggio ancora, catechizzati. L’impressione, piuttosto, è quella di venire gradualmente familiarizzati con una strana zona di chiaroscuro in cui il visibile e l’invisibile si mescolano. Come Davide ha osservato nel testo che chiude questo opuscolo, «l’incontro tra cinema e fede si realizza qui,
8 Paolo Costa nell’ambito del pienamente visibile, di ciò che è accessibile a tutti pur restando oscuro a chi – regista o semplice spettatore – non possiede una sensibilità adeguata e una attenzione davvero partecipativa». La fiducia di Davide nella distribuzione omogenea, e più diffusa di quanto in genere gli accademici si immaginino, di questa sensibilità tra i ranghi della società umana, era una delle principali fonti della sua creatività intellettuale e il motivo per cui si muoveva con così tanta disinvoltura nel complicato reticolo di luci e ombre che ci accoglie ogni mattino al risveglio.5 1 Cfr. Aristotele, Le parti degli animali, a cura di M. Vegetti, in Aristotele, Opere biologiche, a cura di D. Lanza e M. Vegetti, UTET, Torino 1971, p. 582. 2 Cfr. M. de Certeau, L’invenzione del quotidiano, trad. it., Edizioni Lavoro, Roma 2010. 3 Cfr. A. Gopnik, Il bambino filosofo. Come i bambini ci insegnano a dire la verità, amare e capire il senso della vita, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 2010, cap. 4. 4 Cfr. P. Costa - D. Zordan, In una stanza buia. Filosofia e teologia in dialogo, FBK Press, Trento 2014, cap. 4. 5 Si ringrazia la rivista «Munera», in particolare il suo Direttore Stefano Biancu, per avere gentilmente autorizzato la pubblicazione delle recensioni di Davide Zordan in questo opuscolo.
Quello iato tra non morire e vivere di Davide Zordan Titolo Croods (The Croods) Regia e sceneggiatura Chris Sanders e Kirk DeMicco Montaggio Darren T. Holmes Scenografia Christophe Lautrette Fotografia Yong Duk Jhun Art director Paul Duncan Produzione DreamWorks Animation, Stati Uniti 2013 Durata 98’ Alla base della scarsa considerazione che molte persone, una volta uscite dall’infanzia, nutrono nei confronti dei film d’animazione, c’è un dato tecnico ben preciso, anche se spesso non esplicitato come tale. Il fatto cioè che, nell’animazione, l’effetto del movimento è ottenuto non attraverso la macchina da presa, che «registra» tale movimento dal mondo reale, ma attraverso il proiettore. Non è tanto la natura «disegnata» dell’immagine a infastidire, quanto il fatto che ciò che è disegnato, realizzato con l’argilla, la plastilina o altro, non ha «vita» se non sullo schermo dove è proiettato, a differenza delle immagini foto- grafiche che certificano gesti e azioni esistenti prima che noi li vediamo riprodotti in sala. È per questo che siamo normalmente meno disposti a «credere» alle immagini di animazione, o, più esattamente, siamo più restii ad accordare loro quella sospensione di incredulità necessaria per accedere al piacere della fruizione cinematografica. C’è però un altro modo di vedere le cose. In fondo, un film ci coinvolge perché vogliamo lasciarci coinvolgere, quale che sia il suo grado di «realismo», e cioè più esattamente l’illusione di realtà che esso predi- spone. Si tratta pur sempre di non opporre resistenza a quella materia illusoria, di consentirle di catturarci e, anzi, di contribuire alla sua ve- rosimiglianza con la nostra capacità immaginativa. Se è così, allora, è proprio quando il cinema più si allontana dalla sua natura fotografica che sfida maggiormente la nostra immaginazione, che le richiede di es- sere più intensa, più collaborativa. Considerato in quest’ottica, il cinema Recensione pubblicata in «Munera. Rivista europea di cultura», 1, 2014, pp. 93-97.
10 Davide Zordan d’animazione non appare più come una tipologia di cinema anomala e quasi difettosa, insomma un cinema di facile fruizione destinato a un pubblico di eterni Peter Pan, ma al contrario come una delle forme di cinema meno disponibili a essere consumate senza vera collaborazio- ne. Non «roba per bambini» quindi, ma per persone che non lesinano sull’immaginazione, intesa come capacità di figurarsi spazi di novità possibili per sé e per il mondo. Non è forse un caso che, a partire dall’ultima decade del secolo scor- so, e poi in modo sempre più convinto negli anni più recenti, il cinema di animazione si sia imposto come uno dei settori più creativi e di successo dell’industria cinematografica, grazie alle straordinarie pos- sibilità offerte dalla tecnologia digitale, ma anche a una vera e propria rinascita dell’animazione tradizionale a cartoni animati. Di fronte a certi capolavori firmati Disney o Pixar, ad esempio, si ha l’impressione che proprio la grande libertà immaginativa del cinema d’animazione, e il fatto di non essere mai confinato entro un genere definito, consenta di esplorare temi e questioni che il cinema tradizionale mainstream difficilmente potrebbe affrontare senza banalizzare. Si pensi al modo in cui un film come Ratatouille (2007) allude, senza dar l’impressione di farlo, alle questioni così complesse che riguardano l’istinto e la libertà di autodeterminazione, o alla sensibilità inusuale con cui vengono trattati i temi abusati della vecchiaia e della nostalgia in Up (2009). I Croods, distribuito nelle sale da DreamWorks nel 2013, non è certo all’altezza dei due titoli appena citati, eppure, proprio perché non si tratta di un capolavoro, meritano attenzione la naturalezza e l’efficacia con cui il film ci conduce a riflettere su questioni estremamente intri- cate come quelle che riguardano la nostra vicenda evolutiva profonda. Pensandoci bene, quali mezzi potrebbe mettere in campo il cinema se non proprio quelli dell’animazione – e dunque della pura immaginazio- ne – per raccontare la storia lentissima e oscura dell’umanizzazione dell’animale homo sapiens? Una storia così incredibilmente lontana da noi. Eppure è la nostra, e dobbiamo imparare a raccontarcela. A un livello immediato, I Croods è un film sulla famiglia, che ambienta in una preistoria esotica e assolutamente fantasiosa dinamiche e conflitti generazionali tipici del moderno nucleo familiare, senza lesinare sugli stereotipi: lo scontro tra il padre autoritario e la figlia adolescente, una madre comprensiva e mediatrice, il figlio un po’ tonto (da che mondo è mondo, i maschi maturano tardi), la figlioletta minore pestifera e una suocera impertinente e mal sopportata. Ma ciò che caratterizza le grandi
Quello iato tra non morire e vivere 11 produzioni animate è la molteplicità dei livelli di lettura autorizzati, vera chiave per il successo di ogni prodotto di massa. Ecco allora che, a un secondo livello, la famiglia del film si trova confrontata a qualcosa di ben diverso dalla quotidianità piccolo borghese dei Flintstones, i protagonisti della celebre saga Hanna-Barbera. Il prologo del film, realizzato con uno stile che si ispira alle incisioni rupestri, delinea efficacemente il quadro in cui si svolge l’azione: quello di un’aspra lotta per la sopravvivenza che impegna ogni stilla di energia e quel poco di ingegno sviluppato dai nostri cavernicoli, confrontati a un mondo inospitale nel quale essi non sono, né si sentono, razza dominante. Certo la lotta per soprav- vivere e procacciarsi il cibo è descritta da subito con brio e vivacità, come un’esaltante partita di football con in palio l’uovo succulento di un bizzarro struzzo primordiale. Ma il tono scanzonato non nasconde la drammatica precarietà della vita dei Croods. Grug, il padre, ripete ossessivamente ai suoi pargoli la regola aurea di sopravvivenza: «Mai non avere paura!» Paura sempre, e di tutto, per provare a sopravvivere. È interessante come nel film non ci sia un cattivo contro cui combattere. Il «nemico» è, da un lato, il mondo minaccioso che circonda la casa-ca- verna dei Croods, anzi forse la vita stessa nella sua cecità selettiva; dall’altro, però, è anche dentro di noi, sebbene Grug fatichi non poco a realizzarlo: il nemico è la paura quando, da istinto prezioso che ci rende capaci di prevenire i pericoli per superarli, diventa un freno che blocca qualsiasi possibilità di cambiamento. Nel film il cambiamento è rappresentato da Guy, un giovane che, a differenza dei Croods, non si protegge standosene rintanato nel fondo di una caverna buia, ma utilizzando quelle prime rudimentali tecnologie (il fuoco, le calzature) che fanno di lui l’emblema di uno stadio più avanzato dell’evoluzione. Attraverso la conflittualità e poi l’alleanza tra Grug e Guy, tra prudenza paralizzante e apertura intrepida, il film ci aiuta a immaginare come certi elementi di novità possano essersi manifestati nel lungo corso del processo evolutivo e suggerisce, soprattutto, che un tale emergere del nuovo possa essere considerato come qualcosa di diverso da un puro determinismo biologico, come una vera «crisi», come qualcosa in cui la libertà – un certo grado di libertà – è in gioco ben prima che l’essere umano diventi capace di riconoscerla e identificarla come tale. Nel mettere in scena questo processo, che si distende nell’arco di milioni di anni, I Croods ovviamente semplifica, trascura e volgarizza senza scrupoli e senza la minima velleità pedagogica e tuttavia riesce a richiamare numerosi elementi distintivi di quella che, con troppa faci- lità (come osservava il compianto Robert Bellah nel suo ultimo grande
12 Davide Zordan libro, Religion in Human Evolution), chiamiamo la nostra «preistoria» e che dovremmo, invece, cominciare a considerare come la parte più du- revole e decisiva della nostra storia, indispensabile per capire chi siamo davvero. Pensiamo solo all’atteggiamento «animista» manifestato dai protagonisti del film alle prese con la scoperta del fuoco, o al raccon- tarsi storie come modalità decisiva per accedere all’espressione della propria identità e del proprio orizzonte «morale» implicito, o ancora al passaggio tra il dormire abbracciati come utile rimedio contro il freddo alle prime manifestazioni «immotivate» di affetto. Pensiamo soprattutto a ciò che precede e permette tutto questo, e cioè il dischiudersi di un tempo e uno spazio disponibili per qualcosa che non sia mera lotta per la sopravvivenza, presentito con urgenza nel film da Eep, la figlia maggiore, quando prende le distanze dal padre esclamando: «Questo non è vivere, è non morire!». Si noti il paradosso: come in ogni film d’animazione, l’espediente dell’u- manizzazione di ciò che è diverso da noi per rendercelo familiare (l’esem- pio classico è quello degli animali parlanti) è qui largamente utilizzato e non potrebbe essere altrimenti. Ma ciò che viene «umanizzato» ne I Croods è precisamente quello stadio del processo evolutivo profondo della nostra razza attraverso il quale i nostri antenati ominidi avanzano «in cerca» di una umanizzazione a venire. E dunque all’umanizzazione traslata e ironica tipica del genere si sovrappongono certi elementi che vanno chiaramente in senso contrario, per denotare lo stato di esistenza pre-umana dei Croods in cui è la pura istintualità animale a determinare i comportamenti, come quando la nonna, in preda ai mor- si della fame, azzanna alla caviglia il paffuto nipote Tonco. Anche la realizzazione grafica dei personaggi si muove chiaramente in questa direzione, mostrandoci i Croods come veri selvaggi nelle fattezze e nei modi, dotati di forza bruta e grande rapidità, ed evitando di far loro replicare una gestualità umana «acculturata», riconoscibile invece nel personaggio di Guy. L’operazione è complessa, al di là del tentativo del film di rendere ugualmente comici sia gli elementi di umanizzazione precoce sia quelli contrari, di fronte ai quali anche al pubblico più giovane viene il sospetto che l’allegra banda dei Croods non sia proprio così uguale a noi. Senza dubbio i due processi – l’umanizzazione allegorica dell’omi- nide e l’«animalizzazione» come segno distintivo di un diverso pur così simile a noi – sono giustapposti in modo non del tutto riuscito, ma è significativa la scelta degli autori del film di procedere consapevolmente
Quello iato tra non morire e vivere 13 in questa direzione, operando una commistione di elementi antitetici potenzialmente rischiosa per la fruibilità della narrazione. Forse anche per questo la trama del film è molto semplice e perfino banale, priva com’è di peripezie e sviluppi inaspettati. La ricerca di un luogo sicuro in cui vivere di fronte alla minaccia di imminenti sconvolgimenti natu- rali è il tema ricorrente dell’animazione di ambientazione preistorica, da Alla ricerca della valle incantata (1988) a Dinosauri (2000) fino alla fortunata saga de L’era glaciale, e la ripresentazione del medesimo topos fa nascere il sospetto che non sia a livello dell’originalità della trama che gli autori de I Croods abbiano voluto investire le loro risorse creative. Scompare qui, peraltro, anche il ricorso continuo alla citazione e alla parodia, che ha fatto la fortuna della DreamWorks con la saga di Shrek, ma che ha esaurito da tempo il suo vigore. L’estrema linearità e fruibilità della vicenda e la rimozione di espedienti ormai fini a se stessi come il citazionismo a oltranza lasciano spazio, da un lato, a sketch godibili di pura azione che esaltano le possibilità del cinema 3D; mentre, dall’altro, evitano di distogliere il pubblico dal compito primario di identificare lo strano statuto dei suoi protagonisti, quei Croods che avanzano in equilibrio precario tra animalità e umanizzazione, tra non morire e vivere, consapevoli però che, come afferma proprio il recal- citrante Grug: «una cosa è certa, non possiamo più tornare indietro».
La fede, l’abito e la maschera di Davide Zordan Titolo Ida Regia Pawel Pawlikowski Sceneggiatura Pawel Pawlikowski e Rebecca Lenkiewicz Fotografia Ryszard Lenczewski e Lukasz Zal Scenografia Jagna Dobesz Interpreti principali Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela, Adam Szyszkowski Produzione Opus Film in collaborazione con Phoenix Film Investments, Canal+ Polska, Phoenix Film Poland, Polonia-Danimarca-Francia-UK 2013 Durata 82’ Pawel Pawlikowski è un regista polacco di nascita, ma paneuropeo per vocazione. Ha vissuto a Torino e Wuppertal prima di stabilirsi a Londra e di completare la sua formazione a Oxford, dove ha studiato letteratura tedesca e filosofia. Relativamente poco noto in Italia, Pawlikowski ha avuto una carriera apprezzabile dapprima, negli anni Novanta, come documentarista della televisione inglese, poi come sceneggiatore e autore di film di finzione ambiziosi anche quando non del tutto riusciti – si pensi per esempio a La femme du Vème (2011), di produzione franco-britannica e non distribuito in Italia. Giunge ora anche nelle nostre sale il suo film più recente, Ida, che ha mietuto premi nel circuito internazionale dei festival e ricevuto ampi apprezzamenti dalla critica. Ida è un film che usa poche parole e ne suscita molte, eppure il parlarne, o scriverne, lascia un po’ a disagio. Raccontare il film, come pur bisogna fare, rischia di essere soprattutto in questo caso fuorviante. Perché sul- lo schermo a «parlare» sono le immagini, nella splendida e curatissima fotografia in bianco e nero che ricorda un maestro quale Béla Tarr; sono l’economia estrema della narrazione e la staticità del quadro cinema- tografico; sono i personaggi laconici ma intensi. Tutti elementi che è difficile esplicitare a parole senza farne una mera questione tecnica o formale. Eppure qui la forma e il contenuto, o la narrazione, non sono davvero disgiungibili. Sono proprio le reticenze narrative e i silenzi a ren- dere attenti alle «cuciture» del film, al modo in cui prende in contropiede Recensione pubblicata in «Munera. Rivista europea di cultura», 1, 2014, pp. 93-97.
16 Davide Zordan pubblico e critica scegliendo di presentarsi come tipicamente «polacco» (lento, grave, quasi del tutto privo di ironia), ma poi sorprende per la sua incisività e modernità. Primo film girato da Pawlikowski nella natìa Polonia, Ida è ambientato nei primi anni Sessanta del secolo scorso, al tempo dell’infanzia del regista e durante un regime per certi versi unico tra i Paesi del blocco comunista sovietico: un regime opprimente eppure già slabbrato, tra le cui crepe affiorano non solo i segni inequivocabili di una radicata tradizione cattolica, ma anche una singolare tolleranza nei confronti dei costumi culturali d’oltrecortina. Il film rievoca una pagina oscura e feroce di storia, ma non si presta a tirare bilanci netti. Non si affretta a suggerirci da che parte stare, ma ci invita a cogliere i dettagli, le sfumature. In un’intervista a proposito del film, Pawlikowski cita Cechov come fonte di ispirazione. Come il drammaturgo russo, egli vuole trattenersi dal giudicare: «Essere morale nel raccontare la mia storia, ma senza proporre una morale». La sequenza di apertura di Ida è in questo senso paradigmatica, nel suo soffermarsi sui gesti silenziosi e ripetuti di un gruppo di monache, come se quella routine celasse il segreto della loro fede. Proprio quello della fede emerge come uno dei temi centrali, anche se non sbandierati, del film, su cui si soffermerà la mia analisi. Ma andiamo con ordine. Protagonista della vicenda è Anna, un’orfana ac- colta in tenera età in un monastero di religiose la quale, giunta ai diciotto anni, decide di prendere i voti. A pochi giorni dalla solenne professione, la superiora del monastero invita Anna a recarsi in visita da una zia, la sola parente che le resta. L’obbedienza all’ingiunzione della superiora vince l’esitazione della giovane, desiderosa solo di abbracciare la clausura e legarsi in modo definitivo a quella che è sempre stata la sua casa. Ida lascia dunque il monastero per alcuni giorni, che però cambieranno per sempre la sua vita. Se la storia fin qui vi suona familiare, non avete torto. Così iniziava infatti Viridiana (1961) di Louis Buñuel, realizzato nella me- desima epoca in cui è ambientato Ida. Il film di Pawlikowski ne ripropone non solo l’esatto incipit narrativo, ma anche alcuni sviluppi drammatici fondamentali. Eppure, come si vedrà, è un’opera diversissima per lo stile, il tono e l’intenzione che la guida. L’incontro con zia Wanda, magistrato un tempo ammirato e temuto, ma oramai assegnato a mansioni secondarie a causa della sua promiscuità sessuale e della dipendenza dall’alcol, mette brutalmente Anna di fronte alla verità mai conosciuta del suo passato: il suo vero nome è Ida Lebenstein, è ebrea ed è con la zia la sola superstite della sua famiglia, sterminata
La fede, l’abito e la maschera 17 durante il nazismo. Ma se Anna/Ida ha vissuto fino a quel giorno senza sapere chi fosse, accettando semplicemente la sua condizione di orfana senza radici ma con un rifugio sicuro, è in realtà un intero popolo, quello polacco, che vive nell’oblio di una pagina terribile della propria storia, cioè precisamente del trattamento riservato agli ebrei durate l’occupazione tedesca e la guerra. È noto che prima del 1939 la maggioranza degli ebrei europei viveva in Polonia e che in territorio polacco persero la vita più della metà di tutte le vittime dell’Olocausto. Meno noto è il fatto che, oltre a coloro che perirono nei campi di concentramento, molti ebrei polacchi furono vittime di pogrom cui alcuni concittadini presero parte attiva e che molti altri finsero di non vedere; come pure che l’antisemitismo nella cattolica Polonia si perpetuò oltre la fine della guerra e, alimentato dal nuovo regime sovietico, si rivolse non di rado contro i sopravvissuti di ritorno alle loro terre, nel frattempo espropriate. Wanda e Ida sono messe a confronto con tutto ciò nel corso del viaggio in auto che le riporta al villaggio d’origine, alla ricerca di indizi riguardanti l’uccisione dei loro cari, e poi da qui sulle tracce della persona che le aveva protette durante il conflitto. Le due donne non potrebbero essere più distanti l’una dall’altra, come Wanda non manca di sottolineare con i suoi modi spicci («io sono una puttana e tu una santa!»), eppure tra loro si crea un legame singolare. Ciascuna è per l’altra non solo l’occasione non cercata per fare i conti con il passato – lacerante e rimosso per la zia, oscuro e impensabile per la nipote – ma anche per confrontarsi con le proprie responsabilità e scelte. Wanda, che da vittima si era presto trasformata in oppressore, assumendo nel dopoguerra un ruolo decisivo nei processi farsa contro i nemici del popolo fino a meritarsi il sopran- nome di «Wanda la sanguinaria», nasconde dietro il cinismo graffiante e la ricerca di piaceri passeggeri un acuto senso di colpa, che la vicinanza della giovane novizia rende lancinante. Ida, che ha consegnato la sua esi- stenza alla struttura accogliente e rigorosa del monastero ricevendone in cambio una fede intensa e assertiva, si trova improvvisamente esposta al caos di un mondo segnato da un male diffuso e insensato, che mette alla prova il suo credo. Per tutta la durata del viaggio Ida continua a recitare le sue preghiere, ma non può evitare di domandarsi chi sia colei che in quel modo si affida a un Dio che non è quello dei suoi padri. Entrambi i personaggi femminili, interpretati in modo intenso e convin- cente, hanno agganci con persone e fatti reali. Il passato di Wanda evoca alcune efferate protagoniste delle purghe staliniane, quali i colonnelli Julia Brystiger e Helena Wolińska, responsabili dell’arresto ed eliminazione di
18 Davide Zordan molti resistenti antinazisti e antibolscevichi in Polonia. Wolińska, moglie di un professore universitario di Oxford, fu anche personalmente cono- sciuta da Pawlikowski, che avrebbe voluto fare un documentario su di lei. La vicenda di Ida ricorda quella di Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, il quale scoprì le proprie origini ebraiche solo in età adulta, dopo la sua ordinazione come sacerdote cattolico, avviando allora un processo di riavvicinamento all’ebraismo che lo ha spinto a lasciare il servizio pasto- rale per provare a realizzare in Israele una singolare convivenza tra le due fedi cui sente di appartenere. Al suo itinerario di difficile ibridazione tra ebraismo e cristianesimo cattolico la regista israeliana Ronit Kerstner, ella pure venuta a conoscenza in età adulta delle sue origini ebraiche, ha dedicato un intenso documentario intitolato Torn (2011). Per Anna/ Ida, come per Romuald/Jakub e molti altri ebrei perseguitati, la salvezza è venuta dall’essere stati rivestiti di una nuova identità, la cattolica, che ha nascosto a tutti, anche a loro stessi, la radice innominabile da cui provenivano. Alla fine del viaggio le due protagoniste del film provano a tornare ciascuna alla propria vita, ma per entrambe sarà impossibile. Anna/Ida, rientrata al monastero, nel silenzio sembra volgersi ancora confidente verso una statua lignea di Gesù. Rinuncia però a emettere la professione religiosa e partecipa, con emozione mista a un sottile distacco, alla cerimonia nel corso della quale una consorella, che con lei aveva condiviso l’intero percorso vocazionale, si consacra a Dio. Wanda torna a vedere le sue angosce riflesse sul fondo del bicchiere e a condividere le notti con uo- mini che non possono strapparla alla sua solitudine. Per lei soprattutto, il viaggio verso il passato è stato senza ritorno. I fantasmi dissotterrati non taceranno più. In una scena la cui costruzione ricorda l’incipit ful- minante di Così bella, così dolce (1969) di Robert Bresson, la donna si suicida gettandosi dalla finestra di casa. Così ora anche per Ida il rivolgimento è radicale. Quando la giovane si ritro- va nell’appartamento vuoto della defunta zia sente di doversi appropriare di tutto ciò verso cui aveva rivolto fino ad allora uno sguardo non tanto di condanna quanto di estraneità. Ciò che le è sempre stato alieno – il fumo, l’alcol, la musica, infine il sesso – diventa l’unica via per provare non a comprendere ma almeno a misurare ciò che è accaduto, la sofferenza in cui Wanda era sprofondata senza aver più alcuna preghiera da poter recitare, e dunque l’unico legame ormai possibile con la sua famiglia, la sua identità negata, la sua storia mai saputa. Dismesso l’abito religioso, Ida indossa gli indumenti femminili ed eleganti di Wanda. È per lei una
La fede, l’abito e la maschera 19 sorta di nuova vestizione, cui il film assegna la medesima forza rituale. A differenza di Viridiana, che si mette il vestito da sposa della defunta zia come un travestimento momentaneo per rafforzare l’immagine che nutre di se stessa, Ida va in cerca, rivestendosi con l’abito dell’altra, di un’iden- tità che sa di non possedere. Quello di Buñuel è un cinema di maschere indossate per il gusto di strapparle, di travestimenti che mettono a nudo e svelano contraddizioni e ipocrisie. Nel film di Pawlikowski, al contrario, non c’è alcun gesto disvelante e giubilatorio, ma il tentativo faticoso di raccogliere i pezzi sconnessi di un soggetto frammentato e dolorosa- mente incerto. La notte d’amore di Ida con il giovane saxofonista, che porta a compimento il suo percorso di «uscita» dal rifugio monastico e di assunzione cosciente del mondo e della propria corporeità, non è segnata da alcun senso di ribellione, né è il raggiungimento di una «verità» finora ignorata. È un nuovo e prezioso passo su un cammino accidentato, che consente a Ida di accrescere la propria consapevolezza e di mettersi in condizioni di scegliere. Il ragazzo la invita a seguirla. Lei sorride dolente e lo lascia partire. Nell’ultima scena del film vediamo Ida camminare da sola lungo una strada di campagna, in direzione contraria ai radi veicoli in transito. Veste di nuovo l’abito da suora. È forse sulla via del ritorno verso il monastero; in ogni caso l’abito attesta che ella intravvede un modo per integrare la sua fede cristiana e la sua vocazione con ciò che ha scoperto di sé e del mondo che la circonda. Quest’ultima scena segna, dal punto di vista formale, uno stacco netto rispetto al resto del film. Fin qui, come già accennato, la macchina da presa è sempre stata fissa o si è concessa solo piccoli movimenti su cavalletto. In forte contrasto con la struttura da road movie del film, questa modalità di ripresa – accentuata dal clas- sico formato 4/3 scelto dal regista – comunicava il senso di una realtà bloccata, appesantita dalle zavorre di un passato oscuro e incombente. Ora invece la ripresa che precede Ida sul viottolo dissestato, effettuata con camera a spalla, è nervosa e traballante. Essa consente al pubblico di entrare in sintonia con il nuovo atteggiamento della protagonista, che ha la strada davanti a sé (noi però non vediamo dove sia diretta, a diffe- renza di quanto accade nella classica inquadratura di chiusura in cui il protagonista si allontana verso la linea dell’orizzonte seguito a distanza dal nostro sguardo) e avanza tranquilla, se pur controcorrente e soppor- tando le asperità del percorso. Non è Ida ad essersi strappata una maschera (ha invece rivestito nuova- mente l’abito religioso), è il punto di vista narrante ad aver abbandonato
20 Davide Zordan una fissità precostituita, esteticamente appagante ma non in grado di trasmettere il disordine del mondo e della storia, che ora Ida ha accettato di portare con sé. È di conseguenza il nostro stesso sguardo che si ritrova liberato. In molte delle scene precedenti, peraltro, la fissità dell’inquadratura funzionava come un’occlusione alla vista: le protagoniste della vicenda, ma soprattutto Ida, per l’intera durata del film sfuggono ai bordi del qua- dro, se non oltre i suoi margini. In alcuni casi, specie in alcune scene di dialogo, il suo capo appare innaturalmente «tagliato» e la ripresa inquadra il vuoto sopra di esso, a suggerire forse la mancata adesione di Ida alla sfera della corporeità, o la sua tendenza a estraniarsi dalla storia e dai suoi drammi. Solo nel finale il nostro sguardo è libero di posarsi su di lei per così dire nella sua interezza e nel suo incedere in uno spazio aperto. Già la scena delle suore che trasportano la statua del Cristo all’inizio del film esprime simbolicamente l’idea di una religiosità non statica, che si muove e muta con coloro che se ne fanno carico. Se nell’incipit de La dolce vita (1960) di Fellini la statua di Gesù trasportata in elicottero nei cieli di Roma annunciava la fuoriuscita della religione e della fede dalla città degli umani, qui la fede è, da un lato, già marginale, confinata nello spazio chiuso e periferico del monastero, e, dall’altro, disponibile per nuovi inveramenti, a misura della libertà e del rischio degli individui che, come Ida, sono disposti ad assumerne l’orizzonte di senso nonostante l’incertezza in cui vivono. L’impianto narrativo di Buñuel viene in definitiva riutilizzato da Pawlikowski per rovesciarne l’assunto. Solo apparentemente, si può ad esempio notare, Wanda svolge nel film il medesimo ruolo di don Jaime, lo zio di Viridiana che si toglie la vita quando questa decide di ritornare al convento e che, con il suo gesto, impone alla nipote di tornare sui suoi passi. Ida, a differenza di Viridiana, non ha bisogno di emanciparsi da una fede opprimente. E non deve nemmeno «trovare» se stessa, ma piuttosto accettare e custodire i frammenti di ciò che è e di ciò che l’ha condotta fin lì. Non è la sua fede a impedirle di farlo, né essa è sufficiente per riuscire nell’impresa. La fede è qui solo uno degli elementi in gioco, nei confronti del quale il regista mantiene uno sguardo distaccato, che sospende il giudizio per guadagna- re una prospettiva più adeguata, integralmente umana. Né salvifica né ipocrita, la fede di Ida chiede di essere colta per quello che è: un vestito, un habitus con il quale attraversare l’esistenza senza per questo sentirsi al riparo dai suoi colpi. Sapendo che forgiare da essa, e solo da essa, la propria identità, rischierebbe di trasformarla in una maschera.
Prima del Verbo, l’immagine di Davide Zordan Titolo Su Re Regia Giovanni Columbu Sceneggiatura Giovanni e Michele Columbu Fotografia Massimo Foletti, Uliano Lucas, Francisco Della Chiesa e Leone Orfeo Scenografia Sandro Asara Interpreti principali Fiorenzo Mattu, Pietrina Menneas, Tonino Murgia, Paolo Pillonca, Antonio Forma, Luca Todde Produzione Sacher Film, Italia 2012 Durata 80’ Negli studi di cinema di area anglosassone la distinzione tra Jesus film e Christ figure si può oramai ritenere convenzionalmente accolta. Con tali categorie si intende, nel primo caso, la rappresentazione attraverso la finzione cinematografica della vicenda di Gesù, desunta dai vangeli o da altre fonti; mentre nel secondo, una tipologia di personaggi del cinema che, per vari motivi, rimandano esplicitamente alla figura di Gesù, ripercorrendo un cammino per certi versi analogo al suo. Con la prima espressione si indica dunque un genere, o sottogenere, ben attestato nella storia del cinema fin dalle sue origini, mentre con la seconda ci si riferisce a ciò che, in base a un rimando analogico più o meno esplicito, caratterizza certi personaggi di finzione e i film che li mettono in scena. Si tratta dunque di categorie ben distinte, anche se non prive di rimandi, nel vasto intreccio intertestuale del prodotto cinematografico. Una volta assunta tale utile categorizzazione, non si può non riconoscere che il contributo del cinema italiano al genere del Jesus film sia stato decisivo, a partire da un film pionieristico e ambizioso come Christus del 1916, passando per i capolavori di Pasolini e di Rossellini, fino al Gesù di Zeffirelli, che è riuscito a imporre nella cultura popolare una sorta di immagine «canonica» di Gesù. Il cinema di casa nostra sembra però anche convinto che non ci si debba fermare ai fasti del passato e che, in altri termini, sia ancora possibile fare film su Gesù senza riproporre un’immagine già vista e una storia già raccontata, ma anzi allestendo un cinema vitale e capace di interrogare Recensione pubblicata in «Munera. Rivista europea di cultura», 3, 2013, pp. 75-79..
22 Davide Zordan l’umanità del nostro tempo. Prova ne sono opere significative quali Io sono con te (2010) di Guido Chiesa, che si concentra sui vangeli dell’in- fanzia provando in qualche modo a riattualizzarne l’impianto midrashico, e soprattutto Su Re di Giovanni Columbu, incentrato sugli eventi della Passione e distribuito nelle sale a fine marzo di quest’anno grazie al so- stegno convinto della Sacher Film di Nanni Moretti. Ciò che più colpisce in Su Re è proprio la problematizzazione radicale della categoria di Jesus film e di quella complementare di Christ figure, che segna uno scarto vigoroso all’interno di un genere apparentemente così ben consolidato del cinema religioso. Girato nel nuorese, tra le rocce aspre e lunari che attorniano Monte Corrasi, Su Re (in italiano «Il Re») si avvale di attori non professionisti che recitano nella loro lingua sarda e vestono i costumi della tradizione locale. Una scelta in linea con strategie ben collaudate dell’arte cristiana, che fanno rivivere gli eventi della vita di Gesù nella cornice di un presente storico di volta in volta riadattato. Tuttavia il film non si accontenta di ripetere, adeguandoli, i modelli della tradizione iconografica, ma introduce scelte di rottura molto ardite. La vicenda si apre nel sepolcro dove il corpo senza vita di Gesù giace tra le braccia di Maria e fa rivivere, attraverso una serie di flashback apparentemente sconnessi, alcuni momenti della vita e, soprattutto, della passione di Gesù stesso. Le riprese sono state effettuate esclusivamente con camera a spalla, il cui sommovimento costante, percepibile anche nei campi lunghi, non consente in alcun momento una visione rilassata ed «estatica». Chi cerchi la bella immagine in grado di rendersi ospitale nei confronti del sentimento religioso suscitato dai fatti narrati è destinato a rimanere deluso. Non è per questa via, come si vedrà, che il film vuole condurci incontro al personaggio di Gesù. Un cartello iniziale individua nei quattro vangeli canonici la fonte del film, evidenziando così un rimando al tempo stesso palese, ma comunque non sufficiente a definire le coordinate ideali dell’opera. Affermare che Su Re è «tratto» dai vangeli è materialmente corretto. Il fatto è però che l’ambizione del film è quella di porsi in qualche modo a monte della scrittura dei vangeli, pur esplicitamente evocata, a monte della tradizio- ne orale che tale scrittura ha originato, fino al momento in cui l’evento stesso della morte di Gesù avvia, nella mente e nel cuore dei suoi primi e prime seguaci, il lavorio della memoria. Una memoria inizialmente
Prima del Verbo, l’immagine 23 fatta di frammenti, di pezzi di frasi, di promesse ancora informi, o solo parzialmente comprensibili. Una memoria ricomposta faticosamente attraverso il riaffiorare di suoni, gesti, perfino quasi di odori; attraverso squarci improvvisi, brandelli di sogni o speranze (apparentemente) deluse. Quale immagine è possibile ricomporre da una simile accozzaglia di elementi spuri, non ancora filtrati da una comprensione teologica, non ancora regolati dai meccanismi della narrazione, non ancora strutturati in un abbozzo di dogma, dunque alla fine non ancora credibili? Un’immagine priva di forma, e perciò, anzitutto, di bellezza. Con intuizione finemente teologica, Columbu ha il coraggio di rompere in maniera netta con la tradizione iconografica consegnataci da venti secoli di arte cristiana, dal buon (e bel) Pastore delle catacombe al Gesù imberbe e delicato dei preraffaelliti, fino alla lunga serie dei Gesù cinematografici la cui presenza attoriale attira magneticamente l’attenzione dello spettatore. L’irrinunciabile bellezza di questi ritratti, sembra suggerire Columbu, è in realtà un riflesso. Più che rappresentarci Gesù, essa identifica l’ideale di perfezione umana che noi da sempre proiettiamo in lui. Abbiamo certo buone ragioni per farlo, giacché quello stesso ideale si nutre della fede che egli ha suscitato in noi. Ma è possibile immaginare un ritratto di Gesù che prescinda da tale fede? Che ne delinei la figura spogliandola, per così dire, della sua bellezza teologica, mostrandoci in lui l’uomo che soffre attorniato dal disprezzo della sua gente, la sua regalità irrisa, le sue esigue parole confuse nella cacofonia di una umanità vociante e turbata? Mostrandoci, insomma, l’immagine «prima» del Verbo? Certa- mente ciò è possibile, ma soprattutto di fronte a tale ritratto informe, sapremo ancora riconoscere il Cristo della fede? Questa è, mi pare, la sfida che pone Su Re, una sfida anzitutto estetica, ma anche teologica, nella misura in cui provoca la fede, o l’assenza di fede, dello spettatore trascinandola in un territorio inospitale e invitandola a ritrovare in questo luogo le proprie ragioni. Columbu giustifica la sua scelta di un Gesù tozzo e sgraziato sulla base del riferimento alla pericope del Deutero Isaia che apre il film, pronunciata da una voce fuori campo (forse quella di Giuseppe d’Arimatea, o forse quella anonima che suggerisce un primo abbozzo di interpretazione teologica): «Non aveva aspetto né bellezza da incantare. Non aveva niente. Sembrava castigato da Dio». Sul piano meramente esegetico l’interpretazione appare forzata, ma si rivela efficacissima sul piano ci- nematografico, per il modo in cui invita il pubblico a prendere posizione.
24 Davide Zordan Il fatto di lasciarsi interrogare da quell’assenza di grazia e di eleganza che non attrae lo sguardo, di non consentirle di tenerci a distanza da Gesù e dalle sue sofferenze, e dunque di mettere in questione l’ideale di una bellezza armoniosa e scontata, che già ricompone in anticipo i tratti sfigurati del Volto santo, rende possibile, nel buio della sala cinemato- grafica, il dispiegarsi di un vero itinerario spirituale. Peraltro a Fiorenzo Mattu, l’attore che interpreta Gesù, era stato inizialmente assegnato il ruolo di Giuda, che ha invece nel film dei tratti insolitamente aggraziati e gentili. Un rovesciamento paradossale che non pare privo di legami con la tradizione cinematografica – la quale volentieri ha costruito i personaggi di Gesù e di Giuda sulla base di un immediato contrasto, sul piano visivo, simbolico e narrativo – ma che qui ancora una volta viene riscritta da capo a fondo, e suscita nuovi interrogativi. La «bellezza» di Giuda è solo lo specchio che restituisce accentuata la «bruttezza» di Gesù, o non è forse anche un richiamo al tema affascinante di Giuda in quanto «strumento» della grazia divina? Ma se il film si propone come un itinerario spirituale è anche per il modo in cui ricusa qualunque elemento formale e narrativo che si presti a essere «consumato» senza vera partecipazione. In questo senso Su Re è una sfida continua agli standard della fruizione cinematografica. Il modo, ad esempio, in cui le diverse sequenze in flashback si susseguono suscita uno stato di disagio, perché nessun elemento convenzionale aiuta a cogliere i passaggi dall’una all’altra di esse. Manca l’accompagnamento musicale, presente solo nel finale, così come i tipici riferimenti formali che solitamente aiutano a capire quando una singola unità narrativa si apre o si chiude: i passaggi sono bruschi, inaspettati, non dettano un ritmo alla vicenda e lasciano perciò lo spettatore in balia di un flusso di immagini che appare disarticolato, non ancora composto secondo un ordine intelligibile. Manca la chiave, l’impalcatura teologica che consente a tutti i singoli pezzetti di essere collocati al loro posto esatto, e che è andata in frantumi per l’opera di appassionata decostruzione operata dalla regia. Nessuno allora può sostituire lo spettatore nel lavoro necessario a ridare un senso a questa sofferenza, a questa morte, per consentirle di rinviare alle parole che nel finale giungono, inaspettate, dal buio sepolcro: «Dopo tanto dolore, Lui torna a splendere, e con Lui il mondo».
Il cinema, la fede e il visibile di Davide Zordan Quando si parla delle potenzialità religiose del cinema, dei modi in cui il mezzo cinematografico riesce a onorare la dimensione spirituale offrendone una rappresentazione, una delle formule più ricorrenti è quella del «vedere» o «filmare l’invisibile». L’espressione, che risuona spesso in occasione dei convegni e si ritrova in varie pubblicazioni sul tema, sottolinea la capacità di rivelare che il cinema possiede, dando visibilità a qualcosa che in condizioni normali si sottrae alla nostra vista. È interessante notare che questo potere di rivelazione del cinema fu notato e celebrato fin dagli esordi della settima arte, ma non tanto in relazione al dato religioso. Molto semplicemente si notava come il cinema permettesse di «vedere l’invisibile» in maniera analoga ad altri dispositivi ottici capaci di estendere le capacità dell’occhio umano, come il cannocchiale o il microscopio. È chiaro che se l’invisibile si fa visibile, in questo contesto, non è per una accresciuta capacità di inda- gare le zone più misteriose e profonde dell’esperienza, ad esempio la dimensione spirituale, ma per un mero fatto tecnico – anche se questo poté apparire come un prodigio agli spettatori dei primi film proiettati. Riflettere invece a partire da cinema e fede […] significa porre l’accento, mi pare, non tanto sulle virtualità rivelative del cinema, ma sulla fede come esperienza umana che non può non documentarsi visivamente. In questo senso non è l’invisibile a mostrarsi improvvisamente, ma piuttosto il visibile ad ospitare i percorsi e i gesti della fede di tanti uomini e donne, e questi gesti interessano il cinema come tutto ciò che è radicato nell’esperienza umana. «Con le mie opere ti mostrerò la mia fede», afferma un celebre passaggio della Lettera di Giacomo (2,18), ed è precisamente così che la fede si mostra nello spazio della visibilità: attraverso opere, condotte, testimonianze, atti, voti, suppli- che. Il cinema dell’invisibile, intendendo con questo il cinema che ha una ambizione spirituale, è chiamato anzitutto a misurarsi con queste pratiche del visibile, ed è chiamato a restituirle in maniera adeguata, Testo letto al convegno internazionale «Film and Faith», Pontificia Università Lateranense, Roma, 1-2 dicembre 2011.
26 Davide Zordan cioè rispettando il contesto umano e fenomenico del loro prodursi, senza enfasi inopportune. L’incontro tra cinema e fede si realizza qui, nell’ambito del pienamente visibile, di ciò che è accessibile a tutti pur restando oscuro a chi – regista o semplice spettatore – non possiede una sensibilità adeguata e una attenzione davvero partecipativa. La rassegna cinematografica di cui mi occupo da alcuni anni, il Religion Today Film Festival che ha base a Trento, si muove esattamente lungo questa direttiva. Si tratta di una iniziativa nata nel 1997 dalla volontà di valorizzare il cinema come mezzo di conoscenza reciproca tra le religioni, in una società alle prese con un analfabetismo religioso crescente e con tensioni sociali e politiche alimentate, più o meno strumentalmente, da motivi religiosi. Uno degli aspetti più caratterizzanti del festival è la creazione di spazi di confronto e convivenza, durante i pochi giorni della rassegna, tra registi e professionisti di cinema accomunati da un interesse per il religioso e per il modo in cui ciò che ha a che fare con la fede/le fedi può essere espresso in pellicola. Ogni anno il Religion Today Film Festival offre una rassegna di film di diverse tipologie (fiction, documentari, cortometraggi) che aiutano a farsi un’idea della varietà e della complessità dell’universo religioso e delle sue dinamiche. E proprio complessità e dinamismo mi sembrano, anche alla luce di quello che raccontano i film presentati al Religion Today, due elementi che oggi caratterizzano particolarmente l’esperienza religiosa vissuta a tutte le latitudini. Le religioni veicolano tradizioni culturali antiche e venerabili ma in continuo mutamento, anche se tale mutamento può apparire impercettibile. Non solo le forme e le strutture sono soggette al cambiamento, ma anche i modi dell’adesione personale di ciascuno. Ora il cinema, arte del tempo, è particolarmente adatto a cogliere il cambiamento che trapela nel persistere delle credenze. Nel breve tempo a mia disposizione vorrei presentare in modo piuttosto sommario tre film selezionati per la rassegna di Religion Today tra il 2008 e il 2009, per esemplificare quanto detto finora. Ho scelto voluta- mente film che non solo riguardano religioni diverse (islam, ebraismo, cristianesimo) ma che utilizzano linguaggi diversi e appartengono a tipologie differenti (un classico film di finzione, un documentario e un film che si può definire di ricerca, anche dal punto di vista linguistico ed espressivo), proprio per sottolineare la varietà delle prospettive possibili. I film hanno però, mi pare, almeno un punto in comune, ed è il tentativo di problematizzare il discorso attorno alla fede, in modo rispettoso e direi empatico.
Puoi anche leggere