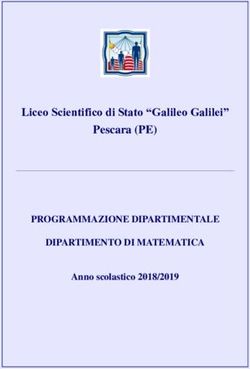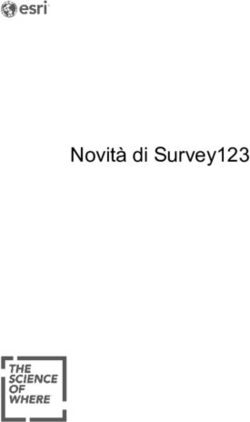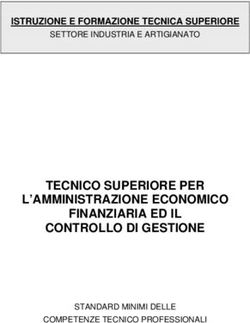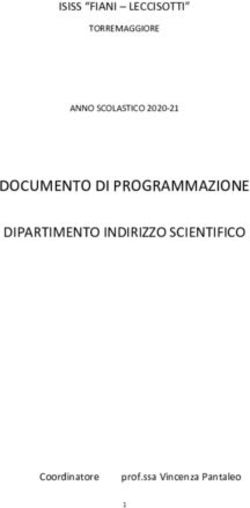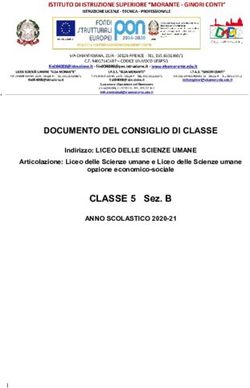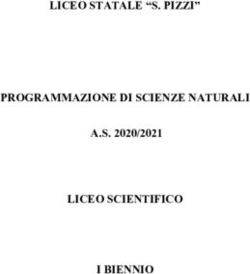PROGRAMMAZIONE DI FISICA - PRIMOBIENNIO - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO DIPARTIMENTO DI FISICA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PROGRAMMAZIONE DI FISICA PRIMOBIENNIO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO DIPARTIMENTO DI FISICA LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA di Ciampino
1. Obiettivi generali 2. Obiettivi specifici primo biennio, secondo biennio e nel quinto anno 3. Moduli e tempi 4. Indicazioni metodologiche 5. La valutazione 6. Il recupero 7. Contenuti essenziali, competenze ed abilità 8. Allegato 1: Certificazione delle competenze al termine del primo biennio 9. Allegato 2: Proposte di griglie di valutazione 10. Allegato 3: A e e e ie e dida iche e a bi fi ic -matematico 1. OBIETTIVI GENERALI L di de a fi ica c ib i ce a a f a i e de a e a i de a ie e c i i ce a ba e e a costruzione di un fi c ae i a e e L i eg a e de a fi ica i c e a i ec ea e discipline, si propone i seguenti obiettivi generali: • la comprensione dei procedimenti caratteristici de i dagi e scientifica e lo sviluppo della capacità diutilizzarli; • lo sviluppo, in particolare, della capacità di analizzare e schematizzare situazioni problematiche reali,di trarre conseguenze dagli schemi costruiti e di esplorare problemi concreti anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare; • abi di e al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprieipotesi interpretative; • ac i i i e di un linguaggio corretto; • ac i i i e di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; • la maturazione della capacità di comprendere e valutare l'intreccio tra le scelte compiute in campo scientifico e i problemi tecnologici, economici e culturali della società contemporanea. 1
2. OBIETTIVI SPECIFICI L'insegnamento della Fisica mira al raggiungimento degli obiettivi generali guidando gli allievi verso lo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze elencate di seguito. CLASSI PRIME Competenze Abilità Conoscenze Leggere, Va a e e e di e a a cia a a i a i e Grandezze fisiche, misura comprendere e Calcolare e e relativo di una misura. Calcolare il ed errori, rappresentazione interpretare un testo valore c e i de e e c i de e da di dati e fenomeni, relazioni scritto delle varie associare ad una grandezza in presenza di misure ripetute tra grandezze fisiche: tipologie previste (media e scarto quadratico medio oppure valore centrale anche in contesti non La misurazione della e semi- dispersione). Calcolare la propagazione noti. ghe a de a ea de de e e e a somma, la differenza, il prodotto e il volume, della massa, del rapporto tra due grandezze fisiche. Usare la notazione tempo, della densità. scientifica. Rappresentare una tabella riguardante due Osservare, descrivere Il Sistema Internazionale. grandezze correlate mediante un grafico cartesiano. ed analizzare L i ce e a di a i a Riportare le incertezze sperimentali sul grafico fenomeni Tabelle, formule e grafici per cartesiano. Stabilire se tra due grandezze correlate esiste appartenenti alla rappresentare una legge una proporzionalità diretta, una relazione lineare, una realtà e riconoscere fisica. relazione di proporzionalità quadratica. Stabilire se tra nelle varie forme i Le grandezze direttamente due grandezze correlate esiste una relazione di concetti di sistema e proporzionali. Altre relazioni proporzionalità inversa. Rappresentare su un piano di complessità. matematiche tra grandezze cartesiano la proporzionalità lineare e quadratica tra due fisiche: la correlazione grandezze correlate. Calcolare la pendenza di una retta in lineare, quadratica ed inversa. un grafico cartesiano. Effettuarele operazioni grafiche di Analizzare dati e La notazione scientifica. interpolazione ed estrapolazione. Effettuare le operazioni interpretarli di interpolazione ed estrapolazione mediante il calcolo sviluppando algebrico. deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con a ii di rappresentazioni Distinguere grandezze e vettoriali. Operare graficamente grafiche, usando gli con i vettori. Scomporre graficamente un vettore rispetto Vettori e forze: strumenti di calcolo. a una coppia di direzioni assegnate. Operare con le I vettori. componenti cartesiane utilizzando anche le definizioni Gli spostamenti e le g i e iche Uii a e e e ie a operazioni sugli spostamenti. Individuare le comportamento elastico di una molla per stabilire la La forza elastica e il strategie appropriate proporzionalità diretta tra i e i della forza elastica e dinamometro. La forza peso, per la risoluzione di la corrispondente deformazione della molla. Distinguere la forza elastica e la forza di semplici problemi. tra i e i presentata dalla forza di attrito statico e la attrito radente. Le operazioni Essere consapevoli forza di primo distacco. Individuare la forza premente da sulle forze. delle potenzialità e dei cui dipende la forza di attrito statico. Distinguere la massa L e i ib i di gge limiti delle tecnologie e il peso di unoggetto. Individuare le forze (forza-peso, puntiforme. nel contesto culturale forza di attrito statico, forza di reazione vincolare, forza L e i ib i di gge e sociale in cui elastica, tensione delle corde) agenti su un oggetto puntiforme su un piano vengono applicate. puntiforme, specificandone la direzione, il verso e inclinato. i e i Determinare la risultante delle forze agenti su un oggetto puntiforme edia e a ica i e g afica della regola del parallelogrammo e/o mediante la scomposizione grafica delle forze agenti lungo direzioni opportune. Scomporre graficamente la forza-peso agente su un oggetto appoggiato su un piano inclinato lungo la direzione parallela e quella perpendicolare al piano stesso. Risolverealgebricamente problemi di equilibrio sul piano inclinato mediante la similitudine dei triangoli e/o delle funzioniseno e coseno. Risolvere problemi relativi
a e i ib i de punto materiale riconoscendo le interazioni fra i corpi coinvolti. Equilibrio dei solidi: Calcolare il momento di una forza e saperne descrivere qualitativamente gli effetti. Classificare le leve e saperne Equilibrio del punto discutere e i ib i Risolvere problemi relativi materiale. all'equilibrio meccanico per sistemi rigidi semplici. Il momento di una forza Individuare il baricentro in sistemi meccanici semplici. rispetto a un asse. L'equilibrio Calcolare la coppia di forze agente su un corpo. Discutere nelle rotazioni. semplici casi legati alla stabilità de e i ib i dei corpi. Le coppie di forze. Le leve ed il baricentro Ottica geometrica: Descrivere alcuni fenomeni legati alla propagazione della ce Di eg a e i agi e di a ge e i a e Le leggi della riflessione. Gli de e i a e e di e i i a ica d e eggi de ica specchi. Le leggi della geometrica. if a i e de a ce L a g limite e la riflessione totale. La differenza fra lenti convergenti e lenti divergenti. 3
CLASSI SECONDE Competenze Abilità Conoscenze Leggere, comprendere e Applicare la definizione di pressione come forza Equilibrio dei fluidi: interpretare un testo distribuita su una superficie. Discutere gli effetti della La pressione. Il principio di scritto delle varie pressione di un liquido anche in relazione ad esperienze Pascal. La legge di Stevino. I tipologie previste anche concrete. Applicare e saper discutere la legge di Stevino. vasi comunicanti. La pressione in contesti non noti. Comprendere il ruolo della pressione atmosferica, il atmosferica e l'esperienza di modo in cui può essere misurata e applicarla Torricelli. La spinta di al e i ib i dei liquidi. Calcolare la spinta idrostatica Archimede e il galleggiamento per un corpo completamente immerso in un fluido. Osservare, descrivere dei corpi. Risolvere problemi sul galleggiamento di un corpo. ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà ericonoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di Saper discutere le leggi della dilatazione termica e Temperatura, calore e complessità. applicarle alla risoluzione dei problemi. Saper cambiamenti di stato: descrivere il funzionamento di un termometro e Dilatazione lineare, operare con le scale Celsius e Kelvin. Riconoscere superficiale, cubica dei solidi. situazioni di equilibrio e non equilibrio termico in Termometrie scale di Analizzare dati e relazione a scambi di calore. Applicare le leggi della temperatura. interpretarli calorimetria Q = c m ΔT. Risolvere problemi Definizione e misura del sviluppando deduzionie e i ib i termico. Discutere le modalità di calore. Trasmissione del ragionamenti sugli trasmissione del calore e applicare la legge della calore. Equilibrio termico e stessi anche con conduzione. Descrivere le leggi fisiche per i capacità termica. Calore a ii di cambiamenti di stato e applicarle per risolvere specifico. I cambiamenti di rappresentazioni problemi. stato e il calore latente. grafiche, usando gli strumenti di calcolo. Riconoscere e/o saper definire un sistema di riferimento. Definire e saper discutere i concetti di Cinematica Individuare le strategie velocità media e istantanea e utilizzarli per operare nei unidimensionale: appropriate per la problemi. Saper costruire un grafico posizione-tempo. Lo studio del moto e la risoluzione di semplici Calcolare e interpretare la pendenza del grafico velocità. problemi. posizione-tempo. Definire ilmoto rettilineo uniforme e Il moto rettilineo uniforme. risolvere problemi usando la sua legge oraria. Definire e L acce e a i e e i saper discutere i concetti di accelerazione media e rettilineo uniformemente Essere consapevolidelle istantanea e utilizzarli per operare nei problemi. Saper accelerato. Grafici tempo- potenzialità e dei limiti costruire un grafico velocità-tempo e riconoscere la spazio e tempo-velocità. delle tecnologie nel relazione fra area e spazio percorso. Interpretare i La caduta libera. contesto culturale e grafici posizione-tempo e velocità- tempo nel moto sociale in cui vengono rettilineo uniformemente accelerato per ricavarne dati applicate. e informazioni. Saper discutere le equazioni orarie del moto rettilineo uniformemente accelerato e applicarle per risolvere problemi. Conoscere acce e a i e di gravità e risolvere problemi elementari sul moto di caduta libera con velocità iniziale o verticale Riconoscere sistemi di riferimento inerziali e non. Principi della dinamica: Enunciare e discutere i principi della dinamica. Dedurre il moto di un corpo quando la forzarisultante applicata Il primo principio e i sistemi di è nulla o non nulla. Saper determinare le forze agenti in riferimento inerziali. Il semplici casi di moto rettilineo uniformemente secondo principio. Corpo in accelerato e calcolare l'accelerazione e le altre caduta libera. Il terzo caratteristiche.Discutere e risolvere problemi legati alla principio. Applicazioni dei caduta libera e al moto sul piano inclinato, anche in principi della dinamica: moto presenza di attrito. Riconoscere le forze di interazione orizzontale in presenza di 4
fra più corpi e risolvere semplici problemi relativi a attrito, moto lungo il piano sistemi di corpi interagenti. inclinato con e senza attrito. LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE La sezione di Liceo Scientifico Internazionale opzione lingua inglese svolgerà anche i seguenti moduli nel corso del biennio seguendo il syllabus ufficiale per la preparazione all'esame Cambridge IGCSE Physics (0625) scaricabile su cambridgeinternational.com PRIMO ANNO General Physics: Length and time, Motion, Mass and weight, Density, Forces, Momentum, Energy, work and power, Pressure SECONDO ANNO Thermal Physics: Simple kinetic molecular model of matter, Thermal properties and temperature, Thermal processes. Properties of waves, including light and sound: General wave properties, Light, Electromagnetic spectrum, Sound. AL TERMINE DEL BIENNIO GLI STUDENTI DOVRANNO, INOLTRE, ESSERE IN GRADO: • di utilizzare il righello graduato, il cronometro, il cilindro graduato, il dinamometro, il termometro; • di scrivere il risultato di una misurazione nella forma ∆ unità di misura; • di riportare i risultati di un esperimento in una tabella e nel grafico corrispondente; • di disegnare lo schema de a a a sperimentale utilizzato in e e ie a • di compilare una relazione di laboratorio e e ie a svolta; • di elaborare i risultati di un esperimento mediante il foglio elettronico (*); • di utilizzare correttamente le unità di misura delle grandezze studiate; • di impostare e portare a termine lo svolgimento strutturato di un esercizio con il corretto utilizzo delle unità di misura. Le capacità e le competenze maturate dagli studenti nel corso del biennio vengono valutate nella ce ifica i e de e c e e e e a ec a e a e a ic e e e cie ific i ba e a che a i a e Allegato 2. 5
CLASSI TERZE Competenze Abilità Conoscenze Analizzare fenomeni Enunciare e discutere il principio di relatività. Saper Dinamica e composizione fisici sia dal punto di risolvere semplici problemi sulla composizione di moti dei movimenti. vista qualitativo che uniformi. Il principio di relatività quantitativo. Riconoscere i riferimenti non inerziali e risolvere galileiana. Sistemi di Formulare ipotesi problemi tenendo conto della forza apparente. Analizzare riferimento non inerziali e utilizzando modelli e e risolvere il moto dei proiettili con velocità iniziali forze apparenti. Cinematica e leggi. diverse utilizzando metodi algebrici e grafici. Discutere e dinamica dei moti piani: moto Interpretare le leggi calcolare la gittata di un proiettile. Individuare le parabolico, circolare fisiche. Saper grandezze caratteristiche del moto circolare uniforme e uniforme e armonico. Il confrontare leggi risolvere problemi in ambito cinematico. pendolo semplice. individuando analogie I a e e a i e de a di a ica e c i e differenze. moto circolare uniforme riconoscendo le forze agenti e individuando la forza centripeta. Definire il moto armonico e le sue caratteristiche in relazione al moto Risolvere problemi circolare uniforme. utilizzando le formule Discutere algebricamente e graficamente le leggi orarie e saperli risolvere del moto armonico ed applicarle nei problemi. Impostare anche analizzando un e a i e de a di a ica e c i grafico. armonico riconoscendo le forze agenti e individuando la forza di richiamo. Risolvere problemi con corpi soggetti a forze elastiche. Discutere la dinamica del pendolo Contestualizzare semplice e utilizzarla per risolvere problemi. storicamente le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche. Enunciare e discutere le definizioni di impulso e quantità Principi di conservazione: di O e a e c i e e a de i e i e e problemi. Enunciare il principio di conservazione della Impulso e quantità di moto. La Usare in modo quantità di moto per un sistema di corpi isolato conservazione della quantità corretto il linguaggio mettendolo in relazione ai principi della dinamica. di moto. Il lavoro meccanico. specifico. Applicare la conservazione della quantità di moto per L'energia cinetica e il teorema Verificare la coerenza risolvere problemi. Definire e calcolare il lavoro delle forze vive. Le forze deirisultati. ecca ic e e e gia ci e ica Enunciare e saper conservative e l'energia Utilizzare il calcolo applicare e discutere il teorema delle forze vive. Definire potenziale. La legge di dimensionale. e riconoscere le forze conservative. Saper calcolare conservazione dell'energia l'energia potenziale del peso e l'energia potenziale meccanica. Gli urti di corpi elastica di un corpo. Distinguere le forze non conservative puntiformi. e discutere in particolare il ruolo de a i Di c e e e Applicare le saper applicare la legge di conservazione dell'energia conoscenze fisiche meccanica in problemi relativi al moto di uno o più corpi nell'ambito di sotto l'azione della forza peso e della forza elastica, con o problemi reali, anche senza attrito. in campi al di fuori Applicare le leggi di conservazione per risolvere problemi dello stretto contesto elementari relativi agli urti di due corpi puntiformi. disciplinare. Comprendere e Inquadrare storicamente modello geocentrico ed Gravitazione universale: valutare le scelte eliocentrico. Enunciare e saper applicare le leggi di Dal modello geocentrico al scientifiche e Keplero. Discutere il contributo di Newton ed esporre le modello copernicano. Le leggi tecnologiche che relazioni fra leggi di Keplero e legge di gravitazione di Keplero. La legge della 6
interessano la società. universale. Risolvere problemi riguardo la dinamica del gravitazione universale. moto di pianeti e satelliti usando la forza gravitazionale e L'energia potenziale il moto circolare uniforme. Definire e saper interpretare gravitazionale e la legge di e e gia e ia e g a i a i a e e applicare le leggi di conservazione dell'energia conservazione ai moti celesti. meccanica. Operare con le leggi della dilatazione termica, scale di Termodinamica: temperatura, conduzione del calore, calore specifico e Ripasso degli argomenti calore latente. Saper definire il numero di moli e il numero affrontati al II anno. Le leggi di Avogadro ed operare con essi. Discutere e a i e di dei gas e l'equazione di stato stato dei gas perfetti e applicarla alla risoluzione di dei gas perfetti. La teoria problemi. cinetica del gas perfetto. Le Rappresentare le principali trasformazioni trasformazioni termodinamiche nel piano P-V e risolvere problemi termodinamiche (isocora, utilizzando sia le proprietà algebriche che grafiche. isobara, isoterma, adiabatica). Enunciare le ipotesi del modello cinetico dei gas e saper Il lavoro termodinamico. Il ricavare ed interpretare la relazione fra energia cinetica e primo principio della temperatura. Saper calcolare la velocità quadratica media termodinamica. Il secondo della molecola di un gas perfetto o la temperatura o il peso principio della molecolare di un gas perfetto all'equilibrio termico note termodinamica. Entropia e le altre due grandezze. Saper connettere il punto di vista interpretazione statistica del macroscopico e quello microscopico nell'interpretazione secondo principio della dei fenomeni termodinamici studiati. Definire il lavoro termodinamica. termodinamico di un gas. Discutere e e i e di Joule e riconoscere le relazioni tra energia, temperatura e calore anche in termini cinetici. Enunciare e saper applicare il primo principio della termodinamica. Saper calcolare il lavoro e il calore scambiati lungo le trasformazioni termodinamiche studiate e risolvere semplici problemi relativi alle trasformazioni termodinamiche anche cicliche. Enunciare e saper discutere gli enunciati del secondo principio della termodinamica comprendendone e i ae a Distinguere trasformazioni reversibili e irreversibili. Saper descrivere e risolvere problemi sul ciclo di Carnot. Dedurre il teorema di Carnot e discuterne le conseguenze sulle macchine reali. Definire la variazione di entropia e calcolarla in semplici trasformazioni termodinamiche. Enunciare e discutere il principio di aumento de e ia anche in relazione a i e e a i e cinetica e molecolare. LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE La sezione di liceo scientifico internazionale opzione lingua inglese svolgerà anche i seguenti moduli nel corso del terzo anno seguendo il syllabus ufficiale per la preparazione all'esame Cambridge IGCSE Physics (0625) scaricabile su cambridgeinternational.com 7
TERZO ANNO Electricity and magnetism Simple phenomena of magnetism, Electrical quantities, Electric circuits, Digital electronics (Extended candidates only), Dangers of electricity, Electromagnetic effects. Atomic physics The nuclear atom, Radioactivity. 8
CLASSI QUARTE Competenze Abilità Conoscenze Analizzare fenomeni Saper descrivere la propagazione delle onde meccaniche Onde meccaniche e suono: fisici sia dal punto di distinguendone le caratteristiche. Definire e saper Propagazione delle onde vista qualitativo che operare con i parametri più comuni: periodo, frequenza, meccaniche su una corda. quantitativo. ghe a d da a ie a C ce e e e i e Oscillazioni e onde: parametri algebrica per onde sinusoidali e saperle rappresentare sul caratteristici ed equazione di piano cartesiano. propagazione. Il principio di Enunciare e discutere il principio di sovrapposizione delle sovrapposizione. Formulare ipotesi de i e a i e a i e fe e a c i a e di i a Fenomeni d i e fe e a e utilizzando modelli e Saper calcolare la distanza tra le frange di una figura di diffrazione. Onde sonore e loro leggi. Interpretare le interferenza noti gli altri parametri implicati. Discutere le caratteristiche. Le onde leggi fisiche. caratteristiche delle onde sonore anche in relazione alle stazionarie Intensità e livello Saper confrontare leggi proprietà sensoriali. sonoro. Effetto Doppler. individuando analogie e Risolvere problemi connessi alla velocità del suono nei differenze. a i a e ia i e a ec Di c e e i be i ea i ia e onde stazionarie e alle frequenze proprie di vibrazione e c de e c e d a ia Defi i e i e i ra e la relazione con la distanza dalla sorgente e risolvere Risolvere problemi problemi in questo ambito. Saper operare con il livello utilizzando le formule e sonoro espresso in dB. Saper risolvere semplici problemi saperli risolvere anche effe D e analizzando un grafico. O e a ec e eggi de ica geometrica per risolvere Ottica ondulatoria: Ripasso Contestualizzare problemi sulla riflessione, la rifrazione, riflessione totale sull'Ottica geometrica (in storicamente le e a g i i e Me e e i e a i e e eggi de ica particolare le leggi della principali scoperte geometrica con le proprietà ondulatorie della luce. riflessione e della rifrazione scientifiche e Discutere le caratteristiche delle onde luminose in della luce, angolo limite e invenzioni tecniche. relazione anche alle proprietà sensoriali: frequenza e riflessione totale). e c e De c i e e e e i e di Y g e Onde luminose e colori. c e de e i a a ica L'interferenza e la diffrazione Usare in modo corretto A ica e e eggi de i e fe e a e e e e i luminosa e la natura il linguaggio specifico. ea i e i a a e i de a a a e de a ce ondulatoria della luce. Verificare la coerenza e e e i e di Young. Saper calcolare la distanza tra deirisultati. le frange di una figura di interferenza o diffrazione noti gli Utilizzare il calcolo altri parametri coinvolti. dimensionale. Applicare le conoscenze Descrivere i metodi di elettrizzazione dei corpi e Campo elettrico: fisiche nell'ambito di distinguere materiali conduttori e isolanti. Saper L'elettrizzazione dei corpi e problemi reali, anche in discutere sugli esperimenti e la legge di Coulomb l'interazione elettrica. campi al di fuori dello c g ie d a a gia c a f a di La legge di Coulomb. stretto contesto g a i Sa e i e e b e i ega i a i e a i e di Il campo elettrico. disciplinare. particelle cariche nel vuoto o in presenza di un dielettrico. L'energia potenziale elettrica. Definire il campo elettrico e le linee di campo Il potenziale elettrico. discutendone il significato. Saper calcolare e Il teorema di Gauss. rappresentare il campo elettrico generato da una L'elettrostatica dei conduttori. Comprendere e sorgente puntiforme o da due sorgenti puntiformi. Il condensatore piano. valutare le scelte Definire il flusso del campo elettrico e discutere il scientifiche e teorema di Gauss. Saper utilizzare il teorema di Gauss e le tecnologiche che opportune considerazioni di simmetria per dedurre il interessano la società. campo elettrico prodotto da una distribuzione di carica sferica, rettilinea o piana. Operare con il campo elettrico per le distribuzioni continue e in particolare per un condensatore piano carico. Defi i e e e gia tenziale 9
elettrica e il potenziale. Operare utilizzando il principio di c e a i e de e e gia e i a i a bi elettrostatico. Definire le superfici equipotenziali e spiegare la loro relazione con le linee di campo. Applicare il concetto di potenziale per risolvere problemi relativi a cariche puntiformi o distribuzioni piane o sferiche. Discutere le proprietà dei conduttori carichi in relazione alla distribuzione delle cariche, al campo elettrico e al potenziale e qualche applicazione tecnologica. Saper definire e calcolare la capacità di un c de a e ia e e ca a e i iche de e e e circuitale. Saper prevedere il comportamento di una particella elettrizzata noto il campo o il potenziale elettrico in cui è immersa. Risolvere problemi per cariche in moto in un campo uniforme. Saper definire e operare con il lavoro di carica di un condensatore piano. Saper risolvere circuiti con condensatori in regime statico utilizzando anche la capacità equivalente per collegamenti in serie e parallelo. Saper definire e discutere le definizioni e le convenzioni Corrente elettrica continua: relative ai circuiti elettrici. Distinguere i principali Gli elementi del circuito componenti dei circuiti in continua. Definire e operare elettrico. con la corrente elettrica. L'intensità di corrente Discutere e saper applicare le leggi di Ohm. Saper ricavare elettrica. la resistenza elettrica di un elemento circuitale da una Le leggi di Ohm. tabella (V, I) ottenuta in un esperimento. Saper risolvere L'effetto Joule. circuiti in corrente continua utilizzando la resistenza equivalente per collegamenti in serie e parallelo. La carica e la scarica di un Discutere e saper operare con le leggi che descrivono condensatore. effe J e Di c e e e a e e a ec e ea i i che descrivono il comportamento di un circuito RC in continua. Discutere la fenomenologia del magnetismo naturale e Magnetismo: terrestre e operare con le linee di campo. Descrivere gli I magneti e le linee del campo esperimenti cruciali sulle interazioni fra magneti e magnetico. L'interazione tra correnti. Applicare la forza fra fili paralleli percorsi da un filo percorso da corrente corrente per risolvere problemi. elettrica e un magnete. Defi i e e e a e c i e i de ca ag e ic L'interazione tra due fili Applicare le definizioni di flusso e circuitazione al campo percorsi da corrente elettrica. magnetico per ricavarne i teoremi di Gauss e Ampere. Il campo di induzione Saper calcolare il campo di induzione magnetica generato magnetica. Flusso e da un filo rettilineo indefinito e da una bobina. Saper circuitazione del campo calcolare la forza magnetica agente su un filo rettilineo magnetico. La forza di Lorentz. percorso da corrente elettrica e immerso in un campo di induzione magnetica uniforme, e saper gestire problemi inversi. Descrivere il funzionamento di importanti strumenti come il motore elettrico e gli strumenti a bobina mobile. Definire e saper calcolare la forza di Lorentz agente su una particella elettrica immersa in un campo di induzione magnetica uniforme. Risolvere problemi relativi al moto di una particella carica in un campo magnetico. Saper risolvere problemi sulle forze agenti sui conduttori in moto in un campo di induzione magnetica uniforme. 10
CLASSI QUINTE Competenze Abilità Conoscenze Integrare la realtàfisica Sa e de c i e e g i e e i e i i d i e Induzione elettromagnetica: con i modelli costruiti elettromagnetica. Sa e ic ce e e e ae La legge di Faraday- per la sua i e e de i d i e elettromagnetica in un Neumann. interpretazione. fenomeno o in una disposizione sperimentale. Saper L'alternatore. Il trasformatore. calcolare la fem generata dalla variazione di flusso di Il circuito LC. Il circuito RLC. campo magnetico in casi elementari e saper gestire problemi inversi. Descrivere importanti applicazioni Modellizzare sistemi tecnologiche come alternatori e dinamo. Saper ricavare fisici che coinvolgono i d a a di solenoide. conduttori rettilinei, spire e solenoidi Descrivere il funzionamento e saper risolvere elementari percorsi da corrente. problemi sul trasformatore. Discutere qualitativamente i b e i e a i i a a di ib i e de e e gia e e ica e alla corrente alternata. Saper calcolare il valore efficace di una grandezza sinusoidale. Descrivere il comportamento Utilizzare il concetto di oscillante e saper calcolare la pulsazione di un circuito LC. flusso di campo Saper risolvere problemi elementari sui circuiti RLC e magnetico e di discutere applicazioni tecnologiche. circuitazione del campomagnetico. Saper collegare le leggi di Maxwell presentate in forma Analizzare situazioni integrale con i fenomeni elettromagnetici che sono a Equazioni di Maxwell e Onde fisiche con campi fondamento di esse. elettromagnetiche: elettrici e magnetici Discutere i problemi che hanno portato alla scoperta della Le equazioni di Maxwell. variabili mediante le corrente di spostamento e saper operare con essa in casi Le onde elettromagnetiche. La equazioni di Maxwell. e ici Sa e i a e i e a i e a ca e e ic natura elettromagnetica della Inquadrare in ambito e il campo di induzione magnetica alla base della luce. storico relatività aga i e di da e e ag e ica Sa e Lo spettro elettromagnetico. ristretta e generale calcolare il campo elettrico in un'onda elettromagnetica cogliendo il nesso tra lo piana noto quello magnetico e viceversa. Saper calcolare sviluppo della e e gia a a a da da e e ag e ica. Saper conoscenza fisica ed il calcolare la f e e a di da e e ag e ica contesto filosofico e sinusoidale note la velocità e la lunghezza d'onda e saper culturale in cui essa siè gestire problemi inversi. Riconoscere e discutere le sviluppata. principali suddivisioni dello spettro elettromagnetico e la fenomenologia connessa. Collocare nel contesto storico e culturale la fisica quantistica. Relatività ristretta: Sa e de c i e e e e i e di Miche eM e ei i ai i e a i e a i e i de e e e e a a Le e i e di Miche e discussione storica sulla propagazione delle onde Morley. elettromagnetiche. Discutere i postulati della relatività Le trasformazioni di Lorentz. I ristretta. Saper applicare le trasformazioni di Lorentz e postulati della relatività coglierne le relazioni con le trasformazioni di Galilei. ristretta di Einstein. Saper risolvere elementari problemi sulla dilatazione dei La dilatazione dei tempi e tempi e sulla contrazione delle lunghezze. Risolvere e e i e i i semplici problemi sulla composizione delle velocità. La legge di addizione Saper risolvere elementari problemi di dinamica relativistica delle velocità. relativistica, con particolare riguardo agli urti tra La legge di conservazione della a ice e Di c e e e i a e a f a a a ed e e gia e quantità di moto. La dinamica risolvere semplici problemi. relativistica (cenni). Fisica quantistica: Saper presentare il rapporto esistente tra la fisica classica e i dati sperimentali relativi allo spettro del corpo nero, Lo spettro del corpo nero e 11
a effe f - elettrico, agli spettri atomici, i e i di P a c a e e i e di F a c - He a effe C a a L effe f e e ic e i e i diffrazione elettronica. Saper usare la legge di Einstein sui quanti di luce di Einstein. effe f e e rico per risolvere elementari Gli spettri atomici e l'ipotesi di be i effe f e e ic e e i e e a e Bohr sulla quantizzazione dei grafici e tabelle relative al fenomeno. Saper risolvere livelli atomici. L'esperimento di elementari problemi relativi al modello atomico di Bohr Franck-Hertz. sul calcolo della frequenza della radiazione L effe C i i ai emessa/assorbi a de e e gia de a adia i e e i e ai ee e- emessa/assorbita, delle orbite di partenza e di arrivo. fotone. Sa e di c e e effe C c ei e a i e a a L'ipotesi di De Broglie sul adia i e e e ag e ica d a e g i e e i ibe i comportamento ondulatorio Saper confrontare il comportamento dualistico degli degli elettroni. elettroni e quello della radiazione luminosa in un esperimento di diffrazione. Saper presentare il legame tra il c a e d a i ic de e e e e i de atomico di Bohr. Collocare nel contesto Individuare le particelle del nucleo e le loro OPZIONALE: storico e culturale la fisica caratteristiche. Fisica nucleare: nucleare Descrivere le caratteristiche della forza nucleare. I nuclei degli atomi. Le forze Me e e i e a i e i dife di a a e e e gia di c ea i e e e gia di ega e legame del nucleo. dei nuclei. Descrivere il fenomeno della radioattività. La radioattività. La legge del Descrivere i diversi tipi di decadimento radioattivo. decadimento radioattivo. Li e a i e debole. La Applicare e i a e a a a-energia in situazioni medicina nucleare. Le reazioni concrete tratte da esempi di decadimenti radioattivi, nucleari esoenergetiche. La reazioni di fissione o di fusione nucleare fissione nucleare. Le centrali Descrivere il funzionamento delle centrali nucleari e dei nucleari. La fusione nucleare. reattori a fusione nucleare. Li i i de a fi ica de e Discutere rischi e benefici della produzione di energia particelle: il positone e il nucleare. muone. Le particelle nucleari instabili. Le particelle-materia fondamentali. Le forze elettromagnetica e forte. La forza debole neutra e la forza gravitazionale. 12
3. MODULI E TEMPI La scansione temporale proposta è solo indicativa e dovrà essere svolta, a scelta del docente, in relazione alla i a i e de a c a e e a e da i de E a e di S a PRIMO ANNO MODULO TEMPI 1: MISURE E Grandezze fisiche, cifre significative e ordini di grandezza, strumenti ed 20 h RAPPRESENTAZIONI errori di misura. (set-nov) Propagazione degli errori, rappresentazioni e relazioni tra grandezze fisiche. 2: L EQUILIBRIO Vettori e operazioni con i vettori, le forze: forza peso, forza elastica, forze 12 h DEL PUNTO di attrito, forze di tensione. (dic-gen) MATERIALE L e i ib i de e e a ica i i ia i a e ia inclinato, corpo appeso. Tecniche per il laboratorio: rette di massima e minima pendenza. 3: L EQUILIBRIO DEL I c i igidi i e ecca ic e i ib i di c igid 16 h CORPO RIGIDO baricentro ed equilibrio, le macchine semplici: leve, carrucole, piano (feb- mar) inclinato. 4: OTTICA GEOMETRICA Le leggi della riflessione. Gli specchi. Le leggi della rifrazione della luce. 16 h La g i i e e a if e i e a e La diffe e a f a e i c e ge i (apr- mag) e lenti divergenti. SECONDO ANNO MODULO TEMPI 1: EQUILIBRIO DEI La pressione. Il principio di Pascal. La legge di Stevino. I vasi 12 h FLUIDI comunicanti. La pressione atmosferica e l'esperienza di Torricelli. La (set-ott) spinta di Archimede e il galleggiamento dei corpi. 2: TERMOLOGIA Misura della temperatura; Dilatazione termica dei corpi; Calore e sua 12 h misura; Calore specifico e capacità termica; Propagazione del calore; (nov-dic) Cambiamenti di stato e calore latente. 3: CINEMATICA Lo studio del moto e la velocità. Il moto rettilineo uniforme. 16 h UNIDIMENSIONALE L acce e a i e e i e ii e if e e e acce e a G afici (gen-mar) tempo- spazio e tempo-velocità. La caduta libera. 4: PRINCIPI DELLA Il primo principio e i sistemi di riferimento inerziali. Il secondo 16 h DINAMICA principio. Corpo in caduta libera. Il terzo principio. Applicazioni dei (apr- mag) principi della dinamica: moto orizzontale in presenza di attrito, moto lungo il piano inclinato con e senza attrito. 13
TERZO ANNO MODULO TEMPI 1: DINAMICA E Il principio di relatività galileiana. Sistemi di riferimento non inerziali e 18 h COMPOSIZIONE DEI forze apparenti. Cinematicae dinamica dei moti piani: moto parabolico, (set-ott) MOVIMENTI circolare uniforme e armonico. Il pendolo semplice. 2: PRINCIPI DI Impulso e quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. Il 20 h CONSERVAZIONE lavoro meccanico. L'energia cinetica e il teorema delle forze vive. Le (nov-dic) forze conservative e l'energia potenziale. La legge di conservazione dell'energia meccanica. Gli urti di corpi puntiformi. 3: GRAVITAZIONE Dal modello geocentrico almodello copernicano. Le leggi di Keplero. La 15 h UNIVERSALE legge della gravitazione universale. L'energia potenziale gravitazionale (gen-feb) ela legge di conservazione dell'energia meccanica. 4: TERMODINAMICA Ripasso degli argomenti affrontati al II anno. Le leggi dei gas e 30 h l'equazione di stato dei gas perfetti. La teoria cinetica del gas perfetto. (mar-apr- Le trasformazioni termodinamiche (isocora, isobara, isoterma, mag) adiabatica). Il lavoro termodinamico. Il primo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica. Entropia e interpretazione statistica delsecondo principio della termodinamica. QUARTO ANNO MODULO TEMPI 1: ONDE MECCANICHE Propagazione delle onde meccaniche su una corda. Oscillazioni e onde: 18 h E SUONO parametri caratteristici ed equazione di propagazione. Il principio di (set-ott) sovrapposizione.Fe e i d i e fe e a e diffrazione. Onde sonore e loro caratteristiche. Le onde stazionarie Intensità elivello sonoro. Effetto Doppler. 2: OTTICA Ripasso O ica ge e ica (in particolare le leggi della riflessione e 20 h ONDULATORIA della rifrazione della luce, angolo limite e riflessione totale). (nov-dic) Onde luminose e colori. L'interferenza e la diffrazione luminosa e la natura ondulatoria dellaluce. 3: CAMPO ELETTRICO L'elettrizzazione dei corpi e l'interazione elettrica. La legge di Coulomb. 20 h Il campo elettrico. L'energia potenziale elettrica. (gen-feb) Il potenziale elettrico. Il teorema di Gauss. L'elettrostatica dei conduttori. Il condensatore piano. 4: CORRENTE Gli elementi del circuito elettrico. L'intensità di corrente elettrica. Le 15 h ELETTRICA CONTINUA leggi di Ohm. L'effetto Joule. La carica e la scarica di un condensatore. (mar-apr) 5: MAGNETOSTATICA I magneti e le linee del campo magnetico. L'interazione tra un filo 15 h percorso da corrente elettrica e un magnete. L'interazione tra due fili (apr- mag) percorsi da corrente elettrica. Il campo di induzione magnetica. Flusso e circuitazione del campo magnetico. La forza di Lorentz. 14
QUINTO ANNO MODULO TEMPI 1: INDUZIONE La legge di Faraday-Neumann. 20 h ELETTROMAGNETICA L'alternatore. Il trasformatore. Il circuito LC. Il circuito RLC. (set-nov) 2: EQUAZIONI DI Le equazioni di Maxwell. 12 h MAXWELL E ONDE Le onde elettromagnetiche. La natura elettromagnetica della luce. (dic-gen) ELETTROMAGNETICHE Lo spettro elettromagnetico. 3: LA RELATIVITA Le e i e di Miche -Morley. Le trasformazioni di Lorentz. I 24 h RISTRETTA postulati della relatività ristretta di Einstein. La dilatazione dei tempi e (feb- mar) e e i e i i La egge di addi i e e a i i ica de e velocità. La legge di conservazione della quantità di moto. La dinamica relativistica. 4: LA FISICA L e de c e e i e i di P a c L effe f e e ic e 20 h QUANTISTICA i e i i a i di ce di Ei ei G i e i a ici e i e i di (apr- mag) Bohr sulla quantizzazione dei livelli atomici. L'esperimento di Franck- He L effe C i i ai e i e ai ee e- fotone. L'ipotesi di De Broglie sul comportamento ondulatorio degli elettroni. 5 (OPZIONALE): I c ei deg i a i Le f e c ea i e e e gia di ega e dei c ei La 20 h LA FISICA NUCLEARE adi a i i La egge de decadi e adi a i Li e a i e (apr-mag) debole. La medicina nucleare. Le reazioni nucleari esoenergetiche. La fi i e c ea e Le ce a i c ea i La f i e c ea e L i i i de a fisica delle particelle: il positone e il muone. Le particelle nucleari instabili. Le particelle-materia fondamentali. Le forze elettromagnetica e forte. La forza debole neutra e la forza gravitazionale. 15
ATTIVITÀ DI LABORATORIO È prevista la possibilità di una diversa scansione temporale degli argomenti e di una diversa rosa di esperienze di laboratorio in relazione alle scelte metodologiche del docente e alle specificità della classe. In ogni caso, levariazioni dovranno: • essere coerenti con le indicazioni ministeriali; • mirare al raggiungimento degli obiettivi specifici elencati nel §.2; • sincronizzare a i i di laboratorio della classe con la programmazione stabilita a livello d I i per del laboratorio di Fisica. La calendarizzazione delle attività verrà affissa, settimana per settimana, sulla porta del laboratorio e ogni docente potrà prenotarsi con la propria classe. CALENDARIO ESPERIMENTI MESE Classi I Classi II Classi III Classi IV Classi V Strumenti di Statica dei fluidi Moto parabolico Onde meccaniche Circuiti in continua Settembre misura e Ottobre valutazione Spinta di Moto armonico Fenomeni de i ce e a Archimede magnetostatici Moto circolare Misure Moto rettilineo Applicazioni e Onde acustiche Novembre indirette e con la rotaia verifica dei Induzione valutazione principi della elettromagnetica de i ce e a dinamica Dipendenza fra Sistemi di Ottica ondulatoria Dicembre grandezze e riferimento non grafici inerziale sperimentali Legge di Hooke Verifica dei principi Conservazione Deflessione edelasticità delladinamica energia magnetica di un Gennaio meccanica fascio elettronico Fenomeni elettrostatici Urti Misure con Caduta dei gravi Esperimento di Deflessione dinamometri e Millikan magnetica di un Febbraio verifica delle Misura fascio elettronico proprietà de acce e a i edi vettoriali delle gravità forze Forza d'attrito Attrito dinamico Leggi di Ohm e Effetto fotoelettrico Marzo Moto sul piano circuiti in corrente Equilibrio sul inclinato continua piano inclinato Calorimetro Esperimenticon Circuito RC Misure di Esperimenti su Aprile le leve ed Proprietà dei gas termologia e sistemi quantistici equilibrio dei calorimetria corpi Semplici Fenomeni Maggio sistemi ottici magnetostatici 16
4. INDICAZIONI METODOLOGICHE Nel biennio l'insegnamento della fisica concentra la sua attenzione sull'acquisizione dei procedimenti di base dell'attività sperimentale e sullo sviluppo della capacità di impostare e risolvere elementari problemi legati alla dipendenza funzionale tra le grandezze fisiche, alla cinematica e alla dinamica dei moti rettilinei. Ne ie i i eg a e de a Fi ica rivolge maggiore attenzione all'impianto teorico e alle sintesi formali in cui si collocano i risultati sperimentali, mettendo in evidenza i collegamenti interdisciplinari degli argomenti studiati. L a i i di laboratorio svolge un ruolo centrale e i eg a e della Fisica. Tale attività va inserita organicamente nello svolgimento dei moduli didattici e nella successione temporale delle lezioni. Si prevede, in particolare, che,dopo le esperienze di laboratorio, la classe discuta i risultati ottenuti, li inserisca in un coerente quadro concettuale e sia guidata dal docente, nelle modalità abi i e da e i verso una rielaborazione scritta de e e i e svolto. Si prevede, inoltre, la possibilità che, dopo lo svolgimento e la di c i e de e e ie a a c a e torni in ab a i e e ab a e i i a i de e e ie a c a ii del foglio elettronico e/o di altri strumenti informatici. Qualora lo ritenga proficuo, il docente farà uso, oltre che del libro di testo, di altri materiali a stampa, di lucidi, di software didattico, dei CD-DVD e delle videocassette in possesso de I i La i i didattica è suddivisa in due periodi: un trimestre e un pentamestre. I temi presentati saranno sviluppati possibilmente nei tempi e periodi indicati, flessibilmente adeguati alla realtàde e i g e c a i e c a e i e i eg a i i add e i eg a e e a eda a ece i anche per esigenze di collegamento con altre discipline. 5. LA VALUTAZIONE Ne c de a aa e a e d e e ifiche e i e e e a e e e ifiche e e a e e È il singolo docente a stabilire, sulla base del percorso didattico delineato per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, il tipo di prova da effettuare per procedere ad una congrua valutazione degli alunni. Nella valutazione della prova orale si prenderanno in esame i seguenti indicatori: • conoscenza e comprensione degli argomenti • capacità di motivare le risposte fornite • pertinenza delle risposte • fluidità e proprietà de e i i e Nella valutazione della prova scritta si prenderanno in esame i seguenti indicatori: • conoscenza degli argomenti oggetto della prova • grado di completezza de e ab a • argomentazione delle risposte fornite • pertinenza delle risposte • correttezza del calcolo • qualità de e i i e La valutazione de attività di laboratorio terrà conto: • delle modalità di lavoro dello studente nel laboratorio; 17
• delle relazioni e/o delle eventuali prove scritte/orali sulle esperienze svolte. Nella valutazione delle relazioni e delle eventuali prove scritte/orali sulle esperienze di laboratorio svolte si terràconto dei seguenti indicatori: • completezza dello svolgimento • correttezza de e ab a i e dei dati • qualità delle tabelle e dei grafici • qualità de e i i e e della composizione grafica. La valutazione globale al termine del primo trimestre e al e i e de a scolastico sarà elaborata: • in funzione degli obiettivi specifici raggiunti dallo studente; • sulla base degli elementi che emergeranno dalle interrogazioni orali, dalle verifiche scritte, da a i i di laboratorio e dalle modalità di lavoro dello studente e a bi del gruppo- classe; • in relazione a i eg di studio e al metodo di lavoro messi in campo da a ie • in relazione ai progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza Nell'allegato 2 sono riportate la proposta di una griglia di valutazione per una verifica scritta centrata sui b e i e e a di a g ig ia di a a i e e a e I eg i a e e e ie e di ab a i i d ce i i base a valutazioni di opportunità potranno richiedere una relazione scritta. Viene proposta anche una griglia per la valutazione della relazione di laboratorio, il voto riportato potrà essere conteggiato nella media come e i de c i e de ae c e di e Si precisa che i voti assegnati si riferiscono alla preparazione in Fisica dello studente e non rappresentano un giudizio sulla personalità dello studente. Nella sezione di Liceo Scientifico Internazionale opzione italo-inglese si effettueranno prove scritte strutturate e valutate come gli esami Cambridge IGCSE Physics (0625) che gli studenti affronteranno al quarto anno. 6. IL RECUPERO L a i i di ec e a ai ii e ee ia a a che e I i di dei f di ece a i de sportello e dei corsi di ec e a i a i e I i L a i i di ec e i i i e e e i i e i ce a i e a c e i e i c a e deg i e e ci i assegnati, nella discussione delle richieste di chiarimento degli studenti, nelle interrogazioni, nella disamina dei risultati emersi nelle verifiche scritte e in eventuali lezioni appositamente programmate. 18
7. CONTENUTI ESSENZIALI, COMPETENZE ED ABILITÀ CLASSI PRIME Contenuti essenziali Competenze ed abilità Grandezze fisiche ed unità di misura - Saper descrivere i caratteri qualitativi dei fenomeni naturali Le grandezze fisiche e il Sistema Internazionale di studiati in modo coerente e funzionale; unità di misura; - Saper interpretare i dati sperimentali riconoscendo le relazioni Conversione delle unità di misura; funzionali tra grandezze; La lunghezza, area e volume; - Saper organizzare una relazione scientifica; Intervallo di tempo, massa, densità; - Saper gestire il lavoro di gruppo in laboratorio; Rapporti, proporzioni e percentuali; - Saper rappresentare graficamente le relazioni tra le grandezze. Proporzionalità diretta e inversa; - Sapere svolgere semplici operazioni di utilità diretta nelle Potenze di 10 e prefissi del Sistema Internazionale. applicazioni fisiche trattate, come ad esempio le somme e le differenze di vettori; sapere scomporre un vettore nelle sue componenti cartesiane almeno in modo grafico. Misura delle grandezze fisiche - Saper risolvere semplici problemi sugli argomenti trattati. L i ce e a de e i e e ibi i e e - Saper riconoscere le forze di un sistema e discuterne le casuale, errore sistematico; errore assoluto e condizioni di equilibrio. relativo; Valor medio e incertezza per misure ripetute; Le cifre significative. Grandezze vettoriali e forze Significato qualitativo del concetto di forza; La forza elastica e la legge di Hooke; Il dinamometro e la misura delle forze; La forza peso; Definizione di vettore e grandezze fisiche vettoriali; Operazioni fra vettori: costruzione geometrica e calcolo in casi semplici (anche usando il teorema di Pitagora); Definizioni di seno, coseno (in relazione ai triangoli rettangoli); Componenti cartesiane dei vettori; Operazioni e ia i c de e c e i ca e ia e I principi della statica Vincoli e forze vincolari: reazione normale, tensione delle corde; E i ib i ia i ci a La i ade e caso statico; Il momento delle forze; Condizione di equilibrio dei corpi rigidi; Semplici b e i e a i i a e i ib i di c 19
CLASSE SECONDA: Contenuti essenziali Competenze ed abilità Equilibrio dei fluidi - Saper costruire e interpretare correttamente grafici di dati. Caratteristiche dei materiali fluidi; - Saper realizzare il diagramma del corpo libero. La pressione; - Saper gestire il lavoro di gruppo in laboratorio. La pressione nei fluidi e la legge di Pascal; - Saper risolvere semplici problemi sugli argomenti trattati Pressione e forza peso: la legge di Stevino; - Saper applicare la legge di Stevino e risolvere semplici La spinta di Archimede; problemi di galleggiamento Condizioni per il galleggiamento dei corpi; - Sa e a ica e a egge de e i ib i e ic e conoscere le La pressione atmosferica; semplici esercizi scale termometriche. applicativi. - Riconoscere i cambiamenti di stato ed applicare le leggi della calorimetria Termologia - Saper definire le grandezze cinematiche e i sistemi di Misura della temperatura; riferimento Dilatazione termica dei corpi; - Saper risolvere semplici problemi del moto rettilineo Calore e sua misura; uniforme ed uniformemente accelerato Calore specifico e capacità termica; - Conoscere i principi della dinamica e saper risolvere semplici Propagazione del calore; problemi. Cambiamenti di stato e calore latente. Il moto rettilineo Descrizione del moto del punto materiale; Sistemi di riferimento; traiettoria; tabella oraria; La velocità media e istantanea; Il grafico spazio tempo; Il moto rettilineo uniforme; Il moto vario; L acce e a i e edia e i a a ea Il grafico velocità tempo; Il moto uniformemente accelerato e la caduta libera; Equazioni del moto del moto uniformemente accelerato; semplici problemi applicativi. I principi della dinamica e le applicazioni Il primo principio della dinamica; Sistemi di riferimento inerziali; Il secondo principio della dinamica; Il terzo principio della dinamica; Il peso e la caduta; L a i ade e Moto sul piano inclinato con e senza attrito; Problemi applicativi dei principi della dinamica e delle equazioni cinematiche. CLASSE TERZA Contenuti essenziali Competenze ed abilità Equilibrio e dinamica del punto materiale - Sapere applicare i principi della dinamica a problemi con Le forze e la loro natura: peso, forza elastica, carrucole, molle, piano inclinato. vincoli e forza di attrito; Operazioni vettoriali; 20
Principi della dinamica e applicazioni; - C e de e i a a dei i ci i di conservazione Forze e movimento: moto sul piano inclinato con nella Fisica e saper trattare semplici problemi relativi ai e senza attrito; principi di conservazione. Moto circolare uniforme e forza centripeta, moto - Sapere trattare problemi relativi al moto dei pianeti tramite armonico, moto del pendolo. le leggi di Kepler. - Sapere applicare i principi della gravitazione universale a Lavoro ed energia semplici problemi. Il lavoro e la potenza; - Sapere applicare i principi della termodinamica a semplici L e e gia ci e ica e i e e a de e e gia problemi. cinetica; Forze conservative ed energia potenziale; La c e a i e de e e gia eccanica; Energia potenziale della forza peso ed energia potenziale elastica. Quantità di moto e impulso La quantità di moto; La defi i i e de i di a f a Il principio di conservazione della quantità di moto; Gli urti sulla retta. La gravitazione universale Le leggi di Keplero; La forza di gravitazione universale; Moto di satelliti e pianeti; Energia potenziale gravitazionale. Termologia, teoria cinetica dei gas, calore Scale Celsius e Kelvin; Ipotesi atomica e numero di Avogadro; Gas perfetto e leggi dei gas; Energia interna e temperatura; Esperimento di Joule ed equivalente in Joule della caloria; Calore specifico e capacità termica; Equilibrio termico e scambio di calore; Cambiamento di stato e calore latente. Principi della termodinamica Trasformazioni termodinamiche e lavoro; Il primo principio della termodinamica; Trasformazioni reversibili e non reversibili; Applicazioni ai gas perfetti: Trasformazioni isoterme, isocore, isobare, adiabatiche; Enunciati di Kelvin e Clausius del secondo principio della termodinamica; Ciclo di Carnot e teorema di Carnot, rendimento della macchina reversibile. 21
CLASSE QUARTA Contenuti essenziali Competenze ed abilità Onde suono luce - Descrivere graficamente ed analiticamente le onde Onde meccaniche; ampiezza, frequenza, periodo, - Scrivere l'equazione matematica di un'onda armonica velocità; propagazione delle onde; onde unidimensionale riconoscendo tutte le grandezze che vi armoniche; sovrapposizione e interferenza; il compaiono. suono; intensità e livello; natura ondulatoria della - Applicare le leggi della riflessione e della rifrazione delle luce; spettro luminoso; riflessione e rifrazione; onde. interferenza ed esperimento di Young. - Descrivere le caratteristiche delle onde sonore - Riconoscere, in base alla frequenza, infrasuoni, suoni e Fenomeni elettrici e campo elettrico ultrasuoni. Cariche elettriche e fenomeni di elettrizzazione; - Conoscere le caratteristiche delle onde luminose Conduttori e dielettrici; - Calcolare la frequenza o la lunghezza d'onda di una La egge di C be i di i a de a ca ica radiazione luminosa. elettrica; - Conoscere le leggi della rifrazione e della riflessione. Il campo elettrico; - Saper descrivere e e i e di Young. Definizione del vettore campo elettrico; - Descrivere l'elettrizzazione per contatto, strofinio e Principio di sovrapposizione; Le linee di campo induzione e interpretarli. - Calcolare la forza tra due cariche puntiformi nel vuoto Il flusso del campo elettrico e il teorema di - Applicare il principio di sovrapposizione delle forze. Gauss - Operare con il campo elettrico Il flusso del campo elettrico attraverso una - Descrivere il passaggio dall'interazione a distanza al concetto superficie; di campo. Il teorema di Gauss; - Determinare (in modulo, direzione e verso) il campo Campo dovuto ad una distribuzione di carica con elettrico generato da una carica puntiforme. simmetria sferica; - Calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una Campo generato da distribuzioni piane infinite di superficie assegnata. carica - Operare con potenziale e capacità elettriche - Calcolare l'energia potenziale di un sistema formato da due o Lavoro ed energia potenziale elettrica più cariche puntiformi ed in particolari campi. L e e gia e ia e di i e a di ca iche - Ricavare la relazione tra campo elettrico e potenziale (caso Il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali; del campo uniforme). La differenza di potenziale e il moto delle cariche; - Calcolare la capacità elettrica di un conduttore e risolvere La relazione tra campo elettrico e potenziale; semplici problemi. Campo, potenziale e distribuzione della carica in - Sapere impostare e svolgere problemi sui circuiti elettrici. un conduttore in equilibrio elettrostatico; - Saper comprendere ifica i e f a e e ici e Campo e potenziale generato da un conduttore magnetismo. sferico carico. - Saper definire il campo magnetico e le interazioni fra magneti e correnti elettriche. Saper discutere il moto di una I condensatori carica in presenza di campo magnetico. Capacità di un conduttore; Capacità di un condensatore piano; Energia di un condensatore; Collegamento dei condensatori in serie e parallelo. Circuiti elettrici Generatori e utilizzatori; la corrente elettrica; resistori e legge di Ohm; bilancio energetico ed effetto Joule; collegamenti in serie e parallelo; risoluzione di semplici circuiti. Campo elettrostatico Campi conservativi, potenziale ed energia potenziale. Circuitazione di un vettore. 22
Moto di particelle cariche in un campo elettrostatico. Corrente continua e leggi di Ohm. Circuiti elettrici. Effetti della corrente elettrica. Campo magnetico. Interazione magnetiche tra correnti. Moto di cariche in un campo magnetico. Forza di Lorentz. Teorema di Gauss per il campo magnetico. CLASSE QUINTA Contenuti essenziali Competenze e abilità Induzione elettromagnetica - Saper di c e e i fe e de i d i e e e ag e ica Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. e conoscerne le leggi e relative applicazioni Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday- - Saper esporre le principali caratteristiche delle onde Neumann. elettromagnetiche. Le equazioni di Maxwell. Cenni sulle onde - Saper formulare i principi della relatività ristretta. elettromagnetiche. - Saper formulare e di c e e e e e i i de e e gia a e della massa e della quantità di moto in meccanica Relatività relativistica. Postulati della relatività ristretta; la dilatazione dei - Conoscere e illustrare il dualismo onda-corpuscolo e tempi e la contrazione degli spazi; relazione tra formulare la relazione di de Broglie massa ed energia relativistica. - Sa e di c e e effe f e e ic e effe C pton La fisica quantistica C ce e i e i di P a c c e de e e c eg e e Sa e de c i e e effe fotoelettrico. I docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica che insegnano Fisica e a 2022-2023: Altobelli, Becce, Calabria, De Santis, Eramo, Funaro, Galloppa, Maccari, Macrì, Maggi, Manna, Marone, Nufris, Paganizza, Papalini, Paparini, Pelagalli, Pesce, Simonetti, Sopranzi, Sorvillo, Stalteri, Stasi, Starnone e Troncone. 23
Puoi anche leggere