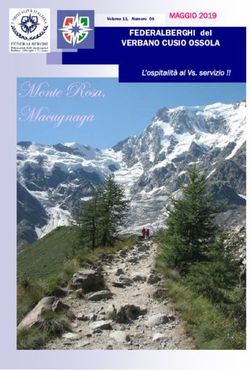I "Facebook files": un caso da non sottovalutare - Il Mantello della Giustizia
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
I «Facebook files»: un caso
da non sottovalutare.
di Leonardo Salutati · “Facebook
files” è il titolo dato ad una
importante inchiesta del Wall
Street Journal che ha
pubblicato migliaia di documenti
che denunciano i rischi delle
ricadute sociali della
condivisione di contenuti
sensibili da parte degli utenti, rivelando il ruolo e i
possibili rischi connessi agli algoritmi usati dalle
piattaforme digitali quali Facebook e Twitter, o da motori di
ricerca come Google e Bing, per gestire i propri contenuti
informativi.
Per capire le implicazioni degli algoritmi sulle dinamiche
dell’opinione pubblica occorre analizzare la loro interazione
con le inclinazioni (bias) comportamentali degli individui.
Gli algoritmi usati dai social media, infatti, decidono quali
informazioni mostrare e in che ordine mostrarle, selezionando
quali informazioni siano più o meno rilevanti per un dato
individuo. In concreto gli algoritmi, svolgono un ruolo
editoriale che li rende molto diversi dai media tradizionali,
più vicino alla statistica che al giornalismo (B. Rieder – G.
Sire, 2013).
Nello scegliere quale contenuto proposto dalla piattaforma
leggere su un determinato argomento, gli individui sono
guidati da una duplice inclinazione. Una che consiste nel
volere vedere confermata la propria opinione (“confirmation
bias”), che li spinge a scegliere contenuti che avvalorano
l’opinione iniziale. L’altra (“attention bias”) è quella diprestare attenzione a pochi contenuti e di scegliere tendenzialmente quei contenuti che sono presentati in posizioni più prominenti nella piattaforma. Ambedue le inclinazioni si basano su un’ampia e verificata evidenza empirica. Con queste due inclinazioni umane interagiscono due macro- classi di algoritmi: 1) quelli basati sulla popolarità di un dato contenuto web, in cui la prominenza data all’argomento aumenta nel tempo con l’aumento della popolarità del contenuto (per esempio più persone cliccano su un sito web); 2) quelli che personalizzano l’ordine dei contenuti in base ad alcune caratteristiche individuali, come indirizzo Ip o cronologia delle ricerche, con la conseguenza che utenti diversi osservano contenuti in ordine diverso. Riguardo agli algoritmi basati sulla popolarità che lavorano sul feedback degli utenti, se le opinioni iniziali su un determinato tema sono generalmente poco corrette e gli utenti hanno un forte “confirmation bias” che li porta a scegliere troppo spesso siti web che hanno informazioni sbagliate, tale dinamica favorisce la crescita nel ranking di questi siti permettendogli, quindi, di attrarre più utenti. Diversamente se l’algoritmo utilizzasse come criterio di efficienza informativa al posto della popolarità, per esempio, quello che ordina i contenuti in maniera casuale, la probabilità che un individuo scelga un sito che riporta informazioni corrette, sarebbe più efficiente. A questo si aggiunga che gli algoritmi basati sulla popolarità generano un effetto tale che, minore è il numero di siti che riporta un dato contenuto informativo, maggiore è l’audience totale che cattureranno, in quanto la più alta concentrazione del traffico verso pochi siti, ne aumenta il ranking. Questo tipo di meccanismo può contribuire a spiegare perché le piattaforme digitali sembrano favorire la diffusione di fake news (F. Germano – F. Sobbrio, 2021).
A loro volta gli algoritmi personalizzati, conducono a polarizzare le opinioni iniziali degli individui creando quindi delle cosiddette “camere dell’eco” algoritmiche, che producono una riduzione dell’efficienza informativa su temi in cui c’è una verità “oggettiva”. In particolar modo, la personalizzazione tende a contrastare i pur possibili effetti positivi degli algoritmi basati sulla popolarità (evitiamo di specificare il meccanismo per motivi di spazio). In definitiva, le informazioni emerse dai “Facebook Files” evidenziano la rilevanza dell’interazione tra algoritmi e comportamento umano, oltre alle responsabilità dei vertici di Facebook di aver insistito su di un algoritmo che poneva un forte accento sulla popolarità e la personalizzazione, nonostante vi fossero dati che segnalassero gli effetti negativi in termini di disinformazione e polarizzazione. Tale vicenda pone un grave problema morale, che mina alla base la possibilità di convivenza pacifica e democratica di una società, che consiste nel dominio sulla libertà e sulla coscienza di tanti uomini e donne attraverso sofisticati strumenti tecnici, dettato fondamentalmente dalla logica del potere e/o del profitto. È quanto aveva già lucidamente intravisto il teologo Enrico Chiavacci negli anni ’80 del secolo scorso, nel descrivere le possibilità aperte dalla “rivoluzione del silicio”, che ha introdotto l’umanità nell’era dei semiconduttori e dei circuiti integrati, caratterizzata da una forte accelerazione tecnica che ha favorito il consolidarsi di “strutture di potere e di dominio culturale” operanti a livello globale, di cui aveva tra l’altro con precisione descritto la genesi e i
meccanismi di ulteriore sviluppo. A Chiavacci farà eco Benedetto XVI quando denuncerà le strettoie della mentalità tecnicista che fa «coincidere il vero con il fattibile» assumendo come «unico criterio della verità l’efficienza e l’utilità» (Caritas in veritate n. 70). Recentemente, nel messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali del 2016 Papa Francesco scriveva: «Non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell’uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione». Per questo «occorre interrogarsi su ciò che [in Rete e sui social] è buono, facendo riferimento ai valori propri di una visione dell’uomo e del mondo, una visione della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto quella trascendente» (Francesco, discorso all’Università Roma tre, 2017), diversamente la transizione dell’epoca postmoderna non potrà che caratterizzarsi come «cultura del naufragio», in quanto caratterizzata da «mentalità tecnicistica», da «messianismo profano» che porta l’uomo di oggi a fare esperienza «sulla propria pelle un senso di sradicamento e abbandono» (card. Bergoglio, 2006). Ancora su I Padrenostri di questi tempi
di Carlo Nardi · Ripropongo con alcune
ulteriori considerazioni quanto ho già
scritto sull’argomento I Padrenostri di
questi tempi, in Il mantello della giustizia
in rete, aprile 2021:
Su questo argomento molti hanno scritto e molto è stato
scritto. Ecco una mia noterella.
Voglio offrire un pensiero che mi stuzzica la mente. Penso al
vecchio Padre nostro con … e non c’indurre in tentazione,
modificato adesso nel nuovo messale con … e non abbandonarci
alla tentazione.
In verità, questa nuova traduzione non mi sconfinfera. Il
salto di resa nelle due versioni è grande: in effetti quei due
verbi ‘indurre’ e ‘abbandonare’ sono due cose diverse. Forse
vicine, ma non mi sento di dire di più. A questo riguardo
rimando al dotto libro di Alberto Maggi (Padre dei poveri: 2.
Il Padrenostro. Traduzione commento dal Vangelo di Matteo,
Cittadella Editrice – Assisi, terza ristampa, febbraio 2018),
il quale presenta un condivisibile studio sui testi della
preghiera (pp. 137-151). In particolare, egli traduce il
versetto in questione (Matteo 6,13a) col verbo introdurre”,
che rende il senso del greco eisférein, “portare/spingere
verso”. Al contrario, non appare nel testo originale l’idea di
un “abbandono”, per quanto essa possa sembrare a prima vista
più consolante. Di fronte all’importanza di questa preghiera
per il Cristianesimo, mi pare che si dovrebbe andare assai
cauti, anche sulla scorta di Dei Verbum 10: “la Sacra
Tradizione, la Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa,per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti da non potere indipendentemente sussistere, e tutti insieme, secondo il proprio modo, sotto l’azione di un solo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime”. D’altronde, rispetto a questo imbarazzo nei riguardi del Vangelo, mi viene da domandarmi: vogliamo forse essere più cristiani di Cristo? Fin qui quello che ho scritto, sennonché mi sentivo di dire qualcosa di nuovo. La nuova versione di quel punto del Padre nostro mi pare che non sia valida, perché si tratta di una parola del Signore, e in questo modo non lo è più. E’ così che quando ho dovuto usare il nuovo Messale italiano (pag. 445), ho detto ai miei parrocchiani che il nuovo Padre nostro nel punto in questione è diverso dalla vecchia versione e anche dall’antico testo latino che è tuttora rimasto in uso, e meno male, grazie a Dio. Per questo, dopo aver pronunciato obtorto collo il nuovo testo, aggiungiamo il canto del Pater noster in latino, in modo che sia chiara la differenza in quel pezzettino. E d’altra parte la differenza fra i due pezzettini ha il pregio di stimolare la nostra riflessione sul mistero del male, del “cattivo”, con il quale siamo sempre in contesa, una contesa in cui ci affidiamo alla bontà del Signore.
Anche l’antica preghiera dell’Ave Maria ha subito una forzatura quando il fructus ventris tui è stato tradotto con frutto del tuo seno. Per quanto in greco il termine koilìa (seno) abbia un significato estensivo, risulta evidente che in specifica relazione con la maternità il termine venter (ventre) del latino è chiaramente e in tutti i sensi il più preciso e appropriato. A tal proposito mi ritorna alla mente una colorita espressione del dotto padre Ferdinando Batazzi: “O che i figlioli possano nascere dalle mammelle?” … dalle ciocce, dico io. Tornando al Padrenostro, sarebbe quindi opportuno quanto meno un ulteriore sforzo per ricercare una espressione che volendo superare quella percezione di costrizione, che come osserva il nostro arcivescovo Giuseppe Betori cardinale (in Avvenire, intervista del 10 dicembre 2017) oggi ha assunto il termine introdurre nell’italiano corrente, risulti aderente e coerente appunto con portare o spingere verso. E il Padreterno sorriderà bonariamente? Se Dio vuole, come dicevano i nostri vecchi. Ireneo di Lione: «Doctor Unitatis »
di Alessandro Clemenzia · «Il vostro
patrono, Sant’Ireneo di Lione, che
volentieri dichiarerò Dottore della
Chiesa prossimamente con il titolo di
Doctor unitatis, è venuto dall’Oriente
e ha esercitato il suo ministero
episcopale in Occidente, è stato un
grande ponte spirituale e teologico
tra cristiani orientali e
occidentali». Con queste parole,
pronunciate da papa Francesco (7
ottobre 2021) al gruppo misto di
lavoro ortodosso-cattolico “sant’Ireneo”, viene sinteticamente
presentata la figura di Ireneo di Lione, il grande Pastore
che, nel terzo secolo d.C., attraverso la sua instancabile
attività, non soltanto ha difeso le verità di fede dalle
diverse correnti di pensiero a lui contemporanee, ma con la
sua stessa presenza ha anche rappresentato il punto d’unità
tra Oriente e Occidente.
Tra queste correnti interne alla Chiesa, quella più forte e –
per certi aspetti – “di moda” era certamente lo gnosticismo,
una sorta di cristianesimo intellettualista (e dunque
un’esperienza riservata a pochi eletti) che aveva una visione
dualistica e pessimistica della realtà, andando così contro le
fondamentali verità di fede. Di fronte a queste
interpretazioni, Ireneo ha presentato la vera Tradizione
apostolica. In un’udienza generale (28 marzo 2007) incentrata
proprio su Ireneo di Lione, Benedetto XVI ha spiegato che «la
Tradizione di cui egli parla, ben diversa dal tradizionalismo,
è una Tradizione sempre internamente animata dallo Spirito
Santo, che la rende viva e la fa essere rettamente compresa
dalla Chiesa. Stando al suo insegnamento, la fede della Chiesa
va trasmessa in modo che appaia quale deve essere, cioè
“pubblica”, “unica”, “pneumatica”, “spirituale”».
Ireneo, attraverso la difesa della dottrina della Chiesa, haillustrato una organicità dei misteri della fede, tanto da essere considerato uno dei primi grandi teologi della storia. Al di là della sua figura legata a ciò che egli ha compiuto come Pastore, è importante cogliere il nesso d’unità tra l’Oriente e l’Occidente che egli rappresentava. Il termine “unità” è di decisiva importanza; per comprenderlo possiamo lasciarci guidare da un termine che Papa Francesco stesso ha sottolineato, richiamandosi a quanto aveva precedentemente affermato il cardinale Koch nel suo saluto: «È stato interessante quello che Lei ha detto dell’interpretazione come Gegensatz: mi è piaciuto, grazie». Gegensatz è una parola che, dal tedesco, può essere tradotta con “opposizione”: essa è un contrario di “contrapposizione” (Widerspruch) più che di “unità”. La differenza tra questi due termini, apparentemente sinonimici, è stata ben espressa da Romano Guardini, nella sua opera filosofica L’opposizione polare (Der Gegensatz, 1925), e un secolo prima dall’ecclesiologo Johann Adam Möhler, nel suo testo L’unità della Chiesa (Die Einheit in der Kirche, 1825). Quest’ultimo ha spiegato la relazione tra unità e distinzione nella Chiesa attraverso l’immagine di un coro polifonico, capace di inverare un’unica armonia dove ognuno conserva la propria individualità; anzi: ritrova se stesso proprio nella relazione di opposizione con gli altri. Chi, invece, nel coro cerca di prevalere sui singoli e di ergersi a unica voce, tendendo addirittura all’eliminazione dell’altro per ovviare a ogni distinzione, ciò «non costituisce un opposto, perché gli opposti non possono esistere che nell’unità; egli dà luogo a una vera contraddizione» (J. A. Möhler, L’unità nella Chiesa, Città Nuova, p. 194). Dunque, il concetto di opposizione è ciò che, favorendo la distinzione (e dunque l’alterità), garantisce l’unità della Chiesa, essendone in qualche modo un motore interno, capace cioè di dinamizzarla dal di dentro. La contraddizione, invece, non ha a che fare con l’unità, dal momento che ha come obiettivo l’eliminazione dell’altro. Per Möhler, inoltre, è proprio nell’unità che emerge la peculiarità di ciascun elemento distinto, come a dire che è
nella relazione di opposizione, nel tra loro, che l’io e il tu trovano ciascuno il completamento della propria esistenza. La stessa dinamica, legata alla parola Gegensatz, si può rintracciare, in modo molto più sistematico, nell’opera già menzionata di Romano Guardini. Il Papa, dunque, ricordando questo vocabolo tedesco, mostra al gruppo misto di lavoro ortodosso-cattolico “sant’Ireneo” a quale unità egli allude. Al di là di una semplice e circostanziale ripetizione di un termine pronunciato precedentemente dal cardinale Koch, si può arrivare a rintracciare nel lemma Gegensatz quella costante che anima, come fondamento filosofico, tutto il pensiero dell’attuale Pontefice. Per un approfondimento su questo tema, rimando agli studi del filosofo Massimo Borghesi, e in particolare ai suoi testi: Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale (Jaca Book 2017); Francesco. La Chiesa tra ideologia teocon e «ospedale da campo» (Jaca Book, 2021). In questa luce si possono comprendere meglio queste parole di Papa Francesco: «È bello coltivare un’unità arricchita dalle differenze, che non ceda alla tentazione di un’uniformità omologante […]. Animati da questo spirito, vi confrontate per comprendere come gli aspetti contrastanti presenti nelle nostre tradizioni, anziché alimentare contrapposizioni, possano diventare opportunità legittime per esprimere la comune fede apostolica». L’unità tra Oriente e Occidente, dunque, si gioca proprio nel reciproco riconoscersi l’uno in opposizione all’altro: ogni tentativo di supremazia, generando una contraddizione, porterebbe ciascuno alla perdita della
propria identità. Con un termine, Papa Francesco ha illustrato il significato di sant’Ireneo, Doctor unitatis. Formazione e lavoro La fabbrica delle competenze e della dignità. Idee e progetti per il PNRR: Next Generation Italia di Giovanni Campanella · Nel mese di luglio 2021, la casa editrice Edizioni Lavoro ha pubblicato, all’interno della collana “Società Circolare”, una raccolta di piccoli articoli intitolata La fabbrica delle competenze e della dignità – Idee e progetti per il Pnrr: il Next Generation Italia. La prefazione è di Tommaso Nannicini, senatore e professore ordinario di Economia Politica all’Università Bocconi. Gli autori principali sono Luigi Campagna, Marino Lizza, Luciano Pero e Roberto Rossini. Altri articoli sono di Roberto
Benaglia (segretario generale della Fim Cisl), Antonella Marsala (dirigente di Anpal Servizi e responsabile territoriale della Regione Lombardia), Paride Saleri (titolare della Omb Saleri di Brescia, fabbrica a gestione di “ispirazione umanistica”) e Paola Vacchina (presidente di Forma – Associazione nazionale enti di formazione professionale). Luigi Campagna è docente di ingegneria gestionale al MIP (Master in Ingegneria della Produzione) del Politecnico di Milano. Marino Lizza è imprenditore, esperto di economia del lavoro e delle organizzazioni, con incarichi di direzione in programmi EU sui temi dell’innovazione di prodotto e di processo e dello sviluppo delle risorse umane. È managing partner di WeCanJob.it . Luciano Pero è docente di Organizzazione al MIP del Politecnico di Milano. Si interessa di innovazione organizzativa, architetture dei sistemi informativi, relazioni industriali e mercato del lavoro. Roberto Rossini, sociologo, laureato in scienze politiche, è docente di diritto e metodologia della ricerca sociale presso l’istituto bresciano Maddalena di Canossa. È portavoce dell’Alleanza contro la povertà ed è stato presidente nazionale delle Acli e di Enaip. La crisi pandemica da COVID 19 ha aggravato, e non generato, problemi di lungo corso del mercato del lavoro italiano. È facile intuire che gli effetti nefasti colpiranno soprattutto le fasce più deboli della società: lavoratori, precari, piccoli imprenditori, autonomi, disoccupati. Con un percorso di analisi e proposte concrete utile nella progettazione esecutiva del Next Generation Italia, gli autori del presente volume suggeriscono come realizzare un nuovo mix di “saperi” e “saper fare” di cui in troppi lamentano la carenza: un’autentica “fabbrica delle competenze e della dignità”, una filiera ininterrotta in grado di allineare chi entra e chi opera sul mercato del lavoro con le dinamiche produttive del XXI secolo.
«La scoperta del proprio talento rappresenta il fondamento del cammino virtuoso, che prosegue nei percorsi professionalizzanti che miscelano formazione e lavoro, alimentato infine nei continui processi di apprendimento formale e non formale nelle aziende, ambiti ove costruire e manutenere, e non solo fruire, le competenze critiche. Proprio l’investimento sulle nuove competenze tecnico-professionali costituisce il fattore decisivo per innalzare il tasso di occupabilità individuale, solido argine a sostegno di una dignità sociale oggi in pericoloso appannamento» (quarta di copertina). Come già accennato, in fondo al libro si trovano alcune esperienze di stakeholder rilevanti del mondo dell’impresa (mi riferisco all’intervento di Saleri), del sindacato (Benaglia), degli operatori della formazione professionale (Vacchina), dell’istituzione pubblica per le politiche del lavoro (Marsala), sollecitando già nel testo un confronto nel merito delle proposte. PNRR sta per Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e fa parte del programma europeo noto come Next Generation EU, un fondo per la ripresa europea da 750 miliardi di euro. Come il nostro libro indica, il piano punterà molto sul potenziamento della formazione, elemento chiave per ridurre le disparità sociali, la povertà e le situazioni di disagio ed emarginazione. Essere disposti e impegnarsi a essere formati e orientati affina le nostre inclinazioni e i nostri talenti per servire il Signore e i fratelli. Ciò rende la nostra vita piena, partecipativa e fruttuosa.
«La carità del sorriso»
Giovanni Paolo I Beato
di Andrea Drigani · Il 13 ottobre Papa
Francesco ha autorizzato la Congregazione
delle Cause dei Santi ha promulgare il
Decreto riguardante il miracolo
attribuito all’intercessione del
Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I
(Albino Luciani), nato nel 1912 e morto
nel 1978.
Giovanni Paolo I, che fu Sommo Pontefice per trentatre giorni,
verrà pertanto inserito nel catalogo dei Beati.
A questo annuncio mi sono venute in mente le parole del
cardinale Pericle Felici che aveva scritto: «Nel rapidissimo
arco del suo pontificato ha riversato copiosamente quella che
chiamerei la carità del sorriso».
E proprio la carità fu oggetto dell’ultima udienza generale
tenuta da Giovanni Paolo I, il 27 settembre 1978, il giorno
prima della sua morte, avvenuta, appunto, il 28 settembre.
Papa Luciani esordì con una preghiera notissima intarsiata di
frasi bibliche: «Mio Dio, amo con tutto il cuore sopra ogni
cosa Voi, bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor
Vostro amo il prossimo mio come me stesso e perdono le offese
ricevute. O Signore, ch’io vi ami sempre più».Giovanni Paolo I volle spiegare questa preghiera cominciando dalla parola «amo». Ricordò che l’«Imitazione di Cristo» dice che chi ama «currit, volat, laetatur» (corre, vola e gode). Amare Dio, osservava, è dunque un viaggiare col cuore verso Dio. Il viaggio porta anche dei sacrifici, ma questi non devono fermarci. L’amore a Dio è anche un viaggio misterioso: io non parto cioè, se Dio non prende per primo l’iniziativa. E la libertà umana? Sant’Agostino rileva che Dio non soltanto ti attira in modo che tu stesso voglia, ma perfino in modo che tu gusti di essere attirato. «Con tutto il cuore». Giovanni Paolo I notava come il termine «tutto» potrebbe fare riferimento al totalitarismo, che in politica è pessima cosa, ma nella vita di fede un nostro totalitarismo nei confronti di Dio va benissimo (cfr. Dt 6, 5-9). Quel «tutto» ripetuto e piegato alla pratica con tanta insistenza è la bandiera del massimalismo cristiano. Ed è giusto. È troppo grande Dio, troppo egli merita da noi. Egli è bene infinito e sarà nostra felicità eterna: i denari, i piaceri, le fortune di questo mondo al suo confronto, sono appena frammenti di bene e momenti fugaci di felicità. Non sarebbe saggio – diceva Papa Luciani – dare tanto di noi a queste cose e poco di noi a Gesù. «Sopra ogni cosa». Si viene ad un confronto diretto tra Dio e l’uomo, tra Dio è il mondo. Non sarebbe giusto dire: O Dio o l’uomo. Si devono amare Dio e l’uomo; quest’ultimo, però, mai più di Dio o contro Dio o alla pari di Dio. L’amore di Dio è bensì prevalente, ma non esclusivo. «E per amor vostro amo il prossimo mio». Siamo qui di fronte – aggiungeva Giovanni Paolo I – a due amori che sono fratelli gemelli e inseparabili. Alcune persone è facile amarle; altre è difficile; non ci sono simpatiche, ci hanno offeso e fatto del male; soltanto se amo Dio, arrivo ad amarle, in quanto figli di Dio e per questo me lo domanda. «Perdono le offese ricevute». A questo perdono – rilevava Papa
Luciani – pare quasi che il Signore dia precedenza sul culto: «Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a ad offrire il tuo dono» (Mt 5, 23-24). «Signore, ch’io vi ami sempre più». Amare Dio – concludeva Giovanni Paolo I – è, come si è visto, un viaggio: Dio lo vuole sempre più intenso e perfetto. Ha detto ai suoi: «Voi siete la luce del mondo, il sale della terra» (Mt 5,8); «siate perfetti com’è perfetto il vostro Padre celeste» (Mt 5,48). Ciò significa: amare Dio non poco, ma tanto, non fermarsi al punto in cui si è arrivati, ma col suo aiuto, progredire nell’amore. La morte di Giovanni Paolo I – scrisse Madre Teresa di Calcutta – è un mistero che dobbiamo accettare; non ci sono spiegazioni umane. Il suo passaggio ha dato una dimostrazione della vitalità della Chiesa. Eberhard Jüngel (1934-2021), uno degli ultimi grandi teologi del secondo Novecento
di Gianni Cioli · Eberhard
Jüngel, recentemente scomparso
all’età di 86 anni (5 dicembre
1934 – 28 settembre 2021), è
stato un teologo luterano
tedesco particolarmente noto
anche nell’ambito della teologia
cattolica italiana. Professore
Emerito di Teologia Sistematica
e Filosofia della Religione
presso la Facoltà di Teologia Protestante dell’Università di
Tubinga, può certamente essere considerato uno degli ultimi
grandi teologi del secondo Novecento. «Era un pensatore
cresciuto nel vecchio stile della formazione teologica
tedesca: una formazione ampia e consolidata: lingue classiche,
filosofia, Hegel, Heidegger, Schleiermacher, Bultmann e i suoi
allievi. E, naturalmente, Karl Barth, di cui diceva: “È un mio
maestro, ma io non sono un suo scolaro”. Queste
caratteristiche fanno di Jüngel appunto, per molti versi, un
teologo ben inscritto nel solco della generazione precedente»
(vedi)
I suoi libri, non moltissimi ma assai significativi, risultano
«scritti in maniera complessa: una costruzione in periodi
molto articolati nella subordinazione delle frasi, ma anche
uno stile rigorosissimo, tale che, applicandocisi con impegno,
la loro leggibilità alla fine premia il lettore» (Ibid.). Fra
le sue opere pubblicate in italiano si possono segnalare:
Morte, Queriniana, Brescia, 1972; Paolo e Gesù, Paideia,
Brescia, 1978; L’essere di Dio è nel divenire, Marietti,
Casale Monferrato, 1986; Dio, mistero del mondo, Queriniana,
Brescia, 1982; Possibilità di Dio nella realtà del mondo,
Claudiana, Torino, 2005; L’avventura di pensare Dio,
Claudiana, Torino, 2007.
Pur mantenendo sempre netta la propria identità e appartenenza
ecclesiale, Jüngel si è dimostrato un autore autenticamenteecumenico nella sua capacità di fare teologia con una visione aperta. Come ha osservato, in effetti, Giuseppe Lorizio, quello che colpisce ad esempio «nella sua riflessione intorno a Dio mistero del mondo (Queriniana, 1982) è l’attenzione che da parte di un teologo certamente di matrice luterana» viene «rivolta alla dimensione cosmico-antropologica della Rivelazione e l’elaborazione della dottrina dell’analogia, ritenuta comunemente monopolio dell’ambito propriamente cattolico-tomista» (vedi). Personalmente mi sono imbattuto nella teologia di Jüngel nell’ambito della ricerca teologico morale quando, grazie alla frequentazione del pensiero etico teologico di Klaus Demmer, ho avuto modo di approfondire il significato esistenziale della morte come imprescindibile orizzonte delle scelte umane in relazione alla vicenda pasquale di Cristo. Jüngel dedicò in effetti proprio al tema della morte una delle sue prime e più significative monografie. Secondo la sua interpretazione, l’essenza della morte consiste nell’«irrelazionalità», ovvero nella solitudine, come lo stesso Gesù ha sperimentato sulla croce. Ma, proprio per questo, la morte può e deve diventare ciò che l’ha resa il Signore nel suo abbandono al Padre nell’esperienza stessa della croce: l’attestazione del primato di Dio e non di altri sulla nostra esistenza, perché là dove non possiamo fare nulla, nella nostra assoluta impotenza, egli è presente per
noi. Riporto alcuni stralci della monografica in questione che illustrano bene l’idea di morte come «irrelazionzionalità» a partire dall’antropologia veterotestamentaria. Si tratta di brani che confermano l’impressione di come la scrittura di Jüngel sia effettivamente tanto complessa e impegnativa, quanto proficua e arricchente per il lettore disposto a misurarsi con la fatica del concetto. «Che la morte sia stipendio del peccato è affermato (…) solo nel Nuovo Testamento, e più precisamente in un contesto che parla del superamento di questa morte. Tuttavia, nell’intero arco dell’Antico Testamento, la morte si presenta con un’affinità specifica con la colpa di cui l’uomo, da vivo, ha sciaguratamente oberato la sua vita. La morte non getta soltanto la sua ombra sulla vita umana. Piuttosto si deve dire che l’ombra proiettata dalla morte è l’ingrandimento sinistro dell’ombra originaria che dalla nostra vita cade sulla nostra fine. (…) Si può esprimere sinteticamente quest’importante fatto con la tesi che soltanto ciò che nel corso della nostra vita facciamo di essa rende la morte una potenza minacciosa non solo per i singoli individui ma anche per le intere comunità, anzi per i popoli»: (E. JÜNGEL, Morte, Brescia 1972, 110-111). «La valorizzazione massima della vita, quale rifiuto della morte (di fronte alla morte), operata dall’Antico Testamento, permette la formulazione di una chiara comprensione teologica di quello che è propriamente il fenomeno antropologico della morte. Si deve quindi prendere le mosse dalla vita. La valorizzazione massima della vita scaturisce dalla fede in Jahvé quale sorgente e pienezza della vita. L’uomo perciò, per parte sua vive perché e in quanto Jahvé sta in rapporto con lui, che a sua volta si rapporta a Jahvé in modo corrispondente al rapporto che Dio intrattiene con lui. L’uomo si differenzia da Dio proprio perché si rapporta a colui dal quale trae la sua vita. “Vivere”, quindi, nell’Antico
Testamento significa avere un rapporto. Anzitutto, avere un rapporto con Dio, il rapporto cioè di una provvidenziale distanza che, sola, rende possibile un retto rapporto. La vita dell’uomo dell’Antico Testamento è determinata da dei rapporti, da dei rapporti chiari; essi sono regolati dalla Legge: rapporti chiari con il prossimo, con il popolo, con se stessi e con Dio. L’uomo può tentare di offuscare e sovvertire questi rapporti chiari. Ogni tentativo di distruzione di questi rapporti vitali è detto dall’Antico Testamento peccato, cioè ribellione contro Dio, che in ogni rapporto vitale è già sempre in relazione con l’uomo. Il peccato priva dei rapporti, rende isolati. Ora la morte è risultato di questa tendenza alla distruzione dei rapporti. Per questo antropologicamente la morte non è presente soltanto alla fine della vita, ma in ogni suo istante come reale possibilità in virtù della tendenza all’irrelazionalità. (…) L’uomo morto però non è privo di rapporti solo nei confronti di tutto ciò che è diverso da lui, ma anche, e in primo luogo, rispetto a se stesso: “I viventi (almeno) sanno che devono morire, i morti invece non lo sanno più” (Qo 9,5)» (Ibid., 114-115). Le scuole religiose nel mondo mussulmano e il loro ruolo nei conflitti in Asia Centrale e nel terrorismo.
di Carlo Parenti · Negli anni
passato ho compito numerosi
viaggi in Asia centrale. Ho
visitato bene Turkmenistan,
Tagikistan, Kirghizistan,
Kazakistan, Uzbekistan. I
confini geografici dell’Asia
centrale sono stati soggetti nel
tempo a varie definizioni, anche se l’accezione più diffusa
rimane quella che include le cinque citate repubbliche ex-
sovietiche, ora indipendenti.
l’’UNESCO definisce invece i confini della regione in base a
criteri storico-culturali includendo così anche altri Stati:
la Mongolia, la Cina occidentale (incluso il Tibet), il nord-
est dell’Iran, l’Afghanistan, parte della Russia e le parti
settentrionali di India e Pakistan.
Ho comunque visitato il Pakistan in particolare il suo nord
fino al confine con la Cina (e qui non ho potuto entrare nella
cinese Regione autonoma Uigura dello Xinjiang), la Mongolia,
l’india e il suo settentrione, l’Iran, la Russia in molte sue
repubbliche. Ho anche provato a entrare in Afghanistan, ma al
Khyber Pass non mi hanno fatto passare. Diciamo che ho “visto”
i poverissimi villaggi del lungo confine afgano con il
Tagikistan.
Dovunque è fortemente presente l’Islam. Infatti, la religione
più diffusa in Asia centrale è l’Islam sunnita, in particolare
la scuola Hanafi; gruppi sciiti sono presenti in scarso numero
in tutte le repubbliche, in particolare tra la minoranza
azera. Il cristianesimo è la seconda religione più diffusa,
perlopiù con la Chiesa ortodossa russa. Piccolissime sono le
sparse minoranze zoroastriane, ebree -specie bukhariane-,
buddiste.
Mi soffermerò qui sulla presenza mussulmana e in particolare
sul ruolo delle madrase e l’influenza dell’estremismoreligioso nei violenti conflitti della regione e nelle azioni terroristiche. Negli ultimi anni, infatti, si è molto discusso delle connessioni tra estremismo islamico e terrorismo transnazionale. Uno degli elementi più controversi del problema è quello della diffusione del fondamentalismo in una parte delle scuole islamiche. Il fatto che molti leader del terrore, operativi di Al-Qa’ida e talebani, i militanti dell’Isis siano stati istruiti in sistemi scolastici religiosi ha focalizzato su di questi l’attenzione (si veda l’analisi storica di Carlo Centoducati) da cui colgo alcuni spunti e citazioni. Iniziamo dal ruolo delle madrase: “In linea generale nel mondo musulmano accanto alla scuola pubblica esistono due tipologie di scuole islamiche: le maktab, o scuole coraniche, dedicate all’istruzione religiosa di base, e le madrase, centri di studio avanzato. Le maktab sono scuole di piccole dimensioni, spesso improvvisate, in cui si insegnano la lettura e la recitazione del Corano. Il termine madrasah indica invece istituzioni più organizzate, spesso anche in grado di ospitare gratuitamente gli studenti. Madrasah costituisce senza dubbio il termine più conosciuto in riferimento al sistema di istruzione -solo per i maschi- in vigore nei Paesi islamici. Da sottolineare che non esiste un modello generale di madrasa, infatti, finalità e strutture variano da Paese a Paese. In alcuni Stati, questi organismi sono però fonte di preoccupazione, principalmente a causa di infiltrazioni fondamentaliste”. In Pakistan -il paese più attenzionato sul piano del fondamentalismo e il quinto più popoloso nel mondo,
con una popolazione superiore ai 224 milioni di persone – alcune stime riportano più di 45.000 madrase e una percentuale dei frequentanti pari al 33% della popolazione studentesca totale. Altri dati invece riferiscono che le scuole religiose oggi sono circa 35.000 ed accolgono tra i due milioni e mezzo e i tre milioni di studenti. Erano poco più di duecento tali scuole nel momento dell’indipendenza nel ’47. L’assenza di criteri di selezione e di rette scolastiche per gli studenti ha portato le madrase ad accogliere per lo più bambini e giovani studenti provenienti dalle aree rurali del Paese e da famiglie sotto la soglia di povertà o appartenenti alle fasce meno abbienti della popolazione. Le madrase, dunque, svolgono non solo un ruolo formativo ma anche socio-assistenziale nei confronti della popolazione, agendo talvolta come organizzazioni non governative e colmando quelle lacune del sistema di welfare nazionale a cui il governo non riesce a far fronte. A seconda dei fondi a disposizione, infatti, le madrase offrono ai propri studenti vitto e alloggio oltre alla partecipazione ai corsi scolastici. (si veda Francesca Manenti, Il Pakistan alla prova della deradicalizzazione. ) Circa il 97,0% dei pakistani sono musulmani.Circa il 75% di essi sono sunniti ed è presente una corposa minoranza di circa il 25% di sciiti. L’attività politica delle madrase pakistane è notevole. “A preoccupare maggiormente è il dato relativo al gran numero di studenti provenienti da quasi tutte le aree di crisi, dai Balcani alla Cecenia, alle Filippine, alle Repubbliche centroasiatiche, al medio oriente e la tendenza di alcune madrase ad interrompere la propria attività nei periodi in cui le crisi internazionali raggiungono il punto di massima asprezza, che hanno condotto alcune autorevoli istituzioni a temere che gli studenti siano inviati all’estero per combattere la jihad islamica”. L’autoreferenzialità e la forte
componente ideologica integralista che caratterizza l’indottrinamento impartito talvolta hanno reso alcuni di questi istituti incubatrici ideali di radicalizzazione. “Nel corso degli ultimi anni si è verificato un cospicuo aumento delle iscrizioni alle madrase, accompagnato da un’ampia opera di espansione infrastrutturale che ha sollevato non poche perplessità. Sebbene vi sia un certo malcontento per la facilità con cui le autorità concedono appezzamenti ed infrastrutture ai leader religiosi, l’attenzione degli analisti va concentrandosi soprattutto sui metodi e sull’entità dei finanziamenti, spesso occulti, destinati alle madrase. In questo contesto, una fonte non trascurabile è costituita dalla filantropia religiosa della sadiqa e della khairat (Donazioni caritatevoli” volontarie), di origine sia estera -proveniente soprattutto dal Golfo Persico e in particolare dall’Arabia Saudita- che interna”. Per approfondire il tema della devoluzione di ingenti finanziamenti alle scuole religiose con cui facoltosi protettori, interni o esterni al Paese, cercano di sponsorizzare un’interpretazione wahabita o salafita dell’Islam, tipica della Arabia saudita e dei paesi del golfo, si veda : Soldi, madrasa e jihad: il segreto di Pulcinella del Pakistan su Limes. Negli ultimi 30 anni “il Pakistan è stato il Paese in cui le sette religiose sono state maggiormente strumentalizzate nello scontro politico interno ed internazionale. Come internazionalmente riconosciuto, il fondamentalismo che flagella il Paese è in buona parte il risultato della continua strumentalizzazione degli ulamā nella storia di questo Paese e del mancato riassorbimento dei mujaheddin formati lungo il confine afghano-pakistano ai tempi della jihad antisovietica. In quel particolare momento storico, una radicalizzazione religiosa fu, per varie ragioni, considerata utile e col supporto di altri fattori si rivelò vincente. L’instaurazione del regime talebano in Afghanistan, il peso crescente del
fondamentalismo nella politica pakistana, il proliferare di forze antioccidentali che professano l’unità della nazione islamica, l’emergere di organizzazioni criminali e terroristiche attive in ogni dove, costituiscono gli effetti più evidenti non solo della sopravvivenza degli ideali professati dai mujaheddin e di un’offensiva portata ai vecchi partner, ma anche del radicamento degli ex-guerriglieri negli ambienti più influenti di molti Paesi e della loro capacità di produrre consenso” Venendo alle recenti vicende afgane dobbiamo inoltre ricordare che le scuole dove si impara il Corano, solo per maschi, per la maggioranza delle famiglie sono l’unica via per avere cibo e istruzione. Ora, con i talebani –che letteralmente vuol dire studenti coranici, inizia una nuova era fondamentalista e penalizzante le donne. Tutto quanto premesso non tutte le madrase, ma solo una minoranza non solo pakistana purtroppo sono incubatrici di un terrorismo internazionale. Concludo con le parole di papa Francesco pronunciate durante la sua visita nel marzo 2021 a Mosul in Irak e nella zona di Nassiriya, devastate da attentati terroristici: «Dio è misericordioso e l’offesa più blasfema è profanare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo religioso: sono tradimenti della religione. E noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione» Nel novembre 2020, Papa Francesco aveva condannato attentati sanguinosi, pur guardandosi bene dall’etichettarli islamici. «I gravi attentati che hanno insanguinato l’Europa da Nizza a Vienna e la popolazione che li ha subiti sono nel pensiero e nella preghiera del Papa e sono deprecabili eventi che cercano di compromettere con la violenza e l’odio la collaborazione fraterna tra le religioni».
Nell’enciclica “Fratelli tutti” il papa autorevolmente scrive
(n. 283) che: «Il culto a Dio, sincero e umile, porta non alla
discriminazione, all’odio e alla violenza, ma al rispetto per
la sacralità della vita, al rispetto per la dignità e la
libertà degli altri e all’amorevole impegno per il benessere
di tutti. In realtà, “chi non ama non ha conosciuto Dio,
perché Dio è amore”» (1Gv 4,8)”
I cambiamenti culturali e
generazionali non incidono
sull’identità della Chiesa,
la cui forma giuridica è
segno esteriore della sua
vita interna
di Francesco Romano • Il nuovo Israele,
costituito in nuovo Popolo di Dio per
fondersi in unità non secondo la carne, ma
nello Spirito, nasce dal nuovo patto
istituito nel sangue di Cristo. Un tempo
non era neppure popolo, ma ora è il Popolo
di Dio perché è stato rigenerato di un
seme incorruttibile. Questo popolo, che è
la Chiesa, è caratterizzato dalla sua
stessa origine avendo per capo Cristo, per
condizione la dignità e la libertà dei
figli di Dio, per legge il precetto di amare come lo stesso
Cristo ci ha amati, per fine il Regno di Dio. La Chiesa, purapparendo talora piccolo gregge, è stata costituita come sacramento visibile di questa unità salvifica per tutti e per i singoli. La Chiesa, pertanto, ha origine dalla volontà fondazionale di Cristo. Il popolo messianico, infatti, ha per capo Cristo, ha per legge il precetto di amare, è costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità, e di verità come pure è da Lui assunto per essere strumento di redenzione per tutti (LG, 9). La Chiesa, a differenza delle società naturali, non risponde alle istanze del diritto naturale dei giusnaturalisti. Essa è un’emanazione non della società naturale, bensì della volontà fondazionale di Cristo. Il Concilio Vaticano II molto diffusamente ha applicato il termine “società” alla Chiesa. Essa è definita società visibile e comunità spirituale (GS 40, 2). La Chiesa nella sua dimensione sociale ha un aspetto istituzionale che le viene dalla sua organizzazione giuridica che struttura la società e la organizza. Tuttavia, la Chiesa, considerata nella totalità del suo essere realtà sociale, trascende l’aspetto meramente giuridico del suo ordinamento per completarsi ed essere identificata con la componente pneumatica. Essa, sottolinea la Lumen Gentium, insieme alla Chiesa che è “ormai in possesso dei beni celesti, forma una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per una non debole analogia, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato” (LG 8, 1). La Chiesa, quindi, è una vera società che nasce da un atto di amore di Dio-Cristo, ma non come esigenza della natura sociale degli uomini. Essa persegue il fine che le è proprio, il bene comune soprannaturale, la salus animarum di ogni battezzato nella totalità del suo essere persona nella Chiesa. Pio XII nell’enciclica Mystici Corporis delinea i tre momenti
dellafondazionedellaChiesa:Cristoconlapredicazione cominciò l’istituzione della Chiesa, nel sacrificio della croce la consumò, il giorno di Pentecoste la manifestò (AAS 35 (1943) 204-207). La Chiesa è visibile nella sua struttura sociale, “l’organismo sociale della Chiesa è a servizio dello Spirito di Cristo che lo vivifica, per la crescita del corpo” (LG 8 n.1). Divenuti christifideles per il battesimo, i membri della Chiesa entrano a far parte del suo corpo sociale, acquistano lo stato giuridico di cittadino, cioè soggetto di diritti e di doveri. Illuminanti, a questo proposito, sono le parole di Paolo VI: “Tutti gli elementi istituzionali e giuridici sono sacri e spirituali, perché vivificati dallo Spirito Santo. In realtà lo “Spirito” e il “Diritto” nella loro stessa fonte formano un’unione, in cui l’elemento spirituale è determinante; la Chiesa del “diritto” e la Chiesa della “carità” sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica” (Discorso al Congresso Internazionale di Diritto Canonico in Communicationes 5(1973)126-130) La visibilità della Chiesa nei suoi elementi esteriori ci interroga sulla sua immutabile identità ontologica. Passano le generazioni di fedeli come pure le situazioni storiche. I cambiamenti culturali e generazionali non incidono sull’identità della Chiesa. Il concetto giuridico di “istituzione” applicato alla Chiesa soddisfa il senso della domanda. Cristo è il capo della Chiesa, la presenza divina e immutabile. L’atto fondazionale della Chiesa è unico ed
esclusivo di Cristo. L’ordinamento giuridico che si concretizza nell’organizzazione della Chiesa proviene dal suo Fondatore. La struttura istituzionale è l’oggettivazione dell’atto istituzionale di Cristo; essa garantisce l’immutabilità dell’identità nonostante il succedersi degli individui e delle generazioni. La società – i fedeli organizzati in corpo sociale – è la forma che la Chiesa assume come istituzione. Essa possiede come nota peculiare di essere transpersonale e di avere una struttura organica, “Questa Chiesa, in questo modo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui” (LG 8 n.2). La sua struttura societaria è dovuta a vincoli di unione istituzionalizzati che realizzano la comunione ecclesiastica e creano relazioni giuridiche. Si pensi alla partecipazione ai beni salvifici, alla comunione di fede, agli uffici e alle funzioni di insegnare, di santificare e di governare che perpetuano l’opera salvifica di Cristo, all’organizzazione ecclesiastica. Sono questi gli elementi sostanziali immutabili dell’ordinamento giuridico, cioè della Chiesa-istituzione, corrispondenti alla volontà fondazionale di Cristo. La Chiesa-istituzione riceve dal suo Fondatore un ordinamento giuridico primario e originario. Gli elementi essenziali dell’ordinamento giuridico manifestano permanentemente l’opera salvifica di Cristo, sono costitutivi e connaturati con il progetto fondazionale, rappresentano le coordinate permanenti della Chiesa-istituzione: il popolo adunato dalla Parola, la professione di fede, i sacramenti, i carismi, il culto divino, i “tria munera”, la custodia del deposito rivelato, il governo ecclesiastico. È questo l’ordinamento sostanziale, l’insieme degli elementi costitutivi immutabili voluti da Gesù Cristo quando ha fondato la Chiesa-istituzione. Vi sono, poi, nella Chiesa-istituzione, elementi variabili che
costituiscono l’ordinamento formale, detto anche materiale, cioè la realizzazione storica del popolo di Dio, il modo concreto con cui nel suo divenire si configura all’immutabile volontà di fondazione, la struttura che si attua, l’incarnazione dell’ordinamento sostanziale, l’insieme delle norme e il sistema di rapporti che reggono il corpo sociale. Nella concezione della Chiesa come sacramento, il dono invisibile di Dio – il carisma – si manifesta attraverso il segno visibile dell’istituzione. La Chiesa è nello stesso tempo carismatica e istituzionale. La Chiesa è un’unica realtà di ordine pneumatico e spirituale (cf. PIO XII, encicl. Mystici Corporis, in AAS 35 (1943) 224). In questo modo il rapporto tra carisma e istituzione viene sottratto a una lettura spesso riduttiva quando i due termini sono presentati in conflitto tra di loro. La Chiesa- istituzione nei suoi elementi essenziali è irriformabile. Può essere riformabile, invece, solo a livello di ordinamento formale. Anzi, è necessario che ciò avvenga perché la Chiesa sia segno sacramentale di salvezza sempre più autentico e fedele alla volontà del suo Fondatore, quel perfezionamento costante della relazione tra la Chiesa del diritto e la Chiesa della carità che sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica. Ripartire dai giovani e con i giovani. Il messaggio di Papa Francesco per la XXXVI GMG
di Stefano Liccioli · Da
quest’anno, per la prima volta,
la celebrazione diocesana della
Giornata Mondiale della Gioventù
si terrà la Domenica di Cristo Re
e non più quella delle Palme,
così com’era stato fin dal 1985,
anno della sua istituzione. Un cambiamento di data che però
non altera l’elemento fondante di questa iniziativa e cioé il
Mistero di Gesù Cristo Redentore dell’uomo, come ha sempre
sottolineato San Giovanni Paolo II, iniziatore e patrono delle
GMG.
Il titolo della Giornata Mondiale della Gioventù 2021 fa
riferimento al versetto degli Atti degli Apostoli:«Alzati! Ti
costituisco testimone di quel che hai visto!» (cfr. At 26,16),
tratto dalla testimonianza di Paolo di fronte al re Agrippa,
mentre si trova detenuto in prigione. Si potrebbe dire che il
Papa nel messaggio per questa ricorrenza usi la figura di San
Paolo per una catechesi ai giovani, breve, ma densa di
significato.
Il Santo Padre ricorda innanzitutto come la fede in Gesù non
sia frutto di un ragionamento, ma di un incontro personale con
Lui perché solo un incontro di questo tipo è in grado di
cambiare la vita: «Non basta aver sentito parlare di Cristo da
altri, è necessario parlare con Lui personalmente. Questo, in
fondo, è pregare. È un parlare direttamente a Gesù, anche se
magari abbiamo il cuore ancora in disordine, la mente piena di
dubbi o addirittura di disprezzo verso Cristo e i cristiani».
Se si sta accanto ai giovani si percepisce che molti di loro
hanno davvero il cuore in disordine, la mente affollata da
dubbi che aspettano di condividere con qualcuno che li sappia
ascoltare. Purtroppo in questi anni abbiamo dovuto registrare
troppo spesso l’ “abbandono” delle nuove generazioni da parte
degli adulti: questi sovente abdicano al loro ruolo di
educatori, rinunciano a confrontarsi con ragazzi e ragazzi,preferendo la delega esclusiva agli specialisti. Il pontefice sembra invece conoscere bene l’animo dei più giovani, agitato da passioni e paure, radicato in convinzioni e certezze che rischiano però di ingabbiarli in delle presunte verità assolute, impedendo loro un incontro autentico con la realtà ed anche con Cristo. D’altra parte Papa Francesco appare essere consapevole quanto sia necessaria un’ermeneutica dei giovani, interpretare quanto dicono e fanno per andare alle radici delle loro vere intenzioni. Scrive Bergoglio:«Quanti giovani hanno la passione di opporsi e andare controcorrente, ma portano nascosto nel cuore il bisogno di impegnarsi, di amare con tutte le loro forze, di identificarsi con una missione! Gesù, nel giovane Saulo, vede esattamente questo». Al di là di tutto il Santo Padre richiama ragazzi e ragazze all’autenticità, in un’epoca in cui l’apparenza, il mostrarsi sembra più importante dell’essere:«Oggigiorno tante “storie” condiscono le nostre giornate, specialmente sulle reti sociali, spesso costruite ad arte con tanto di set, telecamere, sfondi vari. Si cercano sempre di più le luci della ribalta, sapientemente orientate, per poter mostrare agli “amici” e followers un’immagine di sé che a volte non rispecchia la propria verità. Cristo, luce meridiana, viene a illuminarci e a restituirci la nostra autenticità, liberandoci da ogni maschera. Ci mostra con nitidezza quello che siamo, perché ci ama così come siamo». Interessante poi il passaggio del messaggio in cui il Papa ricorda che Saulo in qualche modo – senza saperlo – aveva incontrato Cristo, incontrandolo nei cristiani che perseguitava:«Quante volte abbiamo sentito dire: “Gesù sì, la Chiesa no”, come se l’uno potesse essere alternativo all’altra. Non si può conoscere Gesù se non si conosce la Chiesa. Non si può conoscere Gesù se non attraverso i fratelli e le sorelle della sua comunità. Non ci si può dire pienamente
Puoi anche leggere