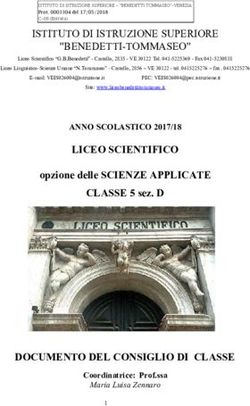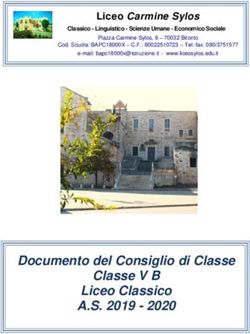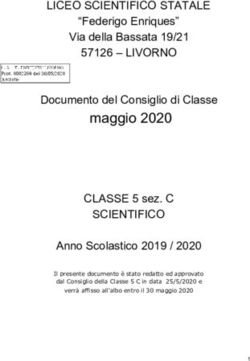Documento del Consiglio di Classe - Liceo ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini”
Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa
tel.: 050 20036 fax: 050 29220
http://www.liceodini.it/
pips02000a@istruzione.it
Esame di Stato 2019/2020
Documento del Consiglio di Classe
Classe V Sez. F
Indirizzo: SCIENTIFICO1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
1.2 Finalità dell’indirizzo e quadro orario
1.3 Presentazione e storia della classe
2. CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SUL PERCORSO FORMATIVO
2.1 Obiettivi formativi trasversali
2.2 Metodologie e strategie per l’apprendimento
2.3 Ambienti di apprendimento: strumenti/Spazi/Tempi
2.4 Valutazione degli apprendimenti anche nella Didattica a distanza
2.5 Credito scolastico
2.6 Verifiche e valutazioni effettuate in preparazione all’esame di Stato
2.7 Percorsi formativi, progetti, attività extracurricolari, attività di Potenziamento
2.8 Osservazioni sulla preparazione della classe all’Esame di Stato
3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
3. 1 Caratteristiche generali del progetto di scuola
3. 2 Particolarità dei singoli percorsi
4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
4.1 Indicazione dei temi trattati
5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
5.1 Prima prova
5.2 Seconda prova
6. RELAZIONI E PROGRAMMI
6.1 Relazioni e percorsi effettivamente svolti
7. ALLEGATI
7.1 Percorsi, progetti e attività
7.2 Caratteristiche generali del progetto di scuola (PCTO)
7.3 Particolarità dei songoli percorsi (PCTO)
8. ALTRO
8.1 Griglie di valutazione
8.2 Elenco testi d’Italiano per la fase 2 del colloquio
21.1 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTE MATERIA INSEGNATA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
PANICUCCI Paola Italiano* si si si
PANICUCCI Paola Latino* si si si
COPPINI Maria Cristina Storia* si si si
COPPINI Maria Cristina Filosofia* si si si
FINZI Mughetto Lingua straniera Inglese* si si si
MIGLI Elisabetta Matematica* si si si
MIGLI Elisabetta Fisica* si si si
LAMI Chiara Scienze si
ALTERISIO Maria Scienze* si su
GIANNETTONI Isabella Disegno e Storia dell’Arte* si si si
BECHELLI Alessandra Scienze motorie* si si si
NOTTURNI Paolo IRC/Att.alternativa si si si
* Commissari interni
1.2 Finalità dell’indirizzo e quadro orario
In accordo con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, il Liceo Dini si è sempre proposto come
finalità la formazione di un cittadino consapevole, educato allo spirito critico, all'esercizio responsabile della
libertà, al rispetto delle diversità. A tal fine il liceo assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità e
l’educazione alla parità tra i sessi nell’ottica di prevenire le violenze di genere e tutte le discriminazioni. Sul
piano culturale, mira alla preparazione di uno studente dotato di una solida formazione di base, il quale,
all’interno di un percorso di studi scientifico nei metodi di indagine e nell’indirizzo delle conoscenze, abbia
ricevuto una preparazione di qualità anche nell’ambito umanistico, avendo modo di acquisire nel tempo la
piena consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi e risultando in grado di proseguire gli
studi in qualunque settore, in una prospettiva di formazione permanente e ricorrente. La scuola ribadisce
l’impegno a utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui riuscirà a disporre per offrire alle
proprie studentesse e ai propri studenti elevati livelli di istruzione e solide competenze, mediando
opportunamente fra tradizione e innovazione.
Insegnamenti obbligatori I biennio II biennio V anno
Lingua e lett. Italiana ** 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura 3 3 3 3 3
straniera*
Storia e Geografia 3 3
3Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
(con informatica al primo
biennio)
Fisica** 3 3 3 3 3
Scienze Naturali ** 3 3 3 3 3
(Biologia, Chimica e Scienze
della Terra)
Disegno e St. Arte 2 2 2 2 2
Scienze Motorie 2 2 2 2 2
Religione cattolica o 1 1 1 1 1
Attività alternative
TOTALE 29 29 30 30 30
*Lingua Inglese o Francese (sezione C) o Tedesca (sezione A). Nel 2° biennio e 5° anno della sezione C di Francese (ESABAC) le ore di lingua straniera
sono 4.
** Nelle classi prime e seconde è stata aggiunta un’ora di Fisica al piano di studi ministeriale in orario mattutino.
1.3 PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE
Presentazione e storia della classe 5F
La classe 5F è composta da 23 allievi (14 femmine e 9 maschi) che risultano iscritti per la prima volta
all’ultimo anno di corso. Durante il triennio la composizione è mutata nel modo seguente:
- due alunni si sono aggiunti in terza, uno proveniente dalla 3F dell’anno precedente, e l’altra per
trasferimento da una classe di lingua Tedesca;
- un alunno non è stato ammesso alla classe quarta;
- due alunni non sono stati ammessi alla classe quinta.
Il gruppo classe attuale è costituito da allievi tutti provenienti dalla prima F, più l’alunna che si è aggiunta in
terza e che si è integrata perfettamente nella classe.
Gli studenti sono sempre stati corretti e responsabili nel corso del quinquennio, ed hanno seguito con
interesse il percorso didattico in tutte le discipline.
Nel corso del triennio gli allievi si sono progressivamente confrontati con l’esigenza di acquisire un metodo di
studio efficace che consentisse di consolidare le competenze e i contenuti proposti dalle varie discipline,
avviando al contempo un percorso di consapevolezza volto ad un impegno più attivo .
4Tuttavia, la partecipazione, per alcuni studenti con indole riservata e poco inclini alla comunicazione, non è
sempre risultata sufficientemente attiva. Ciò ha influenzato maggiormente lo svolgimento delle lezioni nelle
materie linguistico-letterarie.
Il lavoro svolto dai docenti, anche mediante il coinvolgimento degli allievi in progetti di ampio respiro, non si è
tradotto per tutti in una soddisfacente partecipazione attiva che consentisse di sviluppare un’opportuna
capacità di rielaborazione personale e critica dei contenuti assimilati.
Alcuni allievi della classe con impegno e interesse costante, nel corso del triennio, hanno raggiunto risultati di
eccellenza nella maggior parte delle discipline.
Un piccolo numero di allievi ha avuto più di altri, difficoltà a gestire il carico di lavoro, che solo alcuni, in
questa classe, non hanno percepito come eccessivamente gravoso. In alcune discipline, infatti, un metodo di
lavoro inadeguato e un impegno non sistematico, finalizzato di volta in volta al superamento delle singole
verifiche, non ha favorito il processo di evoluzione sperato. A questo ha anche contribuito la difficoltà ad
adeguarsi a nuove strategie didattiche e alle richieste dei docenti.
Da sottolineare, inoltre, che gli elementi di eccellenza presenti hanno esercitato solo in parte una funzione
trainante, anzi spesso si sono adeguati ai livelli di partecipazione della maggioranza e questo, negli anni, ha
influito sulla qualità del lavoro in classe.
In generale, la classe si caratterizza per un esiguo numero di allievi fortemente motivati e con un metodo di
lavoro collaudato che si è evoluto nel triennio e che ha prodotto risultati anche di eccellenza. Questi alunni
sono autonomi e discretamente critici nello studio, anche se non sempre partecipano attivamente allo
svolgimento delle lezioni.
Il resto del gruppo è costituito di elementi dal profitto globalmente soddisfacente anche se con qualche
distinguo.
Tuttavia nel corso del quinto anno anche in questi allievi è stato possibile rilevare una crescente capacità di
autovalutazione, un impegno più omogeneo nello studio e una maggiore consapevolezza delle personali
difficoltà, tanto che alla fine dell’anno, con un adeguato supporto, essi mostrano di aver acquisito le
competenze mediamente adeguate.
Per concludere vorremmo sottolineare che gli studenti si sono sempre positivamente distinti nella
partecipazione ad attività extrascolastiche, dove hanno messo in luce le loro caratteristiche di educazione,
organizzazione e interesse.
La reciproca disponibilità di ragazzi ed insegnanti alla costruzione di un buon dialogo educativo che
si è evoluta negli anni ha determinato un ambiente sereno e produttivo per il lavoro comune.
52. CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SUL PERCORSO FORMATIVO
2.1 Obiettivi formativi:
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning;
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai
legami con il mondo del lavoro;
8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
11) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 12 ) definizione di un
sistema di orientamento.
2.2 Metodologie e strategie didattiche
Il Consiglio di classe ribadisce come fondamento metodologico la centralità dello studente nei processi di
apprendimento. L'attività didattica, nel suo insieme, intende trasmettere allo studente il senso
dell'unitarietà del sapere, attraverso:
§ l'equilibrato approfondimento delle discipline tanto sul versante scientifico quanto su quello umanistico;
6§ il ricorso sistematico ad un approccio interdisciplinare sia dal punto di vista dei contenuti sia da quello
degli strumenti comunicativi e dei linguaggi utilizzati;
§ l'organizzazione di attività integrative facoltative in orario pomeridiano, secondo progetti e iniziative di
singole discipline, aree o gruppi di docenti;
§ il ricorso al laboratorio come luogo di lavoro in comune tra docenti e studenti, di discussione e
progettazione collettiva e come complesso di attrezzature con cui è possibile preordinare da parte dei
docenti, e sperimentare da parte degli studenti, le procedure di verifica induttiva e deduttiva dei
contenuti della disciplina;
§ l'opportunità, fornita allo studente, di essere soggetto attivo, e non passivo, di apprendimento attraverso
la progettazione di percorsi autonomi di ricerca al termine dei quali egli è posto nella condizione di
produrre quanto ha acquisito, e di interagire con ambiti ed interlocutori più ampi e variegati di quelli
scolastici in occasioni quali incontri pubblici, lezioni, conferenze, spettacoli teatrali organizzati
dall'Istituto.
La scuola guarda alla persona dello studente nella sua identità, con i suoi ritmi di apprendimento e le sue
peculiarità cognitive ed affettive al fine di agevolarne l'acquisizione piena delle competenze previste dal
percorso di istruzione. Essa, inoltre, promuove iniziative volte a valorizzare l'eccellenza.
Per quanto sopra sono state utilizzate le seguenti metodologie:
- Lezione frontale o interattiva
- Lavoro di gruppo
- Attività laboratoriale per le lingue, l'informatica, la fisica, la biologia, la chimica e le scienze della terra
- Utilizzo guidato di riviste, libri, sussidi audiovisivi
- Lezioni fuori sede
- Visite guidate
- Partecipazione ai progetti del Liceo
- Compito “autentico”
- Sviluppo di attività e progetti personali
- Pratica laboratoriale
Si fa riferimento alle relazioni delle singole discipline per le metodologie di Didattica a distanza utilizzate
nel periodo di chiusura delle scuole dal 5 Marzo u.s. fino alla fine dell’anno scolastico a causa
dell’emergenza Covid 19.
72.3 Testi adottati
DISCIPLINA AUTORE - TESTO/I UTILIZZATO/I EDIZIONE
I.R.C. Pajer:- VOL. UNICO IN ALLEGATO FASCICOLO SEI
CIOTTI, Non lasciamoci rubare il futuro
Italiano LUPERINI ROMANO CATALDI PALUMBO
PIETRO MARCHIANI L MARCHESE: PERCHE’ LA
LETTERATURA 3 vol.
DIOTTI ANGELO DOSSI SERGIO SEI
Latino SIGNORACCI FRANCO: NARRANT 3 LETTERATURA,
ANTOLOGIA,
CULTURA LATINA
Storia* DE BERNARDI GUARRACINO : EPOCHE 3 EDIZIONE BASE B.MONDADORI
Filosofia* RUFFALDI ENZO NICOLA UBALDO LOESCHER
TERRAVECCHIA GIAN PAOLO: NUOVO PENSIERO PLURALE
(IL) 3A+3B
BASILE FRANCESCA: COMPLETE INVALSI COMPREHENSIVE HELBLING LANGUAGES
PRACTICE FOR THE NEW INVALSI ENGLISH
LANGUAGE TEST IN SSSG
Lingua straniera: Inglese AA VV: GRAMMAR & VOCABULARY FOR REAL WORLD OXFORD UNIVERSITY
STUDENT BOOK S/C + OPENBOOK PRESS
SPIAZZI MARINA TAVELLA MARINA:
PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 (LDM)
FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT
AGE ZANICHELLI
Matematica* BERGAMINI: MANUALE BLU 2.0 DI ZANICHELLI
MATEMATICA, vol.4AB,5
Fisica* HALLIDAY : Fondamenti di Fisica vol.1,2,3, ZANICHELLI
Scienze( Biologia,Chimica) Curtis: Invito alla biologie-Fisiologia umana ZANICHELLI
Brady: Materia e sue trasformazioni
Disegno e Storia dell’Arte* Cricco-Di Teodoro: 5. VERS. 5 ARANCIONE ZANICHELLI
(LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. Dall’art
noveau ai giorni nostri
Scienze motorie Del Nista-Tasselli: il corpo e i suoi linguaggi D’ANNA
2.4 Valutazione degli apprendimenti anche nella Didattica a distanza
L’attribuzione del voto, in sede di scrutinio interperiodale (dicembre) e finale (giugno), avviene su proposta
dei singoli docenti e successiva approvazione del Consiglio di classe, e scaturisce dai seguenti parametri:
81. grado di raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali; 2. progressi rispetto ai livelli di partenza;
3. partecipazione e impegno; 4. esito delle attività di sostegno e di recupero; 5. regolarità della frequenza; 6.
livello culturale globale.
Per il periodo di Didattica a distanza è stato pubblicato un documento con i criteri di valutazione
approvati dal Collegio Docenti in data 13 Maggio 2020.
2.5 Verifiche e valutazioni effettuate in preparazione all’esame di Stato
Simulazioni I prova programmata per Aprile non è stata effettuata a causa della chiusura delle scuole.
Simulazione II prova programmata per Maggio non è stata effettuata a causa della chiusura delle scuole.
Per la valutazione degli apprendimenti durante il periodo di Didattica a distanza si rimanda al documento
approvato dal Collegio il data 13 Maggio e reso noto agli allievi e ai genitori.
2.6 Credito scolastico
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:
per l'attribuzione del punteggio minimo e massimo all'interno della banda di oscillazione (vd. O.M.
44/2010, art. 8, c.2 e DPR 323/98, art. 11 c. 8) vengono considerati:
1)la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 2) altri elementi valutativi:
a) l'assiduità della frequenza scolastica; b) l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo; c) l’IRC, le attività alternative e quelle complementari, nonché i crediti formativi.
Nell'ambito della banda di oscillazione prevista si attribuisce il punteggio inferiore nel caso di
differenza minore o uguale a 0,5 tra la media dei voti e la sua parte intera; in presenza di almeno
due degli altri elementi valutativi, si può attribuire il punteggio superiore anche nel caso in cui la
differenza tra la media dei voti e la sua parte intera sia minore o uguale a 0,5.
Per le nuove tabelle si fa riferimento all’OM n.10 del 16 maggio 2020
2.7 Percorsi formativi, progetti, attività extracurricolari , attività di Potenziamento
(Vedi ALL. n° 1)
2.8 Osservazioni sulla preparazione della classe all’Esame di Stato
Nell’ambito di ciascuna disciplina è stata curata la preparazione al nuovo esame di stato con
particolare riguardo alle novità introdotte, quali l’elaborato e la discussione dei testi.
93. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
3. 1 Caratteristiche generali del progetto di scuola
(Vedi ALL. n° 2)
3. 2 Particolarità dei singoli percorsi
(Vedi ALL. n° 3)
4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
4.1 Indicazione dei temi trattati
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:
TEMATICHE BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE (durata, luoghi…)
1. Lo Stato gli organismi istituzionali Lettura e commento in classe del testo della
dello Stato, il Parlamento, Costituzione italiana(seconda parte)
il Governo,la Magistratura.
2. Privilegi, diritti e doveri Diritti e doveri dei lettura e commento in classe dei principi
cittadini fondamentali e della prima parte della
Costituzione italiana.
3. Da sudditi a cittadini Differenze tra monarchia e lezioni in classe sulle differenze sostanziali tra
repubblica. monarchia costituzionale e democrazia
parlamentare.
4. La Costituzione italiana Passaggio dalla dittatura Lezioni in classe sulla Costituente. Lezioni
alla repubblica italiana., la sulla Costituzione come eredità della
Costituente e la Reistenza e compromesso tra forze politiche,
Costituzione come tenute sia in classe sia a scuola dai professori
compromesso tra forze Fabio Pacini, Paolo Pezzino, Pietro Finelli,
politiche. nell'ambito del progetto La Resistenza nella
storia e nell'identità della Repubblica italiana.
5. Le organizzazioni internazionali La Nato, L'Onu,l'Unione Lezioni in classe sulla nascita e la funzione
europea delle organizzazioni internazionali.
I temi da 1 a 5, condivisi a livello d’Istituto, sono stati sviluppati dal docente di Storia e Filosofia con
contenuti, moduli e progetti specifici, come riportato dai programmi sotto elencati.
5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
5.3 Colloquio
(Vedi ALL. n° 6)
106. RELAZIONI E PROGRAMMI
Relazione finale di: ITALIANO e LATINO
LICEO SCIENTIFICO “U. DINI”
RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E LATINO e PROGRAMMI SVOLTI
CLASSE 5^, SEZIONE F, A.S. 2019/2020
DOCENTE: PAOLA PANICUCCI
DESCRIZIONE DELLA CLASSE E ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE
Insegno la disciplina di Italiano nella classe 5F sin dal primo anno di corso ed ho intrapreso l’insegnamento
del latino dal terzo. Ho avuto quindi modo di impostare per tempo e di sviluppare in modo ponderato e
graduale l’attività educativa e didattica, adattandola via via alle esigenze formative in evoluzione degli
studenti e alla loro crescita umana e culturale.
La classe nel percorso educativo e didattico ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e
collaborativo, anche se l’interazione complessivamente non è stata molto attiva. Le lezioni sono state seguite
in genere con attenzione, ma solo un gruppo non ampio di studenti ha partecipato costantemente in modo
vivace, dimostrando forti interesse e curiosità.
Durante il periodo di didattica a distanza a causa dell’emergenza Covid 19 sono state svolte in modo regolare
lezioni on line a cui la classe ha partecipato mediamente con assiduità, manifestando però, anche in questa
fase, un livello di interesse e partecipazione costanti non omogeneo.
Tuttavia nel corso del quinquennio c’è stato un miglioramento graduale complessivo, e attualmente la classe
evidenzia un profilo mediamente accettabile sia nel profitto sia nella partecipazione in entrambe le
discipline, con un piccolo gruppo di studenti che raggiunge ottimi livelli di competenza e alcuni elementi un
più fragili, soprattutto nelle competenze espressive e in quelle di analisi e di elaborazione critica.
Per entrambe le discipline la metodologia di studio è stata la stessa: fondamentali sono state la lettura
diretta dei testi e la loro analisi interna a più livelli (tematica - ideologica, narratologica, metrico - ritmica,
retorica, lessicale, fonologica), nonché la contestualizzazione storico-culturale (con puntuali confronti
intertestuali ed extratestuali).
DISCIPLINA DI ITALIANO
1. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
• Conoscere gli argomenti e i percorsi di civiltà letteraria proposti;
• perfezionare le competenze linguistiche fondamentali (ascoltare, esprimersi oralmente, leggere,
scrivere);
• sapere elaborare testi scritti di diversa tipologia e destinazione, in particolare quelli previsti dalla
Prima prova dell’Esame di Stato;
• perfezionare le competenze di riflessione linguistica (caratteristiche morfologiche, sintattiche e in
modo particolare stilistiche e retoriche di un testo; storicità della lingua italiana; eventuale
estensione della riflessione dal linguaggio verbale ad altre forme di comunicazione, come cinema e
multimedialità);
• saper riconoscere i vari generi letterari e saper cogliere, in un testo, la presenza di elementi di scarto
rispetto alla norma del genere di appartenenza;
11• saper individuare i diversi livelli di lettura cui un testo si offre e proporre in riferimento ad essi
ipotesi interpretative ragionate;
• saper analizzare testi letterari e saggistici e contestualizzare opere e autori, muovendosi in direzione
interna (analisi tematica - ideologica, narratologica, metrico - ritmica, retorica, lessicale, fonologica)
ed extratestuale;
• sapere leggere e utilizzare un testo nel quadro di un percorso organizzato secondo interessi
personali, anche in ottica pluridisciplinare;
• consolidare le competenze di selezione, utilizzazione, condivisione e creazione di risorse digitali.
2. NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA (concordati in sede di Dipartimento)
-Padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
in vari contesti e in relazione a diversi livelli di complessità.
-Fruizione consapevole del patrimonio letterario e artistico comune.
-Ricorso alla lettura come mezzo per accedere a più vasti campi del sapere, per soddisfare nuove personali
esigenze di cultura e per la maturazione delle capacità di riflessione e di critica.
3. METODOLOGIE
ü Uso della pratica laboratoriale
ü Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica
ü Pratica dei metodi di indagine propri dell’ambito disciplinare
ü Esercizio di lettura, analisi di testi letterari e saggistici
ü Pratica dell’argomentazione e del confronto
ü Cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale
ü Uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca, in particolare e in maniera
costante nella fase in cui si è svolta la didattica a distanza (marzo-giugno 2020).
4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Testi adottati: L. Marchiani, R. Luperini, P. Cataldi, F. Marchese, Perché la letteratura, Palumbo, voll. 4,5,6,
fascicolo su Leopardi.
b) Sussidi didattici e testi di approfondimento, digitali e cartacei.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, ambiente moodle, piattaforma Google classroom,
videoproiettore, pc, altri device personali.
5. VALUTAZIONE E RECUPERO
• Modalità di valutazione:
Per ottenere la sufficienza lo/la studente/ssa ha dovuto:
Ø saper comprendere e analizzare un testo letterario o di altro tipo, riconoscendo al suo interno temi,
significati, strutture, scelte espressive;
Ø saper riferire in modo pertinente e in forma ordinata sui contenuti disciplinari, usando un linguaggio
anche semplice ma formalmente corretto;
Ø saper proporre e argomentare opinioni e interpretazioni, anche personali;
Ø saper contestualizzare il testo letterario, con opportuni riferimenti sincronici e diacronici;
Ø saper sintetizzare esperienze di lettura, di studio e culturali in genere;
Ø saper costruire un testo scritto rispettando le consegne e argomentando in modo semplice e
12ordinato, con un lessico appropriato.
• Modalità di verifica:
-prove scritte conformi alle tipologie previste dall’Esame di Stato;
- questionari scritti e verifiche strutturate e semistrutturate;
- prove orali;
-lavori e relazioni di approfondimento svolti dagli studenti.
Modalità di recupero:
Recupero in itinere; utilizzo della pausa didattica dopo il primo trimestre.
6. NUCLEI TEMATICI
U.d.A.1
Titolo: Il Romanticismo in Europa e in Italia. Il dibattito fra neoclassici e romantici in Italia
Il contesto storico-culturale del Romanticismo: definizione del movimento e caratteri; gli intellettuali e
l’organizzazione della cultura; i generi in Europa e in Italia; il dibattito fra neoclassici e romantici nel nostro
paese; le riviste.
Testi
“Dovrebbero a mio avviso gl’italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche” (da
Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni di M.me de Staël).
La tesi di Berchet: “La sola vera poesia è popolare” da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo.
Il poeta come artefice di illusioni: estratto dal “Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica” di
Giacomo Leopardi.
U.d.A. 2
Titolo: Leopardi e Manzoni: la riflessione sul “vero”
Vita, pensiero, poetica ed opere di Giacomo Leopardi.
Testi
Lettera al Giordani del 30 Aprile 1817, Lettera al padre di fine luglio 1819; Lettera al fratello Carlo (20
febbraio 1823); Alla sorella Paolina, da Pisa (12 novembre 1827);
dalle Operette morali: Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di
Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez; un estratto dal Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo di un Venditore
d’ Almanacchi e di un Passeggere.
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (165-166), La natura e la civiltà (1559-62, 4128, 4175-7) poetica
dell’indefinito, del vago, della rimembranza (testi forniti dal docente).
Dai Canti: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; Il sabato del villaggio, A Silvia; Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra, o il fiore del deserto.
Vita, pensiero, poetica ed opere di Manzoni.
Testi
Dagli Inni sacri: La Pentecoste; le quattro quartine di Ognissanti; dalle Odi civili: Il cinque maggio. Dall’
Adelchi: Adelchi e Anfrido, (Atto III, scena I, vv. 43-102), Il coro dell’Atto terzo, Il coro dell’Atto IV, La morte di
Adelchi (atto V, scena VIII, scene IX-X, vv. 338-394); la Lettera a Cesare d’ Azeglio sul Romanticismo del 22
settembre 1823;
I promessi sposi: genesi, struttura, temi; il sistema dei personaggi; i cronotopi; approfondimento sui i capitoli
sulla peste (XXXI-XXXVIII); l ’ideologia religiosa; il problema del male e il tema della Provvidenza.
Confronti: Il giardino della “souffrance” di Leopardi, La vigna di Renzo nei Promessi sposi e Il prato infinito di
Palomar in Palomar di Italo Calvino.
13U.d.A.3
Titolo: La perdita d’aureola dell’arte e le sue reazioni in Europa ed in Italia nel secondo Ottocento: dal
Positivismo in letteratura al Decadentismo
Dal Realismo al Naturalismo; riferimenti al romanzo europeo.
Testi
Lettura integrale e discussione di Madame Bovary di Gustave Flaubert.
É. Zola: La prefazione a La fortuna dei Rougon; Introduzione al saggio Il romanzo sperimentale del 1880;
Il Verismo italiano e il Naturalismo francese; La Scapigliatura.
Il Decadentismo; l’Estetismo; il Simbolismo.
Testi
C. Baudelaire: La caduta dell’aureola, in Lo Spleen di Parigi; Da I fiori del male: Al lettore, L’albatro,
Corrispondenze, A una passante. Paul Verlaine, L’arte poetica; A. Rimbaud, La lettera del veggente.
La prefazione di Eva, di Giovanni Verga.
La figura dell’esteta in Il piacere di D’ Annunzio, fra superomismo e inettitudine: la trama del romanzo e
lettura dei seguenti passi: L’incipit (I,1), Il ritratto di Andrea Sperelli (I,2), La conclusione del romanzo (IV,3).
Riferimenti alla poetica e al classicismo di Carducci: lettura ed analisi di Congedo, da Rime nuove.
U.d.A. 4
Titolo: Verga
Verga: vita, pensiero e poetica.
Testi
Dedicatoria a Salvatore Farina; Lettera a Salvatore Paolo Verdura sul ciclo della Marea”.
Novelle: L’inizio e la conclusione di Nedda; Rosso Malpelo, da Vita dei campi; La roba, Libertà, da Novelle
rusticane.
Lettura integrale e analisi dei Malavoglia.
Mastro-don Gesualdo: trama, temi; tecniche narrative; lettura dei seguenti passi: “La giornata di Gesualdo”
(parte prima, cap. IV); “La morte di Gesualdo”, parte quarta, cap. V).
U.d.A. 5
Titolo: Il simbolismo “complementare” di Pascoli e di D’Annunzio
D’Annunzio: vita, pensiero ed evoluzione della poetica. Struttura e contenuti e ideologia delle Laudi.
Testi
Da Poema Paradisiaco: Consolazione; da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio, Le stirpi
canore; Nella belletta, I pastori.
Pascoli: vita, pensiero e poetica.
Testi
Un estratto dal Fanciullino; da Myricae: Patria, Lavandare, X Agosto, Il tuono; L’assiuolo, Temporale,
Novembre, Ultimo sogno. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, da Primi poemetti: alcuni estratti
da Italy; da Poemetti: Digitale purpurea; dai Poemi Conviviali: Alexandros.
U.d.A. 6
Titolo: Le avanguardie storiche degli inizi del Novecento
Le avanguardie europee: caratteri comuni e peculiarità.
Il crepuscolarismo in Italia e la “vergogna della poesia”; i vociani e la poetica del “frammento”. Le riviste fra
anni Dieci e Venti.
Testi
Il primo manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti; Sergio Corazzini: Desolazione di un povero
poeta sentimentale; Gozzano: Invernale; Totò Merùmeni.
U.d.A. 7
La crisi del teatro borghese e la reazione: il “teatro dello specchio” di Luigi Pirandello
Riferimenti al teatro europeo. Pirandello: la produzione teatrale dalla fase del “grottesco” al teatro dei
“miti”.
14Focus su Sei personaggi in cerca d’autore, letto autonomamente dagli studenti, con analisi delle tematiche.
U.d.A. 8
L’evoluzione della narrativa nel primo Novecento in Europa ed in Italia
La dissoluzione delle forme tradizionali ed i nuovi temi. Riferimenti alla letteratura europea .
Italo Svevo: vita, pensiero, poetica. La parabola dell’“inetto” sveviano: trama e temi di Una vita e Senilità.
Testi
L’elogio dell’abbozzo (da L’uomo e la teoria darwiniana).
Lettura di alcuni estratti Da Una vita e da Senilità: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello
dell’intellettuale (da Una vita, cap. VIII); Inettitudine e “senilità” (da Senilità, cap. I); L’ultimo appuntamento
con Angiolina (da Senilità, cap. XII); La “metamorfosi strana” di Angiolina (da Senilità, cap. XIV).
Lettura integrale e analisi della Coscienza di Zeno.
Pirandello: vita, pensiero, poetica.
Testi
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Di sera, un geranio; C’è qualcuno che ride.
I romanzi “umoristici”: lettura integrale e analisi del Fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio
operatore: trama e temi; lettura ed analisi della pagina finale del romanzo (Il “silenzio di cosa” di Serafino
Gubbio) Uno, nessuno e centomila: trama e motivi; lettura e analisi del libro VIII, cap. IV.
U.d.A. 9
Novecentismo e Antinovecentismo nella lirica italiana
Definizione di Novecentismo e di Antinovecentismo.
Ungaretti: vita, poetica.
Testi
Da L’ Allegria: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso; Mattina, Soldati; da Sentimento del tempo: La madre;
da Il dolore: Non gridate più.
Montale: vita, poetica.
Testi
Da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.
Da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; La casa dei doganieri; Nuove stanze; da La bufera e altro:
A mia madre; La primavera hitleriana e L’anguilla; da Satura: Piove.
Saba: vita, poetica.
Testi
Da Il Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia, Preghiera alla madre; La capra, Amai, Ulisse.
U.d.A. 10
Pagine di neorealismo in Italia dagli anni Trenta alla fine della seconda guerra mondiale.
U.d.A. collegata con il progetto “LA RESISTENZA NELLA STORIA E NELL’IDENTITÀ DELLA REPUBBLICA
ITALIANA”, in collaborazione col Dipartimento di Storia e Filosofia.
Caratteri della narrativa neorealista.
Lettura ed analisi della Prefazione alla seconda edizione di Il sentiero dei nidi di ragno.
Visione ed analisi del film Roma città aperta di Roberto Rossellini come esempio di Neorealismo nel cinema;
partecipazione ad una serie di conferenze nell’ambito del progetto “LA RESISTENZA NELLA STORIA E
NELL’IDENTITÀ DELLA REPUBBLICA ITALIANA”.
Lettura integrale e analisi di:
Beppe Fenoglio, Una questione privata; Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno.
N.B.: la produzione, le idee e la poetica di Italo Calvino sono state approfondite nel corso del quinquennio
con la lettura integrale o antologica di alcuni suoi romanzi.
15DISCIPLINA DI LATINO
1. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
ü Consolidare le conoscenze linguistiche di base:
- perfezionare la conoscenza della morfosintassi per accedere alla complessità dei testi degli autori;
- ampliare il patrimonio lessicale e semantico, con elementi dei linguaggi specifici in riferimento ai testi letti
e ai percorsi effettuati.
ü Conoscere gli argomenti e i percorsi di civiltà letteraria proposti.
ü Saper mettere in relazione un testo latino - anche poetico - con una traduzione data, rendendo
conto di tale traduzione.
ü Saper riconoscere nei testi le fondamentali scelte stilistico – retoriche ed eventualmente metriche,
ragionando sulla funzione espressiva di volta in volta assunta.
ü Saper applicare le conoscenze acquisite circa gli aspetti della civiltà e della cultura latina alla lettura
dei testi, per realizzare una più completa comprensione e per analizzarli nella loro specificità.
ü Sapere istituire e sviluppare opportuni confronti intratestuali e intertestuali.
ü Saper trasporre in lingua italiana, rispettando le strutture grammaticali e sintattiche, un testo latino
di adeguata difficoltà, eventualmente contestualizzato e talora in parte tradotto.
ü Saper sviluppare percorsi e approfondimenti suggeriti dall’insegnante o scelti in base a interessi
personali, servendosi in modo autonomo di opportuni strumenti di lavoro.
ü Saper operare una riflessione metalinguistica in sinergia con l’italiano e altre lingue moderne
conosciute.
ü Saper esporre ed argomentare autonomamente, in modo corretto, convincente e appropriato al
contesto.
ü Consolidare le competenze di selezione, utilizzazione, condivisione e creazione di risorse digitali.
2. NUCLEI FONDANTI
-Conoscenza delle caratteristiche del sistema linguistico latino, fondamentale per la comprensione di testi a
diversi livelli di complessità.
-Consapevolezza del contributo della lingua e della civiltà latina per la formazione della cultura e delle lingue
europee.
-Esercizio della traduzione come strumento di riappropriazione linguistica di testi antichi e di conoscenza del
mondo di cui sono espressione.
3. METODOLOGIE
ü Uso della pratica laboratoriale
ü Studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica
ü Pratica dei metodi di indagine propri dell’ambito disciplinare
ü Esercizio di lettura, analisi di testi letterari e saggistici
ü Pratica dell’argomentazione e del confronto
ü Cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
ü Uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Testi adottati: A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, Narrant, SEI, voll. 1, 3.
b) Sussidi didattici e testi di approfondimento, digitali e cartacei.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, ambiente moodle, piattaforma Google classroom,
videoproiettore, pc, altri device personali.
165. VALUTAZIONE E RECUPERO
• Modalità di valutazione:
Per ottenere una valutazione sufficiente lo/la studente/ssa ha dovuto:
-avere acquisito le competenze di lingua e di analisi del testo fondamentali per leggere, analizzare e
commentare testi d’autore anche con traduzione a fronte;
-conoscere anche in modo essenziale, ma esaustivo, i fenomeni storico-culturali e i testi affrontati in classe;
-sapere individuare collegamenti essenziali tra testo e contesto storico – culturale;
-sapersi esprimere in modo ordinato, corretto e coerente in merito alle questioni (storico-culturali, letterarie,
testuali) poste.
• Modalità di verifica:
-prove scritte di analisi testuale;
- questionari scritti e verifiche strutturate e semistrutturate;
- prove orali;
-lavori e relazioni di approfondimento svolti dagli studenti.
• Modalità di recupero
Recupero in itinere; utilizzo della pausa didattica dopo il primo trimestre.
6. NUCLEI TEMATICI
7. U.d.A. 1
Titolo: Il De rerum natura di Lucrezio e la “risposta” di Cicerone
Lucrezio: vita, idee, opera e poetica: lettura in latino, traduzione ed analisi dei seguenti passi: L’inno a
Venere (I, 1-43); Il primo elogio di Epicuro (I, 62-79); II, vv. 1-22 (Il piacere sublime), II, 216-229; 235-262 (Il
clinamen e il libero arbitrio).
V, 195-234 (Il mondo non è fatto per l’uomo).
In italiano: II,1-62 (la serenità del sapiente epicureo); IV, 962-1023 (la teoria dei sogni), V, 1105-1135
(L’ambiguità del progresso); VI, 1138-1181; 1225-1287 (La peste di Atene)
Il De republica di Cicerone; struttura e temi del Somnium Scipionis; lettura integrale del testo in italiano;
lettura e traduzione di alcuni passi dal latino.
U.d.A. 2
Titolo: La trasformazione del genere satirico in età imperiale
Persio: vita, poetica, opera. Giovenale: vita, poetica, opera.
Testi
Persio: I coliambi; Satira V (vv. 14-46).
Giovenale:
È difficile non scrivere satire (Satire, I,1, vv.1-80), in italiano; dalla Satira 6, alcuni estratti: Invito a Postumo a
non sposarsi (vv. 27-37); Ritratto di Messalina, da imperatrice a prostituta (vv. 114-132); Fine della libertà
per l’uomo (vv. 206-218).
U.d.A. 3
Titolo: L’epigramma
Marziale: vita, poetica, opere.
Testi
17In italiano: Epigrammata X,4 (Hominem pagina nostra sapit); traduzione e analisi di Epigrammata I,47,
VIII,74, V34.
U.d.A. 4
Titolo
Intellettuali e potere: Seneca, Tacito e il tema della libertà
Vita, pensiero e opere di Seneca.
Testi
Traduzione e analisi di Il taedium vitae (De tranquillitate animi 2,6-7).
Solo il tempo è nostro (Epistulae morales ad Lucilium,1); De brevitate vitae, 1, 2, 8.
Il congedo dalla vita (Epistulae ad Lucilium, 61).
In italiano: Il saggio e la politica (De tranquillitate animi,4).
La filosofia e il sapere tecnico (Epistulae morales ad Lucilium 90, 11-15 e 26-28).
Tacito: vita, concezione storiografica, opere.
Testi
Dall’ Agricola: Il principato spegne la virtus (1-3; in parte in latino, in parte in italiano); il discorso di Calgaco
(30, 1-4, in italiano). L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola (in italiano: 39, 41, 43).
Da La Germania, in latino: Da tanto tempo la Germania viene sconfitta (Germania,37).
Annales:
Proemio (I, 1); in italiano: La morte di Seneca (XV, 62-64); La morte di Petronio (XVI, 18-19).
Historiae, I,1,2,3 (in italiano).
U.d.A. 5
Titolo
Il romanzo: il Satyricon, ovvero un romanzo parodia.
Petronio: notizie sul probabile autore del Satyricon; temi, motivi, originalità dell’opera; il linguaggio.
Lettura integrale in italiano e analisi di alcuni passi fra i più significativi svolta in classe.
Data 30/05/2020 F.to IL DOCENTE
Paola Panicucci
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 c.2 del D.L g vo n ° 39/93)
18Relazione finale di: LINGUA STRANIERA
Programma effettivamente svolto di LINGUA STRANIERA (Letteratura e Cultura)
docente: Mughetto Finzi Anno Scolastico 2019-20
Argomenti trattati Testi, documenti, esperienze, progetti, Tematiche
problemi,immagini, ecc..
1) Industrial society a)The Industrial Revolution Cause ed effetti della
and Romanticism pp.244-5 Rivoluzione Industriale
Why did the Industrial Revolution
start in Britain? pp 246-7
b) A new sensibility (subjectivity, Romanticism
nature, the Sublime) pp 250-1
Early Romantic poetry p252
Romantic Poetry (Imagination, the Imagination
child, the individual, the exotic,
nature, poetic technique, two
generations) p.259-60
The term ‘Romanticism’ p.260;
Romanticism in Europe p.263
Iconographic material: the
countryside, machinery and steam
pp244-5; Th.Girtin, Guisborough
Priory p.252; Fuseli, The
Nightmare p.258; Friedrich,
Wanderer above the Sea of Fog
p.262; Doré, Over London by Rail
p.269
W.Blake pp.266-7, complementary
opposites
London p.268
The Lamb p.270
The Tyger p.271;
c)The Gothic novel p.253
Ann Radcliffe, “Terror” p252
Mary Shelley pp.273
Frankenstein pp.274-5; “The
creation of the monster” pp276-7. The Gothic Novel
Topic: Stem cells pp.278-9
192) First generation a) W.Wordsworth pp280-1
of Romantic poets
“A certain colouring of
imagination” pp.281-3
“Composed upon Westminster
Bridge” p.284-5
“Daffodils” p.286-7
“My Heart Leaps Up” (extra)
G.Leopardi, “Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia” (extra)
b) S.T.Coleridge p.288
The Rime of the Ancient Mariner Diversi aspetti del
p.289-10 Romanticismo
La Natura
“The killing of the Albatross” Il Poeta e il processo creativo
p.291-3
“A sadder and wiser man” p.295
Iron Maiden: The Rime of the
Ancient Mariner
“Kubla Khan” (extra).
Iconographic material: G.Doré,
The Rime of the Ancient Mariner
3) Second a) John Keats and unchanging
generation of nature p. 234 Elementi biografici essenziali
Romantic poets
La Natura
“Bright Star” (extra)
Il Poeta
“La Belle Dame Sans Merci” p.309
“Ode on a Grecian Urn” (parts)
p.311
b) Percy B. Shelley and the free
spirit of nature, p.236
“Ode to the West Wind” p.304-6
4) The Victorian a) The Victorian Age pp.4-5
Age
The Great Exhibition (p.5,
expansion)
20The Victorian Compromise p.7
Effetti dell’Industrializzazione
Life in Victorian Britain p.8-9
nel periodo vittoriano
The Empire p.18 La società
“The mission of the colonizer”
p.123
Reforms
b) C.Dickens p37-8
Oliver Twist, p.39
“The Workhouse”, p.40
Hard Times, p.46
“Coketown” p.49-50
Iconographic material: Hunt,
Awakening Conscience, Kahn
Academy (online); Doré, A
riverside Street, p.25; British
Empire, p.18; Queen Victoria, p19,
Manchester, p.49.
5) Aestheticism Aestheticism and Decadence, p.29 Nuove teorie estetiche
O.Wilde, the brilliant Artist and
the Dandy p.124-5
The Picture of Dorian Gray p.126
“The painter’s Studio” p.353-4
The Pre-Raphaelites: Hunt, The
Awakening Conscience, Rossetti,
Ophelia
6) World War I Edwardian England, p.156-7 La Prima guerra mondiale
The Age of Anxiety
The First World War, p.158-9
The Age of Anxiety pp.161-3
A Window on the Unconscious
pp.164-5
The War Poets: Brooke and Owen
p.188, 190
R.Brooke, “The Soldier” p.189
21W.Owen, “Dulce et Decorum Est”
p.191
G.Ungaretti, “Veglia” (extra)
Iconographic material: P.Nash,
The Menin Road, p161, Magritte,
Double Secret, S.Dali, The
Persistence of Memory, p.162,
J.Singer Sargent, Gassed, p.159
7) The alienation Modernism p.176-7 L’uomo moderno
of modern man Tecniche narrative
Modern poetry p.178 Il tempo
T.S Eliot and the alienation of
Modern Man p.202-3;
Impersonality. The Objective
Correlative Coscienza individuale
The Waste Land p.204-5, The
mythical method
“The Fire Sermon” p.208-9
J.Conrad pp.216-7
Heart of Darkness pp.218-9
Lettura e analisi dell’opera
integrale, in inglese
Struttura, trama, personaggi,
scelte stilistiche
“A slight clinking” p.220-1
Stream of Consciousness
The modern Novel pp.180-1
J.Joyce: a modernist writer p.248-
50
Dubliners pp.251-2
“Eveline” p.253-6
A monologue from Ulysses (extra)
V.Woolf p.264-5
Mrs Dalloway p.266-7
22“Clarissa and Septimus” p.268-70
Iconographic material: W.Lewis,
Timon of Athens p.176, Picasso,
The demoiselles d’Avignon p.204,
Magritte, The Lovers, p.209
8) Lord of the Flies Lettura e analisi dell’opera Coscienza individuale
integrale, in inglese
Tecnica narrativa
Struttura, trama, personaggi,
scelte stilistiche
Gli alunni: La docente: Mughetto Finzi
23Relazione finale di: STORIA
Relazione finale di: Storia
Prof. Maria Cristina Coppini
Gli alunni, nel corso dell’attuale anno scolastico, si sono applicati soprattutto durante il primo trimestre con
assiduità, dimostrando tutti, rispetto agli anni precedenti, maggiore motivazione allo studio della disciplina,
con risultati scolastici mediamente discreti, in alcuni casi ottimi. Nel complesso sono stati raggiunti sia gli
obiettivi trasversali che quelli specifici di apprendimento da buona parte della classe, anche se persiste in
qualche alunno la tendenza ad uno studio più mnemonico che critico.
La classe è stata impegnata nel progetto sulla Resistenza per le classi quinte della scuola, che è stato
promosso dal dipartimento di storia e filosofia, a cui ha collaborato anche l’insegnante di lettere, fornendo
agli alunni il supporto di alcune letture letterarie di autori della Resistenza come Una questione privata di
Beppe Fenoglio.
Classe 5^ F
Programma di Storia
Libro di testo:De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol.2 e vol.3
Argomenti trattati Testi, documenti, esperienze, progetti, Unità tematica
problemi,immagini, ecc..
Giuseppe Mazzini:i Libro di testo La Restaurazione
moti e il programma Lettura della Costituzione della repubblica
politico, I doveri romana.
dell’uomo.
3) La nascita della Libro di testo La Questione Sociale
questione sociale, Lettura del capitolo “Borghesi e proletari”
il socialismo europeo, dal Manifesto del Partito Comunista di
il socialismo Marx e Engels.
scientifico di Marx, la
prima e la seconda
Internazionale.
244) Prima e seconda Libro di testo Il Risorgimento Italiano
guerra di
indipendenza italiane.
5) La spedizione dei Libro di testo
Mille,
la formazione del
Regno d’Italia.
6) La politica della Libro di testo L’Italia unita
Destra storica.
7)Le tappe Libro di testo Il processo di unificazione tedesca
dell’unificazione
tedesca, la
Costituzione del
Reich,
politica interna ed
estera di Bismarck.
8) Nascita e fine Libro di testo La Francia dal 1852 al 1900
dell’impero di Lettura di:
Napoleone III in E. Zola,”J.accuse” dall’Aurore
Francia, la guerra
franco-prussiana,
la Comune parigina,
l’antisemitismo nella
terza repubblica,
il caso Dreyfus.
9) Cause e Libro di testo L’Europa del colonialismo e
caratteristiche degli Visione di video sul colonialismo europeo. dell’imperialismo
imperi coloniali Lettura di “Il fardello dell’uomo bianco” di
europei della seconda R. Kipling
metà dell’Ottocento.
10) L’Italia dal Libro di testo La politica della sinistra storica
trasformismo di
Agostino Depretis, a
Crispi e Giolitti fino
alla crisi politica di
25fine Ottocento col
ministero Pelloux.
11) Le riforme di Libro di testo Il periodo giolittiano
Giolitti, Visione di filmati sull’emigrazione tra fine
il patto Gentiloni, Ottocento e il primo decennio del
l’impresa di Libia, il Novecento.
grande balzo Lettura di La grande proletaria si è mossa
industriale dell’Italia, di Giovanni Pascoli
emigrazione ed
arretratezza del
Mezzogiorno,
le convergenze
politiche tra Giolitti e i
socialisti,
le elezioni del ‘13 e la
svolta conservatrice.
12) Cause e Libro di testo. La dissoluzione dell'ordine europeo.
svolgimento della Lettura:
prima guerra estratto finale del discorso di D’Annunzio
mondiale. tenuto a Genova il 05/05/1915.
Giuseppe Ungaretti: “San Martino del
Carso”.
13) Le cause della Libro di testo La Russia rivoluzionaria
rivoluzione russa, dal
governo provvisorio
alla dittatura, la Nep,
aspetti dittatoriali
dello stalinismo,
la pianificazione
economica.
14) I trattati di pace, Libro di testo Conseguenze della prima guerra
dissoluzione degli mondiale
imperi Tedesco, Letture:
Austriaco, Turco). “Il genocidio degli Armeni”da Il secolo dei
26Nascita di nuovi stati genocidi” di B. Bruneteau.
indipendenti dalla
fine dei grandi imperi.
Transizione dei vecchi
imperi verso la
repubblica
15) La Società delle Libro di testo I 14 punti di Wilson
nazioni Lettura :
i 14 punti di Wilson
16) Le origini del Libro di testo. I totalitarismi
totalitarismo in Italia Letture:
e Germania, “Il Manifesto degli intellettuali fascisti”;
le caratteristiche del “Il Manifesto degli intellettuali
totalitarismo fascista antifascisti”.
e nazionalsocialista.
17) Cause e Libro di testo La crisi economica mondiale
conseguenze della
crisi del ‘29
18) Il Fascismo dal Libro di testo Il ventennio fascista
governo di coalizione Letture:
alla dittatura, “Il discorso del bivacco”.
le leggi fascistissime,
politica interna ed
estera del regime,
la guerra di Etiopia,
politica economica ed
autarchia dopo la crisi
del ‘29.
19) Programma Libro di testo Le ideologie totalitarie
politico del Partito Letture:
Nazionale Fascista e “ Programma politico del partito
del Partito nazionalsocialista”;
Nazionalsocialista. “Il Manifesto dei fasci di combattimento”.
20) Le leggi di Libro di testo L’antisemitismo come elemento
Norimberga, Letture: ideologico del nazionalsocialismo
la notte dei cristalli, il “Le leggi di Norimberga”. Testo.
27lager e la soluzione
finale,
la Shoah.
21) Il Manifesto della Libro di testo. Antisemitismo in Italia
Razza e le leggi Letture:
razziali del 1938 in “Il Manifesto della razza”;
Italia. “Testo delle leggi razziali del novembre
1938”.
“Tra gli artigli del mostro
nazista”,memoriale di Frida Misul (video).
22) La guerra civile La Spagna dalla repubblica alla
spagnola guerra civile.
23) Le ragioni del Libro di testo Seconda guerra mondiale
secondo conflitto
mondiale e lo
svolgimento dal 1939
al 1943
24) Caratteri della Libro di testo La Resistenza.
Resistenza partigiana Lettura di alcuni eccidi nazifascisti
in Italia e cenni a dall’Atlante storico delle stragi in Italia:
quella europea. strage del Palude di Fucecchio;
strage di San Biagio Pisa;
strage di Piavola;
strage di Niccioleta;
strage di Forno;
strage di Marzabotto.
Strage di Sant’Anna di Stazzema.
La classe, nell’ambito della disciplina
Cittadinanza e Costituzione, ha partecipato
al progetto La Resistenza nella storia e
nell’identità della Repubblica
italiana,organizzato dal dipartimento di
storia e filosofia della scuola, a cui ha
28preso parte anche il dipartimento di
lettere,per l’aspetto Resistenza e
letteratura. Il progetto è stato svolto
nell’orario scolastico ed
extrascolastico ed è stato articolato in una
serie di lezioni-dibattito sul tema della
Resitenza tenute dai Professori Paolo
Pezzino, Fabio Pacini, Pietro Finelli, Orsetta
Innocenti, con la collaborazione della
Domus mazziniana e il patrocinio dell’Anpi
e nella proiezione di film sull’argomento,
Roma città aperta, L’uomo che verrà. Il
progetto è stato preceduto da una serie di
lezioni propedeutiche da me tenute in
classe in orario scolastico in cui sono stati
affrontati il tema delle stragi nazifasciste e
la contestualizzazione storica della
Resistenza. Sono stati messi a fuoco i vari
aspetti della Resistenza come guerra
patriottica,civile e guerra di classe.
Gli alunni hanno approfondito la dinamica
di svolgimento di alcune stragi nazifasciste
in Toscana tratte dall’Atlante delle stragi
nazifasciste, curato dai professori Pezzino
e Fulvetti.
2925) L’ultimo biennio Libro di testo. La soluzione del secondo conflitto
di guerra e le mondiale.
conseguenze del
conflitto.
26) Il referendum Libro di testo L’Italia dalla monarchia alla
istituzionale, repubblica
la nascita della
Repubblica in Italia,
formazione della
Costituente.
Data: 5 Maggio 2020 Prof. Maria Cristina Coppini
30Relazione finale di: FILOSOFIA
Relazione finale di: filosofia
Prof. Maria Cristina Coppini
La classe ha seguito il programma con impegno e motivazione ad apprendere. E’ venuta a mancare però
una partecipazione attiva al dialogo e allo scambio di idee durante le lezioni, specialmente da parte di alcuni
alunni poco disponibili ad intervenire. La preparazione sugli argomenti trattati risulta mediamente discreta,
in qualche caso più che buona. Non mancano però alunni, anche se poco numerosi, che presentano ancora
alcune difficoltà, a causa di una preparazione poco approfondita e di un’acquisizione solo parziale e non
sempre soddisfacente di specifiche competenze fondamentali. Per quanto concerne gli altri il livello di
apprendimento delle competenze risulta invece buono.
31Puoi anche leggere