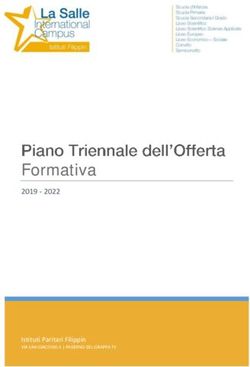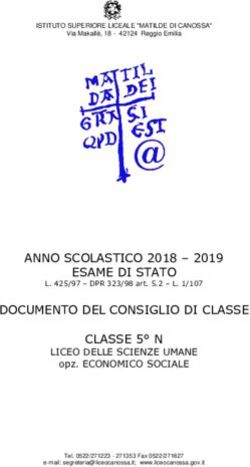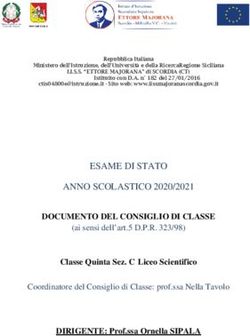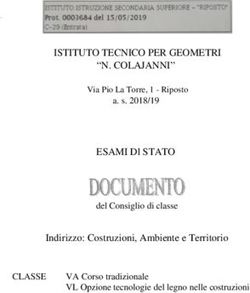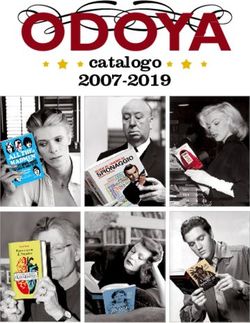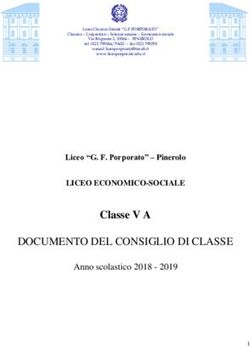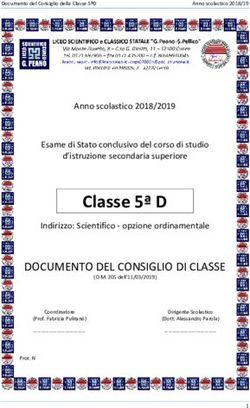ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI - "Enrico Fermi ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LICEO STATALE “Enrico Fermi” CECINA
LICEO SCIENTIFICO -LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo SPORTIVO - LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
Via Ambrogi - 57023 Cecina (Li) - Tel. 0586/684263 - 681515 Fax 0586/684185
Email: lips02000l@istruzione.it Internet: www.fermicecina.it
C.F.80009280498 C.M.LIPS02000L
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI
(L. 425/97 – DPR 323/98)
anno scolastico 2017 - 2018
DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO
DELLA CLASSE
ALLEGATI:
Scheda di presentazione della classe
Schede informative delle prove pluridisciplinari
Schede informative analitiche e programmi relative alle seguenti materie:
Scienze Umane
Filosofia
Scienze Naturali
Storia
Italiano
Latino
Matematica
Fisica
Inglese
Scienze Motorie
IRC
Storia dell'arteIl presente documento è stato redatto ed approvato dal Consiglio di Classe della V AU, affisso all'albo il 15
Maggio 2018.
Docente coordinatore:
Salvatore Di Pietro
Composizione del Consiglio di Classe
Docenti Nomi Cognomi materie firma
della
commis
sione
d'esame
* NORA SILICANI ITALIANO E LATINO
* CHIARA PASQUINELLI STORIA
* SALVATORE DI PIETRO FILOSOFIA
BELINDA ARRIGHETTI SCIENZE NATURALI
MONICA BARI MATEMATICA E FISICA
SALVATORE DI PIETRO SCIENZE UMANE
FRANCESCA PAOLETTI SCIENZE MOTORIE
DANIELA FERRI IRC
ELENA CAPECCHI LINGUA E
LETTERATURA
INGLESE
EMMA ROVENTINI STORIA DELL'ARTE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tania PascucciSCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE A – Composizione della classe e dati statistici All'inizio dell'anno la classe risultava costituita da 26 studenti, 2 maschi e 24 femmine. Nel corso dell'anno una studentessa si è ritirata e ad oggi gli allievi frequentanti sono 25. Inoltre sono presenti alcuni ripetenti e due ragazzi che l'anno scorso sono stati inseriti nella classe e che precedentemente frequentavano il Liceo Scientifico. Per completare il quadro delle variazioni intervenute nel corso del secondo biennio, durante il terzo anno ci sono stati 2 ritiri e 2 respinti. Gli alunni provengono da Cecina e dai paesi limitrofi, Rosignano, Montescudaio, San Vincenzo, Bibbona, Casale. La classe ha avuto nel corso del presente anno scolastico un comportamento corretto e non si sono manifestati, in coerenza con i precedenti anni scolastici, situazioni di tensione o contrapposizione. Il gruppo ha raggiunto un grado di aggregazione buono, progressivamente migliorato nel corso degli anni. In generale il clima in cui si è svolta l’attività didattica è stato sereno e costruttivo. Gli studenti hanno raggiunto un buon livello di autocontrollo e di maturità, manifestato anche nelle diverse attività extracurriculari a cui hanno partecipato. In particolare nel corso del viaggio d'istruzione tenutosi presso Trieste, Venezia, il Vittoriale i partecipanti si sono distinti per la disponibilità all’ascolto e alla collaborazione, il rispetto delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale con cui sono entrati in relazione, la capacità di confrontarsi in modo costruttivo anche con la diversità. In sostanza nel corso di questa esperienza il gruppo-classe ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi trasversali comportamentali ad un livello elevato e in maniera generalizzata. Non si può affermare lo stesso per quanto riguarda gli obiettivi trasversali cognitivi, raggiunti nel complesso, ma in modo piuttosto diversificato, in relazione anche alle differenze presenti tra gli studenti all'inizio dell'anno. Infatti una parte dei componenti della classe, pur migliorando il loro rendimento, ha mantenuto risultati non pienamente soddisfacenti in alcune discipline. In generale gli studenti si sono mostrati collaborativi, partecipi al dialogo educativo, attenti e capaci di affinare il loro metodo di studio dimostrando un impegno crescente nel tempo (proporzionalmente alle rispettive capacità individuali) che ha permesso loro di conseguire obiettivi nel complesso più che sufficienti, seppur affidandosi in alcuni casi ad un metodo di studio ancora essenzialmente mnemonico. Il C.d.C. è concorde nel constatare un quadro abbastanza positivo quanto ad interesse, motivazione ed attenzione, tuttavia le competenze espositive (lessicali, grammaticali e sintattiche) ed argomentative seppur molto migliorate, in alcuni casi sono ancora caratterizzate da una qualche fragilità. In generale il clima in cui si è svolta l’attività didattica è stato sereno e costruttivo. Il consiglio di classe, laddove necessario, ha fatto ricorso a percorsi didattici personalizzati e nel complesso tutti i membri del consiglio di classe hanno adottato modalità didattiche inclusive ed attente ai singoli. Nel gruppo si distinguono, alcune individualità che raggiungono buoni risultati progressivamente migliorati nel corso degli studi, con un approccio agli argomenti proposti serio, maturo, consapevole e attento.
B – Continuità dei docenti
Nome Cognome Materia continuità
NORA SILICANI ITALIANO E Dal quarto anno
LATINO
CHIARA PASQUINELLI STORIA Dal quarto anno
SALVATORE DI PIETRO FILOSOFIA Il terzo e quinto anno
BELINDA ARRIGHETTI SCIENZE Secondo e quinto anno
NATURALI
MONICA BARI MATEMATICA E continuità
FISICA
SALVATORE DI PIETRO SCIENZE UMANE Il terzo e quinto anno
FRANCESCA PAOLETTI SCIENZE Dal quinto anno
MOTORIE
DANIELA FERRI IRC continuità
ELENA CAPECCHI LINGUA E continuità
LETTERATURA
INGLESE
EMMA ROVENTINI STORIA Dal quinto anno
DELL'ARTE
C – Situazione iniziale in relazione alle conoscenze e competenze degli alunni
c.1 Giudizi espressi dal consiglio di classe rispetto ai seguenti indicatori 1
indicatori Giudizio del CdC 2
Conoscenze di base delle diverse discipline In media più che sufficiente.
Competenze delle diverse discipline In media più che sufficiente.
Capacità espressive scritte e orali In media più che sufficiente.
Capacità logico - matematiche Mediamente buone
Capacità di elaborare informazioni, fornire sintesi significative, In media più che sufficiente o
effettuare valutazioni buone
c.2 Valutazione complessiva d’ingresso
La situazione iniziale del gruppo classe era mediamente adeguata e ha consentito di effettuare la
programmazione didattica del C.d C.
D- Attività didattica ed educativa del Consiglio di classe
d.1 Obiettivi generali formativi ed educativi
OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI Complessivamente i seguenti obiettivi cognitivi sono stati
1
Se necessario modificare e/o integrare gli indicatori già inseriti in tabella
2
Indicare un giudizio sintetico (ottimo,buono, sufficiente, mediocre, insufficiente) relativo alla media della classesufficientemente raggiunti, pur in misura diversificata, da tutti gli studenti della classe:
Acquisire un metodo di lavoro efficace sapendo quindi utilizzare le seguenti capacità:
prendere appunti, pianificare in modo efficace il lavoro domestico, utilizzare opportunamente i libri di
testo,
comprendere e interpretare in modo corretto i testi proposti, distinguere le informazioni
visualizzandole in schemi e mappe concettuali, utilizzare i sussidi multimediali in modo adeguato e
corretto
Acquisire una autonomia cognitiva sviluppando le seguenti capacità logiche: operare sintesi dei
contenuti studiati, individuando gli argomenti essenziali, cogliere analogie, differenze e correlazioni,
riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, applicare regole e principi
Sviluppo delle capacità comunicative: comunicare, sia nella forma scritta che in quella orale, in
modo chiaro, ordinato e coerente, utilizzare terminologia specifica nelle varie discipline,utilizzare il
registro formale e i linguaggi specifici nell’esposizione degli argomenti .
OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI Complessivamente i seguenti obiettivi
comportamentali sono stati pienamente raggiunti, pur in misura diversificata, da tutti gli studenti della
classe:
Capacità di autovalutazione. Disponibilità all’ascolto. Rispetto delle regole contenute nel regolamento
di Istituto. Rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale dell’istituto.
Rispetto della struttura scolastica (aule, laboratori, servizi). Disponibilità all’ascolto e alla
collaborazione con docenti e compagni. Capacità di intervenire nel dialogo educativo in modo
costruttivo. Accettazione delle diversità a partire, ma non esclusivamente, da quelle culturali, etniche,
religiose. Partecipazione costruttiva alle attività proposte dalla scuola. Puntualità nel rispetto dei
compiti e delle scadenze assegnate.
d.2 Metodi di lavoro utilizzati dai docenti per il perseguimento degli obiettivi generali
I docenti hanno da subito sollecitato gli alunni ad offrire una preparazione adeguata in forma scritta e
orale sia attraverso le tradizionali verifiche che attraverso frequenti colloqui e la correzione sistematica
degli esercizi proposti. Oltre ad un continuo confronto necessario anche per suscitare la discussione su
temi incontrati o emersi durante l’anno, oggetto della programmazione e/o delle diverse iniziative cui la
classe ha partecipato. I docenti inoltre hanno cercato di svolgere un lavoro di coordinamento relativo alle
iniziative messe in campo e alla loro esecuzione, oltre ad concreto lavoro di interdisciplinarietà tra alcune
discipline di indirizzo come Filosofia, Scienze Umane, Storia; Italiano, Latino.
In conformità con gli obiettivi educativi d’istituto, i docenti si sono proposti di far raggiungere agli alunni
il grado di formazione idoneo a favorire la crescita individuale e personale rafforzando anche le
competenze relative all’indirizzo di studio. Per un maggior coinvolgimento, affinché gli alunni potessero
acquisire le abilità di analisi, sintesi, deduzione e autonomia nel lavoro scolastico, i docenti hanno
utilizzato diverse modalità didattiche, facendo spesso ricorso alla discussione, a lezioni partecipate e
lavori di ricerca. Da subito, il C.di C. ha pensato a metodologie finalizzate allo promozione di una
maggiore autonomia e responsabilità. Pertanto, si è insistito sulle metodologie di miglioramento del
metodo di studio ove ancora carente; infatti, per alcuni alunni si è dovuto insistere sul conseguimento
delle abilità collegate ai concetti chiave indispensabili per la comprensione e l’applicazione delle strategie
risolutive, quali il problem solving per ottenere risultati adeguati. Il C.di C. ha sempre cercato di
rafforzare la capacità argomentativa e critica, sia individuale che del gruppo classe; la competenza
lessicale ed espositiva sia per ciò che riguarda lo scritto che l’orale.
Ricapitolando i docenti della classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi comportamentali
e cognitivi sopra elencati, hanno messo in atto le seguenti strategie e utilizzato i seguenti strumenti:
Partire dalla centralità dello studente nel processo di insegnamento apprendimento (partire dalle
conoscenze già acquisite e dalle esperienze dello studente; esplicitazione dei percorsi dellaprogrammazione; delle modalità di verifica; degli obiettivi; consigliare strategie di studio; preavvertire
delle prove di verifica collettive; equilibrare il carico di studio delle varie discipline).
Stimolare le capacità di intervento personale e critico e favorire lo svolgimento di discussioni guidate.
Stimolare ad una riflessione costruttiva sui propri errori e quindi ad un'appropriata auto-valutazione
Effettuare lezioni frontali; interattive; lavori di gruppo; discussioni guidate; esperienze di laboratorio;
visite guidate; partecipazione ad attività extrascolastiche; utilizzo di fotocopie, video, testi (libri di testo o
altri) in coerenza con la programmazione e gli obiettivi didattici delineati.
d.3 Metodi ed attività di recupero sostegno valorizzazione eccellenze
Gli insegnanti della classe, in coerenza con quanto stabilito dal collegio docenti, in presenza di difficoltà
specifiche nell’acquisizione di conoscenze o competenze da parte degli alunni, hanno operato attraverso
azioni di recupero curricolare, effettuato attraverso esercizi e attività appositamente costruiti per soddisfare
tali esigenze, ed il recupero effettuato attraverso una attività di tutoraggio tra gli studenti stessi, oltre ad
attività di “sportello”.
Inoltre durante l’intero anno scolastico, i docenti, valutandone di volta in volta la necessità, hanno attivato il
recupero in itinere attraverso metodologie di rallentamento e ripetizioni di parti specifiche nello
svolgimento dei contenuti, flessibilità nella programmazione e di semplificazione degli obiettivi cognitivi
(tramite mappe concettuali, schemi, appunti riassuntivi e/o integrativi) in funzione delle difficoltà di
apprendimento emerse.
Al fine di valorizzare le capacità degli studenti più capaci, essi sono stato coinvolti in progetti culturali o
d’istituto e attività di approfondimento nelle varie discipline come specificato nel punto seguente del
presente documento. Si è cercato di coinvolgere gli studenti in molte attività e si sono ottenute risposte molto
positive anche di fronte a proposte opzionali. Nei contesti di discussione, all'interno di conferenze, alla
presenza di relatori provenienti dal mondo universitario, alcuni di loro si sono distinti per la partecipazione
attiva manifestata attraverso domande e spunti critici pregevoli.
d.4 Attività di integrazione e di ampliamento dell’offerta formativa svolte in ambito curriculare e/o
extracurriculare
-CLIL: modulo di Storia in lingua inglese durata 4h avente oggetto movimenti migratori e crisi del 29
(curricolare)
-Progetto Lanterne magiche (curricolare)
-Partecipazione attiva a giornate di studio/approfondimento: Cnr Pisa “Un viaggio nel benessere
dell'adolescente” 27 ottobre 2017. (curricolare)
-Incontro con Silvestro Montanaro, 1 dicembre 2017 (curricolare)
-Giornata della memoria delle foibe, 10 febbraio 2018 (curricolare)
-Conferenza “metodo scientifico e salute” a Rosignano Marittimo del giorno 24 e 31 marzo 2018.
(curricolare riservata a circa 8 studenti)
-Attività di ECDL (opzionale)
-Orientamento universitario: incontri in ambito scolastico con esponenti delle diverse facoltà universitarie e
presso gli atenei toscani (Pisa e Firenze) (opzionale)
-educazione e legalità con la guardia di Finanza il 13 aprile 2018 (curricolare)
-Incontro con “AVIS”, aula magna. 23 gennaio 2018. (curricolare)
-Progetto “Pratiche filosofiche e proposte di valori”. Due conferenze (opzionale)
-Conferenze del ciclo i venerdi della biblioteca, con tematiche filosofiche, presso biblioteca di Cecina, 4
conferenze, (opzionale)-Presentazione del volume “IL RACCONTO DEL VIVERE. Luoghi, cose, persone della Toscana di Carlo
Cassola”, 23 febbraio 2018, promosso dal comune di Cecina (opzionale)
-Certificazione di lingue (opzionale)
-Alternanza scuola-lavoro, con produzione della raccolta delle esperienze relativamente al progetto svolto
nel corrente anno scolastico (curricolare).
-Attività L2 con la classe del terzo anno della scuola dell'infanzia “Sorelle Agazzi” La California. Il
progettosi è conclusa con la drammatizzazione di una fiaba in lingua inglese al teatro “la Palastra” di
Bibbona. (appendice di proposta curricolare)
-Partecipazione alla conferenza-seminario sul Risorgimento del prof. G. Paolini dell’Università di Firenze 20
gennaio 2018 (proposta curricolare)
-Incontro Associazione Volontari Ospedalieri: Corso specifico di 16 ore tenuto da volontari e medici specialisti
(appendice a proposta curricolare di alternanza)
-Presentazione del libro “Zone di guerra”. 19 aprile 2018, (proposta curricolare)
-Conferenza progetto “Educazione e libertà”. 13 aprile 2018, (proposta curricolare)
-Partecipazione alla lezione sul tema “Dal progetto Manhattan a Hiroshima e Dalla non proliferazione alla
messa al bando delle armi nucleari: trattato ONU del 7 luglio 2017” con il prof.Francesco Lenci
dell’Università di Pisa, in collaborazione con USPID e ANPI, 10 marzo 2018, (proposta curricolare)
E – Esiti formativi ed educativi
e.1 Livello medio della classe misurato su scala da 1 a 5 (1 minimo) 3
OBIETTIVI / livelli 1 2 3 4 5
Acquisizione conoscenze disciplinari *
utilizzo dei contenuti acquisiti per risolvere *
situazioni problematiche o produrre nuovi oggetti
o trasferirli in nuovi contesti
Il potenziamento delle capacità espressive scritte e *
orali
Sviluppo capacità di valutazione critica, *
significatività e consapevolezza
dell’apprendimento
e.2 Giudizio complessivo sugli esiti formativi raggiunti nelle varie discipline, nelle aree disciplinari o
pluridisciplinari nell’ambito di attività o progetti di ampliamento dell’offerta formativa e risposta agli
interventi di recupero sostegno
Il giudizio complessivo sugli esiti formativi raggiunti nelle varie discipline, nelle aree disciplinari o
pluridisciplinari, nell’ambito di attività o progetti di ampliamento dell’offerta formativa (anche in risposta
agli interventi di recupero in itinere) è assimilabile a quello generalmente riportato per l’offerta formativa
nel suo complesso (POF). La classe ha conseguito gli obiettivi specifici di apprendimento in modo
diversificato, nonostante la partecipazione generale sia stata positiva e fattiva: una buona parte della classe
ha saputo connettere utilmente i contenuti e attuare collegamenti alle conoscenze, anche pregresse, in
3
Se necessario modificare e/o integrare gli obiettivi già inseriti in tabellamodo efficace e proficuo, ponendosi su di un livello di preparazione mediamente pari a buono, in alcuni casi ottimo. L’altra parte della classe ha fruito delle occasioni di ampliamento dell’offerta formativa, di sostegno e recupero, esclusivamente svolto in classe, ponendosi talvolta con un atteggiamento non sempre partecipativo e/o collaborativo. Ciò ha comunque consentito di conseguire, nel complesso, una preparazione mediamente più che sufficiente, pur restando il fatto che, per alcuni, la capacità di sintesi/rielaborazione personale delle conoscenze e le abilità linguistiche sono state sufficienti. e.3 Livello medio di partecipazione e coinvolgimento nell’attività didattica La classe si è mostrata nel complesso disponibile al dialogo educativo, interagendo e partecipando alle attività didattiche; e.4 Livello medio di impegno e responsabilità Una buona parte della classe ha mostrato un apprezzabile livello sia nell’impegno profuso che nella responsabilità di approccio allo studio, concretizzando attitudini in risultati soddisfacenti. E’ importante comunque sottolineare che quegli alunni inizialmente più carenti hanno compiuto un percorso di crescita e responsabilità, cercando mediamente di migliorare il proprio rendimento con impegno e serietà. e.5 Caratteri del metodo di studio complessivamente sviluppato In linea generale, gli alunni nel loro percorso liceale hanno appreso e, in taluni casi, perfezionato il proprio metodo di studio: in tal senso, hanno cercato (in modo rispondente alle personali predisposizioni) di far proprio lo sviluppo logico delle argomentazioni, migliorando di conseguenza l’esposizione orale/scritta conformemente al linguaggio specifico delle diverse discipline, di creare connessioni tra le diverse discipline e di sviluppare un maggiore spirito critico. Tuttavia permangono, in alcuni componenti della classe, rigidità e difficoltà di apprendimento dovute, anche, ad un metodo di studio ancora poco efficace. e.6 Frequenza La frequenza è stata complessivamente nella norma. Tuttavia in due casi si sono registrate una percentuale di assenze elevata. Non vi sono stati casi di interruzione della frequenza o di prolungati periodi di assenza. Pur essendo presenti diffusi casi di pendolarismo, la classe ha dimostrato nell’arco dell’intero triennio di rispettare la puntualità nell’orario di entrata, ad eccezione di sporadiche ed occasionali situazioni. Allo stesso modo, la medesima considerazione vale anche per le uscite fuori-orario, ridotte essenzialmente a reali necessità. F – Criteri di valutazione f.1 Criteri utilizzati per le verifiche periodiche e per la loro valutazione. Criteri utilizzati per la valutazione degli alunni. La valutazione ha avuto come presupposto l’esplicitazione chiara delle mete educative, formative e disciplinari da parte dei docenti relativamente alla disciplina di studio. Per ciascun argomento, ambito disciplinare sono stati esplicitati gli elementi fondamentali su cui è stata effettuata la verifica dell’apprendimento. Gli indicatori della valutazione si sono riferiti in generale ai seguenti parametri: quantità delle informazioni capacità di organizzare le conoscenze capacità di concettualizzare le conoscenze entro un ambito culturale più ampio la capacità di utilizzare linguaggi specifici in una comunicazione efficace la capacità di problematizzare, articolare giudizi e assumere anche plurimi punti
di vista critici Le verifiche sono state scritte, orali o pratiche, durante o alla fine dei moduli, di tipo strutturato, semi-strutturato o di produzione libera. Più precisamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state effettuate verifiche di vario tipo: produzioni scritte questionari con risposte aperte o multiple colloqui/interrogazioni verifiche “informali” in classe esperienze in laboratorio Il numero delle verifiche per le diverse discipline ha tenuto conto di quanto stabilito dal collegio docenti. Nelle prove di verifica si è utilizzata la misurazione numerica decimale da 1 a 10 secondo le indicazioni presenti nel P.T.O.F. di istituto. Per il voto di condotta si è tenuto conto della tabella approvata dal collegio decenti e inserita nel vigente P.T.O.F . f.2 Criteri utilizzati per l’attribuzione del credito scolastico I criteri utili per l’attribuzione del credito si evincono dalla griglia approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel POF. ALLEGATI
Data Tipo Materie Criteri di Tipologia
di Di prova elaborazione ed e articolazione della prova
svolgime obiettivi
nto verificati
11/04/18 Simulazi Scienze, Storia, Si rinvia alla Tipologia A (trattazione di un
one Latino, Inglese. scheda di argomento in max 20 righe di
della valutazione e testo) Svolgimento in
Terza correzione 120 minuti
Prova
d’esame
09/05/18 Simulazi Scienze Umane Si rinvia alla Modello previsto dal Ministero
one scheda di
della valutazione e
seconda correzione
prova
d'esame
12/05/18 Simulazi Scienze, Storia, Si rinvia alla Tipologia A (trattazione di un
one Filosofia, Inglese scheda di argomento in max 20 righe di
della valutazione e testo) Svolgimento in
Terza correzione 120 minuti
Prova
d’esame
22/05/18 Simulazi Lingua e Si rinvia alla Modello previsto dal Ministero
one letteratura Italiana scheda di
della valutazione e
prima correzione
prova
d'esame
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
Insegnante: prof. Salvatore Di Pietro
CLASSE V SEZ. AU
Anno scolastico 2017-2018
ANTROPOLOGIA
Unità 2: Culture, identità, convivenza
-Movimenti migratori e scambi globali;
-cultura, religione e identità,
Letture:
-A. Rivera, uno scontro fra civiltà? (pag. A35)
-U. Fabietti, dall'etnicizzazione al conflitto etnico: Tutsi e Hutu in Rwanda (pag. A43)
-U. Hannerz, Etnicità e opportunità nell'America urbana (pag. A47)
Unità 3: forme religiose e rituali
-Il sacro e la sua funzione sociale
-Il rituale come linguaggio simbolico
Letture:
-E. Durkheim,Totem, religione e società (pag. A55)
-E. De Martino, la possessione della taranta (pag. A57)
Unità 4: l'indagine antropologica sul campo-L'osservazione partecipante -Il relativismo culturale Letture: -R. Rosaldo, il dolore e la rabbia del cacciatore di teste e dell'antropologo (pag. A 80) -Il caso: il calcio come oggetto antropologico (pag. A82) SOCIOLOGIA Unità 1: l'individuo e la sociologia -Esseri umani, persone e personalità: alcune distinzioni -Status e ruolo -l'attore sociale e la complessità dei ruoli Lettura: -Intervista a N. Bottani, i sociologi e l'educazione lo status e il ruolo dell'insegnante oggi (pag.S7) -Articolo di A. D'Avenia, Diffido dell'istruzione,tratto dal Corriere della sera 05/02/2018 Unità 2: l'orientamento dell'azione sociale -Il controllo e la devianza -l'adattamento sociale e la devianza Unità 3: la socializzazione e le politiche -il processo di socializzazione -letture sociologiche della scuola come agenzia di socializzazione -Welfare, politiche pubbliche e sociologia -La sociologia e le politiche pubbliche per la famiglia e la scuola. Unità 4: il disagio, i servizi e le politiche -In difficoltà: le persone diversamente abili e svantaggiate -I servizi alla persona e le politiche pubbliche per la cura, la salute e la diversabilità Lettura L'evoluzione normativa e culturale sull'handicap in Italia (pag. S92) Unità 5: Multiculturalità. Natura e difficoltà -Lo sviluppo dell'individuazione nella società occidentale tra democrazia e totalitarismo -La globalizzazione, riflessi sulla sfera politica -Il “noi” nel mondo globalizzato e il multiculturalismo -le seconde generazioni (pag. S135) Letture: -E. Fromm, il difficile cammino dell'individuazione (pag. S109) -A. Touraine, Costruire un soggetto nuovo (pag. S 118) -A. Sen, Contro il “solitarismo”: per un'identità plurale (S119) Unità 7: i mass media e la società di massa -I mass media oggi -Il concetto di “Industria culturale” di Adorno ed Horkheimer (cenni) -La propaganda: caratteristiche generali -La “vita sociale delle cose” e il loro significato di comunicazione -La moda come forma di comunicazione PEDAGOGIA -A. Neill pedagogia non-direttiva. L'uomo autoregolato quadro biografico-culturale; la concezione educativa: spontaneità e sviluppo; la metodologia non direttiva -M. Montessori. Sperimentazione e psicologia individuale
Quadro biografico-culturale; una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto; l'embrione spirituale e il suo sviluppo; l'ambiente e il metodo; la scuola montessoriana; -O. Decroly. La funzione di globalizzazione (trattazione schematica effettuata nell'ambito delle critiche al metodo Montessori); l'educazione dei soggetti “irregolari”. -J. Dewey. La scuola progressiva. Quadro biografico-culturale; i fondamenti teoretici: unitarietà del reale e strumentalismo logico; indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva. -G. Gentile. Il pensiero e le idee pedagogiche. -E. Codignola e la scuola-Città Pestalozzi a Firenze. -Don Milani e la scuola di Barbiana. -J. Maritain (cenni sintetici)4 -Nuove norme sui BES: la scuola italiana è scuola dell'inclusione -Le scuole nell'Europa sempre più ampia -Il costruttivismo -La flipped classroom Approfondimenti attraverso brani antologici. Sono stati letti e commentati brani tratti dai seguenti testi -Dewey J. (1963), Esperienza ed educazione, La nuova Italia, Firenze. (ed. or. 1938). -Gardner H., (2007), Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano. (ed.or. 2006) -Lodi M. (2014), Il paese sbagliato.Diario di un'esperienza didattica, Einaudi, Torino, (ed. or. 1970) -Melucci A., (1991), Il gioco dell’io: il cambiamento di sè in una società globale,Feltrinelli, Milano. -Intervista a Touraine (2010), Scuola del soggetto, riconoscimento delle diversità culturali e società delle donne, in Scuola Democratica, N1, Guerini e Associati. -James W. (2003), Discorsi agli insegnanti e agli studenti sulla psicologia e su alcuni ideali di vita, Armando, Roma, (ed. or. 1899). - Possenti I., Flessibilità e istruzione. Una replica a Bauman, in «MicroMega», dicembre 2008, pp. 134-143. -Musatti C. (1971), Super-io individuale e Super-io collettivo, tratto da Libertà e Servitù dello spirito, Boringhieri, Torino. -Bruner J.S. (1969), Dopo Dewey. Il processo di apprendimento nelle due culture, Armando, Roma, (ed. or. 1960) -Bruner J.S., (1997), La cultura dell’ educazione, Feltrinelli, Milano, (ed. or. 1996). -Benasayag M. e Schimit G., (2004), L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano, (ed. or. 2003). 4 Gli argomenti successivi a questo sono saranno trattati dopo la consegna del documento del 15 Maggio.
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Insegnante: prof. Salvatore Di Pietro
CLASSE V SEZ. AU
Anno scolastico 2017-2018
MODULO1: DA KANT ALL'DEALISMO ASSOLUTO
Kant Critica al razionalismo e all’empirismo; Significato di “criticismo” come “filosofia del limite”;
Critica della Ragion Pura: giudizi analitici a priori, sintetici a posteriori, sintetici a priori,
episteme e inconoscibilità della cosa in sé, la produttività del conoscere, la scienza come sapere fecondo,
universale e necessario; La rivoluzione copernicana in filosofia: Le facoltà della conoscenza e la
partizione della Critica della ragion pura; Le intuizioni pure di spazio e tempo; le categorie, intelletto ed
intuizione sensibile, la deduzione trascendentale e l’Io penso; Fenomeno e noumeno La genesi della
metafisica e delle sue tre idee: L’idea di Dio, mondo e anima Il nuovo concetto di metafisica in Kant
Critica della Ragion Pratica: analisi del titolo, realtà e assolutezza della legge morale, la categoricità
dell’imperativo morale (massime e principi, imperativo ipotetico e imperativo categorico); Formulazioni
dell’imperativo categorico La formalità della legge e il dovere. Il fondamento noumenico della ragione
pratica: la libertà. Rapporto tra libertà e legge morale I postulati della Ragion Pratica, il sommo bene come
binomio tra virtù e felicità. Primato della ragion pratica; dibattito sul kantismo (superamento del dualismo:
fenomeno-noumeno).
Dalla cosa in sé alla sua dissoluzione: riflessioni a partire da Reinhold, Jacobi, Schulze
l’idealismo etico: Fichte la vita e gli scritti; L'infinità dell'io; La dottrina della scienza e i suoi tre
principi. La struttura dialettica dell'io; La scelta tra idealismo e dogmatismo; La dottrina della conoscenza;
La dottrina morale; il primato della ragion pratica; la missione sociale dell'uomo e del dotto;
Hegel e l’idealismo Assoluto La vita. critica ai sistemi idealistici di Fichte. La filosofia come
sistema; I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia; Il dibattito
critico intorno al “giustificazionismo” hegeliano; Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; i tre
momenti della dialettica; Hegel e gli illuministi; Hegel e Kant; Hegel e Fichte; la fenomenologia
all'interno del sistema; la coscienza; l'autocoscienza: signoria e servitù.
MODULO 2: CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO
Arthur Schopenhauer Le vicende biografiche e le opere (leggere); Il “velo di Maya” La scoperta
della via d’accesso alla cosa in sé (noumeno); Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; Il
pessimismo: dolore-piacere-noia la sofferenza universale l’illusione dell’amore; Il rifiuto dell'ottimismo
Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi.
Soren Kierkegaard Le vicende biografiche e le opere; l'esistenza come possibilità e fede; Il rifiuto
dell'hegelismo e la verità del singolo; gli stadi dell'esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita
religiosa; l'angoscia; la disperazione e la fede.MODULO 3: DALLO SPIRITO ALL'UOMO Dopo Hegel destra e sinistra Hegeliana; conservazione o distruzione della religione legittimazione o critica dell'esistente? Feuerbach Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione la religione come forma di alienazione. Karl Marx la vita; caratteri generali del marxismo; la critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale; La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia le contro-tesi di Marx agli “ideologi” della Sinistra hegeliana; la sintesi del Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe; la critica dei falsi socialismi: il socialismo reazionario, il socialismo conservatore, il socialismo utopistico Fourier, Owen , Proudhon e Saint-Simon. (cenni); il Capitale: merce-lavoro-plusvalore; il comunismo autentico e “l'uomo nuovo”. MODULO 4: DAL POSITIVISMO ALLA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA Auguste Comte: la legge dei tre stadi; la sociologia; la dottrina della scienza e la sociocrazia. Max Weber: il “valore” dell'oggetto storico e i caratteri della ricerca storica; l'avalutatività delle scienze storico-sociali; la struttura logica della causalità storica e i giudizi di possibilità oggettiva; la teoria dei tipi ideali5; ”il Marx della borghesia”: i limiti del materialismo storico; l'etica protestante e lo spirito del capitalismo; le tipologie dell'agire sociale; il “disincantamento del mondo” e le antinomie della modernità; il significato della scienza. Freud: Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi; la realtà dell'inconscio e i metodi per accedervi; La scomposizione psicoanalitica della personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso edipico; la civiltà come male minore. 5 Al momento della consegna del programma questa parte deve ancora essere svolta
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
INSEGNANTE: Prof.ssa Belinda Arrighetti
CLASSE 5AU
Anno scolastico 2017-2018
MODULO 1: SCIENZE DELLA TERRA: LA DINAMICA INTERNA DEL PIANETA
Minerali e rocce: definizione e classificazione. Il ciclo litogenetico.
Magma e lava: definizione e differenziazione. I vulcani: struttura e classificazione, con esempi. Le
eruzioni vulcaniche: definizione e classificazione, con esempi. La localizzazione dei vulcani sul
pianeta, il rischio vulcanico.
L’attività sismica: definizione di terremoto. Le onde sismiche: descrizione e classificazione. Il
sismografo, il sismogramma e la magnitudo. La determinazione dell’epicentro di un sisma. La
misura dell’intensità dei terremoti: scala Mercalli e scala Richter. La distribuzione geografica dei
terremoti sul pianeta. Il rischio sismico.
Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra. Lo studio dell’interno della Terra. Le superfici
di discontinuità. Il modello della struttura interna della Terra.
Il principio dell’isostasia. La teoria della deriva dei continenti. La teoria dell’espansione dei fondali
oceanici. La teoria della tettonica delle zolle come modello globale per la spiegazione della
dinamica endogena.
MODULO 2: CHIMICA: LA CHIMICA ORGANICA
Il ruolo del carbonio nei composti organici. Caratteristiche dell'elemento Carbonio, con riferimento alla
configurazione elettronica. Il fenomeno della ibridizzazione degli orbitali come spiegazione del dato
sperimentale della geometria dei composti organici.
Definizioni di idrocarburi saturi ed insaturi. Definizioni e nomenclatura di alcani, alcheni, alchini, formula
generale, di struttura e regole di nomenclatura. Reazioni di combustione, alogenazione e cracking degli
alcani. Reazione di addizione elettrofila negli alcheni e negli alchini,
Definizione di isomeria. Isomeria di struttura; di posizione e di gruppo funzionale. Stereoisomeria: gli
enantiomeri. Il polarimetro.
Il benzene: struttura, sestetto aromatico. La reazione di sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione,
alchilazione, nitrazione. Nomenclatura di alcuni idrocarburi aromatici.
Applicazioni e tossicità di alcuni dei composti studiati. Il ruolo dei gruppi funzionali.
Definizione e riconoscimento di alogeno derivati, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri,
ammine ed ammidi.
MODULO 3: CHIMICA: LA CHIMICA ORGANICA
Proprietà del carbonio e isomeria nelle biomolecole. Monomeri e polimeri, reazioni di
condensazione e di idrolisi.
I carboidrati: composizione, classificazione in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Esempi di
monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi di origine animale e vegetale, loro ruolo nei viventi.
I lipidi: composizione, classificazione in trigliceridi saturi e insaturi, fosfolipidi, steroidi. Esempi di
trigliceridi, fosfolipidi e steroidi.
Le proteine: composizione e definizione. Struttura generale degli aminoacidi, il legame peptidico;
struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.
Gli acidi nucleici: composizione, definizione generale, classificazione. Caratteristiche generali di
DNA e RNA.
Energia e metabolismo: catabolismo e anabolismo. Le vie metaboliche. L’energia libera come
indice di spontaneità delle reazioni. Struttura e funzione dell’ATP.Gli enzimi e la loro regolazione: sito attivo, substrato, complesso attivato. Modulazione dell’attività enzimatica: i cofattori e i coenzimi funzione e meccanismo di azione di NAD+ e FAD. La regolazione allosterica degli enzimi. La respirazione cellulare: richiami alla struttura del mitocondrio e alle reazioni di ossidoriduzione. La reazione generale e le tre tappe della respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Localizzazione cellulare di ciascuna tappa, composto di inizio e fine tappa, bilancio in coenzimi ridotti, ATP, H2O e CO2. La via anaerobica: fermentazione lattica e alcolica, significato, prodotti chimici e bilancio energetico. Visione complessiva delle vie anaboliche e cataboliche nel metabolismo cellulare. La fotosintesi clorofilliana: richiami alla struttura del cloroplasto, alla struttura della foglia, alla natura ondulatoria della luce. Fase luminosa e fase oscura. Il ruolo dei fotosistemi, produzione di ATP, NADPH,e O2. Il ciclo di Calvin: significato generale. Valore complessivo della fotosintesi. L’effetto serra e l’assottigliamento dello strato dell’ozono. Strumenti e metodi delle biotecnologie: il DNA ricombinante e le principali tecniche di manipolazione del materiale genetico. Gli organismi geneticamente modificati. Definizione di clonaggio e clonazione e relativi esempi. La clonazione degli organismi e le cellule staminali. Implicazioni ecologiche, etiche, morali e per la salute umana, nell’utilizzo delle biotecnologie.* *Gli argomenti indicati in corsivo verranno affrontati dopo il 3/05/2018.
MATERIA:STORIA
Prof. Chiara Pasquinelli
Ore settimanali: 2
Testi adottati: F. Bertini, Alla ricerca del presente, volume 2 e 3, edizioni Mursia Scuola
Testo da cui sono stati tratti alcuni documenti in lettura :
V. Castronovo, Milleduemila, Un mondo al plurale, Il Novecento ed il Duemila, volume 3 edizioni la
Nuova Italia
Criteri e strumenti Attinenza circa l'argomento proposto e conoscenza dei conte-
di valutazione nuti; articolazione e coerenza argomentative; correttezza e ca-
pacità linguistica, efficacia espositiva; capacità di approfondi-
mento Conoscenza dei temi trattati; proprietà del linguaggio
specifico; articolazione del ragionamento; individuazione dei
concetti chiave; stabilire collegamenti tra i concetti chiave;
esprimere giudizi personali e mostrare spunti di autonomia cri-
tica Partecipazione e impegno durante le lezioni
Livello delle conoscenze, delle capacità e delle compe-
tenze acquisite
Esposizione argomentata con descrizione e analisi dei principali
Verifiche effettuate Colloqui
Prove strutturate e semistrutturate
Metodologia Lezioni frontali
Lezioni frontali e dialogate
Indicazioni cinematografiche* e di visione di documentari su
History Channel
Spazi Aula
aula magna
Recupero Attività di recupero in itinere
Obiettivi minimi Conoscenza delle caratteristiche politiche, economiche, sociali e cultu-
rali del periodo storico considerato nel corso dell’anno scolastico.
Saper collocare cronologicamente e geograficamente le vicende stori-
che affrontate
Aver acquisito familiarità con la lettura dei documenti sto-
rici (in particolare i saggi letti nelle ore di lezione)
Essere disponibili al dialogo culturale e partecipare al lavoro scola-
stico mediante osservazioni, riflessioni e proposte* Indicazioni cinematografiche: IL GRANDE GATSBY (2013) di di Buz Luhrmann IL DISCORSO DEL RE (2010) di Tom Hooper LA CADUTA: GLI ULTIMI GIORNI DI HITLER (2004) di Oliver Hirschbiegel MUSSOLINI ULTIMO ATTO (1974) di Carlo Lizzani IL PIANISTA (2002) di Roman Polański SALVATE IL SOLDATO RYAN (1998) di Steven Spielberg LA CADUTA DEGLI DEI (1969) di Luchino Visconti ROMA CITTA' APERTA (1945) di Roberto Rossellini IL PARTIGIANO JOHNNY (2000) di Guido Chiesa LA CIOCIARA (1960) di Vittorio De Sica UNA GIORNATA PARTICOLARE (1977) di Ettore Scola IMITATION GAME (2014) Morten Tyldum SUITE FRANCESE (2014) di Saul Dibb IL GRANDE DITTATORE (1940) di Chalie Chaplin IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI (1970) di Vittorio De Sica CLIL 2 H ELLIS ISLAND LA PORTA DEL NUOVO MONDO 1 H 1929: THE WALL STREET CRASH Visione del film Hanna Arendt, nel progetto Lanterne Magiche Partecipazione alla conferenza proposte filosofiche e di valori presentazione del libro di Flores: La forza del Mito, edizioni Feltrinelli Partecipazione alla conferenza-seminario sul Risorgimento del prof. G. Paolini dell’Università di Firenze Programma Svolto MODULO 1: Il Risorgimento italiano: le teorie del dibattito risorgimentale, l’Unità d’Italia fino alla crisi di Fine secolo Il 1848: cenni agli aspetti fondamentali dell'"anno dei portenti". Le critiche di Mazzini ai moti dei decenni precedenti. Il Risorgimento Italiano dalla genesi e agli obiettivi: il decennio di preparazione e le aspettative nei confronti di Pio IX.
Il pensiero dei vari teorici del Risorgimento italiano: Mazzini, Gioberti, Cattaneo, Ferrari, D'Aze-
glio.I passi per l'unificazione italiana: dalla teoria della Giovine Italia al neoguelfismo ed il neoghi-
bellinismo. I tratti salienti del decennio di preparazione 1848-1858, l'ascesa di Pio IX e la conces-
sione dello Statuto Albertino da parte di Carlo Alberto di Savoia. Le guerre di Indipendenza. La
nascita del Regno d’Italia 17 marzo 1861.
I problemi e le questioni dell’Italia post-unitaria. Destra e sinistra storica. La rivoluzione del 1876.
La crisi di Fine secolo ed il regicidio (1898-1900)
MODULO 2: Dalla Belle Epoque alla Grande Guerra
1. La società di massa e la Belle Epoque preludio del conflitto:
L'Expo di Parigi, le novità scientifiche ed artistiche, la nascita dell'organizzazione scientifica del
lavoro: Taylorismo e Fordismo, l'Internazionalismo socialista e la prime forme di assistenza e
protezione sociale. La questione migratoria italiana ed Ellis Island
2. L'Italia nell'età giolittiana:
Il primo governo Giolitti, il Trasformismo; la modernizzazione del Paese e il duplice volto di
Giolitti verso il nord ed il sud italiani; la nascita della CGIL, le statalizzzioni; gli oppositori di
Giolitti: da Sonnino a Salvemini Il ministro della malavita; la politica economica e sociale di
Giolitti, la classe imprenditoriale e la forbice fra nord e sud. L'Italietta giolittiana e la nascita del
movimento nazionalista; l'ultimo governo Giolitti e il suffragio universale maschile (maggio 1912);
la guerra Libia (1911-12); Il Patto Gentiloni e la sospensione del Non expedit; Murri, Sturzo e le
Leghe bianche; il Governo Salandra e la settimana rossa.
MODULO 2: Dalla Grande Guerra alla crisi del 29
1. La prima Guerra Mondiale:
Impero austro-ungarico e la polveriera balcanica (indipendenza della Serbia del 1878); Il
crollo dell'Impero Turco-Ottomanno; Gli Usa potenza mondiale: la crescita economica e la
grande immigrazione; Le crisi marocchine e la polveriera balcanica, l’attentato di Sarajevo e
lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, da guerra di movimento a guerra di posizione, il
fronte francese, le trincee ed il dramma della guerra di posizione. L'Italia fra neutralisti ed
interventisti; le divisioni interne nel movimento socialista, i futuristi e la guerra; il Patto di
Londra del 26 aprile 1915, le radiose giornate e l'entrata in guerra dell'Italia: 6 milioni di
italiani al fronte. Il fronte trentino-friulano: le terre irredente e la guida
di Cadorna; la Prima Guerra Mondiale come IV guerra di Indipendenza?; il blocco navale
inglese e la guerra dei mari, la tecnologia e la chimica al servizio della guerra, il
coinvolgimento della popolazione civile e la mobilitazione bellica; le donne alla guerra: le
donne lavoratrici nelle fabbriche e l'emancipazione; 1917 l'anno della svolta: la rivoluzione
russa e l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto, la disfatta di Caporetto: Diaz e la disciplinadella persuasione; il contrattacco dell'Intesa e la sconfitta degli Imperi centrali; la leva del'99 e
Vittorio Veneto: il riscatto degli Italiani, l’inutile strage di Benedetto XV.
1.I trattati di pace:
I 14 punti di Wilson, nazionalità e democrazia, la Conferenza di pace di Parigi e i suoi
protagonisti; la pace punitiva della Germania (Trattato di Versailles) e la questione
dell'Alsazia e della Lorena; la smilitarizzazione tedesca e le riparazioni di guerra, la fine dei
grandi imperi, lo sfaldamento dell'Impero Austro-Ungarico e la nascita del Regno dei Serbi,
dei Croati e degli Sloveni (dal 1929 Jugoslavia); la nascita della Società delle Nazioni; il
fallimento delle prospettive di Wilson
2.Società ed economia fra le due guerre, la crisi del 29:
Società ed economia post bellica: le problematicità della ricostruzione;la recessioni e
l'aumento della disoccupazione; le finanze e i rapporti internazionali; la riconversione
industriale e il pesante impatto sui ceti medi della fine della Guerra; Europa e dopoguerra: il
vecchio continente senza pace; 1924: il piano Dawes e gli aiuti americani al Vecchio
Continente; le fragili istituzioni europee: la Repubblica di Weimar e le sue deboli
fondamenta; la crisi della Ruhr, il putsch di Hitler del 1923; il governo di Stresemann;
l'accordo di Locarno del 1925 e la Germania nella Società delle Nazioni;
La Russia dello Zar e e le prime ideologie rivoluzionarie: bolscevichi e menschevichi. La
Rivoluzione di Ottobre e la nascita dei Soviet, Lenin e Le tesi di Aprile.
Gli 'anni ruggenti' degli Stati Uniti: la ricchezza degli anni Venti; Il crollo della borsa di
Wall Street e la fine di un'epoca; le conseguenze della grande depressione in America e in
Europa; L'Interventismo di Stato; F. D. Roosevelt ed il New Deal.
MODULO 3: L'età dei totalitarismi
1. La nascita del regime fascista:
Il difficile Dopoguerra italiano; la vittoria mutilata e la delusione di Versailles; la vicenda
della città di Fiume; il Biennio Rosso; I consigli di fabbrica e le rivendicazioni dei braccianti;
l'affermarsi dei partiti di massa; il Partito Popolare Italiano di Sturzo (1919); Giolitti e lo
sfaldamento dello liberalismo politico; la nascita dei Fasci di Combattimento; la scissione di
Livorno e la nascita del Partito Comunista (1921); Le paure e le rivendicazioni della
borghesia; lo squadrismo e le camicie nere; l'eclissi dello Stato liberale e Luigi Facta; la
marcia su Roma e l'ascesa al potere di Benito Mussolini; la Legge Acerbo e il delitto
Matteotti, la Secessione dell’Aventino e il discorso del 3 gennaio del 1925; lo Stato Fascista:
il processo di fascistizzazione fra leggi fascistissime e la strategia del consenso;
L'antifascismo fra opposizione e persecuzione; I rapporti con la Chiesa: i Patti Lateranensi
del 1929; Il consenso e la propaganda; la comunicazione di massa e l'Opera Nazionale
dopolavoro; la nascita del Minculpop nel 1937; Economia e interventismo fascista: la
battaglia del grano; quota 90; il programma di lavori pubblici (bonifiche e infrastrutture), la
nascita di Sabaudia e Littoria; l'autarchia; la politica ambivalente di Mussolini all'estero:
dallo spirito di Locarno agli accodi di Stresa; la guerra d'Etiopia e la nascita dell'Impero, le
sanzioni economiche della Società delle Nazioni;
l'avvicinamento alla Germania di Hitler, le leggi razziali del 1938 ed il Manifesto degli
scienziati razzisti.1.La Germania da Weimar a Hitler ed il Terzo Reich:
La Germania, la destra e lo spirito di revanche, il ritorno del Partito nazionalsocialista e la
partecipazione alle elezioni; SA ed SS, le manifestazioni di massa del partito nazista e la
politica della violenza, la pubblicazione di Mein Kampf e la liquidazione del "nemico
interno ed esterno"; il consenso crescente del nazismo e gli effetti della crisi americana del
’29; la congiuntura economica e le conseguenze politiche del Trattato di Versailles; il
presidente Von Hindemburg ed il tentativo di "addomesticare" Hitler; l'opposizione a sinistra
e le sue divisioni interne, la SPD e la lega di Spartaco, il 1930 e l'avvento di Hitler al potere;
la drammatica accelerazione degli eventi dallo scioglimento del Parlamento, l'incendio del
Reichstag alla legge dei pieni poteri; i passi della nazificazione e la notte dei lunghi coltelli;
il Fuhrer e l'ideologia totalitaria; la repressione del dissenso e il controllo capillare della
società, la diffusione dell'antisemitismo; la Gestapo e la liquidazione del dissenso; la politica
estera revisionista e la ripresa dello spirito aggressivo: la teoria dello spazio vitale;
l'antisemitismo statale e la teoria della razza ariana: le leggi di Norimberga del 1935 e
l'emarginazione sociale degli ebrei; la notte dei cristalli del 1938
1.l'URSS dalla dittatura del proletariato al Stalin
Da Lenin a Stalin; la figura di Stalin (acciaio), il centralismo del PCUS; il
ridimensionamento della della struttura federale dell'URSS e Mosca come baricentro del
potere; lo scontro Stalin-Trockij: il socialismo in un solo Paese o la rivoluzione permanente;
l'espulsione di Trockij; l'archiviazione della Nep e la collettivizzazione forzata delle
campagne, la guerra ai kulaki e la requisizione della terra con la redistribuzione coatta; i
piani quinquennali e il processo di espansione dell'industria pesante: il successo
dell'industrializzazione; la costruzione forzata del consenso e il controllo totale sulla società;
l'indottrinamento ideologico e e l'autocrazia politica; il regime totalitario di Stalin; le grandi
purghe ed il Commissariato del popolo per gli affari interni: dai processi pubblici al terrore
staliniano; la realtà dei gulag, le persecuzioni ed epurazioni.
MODULO 4: La Seconda Guerra Mondiale e le conseguenze del conflitto
1. Verso la Seconda Guerra Mondiale:
Il riarmo della Germania e il revisionismo dei trattati di Versailles; uscita della Germania
dalla Società delle Nazioni; la politica del riarmo e la coscrizione obbligatoria, la
Wehrmacht e la Luftwaffe; la conferenza di Stresa e il fronte franco-italo-britannico; la
Guerra d'Etiopia, l'embargo all'Italia e l'avvicinamento di Mussolini ad Hitler; la
rimilitarizzazione della Renania; la Guerra civile spagnola come prologo della Prima Guerra
mondiale (cenni); L'Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern, l'instabilità in Asia:
l’imperialismo giapponese; l'Anschluss e l'Austria provincia del Grande Reich; la politica
dell’attendismo degli Alleati; la questione dei Sudeti, la Conferenza di Monaco e lo
smembramento della Cecoslovacchia; le pretese tedesche sul corridoio di Danzica;
l'invasione italiana dell'Albania nel 1939 e il Patto d'Acciaio; la Realpolitik e il patto
Molotov Ribbentrop.1.La Seconda Guerra Mondiale:
Le prime operazioni belliche; l'invasione e l'occupazione della Polonia (1 settembre 1939) e
il tentativo della guerra lampo; il regime di occupazione in Polonia; la Finlandia occupata
delle truppe sovietiche; l'invasione di Danimarca e Norvegia; Francia e Inghilterra immobili:
la strana guerra; l'assalto a Olanda, Belgio e Lussemburgo, l'occupazione ed il crollo della
Francia, Parigi occupata dalla Wehrmacht; la Francia si spacca in due parti: l'occupazione
militare nazista e il governo di Vichy con Petain; il regime collaborazionista e la resistenza
di De Gaulle; l'Urss invade Estonia, Lettonia e Lituania (1940); L'Italia e non belligeranza
del 1939; la dichiarazione di guerra alla Francia da parte di Mussolini nel giugno del 1940;
Churchill e la resistenza fino alla vittoria, l'operazione Leone Marino e la battaglia di
Inghilterra; la RAF inglese e la Royal Navy resistono agli attacchi tedeschi; la guerra
parallela dell'Italia (dall'Africa all'offensiva dei Balcani); i rovesci militari italiani e il deficit
strategico; l'Afrikakorps di Rommel e la subordinazione degli italiani ai tedeschi; i reparti
tedeschi in Jugoslavia e Grecia; l'Operazione Barbarossa e l'attacco all'Urss; la
controffensiva sovietica; gli Stati Uniti e la Legge affitti e prestiti, la Carta Atlantica ed il
supporto alla guerra antifascista; l'attacco di Pearl Harbor ed i kamikaze giapponesi; gli Usa
entrano in guerra a fianco degli Alleati; l'ordine interno del Terzo Reich: sfruttamento,
razzismo organizzato, persecuzione degli ebrei e soluzione finale del 1941 (la rivolta del
ghetto di Varsavia); le componenti della resistenza antinazista e antifascista, il
collaborazionismo ed i governi fantoccio. La svolta del 41 e la battaglia di Stalingrado, la
vittoria inglese di El Alamein, la conferenza di Casablanca e l'apertura del secondo fronte:
gli Alleati in Sicilia (10 luglio1943); il fronte giapponese e la logica dell'Asia agli Asiatici;
la conferenza di Teheran e lo sbarco in Normandia del 1944; l'Armata Rossa e le vittorie sul
fronte orientale; l'insurrezione di Varsavia; attentato al Fuhrer del 1944; l'ultima fase della
'"guerra totale" e i bombardamenti alleati sulla Germania; Conferenze di Mosca e Jalta e i
progetti per le sfere di influenza; la controffensiva alleata e la morte di Hitler; la resa
incondizionata della Germania; il fronte del Pacifico e gli USA; il presidente Truman e le
bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki.
Si anticipa che nelle ultime settimane di scuola si prevede di affrontare le tematiche della
L'Italia e il 1943: un Paese spaccato in due: la Repubblica di Salò e la Resistenza; La
Guerra Fredda ed il mondo diviso in due blocchi, dell'Italia della Ricostruzione (gli esordi
della Repubblica; la Costituzione e le istituzioni repubblicane, il boom economico).Puoi anche leggere