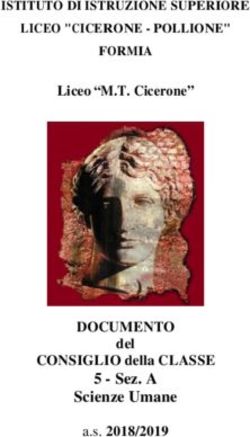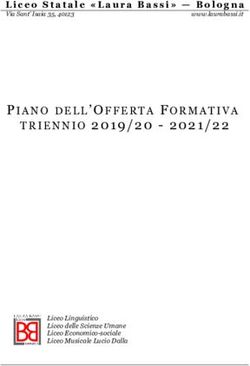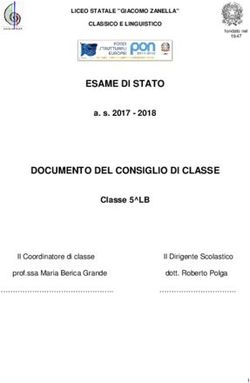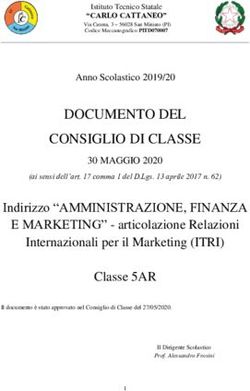DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Classe 5a sez. AT a.s. 2020-2021 indirizzo: LICEO CLASSICO
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe 5a sez. AT
a.s. 2020-2021
indirizzo: LICEO CLASSICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelica BaioneEsame di Stato
Anno Scolastico 2020-2021
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ.AT
Indirizzo: Liceo Classico
Docenti del Consiglio di Classe
1. Gnocchini Marco
2. Martino Francesco Pio
3. Mercuri Laura
4. Montanari Gabriele Cristiano
5. Piattella Maria Paola *
6. Sandroni Claudia
7. Sebastiani Ilaria
8. Tortorella Gaetano
9. Valletta Vera
*Coordinatore di Classe
Rappresentanti degli alunni
1.
2.
Ancona, 15 maggio 2021
Il Dirigente Scolastico
Angelica Baione
2DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. AT
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO
PREMESSA pag. 5
PARTE PRIMA
1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1. Piano di studi, finalità istituzionali pag. 7
2. Quadro orario pag. 8
2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
1. Elenco dei candidati pag. 9
2. Variazioni numeriche della classe pag. 10
3. Continuità dei docenti della classe pag. 10
4. Presentazione della classe pag. 11
5. Strategie e metodi per l’inclusione pag. 11
3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Metodologie e strategie didattiche pag. 12
4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO pag. 12
2. Educazione Civica pag. 13-14
3. Incontri; progetti significativi e viaggi di istruzione pag. 14-15
4. Valutazione: scala dei punteggi e descrittori pag. 16
a) Tabella dei criteri generali di valutazione pag. 16
b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta pag. 17
c) Modalità di attribuzione del credito scolastico pag. 18-20
d) Criteri di attribuzione del credito formativo e del credito scolastico pag. 20-21
5. Griglia di valutazione della prova orale pag. 22
3PARTE SECONDA
1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
1. Lingua e letteratura italiana pag.24
2. Lingua e cultura latina pag.40
3. Lingua e cultura greca pag.44
4. Lingua e cultura straniera (Inglese) pag.48
5. Storia pag.54
6. Filosofia pag.64
7. Matematica pag.70
8. Fisica pag.72
9. Scienze Naturali pag.74
10. Storia dell’arte pag.75
11. Scienze motorie e sportive pag.78
12. IRC pag. 80
4PARTE PRIMA
PREMESSA
Il Documento del 15 maggio per l’anno scolastico 2020-2021 è elaborato sulla base
della rimodulazione della programmazione disciplinare dovuta all’introduzione della
didattica digitale integrata per l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Il documento restituisce un profilo completo della classe, dando indicazioni sui
programmi effettivamente svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici
utilizzati, sui criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico.
Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del
quinquennio, dai percorsi di Educazione Civica alle attività di PCTO, alle varie
progettualità dell’Istituzione scolastica, pone in evidenza le novità introdotte nel
corso del presente anno scolastico in quanto alla ripresa delle lezioni a
settembre l’attività didattica è stata svolta utilizzando la modalità della Didattica
Digitale Integrata DDI che comprende la didattica a distanza DAD e la didattica
in presenza a seconda delle aperture e chiusure delle scuole normate
dall’ordinanze regionali e dai DPCM.
Di conseguenza la pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano
di miglioramento nell’anno scolastico 2020/2021 sono state modificate a causa della
situazione emergenziale sanitaria dovuta alla pandemia per il rapido diffondersi del
Coronavirus.
Considerato che non tutte le attività previste nel RAV 2019/2022 hanno potuto trovare
una realizzazione causa la situazione pandemica, la priorità è stata data a tutte le
azioni finalizzate a garantire agli studenti del Liceo la vicinanza dei loro docenti e la
veicolazione dei contenuti disciplinari per assicurare gli apprendimenti, anche quando
ciò è avvenuto a distanza.
I docenti hanno proseguito nelle nuove pratiche rese necessarie dalla modalità
didattica mista già menzionata quali l’utilizzo della piattaforma G-Suite.
Forti dell’esperienza del precedente anno scolastico, i docenti e il gruppo classe hanno
continuato a
svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale l’orario delle lezioni;
svolgere lezioni asincrone;
condividere materiale didattico su Classroom;
utilizzare le app di Google.
Nel presente anno scolastico i docenti hanno continuato ad essere formati e supportati
nell’utilizzo della nuova modalità didattica tramite tutorial e consulenza individuale
forniti dall’Assistente tecnico, dall’Esperto esterno e dall’Animatore Digitale dell’Istituto,
5che hanno via via ottimizzato il servizio aggiungendo agli strumenti già forniti nuove
estensioni (quali Grid View, Meet Attendance, Nod, Tab Resize) e modalità di fruizione
dei contenuti a distanza (come la condivisione dell’audio del pc per attività di ascolto,
particolarmente importante per le lingue straniere, o la condivisione della lavagna
Jamboard, di utile impiego per lo svolgimento di esercizi di matematica e fisica) e di
creazione, assegnazione, correzione, valutazione e restituzione in piattaforma di
compiti scritti.
I docenti si sono incontrati “online” nell’ambito dei Consigli di Classe e nelle riunioni di
Dipartimento e di Area Disciplinare per condividere spunti di riflessione, griglie per la
valutazione formativa degli apprendimenti, nonché per valutare la possibilità di
prevedere una rimodulazione di programmi e orari per non affaticare troppo gli
studenti, costretti a lavorare al pc per diverse ore la mattina, in videolezione, e il
pomeriggio, per la preparazione delle esercitazioni scritte loro assegnate nelle varie
discipline.
I docenti hanno utilizzato le funzionalità Axios unitamente alla piattaforma GSuite for
Education. L’istituto ha infine provveduto a fornire la dovuta informativa ai docenti e
alle famiglie in tema di Didattica a distanza e privacy.
La didattica digitale integrata ha consentito di mantenere la preziosa relazione tra
docenti e discenti ed è stata declinata con grande interesse e adeguata competenza
dai docenti e con senso di responsabilità dagli studenti, che hanno partecipato in modo
costruttivo al dialogo scolastico.
61. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI
Liceo ClassicoTradizionale
Il Liceo Classico assolve a un doppio impegno: la conoscenza della cultura classica e umani-
stica e l’acquisizione di un metodo che veicola abilità e conoscenze a padroneggiare solide
competenze.
Non a caso lo studio tecnico delle lingue classiche e dell’italiano, affrontato in maniera appro-
fondita e rigorosa nel primo biennio, poggiato su solide basi metodologiche che coniugano il
problem solving con l’esercizio di memorizzazione e rielaborazione delle conoscenze, permette
allo studente, nel triennio, di confrontarsi con i testi latini e greci in lingua originale e con le ope-
re della letteratura italiana.
L’acquisizione di una buona capacità di argomentazione e interpretazione, unita alla metodolo-
gia del problem solving, permette di raggiungere le competenze necessarie alla risoluzione lo-
gica e innovativa di problemi relativi ad ambiti anche assai distanti dalle discipline specifiche
del corso di studi, grazie anche alla sinergia metodologica attivata con le materie scientifiche.
L’esercizio costante della logica e la robusta formazione linguistica e culturale, cui concorrono
anche iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa, permette, inoltre, agli alunni di affrontare
con serenità i test d’ingresso alle facoltà universitarie.
La conoscenza approfondita del percorso storico della nostra civiltà fin dalle sue origini, coniu-
gata con la riflessione filosofica, consente di giungere all’acquisizione delle competenze di cit-
tadinanza, oltre all’elaborazione di un pensiero critico in grado di comprendere ed elaborare la
realtà, contribuendo alla realizzazione di una società equa ed equilibrata.
Il Liceo Classico Tradizionale è stato potenziato fin dal primo anno dallo studio delle Scienze
Naturali, fondamentali per affrontare i quesiti dei test d’ingresso alle facoltà scientifiche, alle
quali negli ultimi anni sempre più si rivolgono gli alunni usciti dal Liceo Classico per continuare
gli studi.
Si conferma infine il ruolo essenziale dello studio della Lingua e della Letteratura Straniera nel
corso dell’intero quinquennio, volto a padroneggiare una seconda lingua. Questa è una com-
petenza ormai da considerarsi imprescindibile come strumento di comunicazione globale, co-
me apertura consapevole alle altre culture e come allargamento delle conoscenze e compe-
tenze critiche nei confronti della produzione letteraria occidentale.
7Il profilo d’uscita atteso
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimen-
to comuni, dovranno:
• Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi,
ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di compren-
sione critica del presente;
• Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (mor-
fosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in
relazione al suo sviluppo storico;
• Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione, compatibilmente con le difficoltà do-
vute alla pandemia, quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una
buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipo-
logie di problemi anche distanti dalle discipline specificatamente studiate;
• Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
1.2 QUADRO ORARIO
ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
I BIENNIO II BIENNIO
PER TUTTI GLI STUDENTI 5°
1° 2° 3° 4° anno
anno anno anno anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 3 3 3
Filosofia - - 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Storia dell’Arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE SETTIMANALI 28 28 32 32 32
82. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
2.1 ELENCO DEI CANDIDATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.2 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE
Anno di corso N° alunni N° alunni N° alunni N° alunni
iscritti trasferiti da trasferiti ad ammessi alla
altre scuole o altre sezioni o classe
sezioni scuole o successiva
ritirati
III 19 19
9IV 19 1 20
V 20
2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE
DOCENTI DOCENTI DOCENTI
MATERIA
CLASSE III CLASSE IV CLASSE V
Sebastiani Sebastiani Sebastiani
Lingua e letteratura italiana
Ilaria Ilaria Ilaria
Ascani Valletta Ve- Valletta Ve-
Lingua e cultura latina
Alessia ra ra
Ascani Ascani Valletta Ve-
Lingua e cultura greca
Alessia Alessia ra
Piattella Ma- Piattella Ma- Piattella Ma-
Lingua e cultura straniera (Inglese)
ria Paola ria Paola ria Paola
Gnocchini Gnocchini Gnocchini
Storia
Marco Marco Marco
Gnocchini Gnocchini Gnocchini
Filosofia
Marco Marco Marco
Mercuri Mercuri Mercuri
Matematica
Laura Laura Laura
Martino
Colonnelli Arcangeli
Scienze naturali Francesco
Raniero Sara
Pio
Mercuri Mercuri Mercuri
Fisica
Laura Laura Laura
Sandroni Sandroni Sandroni
Storia dell’arte
Claudia Claudia Claudia
Montanari
Svegliati Lucchetti
Scienze motorie e sportive Gabriele
Annalisa Cristiana
Cristiano
Tortorella Tortorella Tortorella
Religione cattolica
Gaetano Gaetano Gaetano
Studio indi- Studio indi- Studio indi-
Attività alternativa
viduale viduale viduale
102.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo storico
La classe 5 AT ha seguito fin dal primo anno di corso l’indirizzo tradizionale. Il numero degli
studenti non è variato nel triennio ad eccezione di un alunno che si è trasferito nel nostro istitu-
to, proveniente da Ascoli Piceno. Il corpo docente ha invece subito alcune variazioni nelle di-
scipline di Lingua e Letteratura Greca, Lingua e Letteratura Latina, Scienze, Educazione Fisica.
Questi avvicendamenti didattici, compensati dalla continuità nelle altre discipline, non hanno in
alcun modo ostacolato l’acquisizione e il consolidamento, nel corso del triennio, del metodo di
studio e della capacità sia organizzativa che di rielaborazione personale delle tematiche. Gli
studenti hanno partecipato alle attività di approfondimento disciplinari,curricolari ed extracurri-
colari, previste dal PTOF, sviluppando interessi diversificati, anche rivolti alle scelte future di
studio. Nel momento in cui è stato necessario dare avvio alla didattica a distanza a causa della
pandemia gli studenti hanno dimostrato maturità sia nell’assiduità alle lezioni sia nella continui-
tà dell’impegno .
Il profitto
Nel complesso gli alunni , lavorando con motivazione, serietà ed impegno, hanno ottenuto un
positivo livello di preparazione, ciascuno secondo i propri interessi ed aspirazioni. Sono in pos-
sesso di un valido metodo di analisi e sintesi che si traduce in un profitto buono, con punte di
eccellenza; gli studenti hanno dimostrato di saper rielaborare in modo personale gli argomenti
disciplinari e con la didattica a distanza si è presentata l’opportunità di ampliare e far emer-
gere la propria capacità critica fino al raggiungimento di uno studio consapevole e di un atteg-
giamento nel complesso maturo nei confronti della cultura.
La condotta
Il dialogo educativo si è rivelato sempre positivo ed improntato al confronto. Gli studenti hanno
sempre dimostrato interesse e motivazione per le discipline di studio. Nel corso del triennio è
cresciuto anche il senso di appartenenza alla scuola e con responsabilità è stata gestita
l’organizzazione scolastica da parte dei rappresentanti degli studenti ( sia di classe che presso
la Consulta provinciale). La classe nel corso degli anni ha maturato un atteggiamento collabo-
rativo e di sostegno vicendevole. Durante la DDI gli studenti hanno mostrato solidarietà gli uni
con gli altri, elasticità nell’approccio a nuove strategie didattiche, capacità di approfondire pro-
blematiche e argomenti in team o in modo individuale. E’ cresciuta anche la capacità di orga-
nizzare il lavoro in modo autonomo.
2.5 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Durante i cinque anni di corso sono state approntate strategie e metodi di inclusione quando è
stato necessario ( Pdp per alcuni studenti) e sempre con la collaborazione delle famiglie. Ai
sensi della Normativa sulla Privacy la documentazione relativa è allegata al documento carta-
ceo.
113. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE : SONO STATE UTILIZZATE LEZIONI FRONTALI E DIALOGA-
TE, PROBLEM SOLVING, ESERCITAZIONI GUIDATE, LETTURA , ANALISI E INTERPRETAZIONI DI TESTI,
LAVORI INDIVIDUALI DI APPROFONDIMENTO, PARTECIPAZIONE A OLIMPIADI E CERTAMINA STUDEN-
TESCHI, CONFERENZE, AUDIOVISIVI. NEL CORSO DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO LE LEZIONI SONO
STATE SVOLTE IN MODALITÀ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO PCTO
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza Scuola Lavo-
ro) costituiscono un nuovo approccio alla didattica e si rivolgono a tutti gli studenti del se-
condo biennio e dell'ultimo anno attraverso un percorso di non meno di 90 ore per i licei (
secondo la legge di Bilancio 2019, precedentemente non meno di 200 ore Legge 107/2015)
che alterna lo studio e la formazione in aula ad esperienze pratiche di stage con la finalità di
fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad affronta-
re consapevolmente le scelte future e la possibilità di gettare un ponte tra scuola e Univer-
sità con una proficua continuità della formazione, così da fare esperienza dei contesti orga-
nizzativi propri del mondo del lavoro, di testare la relazione tra “saper fare” e “sapere scola-
stico”.
Le attività di formazione e di tirocinio ineriscono i progetti presentati dai referenti di proget-
to/ tutor interni e sono legate al curriculum integrato del Liceo Classico soprattutto in riferi-
mento alle seguenti competenze
• Consapevolezza dell’espressione culturale
• Competenze sociali e civiche
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Con tali percorsi ci si propone di aprire la scuola al mondo esterno consentendo, più in ge-
nerale, di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning)
e consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro (learning by
doing). Ci si propone inoltre di potenziare le strategie di studio, rafforzare la motivazione e
la percezione di autoefficacia, promuovere l’innovazione della didattica e la diffusione di
processi formativi orientati all’acquisizione di competenze spendibili promuovendo
l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore
coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnolo-
gie.
L’articolazione delle fasi operative all’interno del triennio si è esplicitata in:
• formazione/esperienza: durante il secondo biennio gli studenti hanno seguito la formazio-
ne obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, hanno poi seguito un percorso di formazione che
ha portato ad esperienze di stage o project work. In virtù dell’evidente potenziale orientati-
vo di alcuni progetti di PCTO qualche studente ha anticipato l’orientamento al secondo
biennio.
• orientamento: Tutti gli studenti nel monoennio hanno seguito percorsi di orientamento
12Per la descrizione dettagliata dei percorsi realizzati dagli studenti si fa riferimento al Curri-
culum dello studente e all’allegato PCTO.
4.2 EDUCAZIONE CIVICA
Argomenti Ore di le- Ore di verifi- Tipo di Docente
zione ca prova coinvolto
Ambito 1 - Costituzione ed educazione alla cittadinanza consapevole (12 ore
1) Costituzio- Primo qua- Comprese Orale oppure: Docente
ne ed Ordina- drimestre: nel monte TEST A DO- di Filo-
mento della 6 (Storia e ore di le- MANDA sofia e
Repubblica Filosofia) zione APERTA e/o Storia
2)Autonomie CHIUSA/ pro-
locali e Unione va di com-
Europea Secondo prensione
3) Organismi Quadrimestre:
Internazionali 6 (Greco)
4)La degene- idem Docenti
razione della Idem di greco
democrazia, il
populismo, il
dibattito sulla
migliore forma
di governo
Ambito 2 – Sostenibilità ambientale
Temi da idem idem idem Docente
agenda Onu di Scien-
2030: ze natura-
target 2: li
sconfiggere
la fame:
OGM;
target 7: sa-
lute e be-
nessere: le
biotecnologie
in campo
biomedico.
Ambito 3 – Cittadinanza digitale
131)Adattare le Primo qua- idem TEST A Docente
strategie di co- drimestre DOMANDA di
municazione digi- 4 (Religione) APERTA e/o Religione
tale al destinata- CHIUSA
rio consapevoli
della diversità
culturale e gene-
razionale
2)Identità digitale
3)Pericoli
dell’ambiente di-
gitale
Secondo Esposizione
Quadrimestre dell’attività
5 (Inglese) svolta se-
1)Criticalthinkinge Compresa condo web-
digitalfootprint: le nel monte search, e Docente
tracce digitali in- ore di do- presentazioni di
delebili e relative cenza in ppt Inglese
conseguenze nel-
la vita reale
4.3 INCONTRI, PROGETTI SIGNIFICATIVI E VIAGGI D’ISTRUZIONE
INCONTRI: PROF. CAMILLO NERI: LA NUOVISSIMA SAFFO E VECCHIE QUESTIONI
PROF. GIORGIO IERANÒ: LE BACCANTI DI EURIPIDE TRA RELIGIONE E TEATRO
MINISTRA DELLA GIUSTIZIA MARTA CARTABIA E LUIGI FERRARELLA (CORRIERE DELLA SERA) LEZIONE DI
“COSTITUZIONE, REGOLE E LIBERTÀ”
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA ORGANIZZATA DALLA SCUOLA (ASSEMBLEA DI ISTI-
TUTO)
14Certificazioni Linguistiche (FCE-CAE); Scrittu-
Area Umanistica- linguistica ra Creativa ; Flash dal Quotidiano; Colloqui
Fiorentini; Debate; Olimpiadi della Lingua
Italiana; seminari Diritto e economia
Area Matematica - scientifica Olimpiadi di Matematica a squadra e indivi-
duali; E.E.E.
Scienze Motorie Campionati studenteschi
Interdisciplinari Giornate F.A.I. di Primavera; Orientamento in
entrata; Accoglienza; PON : Progetto “La Fa-
lesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (An-
cona): itinerari fra natura e storia” cod. id.
10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8.; Progetto
Lampedusa; In caratteri matematici (PCTO)
2018-2019: Viaggio in Grecia
2019 : Biennale di Venezia e Museo Guggenheim
154.4 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI
a) Tabella generale dei criteri di valutazione inserita nel PTOF 2019-2022:
CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA
C O N O S C E N Z E ABILITÀ /CAPACITÀ C O M P E T E N Z E
Non è capace di effettuare alcuna
Nessuna conoscenza o Non riesce ad applicare le sue
Molto negativo analisi e a sintetizzare le conoscenze
poche/ pochissime cono- conoscenze e commette errori
(0 - 3) acquisite. Non è capace di autonomia
scenze gravi.
di giudizio e valutazione.
C O N O S C E N Z E ABILITÀ /CAPACITÀ C O M P E T E N Z E
Riesce ad applicare le cono-
Effettua analisi e sintesi solo parziali
Carente Frammentarie e superfi- scenze in compiti semplici, ma
ed imprecise. Sollecitato e guidato
(4 – 4.5) ciali commette errori anche gravi
effettua valutazioni non approfondite
nell'esecuzione
C O N O S C E N Z E ABILITÀ /CAPACITÀ C O M P E T E N Z E
Effettua analisi e sintesi, ma non
complete ed approfondite. Guidato e Commette qualche errore non
Insufficiente Superficiali e non del tutto
sollecitato sintetizza le conoscenze grave nell’esecuzione di compiti
(5 – 5.5) complete
acquisite e sulla loro base effettua piuttosto semplici
semplici valutazioni.
C O N O S C E N Z E ABILITÀ /CAPACITÀ C O M P E T E N Z E
Effettua analisi e sintesi complete, ma
Applica le conoscenze acquisite
Sufficiente Conoscenze complete ma non approfondite. Guidato e sollecita-
ed esegue compiti semplici sen-
(6 – 6.5) non approfondite to riesce ad effettuare valutazioni
za fare errori
anche approfondite
C O N O S C E N Z E ABILITÀ /CAPACITÀ C O M P E T E N Z E
Effettua analisi e sintesi complete ed Esegue compiti complessi e sa
Discreto Conoscenze complete ed approfondite con qualche incertezza. applicare i contenuti e le proce-
(7 – 7.5) approfondite Se aiutato effettua valutazioni auto- dure, ma commette qualche er-
nome parziali e non approfondite rore non grave
C O N O S C E N Z E ABILITÀ /CAPACITÀ C O M P E T E N Z E
Esegue compiti complessi e sa
Effettua analisi e sintesi complete ed
Buono Conoscenze complete applicare i contenuti e le proce-
approfondite. Valuta autonomamente
(8 – 8.5) approfondite e coordinate dure, ma commette qualche im-
anche se con qualche incertezza
precisione
C O N O S C E N Z E ABILITÀ /CAPACITÀ C O M P E T E N Z E
Coglie gli elementi di un insieme,
Conoscenze complete, stabilisce relazioni, organizza auto- Esegue compiti complessi, appli-
Ottimo/Eccellente approfondite nomamente e completamente le co- ca le conoscenze e le procedure
(9 - 10) Coordinate, ampliate e noscenze e le procedure acquisite. in nuovi contesti e non commette
personalizzate Effettua valutazioni autonome, com- errori
plete, approfondite e personali
16b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
AREA DELL’EDUCAZIONE VOTO 10 VOTO 9 VOTO 8 VOTO 7 VOTO 6 VOTO 5
CIVICA - Frequenza -Frequenza - Frequenza - Frequenza - Frequenza - Frequenza
Rispetto del regolamento assidua (as- assidua (as- nel complesso non sempre irregolare irregolare (as-
senze 0%-8%) senze 9-12%) regolare (as- regolare (as- (assenze senze oltre il
- Puntualità -Puntualità senze13-16%) senze 17- 21-25%) 25%)
• Frequenza
- Comporta- -Comporta- - Occasionale 20%) - Ritardi - Ritardi abitua-
• Puntualità
mento lodevole mento corretto mancanza di - Ritardi abi- abituali non li e frequenti
• Rispetto persone e arredi
e corretto ver- verso tutti puntualità tuali giustificati - Numero ele-
• Rispetto delle disposizioni so tutti - Totale as- - Comporta- - Comporta- - Comporta- vato di assen-
del Regolamento d’Istituto - Uso respon- senza di note mento gene- mento non mento non ze non giustifi-
sabile delle disciplinari ralmente cor- sempre corret- sempre cor- cate
strutture e dei retto verso tutti to verso tutti retto verso -Provvedi-
materiali - Qualche ri- - Rispetto par- tutti menti discipli-
- Totale assen- chiamo verba- ziale delle - Rispetto nari
za di note di- le regole parziale
sciplinari - Nessun ri- - Richiami delle regole
chiamo sul scritti sul regi- - Richiami
registro di stro di classe scritti sul
classe o scritto registro di
classe
AREA PEDAGOGICO- -Ruolo collabo- - Ruolo colla- - Ruolo non - Ruolo scar- - Partecipa- - Partecipa-
RELAZIONALE rativo e propo- borativo in sempre colla- samente col- zione zione passiva
sitivo in classe classe borativo laborativo occasionale - Generale
Partecipazione al dialogo - Partecipa- - Buon livello - Interesse e - Interesse e disturbo
educativo zione costrutti- di partecipa- partecipazione partecipazione dell’attività
• Partecipazione al lavoro va zione alle atti- selettivi superficiali
didattico in classe - Ottima socia- vità didattiche
• Senso di responsabilità lizzazione
durante visite e viaggi
d’istruzione e nel corso di
attività extrascolastiche
• Collaborazione con i
compagni
AREA DELL’ISTRUZIONE E - Impegno lo- - Buon impe- - Impegno nel - Impegno - Impegno - Ripetuta
DELLA FORMAZIONE CUL- devole consa- gno complesso discontinuo e saltuario mancanza di
pevole e matu- - Diligente costante superficiale - Scarso rispetto delle
TURALE ro svolgimento - Generale - Rispetto par- rispetto delle consegne
Impegno nello studio - Puntuale e delle conse- adempimento ziale delle consegne
• Rispetto delle con- serio svolgi- gne scolasti- delle conse- consegne
segne mento delle che gne scolasti-
• Presenza alle verifi- consegne sco- che
che lastiche
• Impegno nella didat-
tica curricolare e a
distanza
• Partecipazione alle
iniziative scolastiche
Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per
ciascuna colonna.
17c) Modalità di attribuzione del credito scolastico
Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i
criteri su indicati, considerate le tabelle fissate dal D.Lgs. 62/2017 (che sostituisce il D.M.
99/2009) e dall’O.M 10/2020, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito
scolastico secondo le bande e i criteri di seguito esplicitati, fino ad un massimo di 60 punti
complessivi nel triennio.
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede di
integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative.
Il Consiglio di Classe ha provveduto altresì a convertire il credito scolastico relativo al terzo e al
quarto anno di corso utilizzando le tabelle contenute nell’Allegato A del D.Lgs. 62/2017 e
nell’Allegato A dell’O.M. 10/2020.
ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE DEL CREDITO: TABELLE UTILIZZATE PER ANNO DI CORSO
ANNO DI CORSO TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO TABELLE DI CONVERSIONE APPLICATE
APPLICATA
Terzo (a.s. 2017-18) Tabella A allegata al D.M. 99/2009 1. Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime
transitorio – Candidati che sostengono
l’esame nell’a.s. 2019/2020”
2. Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella A
Quarto (a.s. 2018-19) Allegato A al D.Lgs. 62/2017, Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella B
“Tabella attribuzione credito
scolastico”
Quinto (a.s. 2019-20) Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella C ---
Si riportano di seguito le tabelle citate:
Terzo anno:
• D.M. 99/2009, Tabella A*
Media dei voti Credito scolastico (punti)
I anno
M=6 3-4
6< M ≤ 7 4-5
7< M ≤ 8 5-6
8< M ≤ 9 6-7
9< M ≤ 10 7-8
* È qui trascritta solamente la sezione relativa al primo anno del secondo biennio, ossia al terzo anno di corso.
18• Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime transitorio – Candidati che sostengono
l’esame nell’a.s. 2019/2020”
Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12
• O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella A
Credito conseguito Credito convertito ai sensi Nuovo credito attribuito
dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 per la classe terza
3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18
Quarto anno:
• Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Tabella attribuzione credito scolastico”
Media dei Fasce di credito
Voti IV anno
M39 < M ≤ 10 21-22
Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un
numero intero e deve tenere conto di:
• media dei voti
• curricolo dello studente;
• crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto);
• credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa);
• particolari meriti scolastici.
d) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico approvati
dal Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 17/01/2020
Il Collegio dei Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa,
i criteri in base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti
formativi e dei crediti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più
possibile trasparente ed oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio
Docenti si specificano i seguenti punti:
1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola):
Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica
Istruzione, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport.
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito formativo
assegnando 0,30 punti per ogni certificazione ritenuta valida e comunque entro il limite della
fascia, fino a un massimo di 1 punto.
Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con
sospensione del giudizio.
La documentazione relativa deve comprendere:
• un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno ha
svolto l’attività nonché il livello raggiunto in caso di esami finali;
• una sintetica descrizione dell’esperienza stessa;
• convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero.
2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività
interne (progetti del Piano dell’Offerta Formativa).
La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Progetti del
Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere alla valutazione complessiva
dell’allievo.
Verranno attribuiti crediti in relazione alla partecipazione alle attività previste dal Piano
dell’Offerta Formativa secondo le seguenti indicazioni:
TABELLA DI INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
SPERIMENTAZIONI 0,30
20I.R.C.
0,30
ATTIVITÀ ALTERNATIVA (SOLA OPZIONE B)
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O INTEGRATIVE 0,10 (minore di 10 ore)
(DIDATTICO CULTURALI, SPORTIVE,
ORIENTAMENTO IN INGRESSO) 0,20 (tra 10 e 20 ore)
0,30 (maggiore di 20 ore)
214.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento in-
dicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 1-2
contenuti e dei o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacu-
metodi delle diver- noso.
se discipline del II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 3-5
curricolo, con par- modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
ticolare riferimento appropriato.
a quelle III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse disci- 6-7
d’indirizzo. pline in modo corretto e appropriato.
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 8-9
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 10
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.
Capacità di utiliz- I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisi- 1-2
zare le conoscen- te o lo fa in modo del tutto inadeguato.
ze acquisite e di II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 3-5
collegarle tra loro. con difficoltà e in modo stentato
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 6-7
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline.
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 8-9
una trattazione pluridisciplinare articolata.
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 10
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita.
Capacità di argo- I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 1-2
mentare in manie- o argomenta in modo superficiale e disorganico.
ra critica e perso- II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 3-5
nale, rielaborando solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti.
i contenuti acquisi- III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e per- 6-7
ti. sonali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti.
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 8-9
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni criti- 10
che e personali, rielaborando con originalità i contenuti acqui-
siti.
Ricchezza e pa- I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 1
dronanza lessicale inadeguato.
e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessi- 2
specifico riferi- co, anche di settore, parzialmente adeguato.
mento al linguag- III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 3
gio tecnico e/o di anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore.
settore, anche in IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 4
lingua straniera anche tecnico e settoriale, vario e articolato.
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e se- 5
mantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di setto-
re.
Capacità di analisi I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 1
e comprensione dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo ina-
della realtà in deguato.
chiave di cittadi- II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 2
22nanza attiva a riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
partire dalla rifles- guidato.
sione sulle espe- III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 3
rienze personali base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze per-
sonali.
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla ba- 4
se di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali.
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sul- 5
la base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali.
23SECONDA PARTE
1) DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
1.LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5°At LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2020/2021
Prof.ssa Ilaria Sebastiani
LIBRI DI TESTO E DISPENSE PER LO STUDIO
Dante, Commedia
• Dante Alighieri, Divina commedia, con il commento di Anna Maria Chiavacci Leo-
nardi, Zanichelli Editore, Bologna 2001 (edizione consigliata)
2. Purgatorio
3. Paradiso
Storia della letteratura
• Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher Editore, Torino
2014
o Volume 2A. Dal Barocco all’Età dei Lumi
o Volume 2B. Neoclassicismo e Romanticismo
o Volume 3A. Dal Naturalismo al primo Novecento
o Volume 3B. Il secondo Novecento
Per entrambi gli argomenti
24• Materiali didattici pubblicati nell’apposita sezione del registro elettronico Axios e, a
partire dal 9 marzo 2020, anche sulla piattaforma Google for Education –
Classroom impiegata per la didattica a distanza.
CONTENUTI SVOLTI
DANTE
Completamento del Purgatorio
• Dante nell’Eden:
o riassunto dei canti XXVIII e XXIX;
o parafrasi e commento del canto XXX;
o riassunto dei canti XXXI-XXXIII.
Paradiso
• La cosmologia e l’ordinamento morale del Paradiso dantesco.
• I temi fondamentali della cantica.
• Il linguaggio paradisiaco.
• Parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI e XII; riassunto dei canti XIII-XIV; para-
frasi e commento dei vv. 1-90 del canto XV, riassunto dei restanti; riassunto del
canto XVI; parafrasi e commento del canto XVII: il destino di Dante e la sua missio-
ne poetica.
STORIA DELLA LETTERATURA
Tra Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo
Fresca rosa novella, voll. 2A e 2B
25• Giuseppe Parini: l’assunzione a modello per le nuove generazioni; le Odi pariniane
tra Illuminismo e Neoclassicismo (vol. 2A, pp. 416-418, incluso l’approfondimento
“La ‘funzione’ Parini”)..
• Il Neoclassicismo e il Preromanticismo nelle rispettive fasi di sviluppo e maturazio-
ne; valori e messaggi (vol. 2B, pp. 9-12 e pp. 24-25).
• Il "modello Parini" e la scrittura di Ugo Foscolo (vol. 2B):
o la biografia, la cultura e le idee foscoliane (pp. 194-204);
o il tema dello sradicamento e dell’esilio;
o i temi dell’immortalità della bellezza e della persistenza della memoria;
o I Sonetti e le Odi (pp. 234-236 e 252-253);
o le Ultime lettere di Jacopo Ortis (pp. 205-213).
o Dei sepolcri (pp. 261-265);
o Le Grazie (pp. 290-291);
o altri scritti letterari (pp. 303-304, con particolare attenzione alla Notizia intor-
no a Didimo Chierico).
Testi
o Giuseppe Parini, dalle Odi, La caduta (vol. 2A, pp. 425-430);
o Johann Joachim Winckelmann, da Storia dell’arte e dell’antichità, la descri-
zione dell'Apollo del Belvedere e del Laocoonte (vol. 2B, materiale
Classroom e pp. 14-15).
o Ugo Foscolo (vol. 2B):
Dai Sonetti:, Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni (pp. 237-
239 e 244-250); a raffronto, esilio e della privazione nell’immaginario ro-
mantico: Gérard De Nerval, da Le chimere, El desdichado (materiale
Classroom);
dalle Odi: All’amica risanata (pp. 253-259);
da Ultime lettere di Jacopo Ortis:
- lettera dell’11 ottobre 1797: “Il sacrificio della patria nostra è
consumato” (pp. 214-215);
26- lettera del primo novembre: “Odoardo” (materiale Classroom);
- “L’incontro con Parini” (pp. 218-222);
- “Lettera da Ventimiglia” (pp. 225-228).
Dei sepolcri, vv. 1-90 e 151-198 (pp. 271-280 e analisi del testo, pp. 286-
288).
Alessandro Manzoni
Fresca rosa novella, vol. 2B
• Il dibattito sul Romanticismo in Italia e i caratteri del Romanticismo italiano (pp. 318-
321, con particolare attenzione alle posizioni di Madame de Staël, Pietro Giordani e
Giacomo Leopardi).
• La biografia di Manzoni e la doppia conversione al cattolicesimo e al romanticismo
(pp. 322-332).
• La valorizzazione del "vero", dell' "utile" e dell' "interessante”.
• Gli Inni sacri (pp. 338-339).
• Le tragedie: Il Conte di Carmagnola (trama); Adelchi: la composizione, il contenuto
e i messaggi; la funzione del coro (pp. 356-358, 362 e 363-364).
Testi
o Madame de Staël, Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni (pp. 122-124).
o Dalla Lettera a Mr. Chauvet, "Storia, poesia e romanzesco" (pp. 333-335);
o dalla Lettera sul Romanticismo, “L’utile, il vero e l’interessante” (pp. 335-
337);
o dagli Inni sacri, La Pentecoste (pp. 340-346);
o dall’Adelchi:
atto III, scena I, il dissidio romantico del protagonista (materiale
Classroom);
atto III, Coro Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti (pp. 365-368), raffon-
tato con i testi del “Coro degli Ebrei” nel Nabucco di Giuseppe Verdi
27(Va’ pensiero) e dell’inno nazionale (Canto degli Italiani o Fratelli
d’Italia, di Goffredo Mameli e Michele Novaro).
Letture sul Romanticismo
• John William Polidori, Il vampiro.
• George Gordon Byron, Manfred (riduzione e traduzione di Carmelo Bene).
• Edgar Allan Poe:
o Il pozzo e il pendolo;
o Solo (Alone).
Giacomo Leopardi
Fresca rosa novella, volume 2B
• La vita (pp. 490-494).
• Il pensiero e la poetica (pp. 496-504).
• I Canti: gli Idilli (pp. 506-509).
• Le Operette morali (pp. 590-597, incluso l’approfondimento “Leopardi e la filosofia”).
• Il “risorgimento” e i Canti pisano-recanatesi (“grandi idilli”) del 1828-1830 (pp. 509-
510).
• Il “ciclo di Aspasia” (pp. 510-511).
• La ginestra o il fiore del deserto (vedi sotto, tra i “Testi”).
Testi
o Dallo Zibaldone:
“Natura e ragione” (p. 654);
“Il giardino sofferente” (pp. 654-655);
“La teoria del piacere” (p. 659);
“Parole e termini” (p. 662-663);
28 “La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo” (pp. 663-665);
o Dai Canti:
L’infinito (pp. 525-527);
Alla luna (materiale Classroom);
Il sogno (materiale Classroom);
Ultimo canto di Saffo (pp. 514-519, incluso l’approfondimento “Leo-
pardi e il suicidio”);
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 554-560);
A se stesso (pp. 571-572);
Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale
della medesima (materiale Classroom).
o Dalle Operette morali:
Dialogo della Natura e di un islandese (pp. 608-615);
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (incluso il Coro di
morti, pp. 620-626);
Cantico del Gallo Silvestre (pp. 627-631);
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pp. 639-
641);
Dialogo di Tristano e un amico (pp. 643-649).
o Dai Pensieri:
la noia (materiale Classroom).
o La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-157 e 257-317 (pp. 574-588).
Romanzo e novella tra XIX e XX secolo
Fresca rosa novella, voll. 2B e 3A
• Alessandro Manzoni e l’opzione del romanzo storico (materiale Classroom e 2B, pp.
19).
Testo
29o “Dal Conte del Sagrato all’innominato” (materiale Classroom).
• Il romanzo realista in Europa (3A, pp. 19-25).
• La Scapigliatura (3A, pp. 131-137).
Testi
o Emilio Praga, Preludio (3A, pp. 141-143).
o Arrigo Boito, Lezione di anatomia (materiale Classroom).
• Il Naturalismo francese (3A, pp. 14-15):
o fondamenti teorici e precursori;
o la poetica di Emile Zola: il romanzo sperimentale e il ciclo dei Rougon-
Macquart (pp. 44-45).
Testo
o Edmond e Jules de Goncourt, “Un manifesto del Naturalismo” (introdu-
zione a Germinie Lacerteux, materiale Classroom e 3A, p. 15).
• Giovanni Verga e il Verismo:
o la vita di Verga, il pensiero, l’evoluzione letteraria-ideologica e la svolta
verista (3A, pp. 238-250, inclusa la sintesi “Naturalismo e Verismo a con-
fronto”);
o poetica e tecnica narrativa verghiane e veriste:
“Strumenti ed esiti della narrativa verghiana” (3A, pp. 253-254, inclusa
la sintesi “Il metodo dell’impersonalità”);
“Le tecniche narrative e stilistiche” (3A, pp. 315-316);
o le raccolte di novelle (3A, pp. 265-267);
o Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia:
“Pessimismo e anti-progressismo: il tema dei Vinti” (3A, pp. 255-256);
“Arcaicità e mutamento” e “La prospettiva anti-idillica” (pp. 312-315).
Testi
30o Da Vita dei campi:
L’amante di Gramigna (materiale Classoroom, inclusa la prefazione a
Salvatore Farina, riportata anche in 3A, p. 248);
La Lupa (3A, pp. 289-293).
o Da I Malavoglia:
prefazione al romanzo e al ciclo dei Vinti (pp. 257-260).
o Da Novelle rusticane:
La roba (3A, pp. 295-300).
• La prosa decadente:
o Decadentismo e Simbolismo (3A, pp. 410-412);
o l’estetismo e il romanzo decadente in Europa: temi ed “eroi” della letteratura
decadente; il dandismo e la crisi dell’intellettuale (pp. 450-452):
Joris-Karl Huysmans (pp. 452);
Oscar Wilde (pp. 456-457).
o la scrittura dannunziana dalla novella di ispirazione verista al Notturno (sinte-
si).
Testi:
o Charles Baudelaire, da Lo Spleen di Parigi, “La caduta dell’aureola” (pp. 417-
418);
o Joris-Karl Huysmans, da Controcorrente, “La casa del dandy” (pp. 453-454);
o Oscar Wilde, prefazione a Il Ritratto di Dorian Gray, “La finalità dell’arte” (pp.
458-459);
o Gabriele D’Annunzio:
dalle Novelle della Pescara: La morte del duca d’Ofena (materiale su
Classroom);
da Il piacere, libro I, cap. I, “L’attesa” (3A, pp. 485-489);
da Forse che sì forse che no, libro I, “Il superuomo e la macchina” (pp.
507-509);
31 dal Notturno, Prima Offerta, “Il cieco veggente” (pp. 518-519).
• La prosa italiana del primo Novecento:
o Italo Svevo: dall’eredità del Naturalismo al “flusso di coscienza” (sintesi
Classroom).
o Luigi Pirandello: l’arte umoristica e la vita “inconcludente” (sintesi
Classroom).
Testi
o Italo Svevo, da La coscienza di Zeno:
la “Prefazione” del dottor S. (3A, pp. 876-877);
“Lo schiaffo”: la morte del padre (pp. 889-890);
“Il finale”: la rivincita dell’inetto e la profezia apocalittica (pp.
901-905).
o Luigi Pirandello
da L’umorismo: “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo”
(pp. 927-931, escluso “Manzoni e Sterne”);
da Novelle per un anno: Una giornata (materiale Classroom);
da Uno, nessuno e centomila: “Non conclude” (pp. 995-997).
Il Simbolismo
Fresca rosa novella, vol. 3A
• Charles Baudelaire
o Informazioni essenziali sull’autore e sull’opera (sintesi delle pp. 413-415).
Testi
o Da I fiori del male:
Corrispondenze (pp. 423-424);
Spleen (pp. 425-426);
Le litanie di Satana (materiale Classroom).
32• La poesia simbolista francese (pp. 374-375)..
Paul Verlaine (pp. 430-431).
Testo
Arte poetica (pp. 431-433).
Arthur Rimbaud (pp. 433-434).
Testo
Vocali (p. 437).
• Giovanni Pascoli:
o informazioni essenziali sull’autore e sulla sua poetica e opera (sintesi delle
pp. 573-598, 616 e 631-632);
o Pascoli studioso di Dante (p. 658).
Testi
o Da Myricae:
Scalpitio (materiale Classroom);
Arano (materiale Classroom);
Lavandare (pp. 601-602);
L’assiuolo (pp. 608-610);
Il lampo e Il tuono (pp. 613-614).
o Dai Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno (pp. 625-627).
o Dai Poemi conviviali:
Alexandros (pp. 654-657).
• Gabriele D’Annunzio:
o informazioni essenziali sull’autore e sulla sua poetica e opera in versi
(sintesi delle pp. 466-467 e 522-536).
Testi
33o Da Alcyone:
Le stirpi canore (materiale Classroom);
Meriggio (materiale Classroom).
Il Novecento
Autori europei del primo Novecento*
Materiale Classroom
*Sezione anticipata come parte integrante del programma della quinta classe nel secondo
quadrimestre dell’a.s. 2019/2020.
• Thomas Mann
• Tonio Kröger
Riflessioni: il genere del Bildungsroman; il significato del racconto e la figura
del protagonista; la crisi delle certezze e il tema dell’inettitudine
dell’intellettuale nel primo Novecento.
• La morte a Venezia
Riflessioni: discussione sulla trama e sui significati del romanzo; il personag-
gio dello "straniero" e il concetto freudiano del "perturbante" ("heimlich" /
"unheimlich"); tematiche fondamentali della letteratura mitteleuropea e pri-
mo-novecentesca: senso di estraneità, malattia e salute, inettitudine alla vita;
visione del film di Luchino Visconti (1971), raffrontato col testo d’origine.
• Franz Kafka
34o Lettera al padre.
o Dai Racconti: Un vecchio foglio; Un fratricidio; Davanti alla legge; Il tormento
del capofamiglia.
o Nella colonia penale;
o La metamorfosi;
o gli elementi del “realismo magico”, dell' "allegoria vuota" e del “perturbante”
(riflessione su brani scelti dal saggio omonimo di Sigmund Freud del 1919);
o il finale de Il processo raffrontato con Ernest Hemingway, Gli uccisori
(esempio di “realismo mimetico” e genere noir).
• Rainer Maria Rilke
o Dalle Elegie duinesi, L’angelo tremendo (anche in 3A, pp. 734-735);
o dai Sonetti a Orfeo:
parte prima, III (Un dio può);
parte seconda, I (Respiro, tu invisibile poesia!).
• Stefan Zweig
o La novella degli scacchi
• Joseph Roth
o La tela di ragno
Le Avanguardie e la poesia del primo Novecento
Fresca rosa novella, voll. 3A e 3B
• I futuristi italiani (3A, pp. 758-762).
• Guillaume Apollinaire e Vladimir Majakovskij (pp. 767-769).
• Il Dadaismo, il Surrealismo e l’Espressionismo (3A, pp. 779-781).
• I crepuscolari e i vociani (vol. 3B, pp. 4-8, 32-35 e 72-73).
35Testi e audiovisivi
o Filippo Tommaso Marinetti:
Primo manifesto del Futurismo (3A, pp. 769-771);
Manifesto tecnico della letteratura futurista (3A, pp. 773-774);
Da Zang Tumb Tuuum: Bombardamento (materiale Classroom).
o Corrado Govoni:
Il palombaro (3B, pp. 30-31).
o Guillaume Apollinaire:
La colombe poignardée et le jet d'eau (materiale Classroom);
Lettre-Océan e Il pleut (3A, p. 775)
o Tristan Tzara:
Manifesto del Dadaismo (materiale Classroom).
o André Breton:
Manifesto del Surrealismo (3A, pp. 782-783).
o Luis Buňuel:
Un chien andalou (1929).
o Thea Von Arbou:
Metropolis.
o Sergio Corazzini:
Desolazione del povero poeta sentimentale (3B, pp. 58-61).
o Guido Gozzano:
da I colloqui, “Totò Merumeni” (pp. 54-57).
o Camillo Sbarbaro:
Taci, anima stanca di godere (3B, pp. 87-89).
o Clemente Rebora:
Viatico (3B, pp. 82-86).
Giuseppe Ungaretti
Fresca rosa novella, vol. 3B
36• La vita (pp. 102-104).
• Il pensiero e la poetica (pp. 106-110).
• L’allegria (pp. 110-113).
• Sentimento del tempo (pp. 149-152).
• Il dolore (pp. 157-158).
Testi
o Da L’allegria:
In memoria (pp. 116-118);
Il porto sepolto (p. 119);
Veglia (pp. 120-121);
Sono una creatura (pp. 127-128);
I fiumi (pp. 130-134);
San Martino del Carso (pp. 134-135).
Natale (pp. 145-146);
o Da Sentimento del tempo:
L’isola (materiale Classroom).
o Da Il dolore:
Se tu mio fratello (materiale Classroom);
Giorno per giorno, “Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto …” (mate-
riale Classroom).
Umberto Saba
Fresca rosa novella, vol. 3B
• La vita (pp. 256-258).
• Il pensiero e la poetica (pp. 260-263).
• Il Canzoniere (pp. 263-266).
37• Ernesto e il tema dell’omosessualità (lettura del romanzo incompiuto, unita
all’approfondimento “Ernesto e gli altri”, pp. 289-292).
Testi
o Dal Canzoniere:
Mio padre è stato per me l’“assassino” (pp. 292-294);
La capra (pp. 275-276);
A mia moglie (pp. 268-272);
Trieste (pp. 277-279).
o Ernesto (testo integrale).
Eugenio Montale
Fresca rosa novella, vol. 3B
• La vita (pp. 170-172).
• Il pensiero e la poetica (pp. 174-178, incluso l’approfondimento “Eliot e Montale: il
correlativo oggettivo”).
• Le raccolte:
o Ossi di seppia (pp. 180-183);
o Le occasioni (pp. 203-207);
o La bufera e altro (pp. 230-232);
o Satura (pp. 242-243).
Testi
o Da Ossi di seppia:
In limine (pp. 186-187);
I limoni (pp. 188-191);
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (pp. 192-193);
Meriggiare pallido e assorto (pp. 194-196);
Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 199-200);
38 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pp. 200-201);
Cigola la carrucola del pozzo (pp. 202-203).
o Da Le occasioni:
A Liuba che parte (pp. 209-210);
Non recidere, forbice, quel volto (p. 221);
La casa dei doganieri (pp. 222-224).
o Da La bufera e altro:
La primavera hitleriana (pp. 235-238).
o Da Satura:
Caro piccolo insetto (pp. 243-244);
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pp. 244-245).
392. LINGUA E CULTURA LATINA
PROGRAMMA
LINGUA E LETTERATURA LATINA
CLASSE 5ATa.s. 2020-2021
Prof.ssa Vera Valletta
LETTERATURA E AUTORI LATINI
L’età augustea e l’elegia latina
Origini ed evoluzione dell’elegia latina , modelli greci
Tibullo: dati biografici, corpus delle elegie, tematiche. Lettura in latino : L’ideale di vita
elegiaco (1,1 versi 1-14; il resto in italiano pag.338-339) ; Rimpianti, sogni e speranze (1,3
in italiano pag.344-349)
Properzio: dati biografici, caratteri delle elegie. Letture : Amore oltre la morte (elegie, IV, 7
in italiano pag.362).
Ovidio: la vita e l’esilio , l’opera , il rapporto con Augusto.
Tristia, 4,10 l’autobiografia in fotocopia, in ital.; Tristia , 1,3 la partenza da Roma ( in
trad.ital. pag.407-409) Tristia3,10(vv.1-32); 3,12 (vv1-28): La terra dei Geti ( in fotocopia e
trad.ital).
Attualizzazione: romanzi moderni sulla vita di Ovidio: A.Tabucchi, Sogno di Sogni, Sogno
di Publio Ovidio Nasone poeta e cortigiano (in fotoc); C.Ransmayr, Il mondo estremo (let-
tura integrale del romanzo)
Amores I,9, la milizia d’amore(pag.394 versi 1-20 in latino, in italiano tutta); II, 2 in fotoco-
pia(trad.it.), Il corteggiamento al circo.
Ars Amatoria I,89-134 (in fotocopia:i luoghi dell’amore: il teatro); I,135-170 (i luoghi
dell’amore:il circo) in fotocopia (in trad. ital.): l’ideologia urbana
Metamorfosi:struttura, tematiche,la commistione dei generi e dei registri linguistici; lettura
metrica analisi e traduzione : Prologo ( in latino versi 1-20, pag.415;
Orfeo ed Euridice, lettura metrica, analisi e traduzione X 1-63 (in fotocopia testo on line);
Eco e Narciso III, vv. 357-401( in italiano con parole chiavi lat.pag.431) ; in latino: vv.425-
447 (testo in fotocopia; lettura completa anche in italiano del mito di Narciso testo on line);
Atteone sbranato dai cani III, 131-252 (in fotoc. in ital.); Piramo e Tisbe pag.433( in ital).
Apollo e Dafne ( in italiano ,in fotoc.).
Italo Calvino legge Ovidio ( testo on line materiali didattici )
40Puoi anche leggere