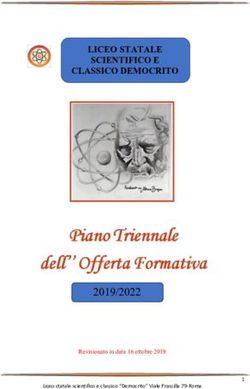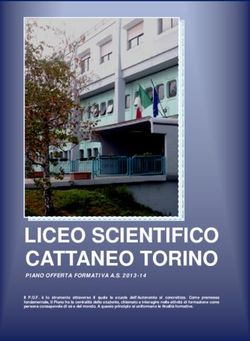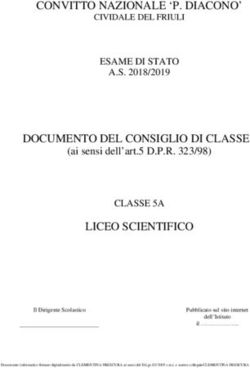CLASSE V LICEO CLASSICO - Convitto Nazionale Statale "Cicognini" Prato - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Convitto Cicognini
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Prot. N. 0002924 D.02.b del 15/05/2018
Convitto Nazionale Statale “Cicognini”
Prato
CLASSE
V
LICEO CLASSICO
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
A.S. 2017 - 2018DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
INDICE
A) Storia della classe
1. Profilo sintetico della classe
2. Situazione degli alunni
3. Situazione dei docenti
B) Percorso formativo
1. Finalità
2. Obiettivi
2.1 Generali e trasversali
2.2 Specifici di area
3. Metodi
4. Mezzi e strumenti
5. Spazi
6. Tempi
6.1 Ore settimanali d’insegnamento previste dal curriculum di studi
6.2 Ore complessive effettuate nell’ultimo anno scolastico
7. Criteri di valutazione
7.1 Criteri per la valutazione stabiliti nel P.T.O.F
7.2 Criteri per la valutazione delle simulazioni delle prove d’esame
8. Verifiche
8.1 Strumenti di verifica
8.2 Simulazioni
8.3 Tracce delle simulazioni di terza prova
8.4 Modello di simulazione di terza prova
9. Attività integrate
9.1 Visita di istruzione
9.2 Uscite didattiche extracurricolari
9.3 Alternanza scuola lavoro
10. Contenuti, tempi e documenti delle singole discipline
10.1 Italiano 10.6 Matematica
10.2 Latino 10.7 Fisica
10.3 Greco 10.8 Scienze Naturali e Scienze
10.4 Inglese della Terra
10.4 Storia 10.9 Storia dell’Arte
10.5 Filosofia 10.10 Scienze Motorie e Sportive
10.11 ReligioneDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
A) STORIA DELLA CLASSE
1. PROFILO
La classe è composta da 25 studenti, 14 femmine e 11 maschi, di cui due alunni inseriti
all’inizio del presente anno scolastico, un alunno rientrato da un percorso didattico annuale
in Argentina e un’alunna che ha trascorso gli ultimi due mesi dello scorso anno scolastico
e parte dell’estate 2017 in Nuova Zelanda.
E’ presente un’alunna DSA per la quale è stato attivato un apposito PDP.
Durante il quinquennio, per cause di forza maggiore, il corpo docenti ha subito numerosi
avvicendamenti anche in materie di indirizzo, talvolta nel corso dello stesso anno.
Ciò ha impedito una vera e propria continuità didattica e ha costretto gli studenti ad
adattarsi a diverse metodologie di insegnamento.
Attualmente il gruppo (che è stato soggetto nel corso degli anni a numerosi inserimenti di
alunni provenienti da diversi Istituti) si presenta variegato e tale varietà è riscontrabile in
diversi aspetti: il percorso scolastico che ha caratterizzato i singoli studenti, la personalità
e la preparazione didattico-disciplinare degli stessi.
A livello didattico si distinguono due gruppi: uno formato da alunni e alunne con evidente
interesse e partecipazione alla vita scolastica e a tutte le attività proposte; l’altro gruppo, al
contrario, anche se con piccoli miglioramenti durante l’anno scolastico, permane formato
da alunni/e con atteggiamenti non sempre positivi e lacune non completamente recuperate,
anche in materie d’indirizzo.
Nel corso degli anni gli studenti hanno alternato momenti d’impegno e di crescita a
situazioni di discontinuità che hanno avuto ripercussioni sullo studio individuale.
Il profitto scolastico risulta disomogeneo per la diversa dedizione allo studio, soprattutto per
l’impegno e l’efficacia del lavoro individuale: un gruppo di alunni ha studiato con regolarità e
raggiunto una preparazione nel complesso più che buona e in alcuni casi eccellente, grazie
a peculiari doti di curiosità intellettuale e di attitudine allo studio interdisciplinare; alcuni
alunni, nel quadro di una discreta preparazione, hanno ottenuto risultati solo sufficienti nelle
singole discipline; altri, purtroppo, non sono riusciti a risolvere certe difficoltà che si
evidenziano soprattutto nella produzione scritta.
In merito alle attività extracurricolari, buona parte della classe ha profuso impegno ed
entusiasmo, trovandovi un complemento alla propria crescita culturale: ciò è risultato
evidente in eventi quali l’organizzazione della “Notte del Liceo Classico”, la partecipazioneDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
numerosa e attiva alle giornate FAI e nel MEP, le attività connesse con il progetto di
alternanza scuola-lavoro.
Il clima sostanzialmente solidale nei rapporti interpersonali del gruppo classe ha avuto
ricadute positive nell’inclusione e nell’accoglienza degli studenti aggiuntisi nel corso del
tempo.
2. ALUNNI
ALUNNI
PROVENIENZA N. ESITO FINALE TRASFERITI
N°. INIZIALE
CLASS ALUNNI
E FINALE IN
NON FINE
M F TOT CO SC PROM ITINER
PROM ANNO
E
I 5 11 16 2 14 14 14 2 0 0
II 8 10 18 1 17 19 19 0 1 1
III 9 10 19 1 18 18 18 1 0 0
IV 10 13 23 0 23 23 23 0 0 0
V 11 14 25 1 24 25
Legenda:
CO = convittori
SC = semiconvittori
PROM = promossi
NON PROM = non promossiDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
3. DOCENTI
Disciplina I II III IV V
MATTEUCCI
RELIGIONE MATTEUCCI R. ROGAI M. MATTEUCCI R. TOMASI A.
R.
ITALIANO NOVELLO F. MERCIAI A. COLACIONE A. VEZZOSI G. MUSCILLO A.
LATINO NOVELLO F. BELLUCCI C. MANCUSO F. VEZZOSI G. MUSCILLO A.
GRECO BELLUCCI C. BELLUCCI C. MANCUSO F. PUCCETTI F. PUCCETTI F.
FANTACCHIO FANTACCHIOT
INGLESE MUGAVERO C. TARANTOLA A. SOCCI G.
TTI M.T. TI M.T.
GEOSTORIA BELLUCCI C. PUCCETTI F.
STORIA GORI I. DI FILIPPO N. CINÀ
FILOSOFIA GORI I. DI FILIPPO N. CINÀ
SCIENZE RUSSO/
GUARINO P. GUARINO P. GUARINO P. MUGNAI M.
NATURALI RICEVUTO
MATEMATICA BALDI L. BALDI L. BALDI L. BALDI L. MOSCARDI C.
FISICA BALDI L. BALDI L. MOSCARDI C.
RODIGHIERO RODIGHIERO RODIGHIERO
ARTE
M. M. M.
SCIENZE
FALUGIANI D. FALUGIANI D. FALUGIANI D. CHIARELLA E. CHIARELLA E.
MOTORIEDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
B) PERCORSO FORMATIVO
DEL LICEO CLASSICO
1. FINALITA’ GENERALI
a. educare a un atteggiamento di attenzione e di apertura alla realtà;
b. educare al desiderio di conoscere;
c. educare al senso della bellezza;
d. educare alla responsabilità;
e. educare al rispetto dell’alterità;
f. educare al senso civico;
g. favorire la memoria del passato e l’interesse per il presente;
h. favorire una coscienza critica e sistematica della tradizione culturale e del mondo
contemporaneo;
i. favorire la coscienza di sé come scoperta dentro la realtà;
j. favorire una cordiale e collaborativa convivenza all’interno della comunità scolastica;
k. favorire la scoperta delle proprie attitudini e potenzialità al fine di orientare
ragionevolmente le scelte future.
2. OBIETTIVI
2.1 OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI
a. acquisire le conoscenze fondamentali delle singole discipline;
b. scoprire e usare in modo adeguato i diversi metodi di conoscenza del reale;
c. ricercare e utilizzare in modo critico le fonti di informazione;
d. sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti
culturali;
e. cogliere interrelazioni pertinenti e significative tra i contenuti delle diverse discipline;
f. confrontare idee, valori e modelli di comportamento del passato e del presente;
g. argomentare in modo logico e coerente;
h. formulare un giudizio consapevole e adeguatamente motivato;
i. possedere un patrimonio lessicale ampio, differenziato e specifico delle singole
discipline;
j. esporre con correttezza, proprietà e organicità;
k. usare in modo autonomo i diversi strumenti didattici.DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA
AREA UMANISTICO-LETTERARIA-ARTISTICA
1. Analizzare, interpretare, valutare i testi ed i prodotti artistici.
2. Riflettere sulla produzione letteraria ed artistica nel segno della continuità tra
mondo antico e mondo moderno, tra civiltà classica e dimensione europea.
3. Individuare raccordi interdisciplinari all’interno di aree come quella storico –
filosofica, storico - letteraria ed artistica.
4. Acquisire conoscenze e consapevolezza storica (in ambito civile, letterario,
scientifico, artistico, linguistico).
5. Acquisire competenze e conoscenze linguistiche come strumento di interpretazione
e di comunicazione.
6. Sviluppare la sensibilità estetica e la consapevolezza del valore della bellezza.
7. Motivare una frequentazione personale delle arti e della letteratura.
AREA SCIENTIFICA
1. Conoscere, comprendere e correlare i concetti scientifici.
2. Operare con il simbolismo della matematica e della fisica.
3. Possedere e utilizzare gli strumenti linguistici specifici.
4. Presentare gli aspetti sperimentali , teorici e formali delle discipline.
5. Inquadrare storicamente i momenti significativi dell’evoluzione storica del pensiero
scientifico.
6. Saper interpretare situazioni dell’esperienza comune, utilizzando modelli e metodi
scientifici.
AREA STORICO-FILOSOFICA
1. Classificare i fatti storici secondo una tipologia data (politica, culturale, economica,
sociale o altra).
2. Inquadrare storicamente i fenomeni studiati individuandone le interrelazioni.
3. Riconoscere i modelli interpretativi e le teorie concettuali.
4. Confrontare e valutare idee e valori del passato e del presente e delle diverse civiltà.
5. Riconoscere la validità delle fonti.
6. Operare collegamenti e raffronti con l’area umanistica letteraria e linguistica..
7. Comprendere e usare in modo pertinente i linguaggi disciplinari.DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
AREA FISICO-MOTORIA
1. Educare alla salute
2. Acquisire la consapevolezza dei movimenti e dell’autocontrollo.
3. Favorire un armonico sviluppo psicofisico.
4. Sviluppare le capacità relazionali.
3. METODI DI LAVORO
ITA LAT GRE STO FIL MAT FIS SC ART SC M. REL INGL
LEZIONE
X X X X X X X X X X X X
FRONTALE
LEZIONE
X X X
LABORATORIO
LAVORO DI
X X X X X
GRUPPO
DISCUSSIONE
X X X X X
GUIDATA
4. MEZZI E STRUMENTI
ITA LAT GRE STO FIL MAT FIS SCI ART SC.M. REL INGLI
Testi vari X X X X X X X X X X X X
Lavagna X X X X X X X X X X X
LIM X X X X X X X X X X
Computer
Lettore
VHS e DVD
Lettore CD X
Attrezzature
X
sportive
Fotocopie X X X X X X X X
Materiale
graficoDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
5. SPAZI
ITA LAT GRE STO FIL MAT FIS SCI ART SC. M. REL INGL
Aula X X X X X X X X X X X X
Lab.scientifico
Aula
X
multimediale
Palestra X
Sala video X
Aula magna
Spazi esterni X
Cappella X
6. TEMPI
6.1 Ore settimanali di insegnamento previste dal curriculum di studi.
Discipline IV GN V GN I LC II LC III LC (ATT. VLC)
RELIGIONE 1 1 1 1 1
ITALIANO 4 4 4 4 4
LATINO 5 5 4 4 4
GRECO 4 4 3 3 3
INGLESE 3 3 3 3 3
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -
STORIA - - 3 3 3
FILOSOFIA - - 3 3 3
SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2
MATEMATICA 3 3 2 2 2
FISICA - - 2 2 2
STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2
SCIENZE MOTORIE E SP. 2 2 2 2 2
Totale 27 27 31 31 31DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
6.2 Ore complessive effettuate nell’a.s. 2017/18
2° 2°
1°
Discipline QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE TOT
QUADRIMESTRE
al 15/5 dopo 15/5
RELIGIONE 11 12 4 27
ITALIANO 56 52 14 122
LATINO 52 40 16 108
GRECO 55 41 12 108
INGLESE 44 40 11 95
STORIA 37 33 15 85
FILOSOFIA 49 39 6 94
SCIENZE 30 20 8 58
MATEMATICA 33 30 7 70
FISICA 27 22 7 56
ARTE 36 24 7 67
SC. MOTORIE SP. 30 19 6 55
Totale 460 372 113 945DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
7. CRITERI DI VALUTAZIONE
7.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DECIMALE STABILITI NEL P.T.O.F.
VOTO CRITERI E PARAMETRI
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento
1-2
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi)
Non conosce le informazioni, le regole, la terminologia di base. Non è in grado di
3 applicare quanto appreso e comunica in modo inadeguato.
(Non ha conseguito gli obiettivi)
Conosce in maniera frammentaria le informazioni, le regole, la terminologia di base;
4 commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione.
(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali)
Conosce superficialmente le informazioni, le regole, la terminologia di base che applica
5 con difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze anche nella comunicazione.
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi)
Conosce e comprende le informazioni, le regole, la terminologia di base, pur non
riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma; usa in modo limitato gli strumenti
6
della comunicazione.
(Ha conseguito gli obiettivi minimi)
Conosce e comprende le informazioni, le regole, la terminologia di base; sa e comunica
con correttezza; effettua analisi e sintesi, seppure con qualche inesattezza, in situazioni
7
note.
(Ha conseguito gli obiettivi)
Conosce e comprende le informazioni, le regole, la terminologia della disciplina,
applicandole anche in situazioni non note, senza commettere errori gravi; è capace di
8
analisi e sintesi; comunica in modo appropriato ed organico.
(Ha pienamente conseguito gli obiettivi)
Conosce e comprende le informazioni, le regole, la terminologia della disciplina,
applicandole anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando in
9 modo pertinente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con
valutazione critica.
(Ha ottimamente conseguito gli obiettivi)
Sa esprimere valutazioni critiche motivate e trovare approcci personali alle
problematiche proposte; ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici; sa affrontare i
10
problemi in maniera multidisciplinare.
(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi)DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
7.2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME
GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
ITALIANO
Candidato ________________________________
Liev
Tipologia A Grav. Ins Max
. Suff. Discreto Buono Ottimo
INDICATORI Insuf. uf. tot.
Ins.
A. Comprensione del
testo e aderenza alle 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4/15
specifiche richieste
B. Contenuti: qualità
dell’analisi e 1 1,5 2 2,5 3 3/15
approfondimenti
C. Capacità di
organizzare il
testo:coesione, 1 1,5 2 2,5 3 3/15
coerenza, organicità di
argomentazione
D. Competenza
linguistica,
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5/15
morfosintattica e
ortografica
Tipologia B Grav. Ins Liev Max
Suff. Discreto Buono Ottimo
INDICATORI Insuf. uf. Ins. tot.
A. Comprensione delle
consegne, aderenza
alle richieste e corretta
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4/15
interpretazione di
documenti e dati a
corredo dell’argomento.
B. Contenuti: qualità
delle interrelazioni
stabilite fra dati testuali
ed extratestuali,
elaborazione critica e 1 1,5 2 2,5 3 3/15
personale e, nell’articolo
di giornale,
attualizzazione
dell’argomento
C. Capacità di
organizzare il
testo:coesione,
coerenza, organicità di 1 1,5 2 2,5 3 3/15
argomentazione e taglio
più o meno personale
della trattazioneDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
D. Competenza
linguistica,
morfosintattica e
ortografica; registro 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5/15
linguistico coerente
con l’argomento e col
destinatario
Tipologia C Grav. Ins Liev Max
Suff. Discreto Buono Ottimo
INDICATORI Insuf. uf. Ins. tot.
A. Comprensione delle
consegne ed aderenza 1,5 2 2,5 3 3,5 4
1 4/15
alla traccia
B. Qualità dei contenuti
e approfondimenti,
1 1,5 2 2,5 3
elaborazione critica e 3/15
personale
C. Capacità di
organizzare il
testo:coesione, 1 1,5 2 2,5 3
3/15
coerenza, organicità di
argomentazione
D. Competenza
linguistica,
morfosintattica e
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
ortografica;
5/15
padronanza del lessico
specifico della disciplina
Tipologia D Grav. Ins Liev Max
Suff. Discreto Buono Ottimo
INDICATORI Insuf. uf. Ins. tot.
A. Comprensione delle
consegne ed aderenza 1,5 2 2,5 3 3,5 4
1 4/15
alla traccia
B. Qualità dei contenuti
e approfondimenti,
1 1,5 2 2,5 3
elaborazione critica e 3/15
personale
C. Capacità di
organizzare il
testo:coesione, 1 1,5 2 2,5 3
3/15
coerenza, organicità di
argomentazione
D. Competenza
linguistica,
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5/15
morfosintattica e
ortografica.
NB: IL PUNTEGGIO CON +0,5 E’ SEMPRE APPROSSIMATO PER ECCESSO AL
PUNTEGGIO SUCCESSIVO.DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
GRIGLIA DI VALUTAZIONE della SECONDA PROVA
LATINO / GRECO
(in quindicesimi)
Candidato _____________________ Classe V Liceo Classico
Indicatori Descrittori
Mancanza di comprensione anche solo del contenuto
1
generale
Frammentaria e approssimativa comprensione del
2
contenuto generale
Parziale comprensione del senso del testo con errori di
3
a) Comprensione del interpretazione
senso del testo Comprensione solo del nucleo essenziale del senso con
4
errori di interpretazione
Comprensione complessiva del senso del testo con errori
5
circoscritti
Comprensione piena del senso e almeno della gran parte
6
dei particolari del testo
Continui e gravissimi errori morfosintattici e lessicali 1
Numerosi e gravi errori morfosintattici e lessicali 2
Vari errori, anche gravi, morfosintattici e lessicali 3
b) Padronanza delle
strutture linguistiche Alcuni errori morfosintattici e lessicali, per lo più circoscritti 4
del testo Complessiva padronanza delle strutture linguistiche con
5
errori circoscritti
Adeguata padronanza delle strutture linguistiche con solo
6
qualche inesattezza
Scorretta e non sempre comprensibile 1
c) Riformulazione del Accettabile anche se molto legata alla lettera del testo
2
testo originale
Nel complesso adeguata, con soluzioni efficaci 3
TotaleDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
GRIGLIA DI VALUTAZIONE della TERZA PROVA
(in quindicesimi)
I docenti, durante l’anno, hanno adottato la griglia sottostante per la valutazione delle
simulazioni della terza prova.
Candidato _____________________ Classe V Liceo Classico
punti
Molto scarse 1
Conoscenze Parziali 2
dei contenuti
Limitate ad una informazione generale 3
Articolate 4
Ampie e consolidate 5
Superficiale 1
Capacità di analisi e Approssimativa 2
rielaborazione critica
(o capacità di applicare le Sostanzialmente corretta 3
conoscenze per risolvere Efficace 4
problemi) Approfondita 5
Confusa 1
Organizzazione e sintesi Complessivamente chiara 2
dei contenuti
Efficace 3
Poco chiara e con errori ripetuti 1
Esposizione Generalmente scorrevole 2
Totale punti …………/15DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO
Candidato _______________________________________
Valutazione Giudizio Indicatori
1-11 Scarso Assoluta carenza di informazioni e di conoscenze anche elementari
Totale incapacità di organizzare informazioni
Incapacità di esporre in modo comprensibile
12-13 Gravemente -Frammentarietà e disorganicità nelle conoscenze di tutte le discipline
insufficiente -Incapacità di organizzare le informazioni e di argomentare
-Esposizione contorta e disorganica
14-15 Del tutto -Lacune gravi nelle informazioni e nelle conoscenze di tutte le discipline
insufficiente -Scarsa organizzazione delle conoscenze e incoerenza nell’argomentare
-Esposizione frammentaria
16-17 Insufficiente -Informazioni parziali e conoscenze approssimative
-Confusione nell’organizzazione delle conoscenze
-Esposizione disordinata
18-19 Quasi -Informazioni e conoscenze superficiali e non sempre corrette
sufficiente -Approssimativa organizzazione delle conoscenze anche semplici
-Esposizione incerta, non senza errori
20 Sufficiente Generica conoscenza dell’argomento, con alcune inesattezze
Capacità di organizzare solo conoscenze semplici con qualche incertezza
Esposizione molto semplificata, con qualche errore
21-22 Pienamente Conoscenze generalmente corrette ma limitate a contenuti essenziali
sufficiente Generale organizzazione di conoscenze con qualche approssimazione
Esposizione accettabile seppure approssimativa
23-24 Più che Informazioni e conoscenze nel complesso corrette, anche se non articolate
sufficiente Accettabile organizzazione delle conoscenze
Esposizione non sempre precisa ma lineare
26-26 Discreto Informazioni e conoscenze abbastanza articolate ma non approfondite
Chiarezza nell’organizzazione delle conoscenze e in argomentazioni
semplici Esposizione nel complesso corretta
27 Più che Informazioni e conoscenze corrette e articolate
discreto Abilità nell’organizzare le conoscenze e nell’argomentare
Esposizione generalmente chiara e corretta
28 Buono Informazioni e conoscenze ampie e precise
Efficace organizzazione delle conoscenze e prontezza nell’argomentare
Esposizione chiara e precisa
29 Molto Buono Possesso sicuro di conoscenze
Efficacia nell’organizzazione di conoscenze anche complesse e
nell’argomentare
Esposizione appropriata ed efficace
30 Ottimo Ricchezza e profondità di conoscenze consolidate
Consapevolezza nell’organizzare conoscenze complesse e nell’argomentare
Esposizione fluida e ben calibrata
PUNTEGGIO … / 30DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
8. VERIFICHE
8.1 STRUMENTI DI VERIFICA
quesiti quesiti presenta
colloquio compito prove prove
discipline risposta scelta zione di
orale scritto pratiche grafiche
aperta multipla problemi
RELIGIONE X
ITALIANO X X X
LATINO X X X
GRECO X X X X
INGLESE X X X
STORIA X X X
FILOSOFIA X X X
SCIENZE X X
NATURALI
MATEMATICA X X
FISICA X X
ARTE X X X X
SC. MOT. E SP. X X X X
8.2 SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
DATA PROVA TIPOLOGIA TEMPI DISCIPLINE
Storia dell’arte, Fisica,
04/12/17 III prova B 150’
Inglese, Latino, Storia
Scienze Naturali, Inglese,
26/03/18 III prova B 150’ Scienze motorie,
Matematica, Latino
Scienze Naturali, Latino,
14/05/18 III prova B 150’ Fisica, Inglese, Scienze
Motorie
07/04/18 I prova TUTTE 360’ ITALIANO
19/05/18 II prova 240' GRECODOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
8.4 MODELLO DI SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
Convitto Nazionale Statale Cicognini
Simulazione Terza Prova
Classe 5^liceo classico Prato,
DISCIPLINA:
Cognome e nome: _______________________________
Tipologia B: Quesiti a risposta singola
Lunghezza della singola risposta: massimo 10 righe.
Durata della prova: … minuti per n°10 quesiti (2 per ogni disciplina).
QUESITO N°1
RISPOSTA N°1DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
QUESITO N°2
RISPOSTA N°2
Parte riservata al Docente
1° quesito punteggio ___ /15
Il Docente:
2° quesito punteggio ___ /15
media ___ /15DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
8.3 TRACCE DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA
Prima simulazione (04/12/2017) – Tipologia B: 10 quesiti – Durata: 150 minuti
Storia
Primo quesito
Illustra sinteticamente l’andamento della Prima Guerra Mondiale fino al 1917.
Secondo quesito
Descrivi quali sono le ragioni della sconfitta della Triplice Alleanza alla fine della
Guerra.
Inglese
Primo quesito
The poet William Blake used the phrase “dark satanic mills” to refer to the effects of
the early industrial Revolution on people’s lives. What are the possible ways
industrialisation affected the life of urban people?
Secondo quesito
Both William Wordsworth and Mary Shelley believed in the great role played by
nature. Outline their point of view analysing common and conflicting aspects.
Storia dell’arte
Primo quesito
In relazione all’immagine proposta indicare: autore, datazione, contesto storico e
significato ed evidenziare gli strumenti compositivi e stilistici che l’artista utilizza.
Secondo quesito
Attraverso esempi pertinenti definire i caratteri generali della pittura inglese di
paesaggio nella prima metà dell’Ottocento.DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
Latino
Primo quesito
Sintetizza la concezione senecana del tempo, indicando anche le opere in cui viene
espressa.
Secondo quesito
Spiega in quali modi Seneca tentò di influenzare il princeps nella sua azione politica
e quale linea di comportamento consigliò. Il suo tentativo fu coronato da successo?
Fisica
Primo quesito
Descrivi il fenomeno dell'effetto Doppler. Supponi di trovarti sul marciapiede mentre
un'ambulanza si avvicina alla velocità di 80 Km/h a sirene spiegate emettendo un
suono della frequenza di 1830 Hz. Quale sarà la frequenza dell'onda sonora che
percepisci?
Secondo quesito
Descrivi la natura della luce. Come si propaga? Enuncia le leggi della riflessione.
Com'è l'immagine riflessa in uno specchio piano?
_______________
Recupero Prima simulazione (18/12/2017) – per alunni assenti (solo dom.modificate)
Fisica
Primo quesito
Quali sono le caratteristiche del suono? Elencale e descrivile.
Considera una cassa che emette un suono di potenza 20W. Quale sarà l'intensità
sonora a una distanza di 5m dalla cassa? Qual è la minima distanza che devo
tenere per non subire danni all'orecchio?
Secondo quesito
Descrivi il fenomeno dell'interferenza tra due onde. Che cos'è un nodo? Quando si
parla di onda stazionaria? Come si calcolano frequenza e lunghezza d'onda delle
armoniche? Determina a quale velocità si propaga un’onda in una corda vibrante a
estremi fissati di lunghezza l=2,5m, sapendo che la frequenza della terza armonica è
= 5,7 .
Inglese
Primo quesito
Explain how the two versions of the “Chimney Sweeper” are related to the
collections they belong to. Consider their style, language and themes.DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
Secondo quesito
According to Samuel Taylor Coleridge, imagination was the poet’s sovereign
creative power. Outline the two main concepts he described concerning this faculty.
_________________
Seconda simulazione (26/3/18) – Tipologia B: 10 quesiti – Durata: 150 minuti
Latino
Primo quesito
Indicare per quali aspetti la Pharsalia di Lucano si opponga alla tradizione epica
latina.
Secondo quesito
Indicare sinteticamente i temi principali della produzione di Marziale e le
caratteristiche tipiche della tecnica compositiva dei suoi epigrammi satirici.
Scienze motorie
Primo quesito
Classifica e descrivi le capacità motorie coordinative.
Secondo quesito
Le modalità di apprendimento sono diverse per ciascuno di noi. Evidenzia in base a
cosa si differenziano e descrivi le più usate.
Inglese
Primo quesito
What values and themes did Jane Austen deal with? What were the features of her
style?
Secondo quesito
What does the whiteness of the whale symbolise in Herman Melville’s Moby Dick?
Matematica
Primo quesito
Definisci la tangente di un angolo e descrivi le caratteristiche (dominio, periodicità,
immagine, simmetrie, grafico) della funzione = tan . Quando una funzione è
invertibile? La funzione = tan è invertibile? E se restringiamo il dominio
all'intervallo − , ? Giustifica le tue risposte.
Secondo quesito
Dopo aver dato la definizione di funzione, definisci dominio e immagine di una
funzione. Dai la definizione di intorno di un punto e specifica cosa si intende per
intorno circolare. Come si definisce il limite finito di una funzione per x che tende aDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
un valore finito? Considera la funzione = e scegliendo opportuni valori da
assegnare alla variabile x, fai una congettura sul valore di lim → .
Scienze
Primo quesito
Descrivi il Ciclo Litogenetico ed esponi le fasi che lo caratterizzano.
Secondo quesito
Fornisci una definizione di roccia sedimentaria, riportandone le caratteristiche
principali e descrivendo la loro classificazione.
____________________
Recupero seconda simulazione (28/03/2018) – per alunni assenti (solo dom. modif.)
Matematica
Primo quesito
Definisci il seno e il coseno di un angolo e descrivi le caratteristiche (dominio,
periodicità, immagine, simmetrie, grafico) delle funzioni goniometriche =
sin , = cos . Quando una funzione è iniettiva? La funzione = sin è iniettiva?
A quale intervallo si può restringere il dominio in modo che la funzione sia iniettiva ?
Giustifica le tue risposte.
Secondo quesito
Dopo aver dato la definizione di funzione, definisci dominio e immagine di una
funzione. Quando una funzione si dice crescente o decrescente? Come si definisce
il limite finito di una funzione per x che tende a un valore infinito? Considera la
"
funzione = e scegliendo opportuni valori da assegnare alla variabile x, fai
una congettura sul valore di lim → # . Esiste il lim → ?
Inglese
Primo quesito
How does Jane Austen criticise British society in Pride and Prejudice?
Secondo quesito
Describe how Moby Dick is a symbol in Herman Melville’s novel Moby
Dick.
____________________
Terza simulazione (14/4/18) – Tipologia B: 10 quesiti – Durata: 150 minutiDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
Latino
Primo quesito
Quali particolarità presenta il decimo libro dell’Institutio oratoria? Perché può essere
considerato una “sintetica storia letteraria per autori e generi”?
Secondo quesito
Spiega sinteticamente quale sia la concezione della natura secondo Plinio il
Vecchio.
Scienze
Primo quesito
Esponi la teoria della tettonica a zolle.
Secondo quesito
Definisci l’orogenesi e spiega in quali modi può avvenire.
Scienze motorie
Primo quesito
Che cos’è il potenziale d’azione e come avviene nel muscolo?
Secondo quesito
Quale parte dell’encefalo ha un ruolo fondamentale nella coordinazione dei
movimenti e perchè?
Inglese
Primo quesito
In Charles Dickens’ novel Hard Times, how is Coketown a mirror to the Victorian
Age?
Secondo quesito
Outline the main themes of Aestheticism and Decadence.
Fisica
Primo quesito
Definisci il campo magnetico e descrivi le esperienze che hanno portato alla
scoperta delle interazioni tra campo magnetico e campo elettrico.
Secondo quesito
Come si calcola il modulo del campo magnetico generato da un filo conduttore
percorso da corrente? Descrivi il procedimento per ottenere il modulo del campo
magnetico mediante l’utilizzo di una carica di prova.
____________________DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
SIMULAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO DEGLI ESAMI DI
STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Pier Paolo Pasolini
Televisione e società, potere e omologazione
La collaborazione di Pasolini con “Il Corriere della Sera” cominciò nel 1973: gli articoli apparsi sul quotidiano
milanese, poi raccolti nei volumi Scritti corsari (1975) e Lettere luterane (1976, postumo), affrontavano
problematiche e questioni oggetto di pubblico dibattito nell’Italia dell’epoca. Fra queste, l’avvento dello
strapotere della televisione, tema su cui è incentrato il brano proposto.
[…] Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi.
Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale1, che però restava lettera morta. Le
varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai
loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario,
l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati.
L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la «tolleranza» della ideologia edonistica2 voluta dal
nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale
repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle
infrastrutture3 e la rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai
strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del
sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della televisione, il Centro ha
assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha
cominciato un’opera di omologazione4 distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè –
come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si
accontenta più di un «uomo che consuma», ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che
quella del consumo. Un edonismo neolaico5, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e
ciecamente estraneo alle scienze umane.
L’antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era, come si sa, la religione: e il cattolicesimo,
infatti, era formalmente l’unico fenomeno culturale che «omologava» gli italiani. Ora esso è diventato
concorrente di quel nuovo fenomeno culturale «omologatore» che è l’edonismo di massa: e, come
concorrente, il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. […]
Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d’animo collettivi. Per esempio, i
sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura e non si vergognavano della propria
ignoranza. Anzi, erano fieri del proprio modello popolare di analfabeti in possesso però del mistero della
realtà. Guardavano con un certo disprezzo spavaldo i «figli di papà», i piccoli borghesi, da cui si
dissociavano, anche quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi cominciano a
vergognarsi della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio modello culturale (i giovanissimi non lo
ricordano neanche più, l’hanno completamente perduto), e il nuovo modello che cercano di imitare non
prevede l’analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari ― umiliati ― cancellano nella loro carta
d’identità il termine del loro mestiere, per sostituirlo con la qualifica di «studente». Naturalmente, da
quando hanno cominciato a vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato anche a disprezzare la
cultura (caratteristica piccolo borghese, che essi hanno subito acquisito per mimesi6). Nel tempo stesso,
il ragazzo piccolo borghese, nell’adeguarsi al modello «televisivo» – che, essendo la sua stessa classe
a creare e a volere, gli è sostanzialmente naturale – diviene stranamente rozzo e infelice. Se i
sottoproletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono sottoproletarizzati. La cultura che essi producono,
essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al vecchio «uomo» che è
ancora in loro di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento7 delle facoltà intellettualiDOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018 e morali. La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto «mezzo tecnico», ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere. Non c’è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogans mussoliniani fanno ridere: come (con dolore) l’aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, voglio ripeterlo, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l’anima del popolo italiano: il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione (specie, appunto, la televisione), non solo l’ha scalfita, ma l’ha lacerata, violata, bruttata8 per sempre. Ora una circostanza che non è certo dovuta al fato, rimette parzialmente gli italiani in una situazione umana «antica». Come una volta (cioè non più cinque o sei anni fa) gli italiani della periferia sono materialmente lontani dal Centro. […] Ciò che, in tutto ciò, resta immutato, e assicura così la continuità del modo di vita che si è ormai storicamente imposto, è la televisione. Non è difficile supporre che in questi mesi di relegazione e di noia, è alla televisione che gli italiani si rivolgeranno senza possibilità di scelte per passare il tempo. Così che in un periodo di emergenza che sembra però destinato a fissarsi e a essere il nostro futuro, la televisione diventerà ancora più potente: e la violenza del suo bombardamento ideologico non avrà più limiti. La forma di vita ― sottoculturale, qualunquistica9 e volgare ― descritta e imposta dalla televisione non avrà più alternative. Ora i dirigenti della televisione usano dichiararsi innocenti da tutto questo: la loro formazione umanistica e cattolica, se anziani, la loro preparazione tecnica elevata se di mezza età, non impedisce loro di rimuovere le proprie responsabilità. […] Li sfido, programmaticamente e elementarmente, su un punto solo. Essi sanno bene che la cultura di massa, così com’è, è sottocultura, anzi, anticultura; e se il fenomeno è ormai irreversibile – essendo le masse una realtà – esso, come ogni fenomeno storico, va affrontato, corretto, modificato. Essi sanno bene, anche, che le lunghe serate e le lunghe domeniche invernali a casa possono riproporre il problema, o la soluzione, della lettura: che al contrario della televisione, non è un fenomeno di sottocultura, ma di cultura. Gli italiani (se mai li hanno scoperti) possono oggi riscoprire i libri. Io dunque sfido i dirigenti della televisione a dimostrare la loro buona fede e la loro buona volontà, attraverso un lancio delle lettura e dei libri: lancio da non relegare però ai programmi culturali, alle trasmissioni privilegiate: ma da organizzare secondo le infallibili regole pubblicitarie che impongono di consumare. […] da Sfida ai dirigenti della televisione, in “Il Corriere della Sera”, 9 dicembre 1973; poi con il titolo Acculturazione e acculturazione in Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975 1. reazionario e monumentale: conservatore e maestosamente solenne. 2. edonistica: finalizzata al conseguimento del puro piacere. 3. infrastrutture: vie e mezzi di comunicazione, servizi pubblici. 4. omologazione: processo culturale in base al quale ci si uniforma a modelli dominanti. 5. neolaico: fondato su una nuova cultura laica. 6. per mimesi: per imitazione. 7. rattrappimento: irrigidimento. 8. bruttata: sporcata (in senso morale). 9. qualunquistica: improntata al disimpegno e all’indifferenza in senso sociale, politico e ideologico. Comprensione del testo 1. In quale accezione nell’articolo viene chiamato in causa il fascismo? Con quale altra realtà viene messo a confronto? Nel rispondere, rifletti sul concetto di «centralismo» (r. 1) con cui Pasolini avvia il discorso, e considera quanto emerge dall’intero brano. 2.Quali ripercussioni a livello sociale è possibile registrare nel contesto italiano in seguito all’avvento della televisione? Quale categoria di persone l’autore prende soprattutto in considerazione?
DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
3. La conclusione dell’articolo, in cui Pasolini si rivolge direttamente ai dirigenti della televisione di Stato,
presenta un chiaro ed esplicito invito a intervenire sulla società in nome della «cultura» e non della
«sottocultura» (rr. 75-80): quale? E con quale intento da parte sua?
Analisi del testo
4. Perché l’autore mette in correlazione «la rivoluzione delle infrastrutture» con «la rivoluzione del sistema
d’informazioni» (rr. 10-11)?
5. Che cosa hanno in comune il cattolicesimo e il nuovo potere del «centralismo» televisivo? In che cosa, invece,
differiscono secondo Pasolini?
6. Individua nel brano le riflessioni che l’autore riserva alla tecnologia: a quali aspetti della problematica trattata
sono riferite?
7. Alcune osservazioni di Pasolini sono rivolte ad aspetti psicologici e comportamentali degli individui che
compongono la nuova società di massa, e, di conseguenza, il pubblico televisivo: individuale e commentale.
8. La prosa pasoliniana evidenzia, fra i molti aspetti che la caratterizzano, il ricorso al procedimento ternario, che
si avvale il più delle volte dell’uso degli aggettivi. Individua nel brano esempi significativi in tal senso,
spiegandone l’efficacia sul piano espressivo.
9. Osserva nel brano il ricorso al sostantivo «abiura» e al verbo «abiurare»: qual è il loro esatto significato? In
quale accezione li utilizza Pasolini?
10. Fornisci una sintetica definizione del livello sintattico del testo – destinato al quotidiano per eccellenza della
borghesia italiana – valutandone la funzione rispetto alle finalità del discorso proposto dall’autore, qui nelle
vesti di acuto e “profetico” polemista.
Interpretazione complessiva e approfondimenti
11. «Pasolini […] era insidiato da un senso di onnipotenza: di fronte al mondo in febbrile trasformazione non
accetta di riadattarsi, resta abbarbicato alla granitica convinzione che non c’è più nulla da desiderare» (F. La
Porta, Pasolini, Il Mulino, Bologna 2012, p. 106): ritieni che la “profezia” sullo strapotere della televisione
espressa da Pasolini, refrattario a qualsiasi “compromesso” con la società dei consumi, sia stata smentita
dalla realtà? Pensi che la massa abbia metabolizzato la “mutazione antropologica”, rivelando un vitalissimo
spirito di adattamento? Nel rispondere, rifletti sull’esattezza delle intuizioni di fondo dell’intellettuale, ma anche
sul fatto che la contemporaneità sembra imporci una diversa chiave di lettura delle sue acute, lungimiranti
analisi.
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI
GIORNALE”
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti
alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale
pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: Amore, odio, passione.
«Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter
esser badessa, c’era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era
contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’
tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno,
ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar
del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo
veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai
pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.»
Alessandro MANZONI, I promessi sposi, sposi 1840-42
«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, Lupa che quando gli si
ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per
svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere
aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi,
confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi
di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la
Lupa tornava a tentarlo:
- Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio,
Idd vi
ammazzo!
- Ammazzami, rispose la Lupa,, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci.
Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a
staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che
luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli
incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. -
Ah! malanno all’anima vostra! balbettò Nanni.»
Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi,
campi 1880
«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento
cominciava a invaderla.
– Ma vieni!
Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente
Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un
piccolo tratto; poi la strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso.
– No, no, no...
Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro
indietr anelando e
tremando.DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018 – Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo? Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una violenza più acre e trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo sinistro che le folgorò l’anima di terrore. – No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio dirti... Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo. – Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami! Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo la morte. – Assassino! – urlò allora furibonda. E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. – Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo dell’abisso, perduta. Il cane latrava contro il viluppo. Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora nel profondo dell’anima un odio supremo. E precipitarono nella morte avvinti.» Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894 «Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né – come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non sognerò mai più – pensò uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non ci ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava d’importanza.» Italo SVEVO, Senilità, 19272 (1a ed. 1898) 2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO ARGOMENTO: Siamo quel che mangiamo? DOCUMENTI «“Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno non lasciano dubbi - dice Massimo Volpe, presidente della Siprec (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) - la vita sedentaria è un rischio per il cuore. Se a questo si aggiunge che spesso si mangia male, il quadro generale peggiora. Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e gli alimenti cardine di una sana alimentazione. Pochissimi sanno davvero giudicare la salubrità di un alimento, molti si nutrono in modo disorganizzato”. Il 95 per cento, continua l’esperto, dichiara che il pranzo è il pasto più importante, ma poi l’80 per cento sceglie una pasta molto condita accompagnata dal pane. Un italiano su due mangia carne magra, ma c’è un buon 20 per cento che sceglie carni grasse più volte alla settimana; il 45 per cento consuma formaggi come minimo tre volte alla settimana. Uno su tre, poi, mangia pesce appena una volta alla settimana, mentre «Mercoledì 17 novembre 2010. La quinta sessione del Comitato Intergovernativo dell’UNESCO [...] ha iscritto la Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista (sc. del patrimonio culturale immateriale dell’umanità). [...] La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di
DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018 competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) è molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo.» CNI-UNESCO, La Dieta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità, www.unesco.it «La politica alimentare [...] si deve basare sul concetto che l’energia primaria della vita è il cibo. Se il cibo è energia allora dobbiamo prendere atto che l’attuale sistema di produzione alimentare è fallimentare. […] Il vero problema è che da un lato c’è una visione centralizzata dell’agricoltura, fatta di monoculture e allevamenti intensivi altamente insostenibili, e dall’altro è stata completamente rifiutata la logica olistica, che dovrebbe essere innata in agricoltura, per sposare logiche meccaniciste e riduzioniste. Una visione meccanicista finisce con il ridurre il valore del cibo a una mera commodity, una semplice merce. È per questo che per quanto riguarda il cibo abbiamo ormai perso la percezione della differenza tra valore e prezzo: facciamo tutti molta attenzione a quanto costa, ma non più al suo profondo significato. […] Scambiare il prezzo del cibo con il suo valore ci ha distrutto l’anima. Se il cibo è una merce non importa se lo sprechiamo. In una società consumistica tutto si butta e tutto si può sostituire, anzi, si deve sostituire. Ma il cibo non funziona così.» Carlo PETRINI in Petrini-Rifkin. Il nuovo patto per la natura, “la Repubblica” - 9 giugno 2010 «Mangiare mentre si legge la posta, si gioca o si lavora al pc può avere serie conseguenze sulla nostra forma fisica. [...] Secondo quanto riportato dalla rivista American Journal of Clinical Nutrition, chi mangia svolgendo altre attività, sia questa navigare in internet o sui profili degli amici su Facebook, è più propenso ad esagerare con le quantità in quanto non ha il senso delle calorie che sta realmente introducendo e inoltre ha più voglia di dolci. [...] Quindi nonostante sia costume sempre più diffuso quello di mangiare rimanendo “connessi” col mondo intorno a noi, per chi ci tiene a non mettere su chili di troppo, meglio evitare le distrazioni durante i pasti e focalizzare l’attenzione su quello che si sta consumando.» Silvia MAGLIONI, Mangiare davanti al computer fa male alla linea, www.leonardo.it 3. AMBITO STORICO-POLITICO ARGOMENTO: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento DOCUMENTI Scheda: Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di esiliati e fuoriusciti politici. Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un milione di deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori forzati.
DOCUMENTO DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2017- 2018 Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936?38 furono eliminati 30.000 funzionari su 178.000; nell'Armata rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali, alti ufficiali e commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell'Est, Cina, Corea del Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati circa 100 milioni di persone contrarie al regime. Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate torture su persone per reati d'opinione. "Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima nemico e poi criminale, viene trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente nell'idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema fondamentale del totalitarismo: si tratta di costruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un'ideologia dell’ eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri". S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000 "Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un altro". Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948 "Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare". C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, (L'autore era segretario generale del Partito socialista cileno) "I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una manomissione completa della memoria". T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, Garzanti, 2001 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO ARGOMENTO: «Sensate esperienze» e «dimostrazioni certe»: la nascita della scienza moderna. DOCUMENTI «La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.» G. GALILEI, Il Saggiatore, 1623 «Siamo in uno dei grandi momenti dello spirito umano. Galileo scopre le immense possibilità offerte dalla modellizzazione matematica della realtà fisica, traducendo la sua meraviglia in queste frasi rimaste celebri [quelle riportate nel brano precedente]. Il fatto che la natura si esprima in linguaggio matematico, o, per utilizzare termini meno immaginosi, che concetti matematici collegati tramite equazioni e calcoli possano permettere di riprodurre e di prevedere il comportamento di oggetti fisici nel mondo reale resta ancor oggi, quattro secoli dopo Galileo, una fonte inesauribile di stupore...» I. EKELAND, Il migliore dei mondi possibili. Matematica e destino, Torino, 2001
Puoi anche leggere