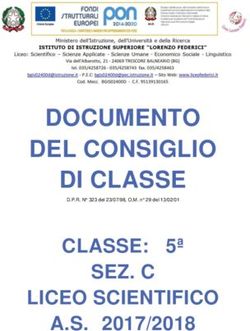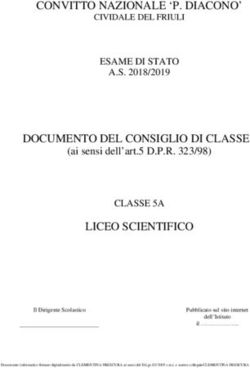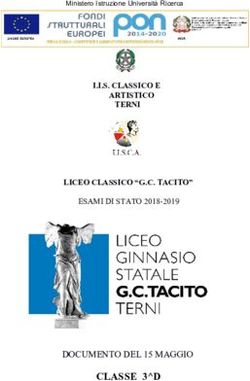CLASSE 5C Liceo Classico - Documento del Consiglio di Classe - liceo Aristofane
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE
ARISTOFANE
Via Monte Resegone,3 - 00139 Roma
( 06121125005 * rmpc200004@istruzione.it
Cod. Scuola RMPC200004 – C.f. 80228210581
Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX
rmpc200004@pec.istruzione.it- U.R.L. www.liceoaristofane.gov.it
Documento del Consiglio di Classe
CLASSE 5C
Liceo Classico
Anno Scolastico 2018/2019
1“La coscienza dei cittadini è creata dalla scuola; dalla scuola dipende come sarà domani il
parlamento, come funzionerà la magistratura, cioè quale sarà la coscienza e la competenza di
quegli uomini che saranno domani i legislatori, i governanti e i giudici del nostro paese. La
classe politica che domani detterà le leggi e amministrerà la giustizia, esce dalla scuola; tale sarà
quale la scuola sarà riuscita a formarla. […]
Proprio per questo, fra tutti i rami dell’amministrazione, quello scolastico propone i
problemi più delicati e più alti: per risolvere i quali non basta essere esperti di problemi tecnici
attinenti alla didattica, alla contabilità e all’edilizia, ma occorre soprattutto avere la
consapevolezza dei valori morali e pedagogici che si elaborano nella scuola, dove si creano non
cose ma coscienze; e, quel che è più, coscienze di maestri che siano capaci a lor volta di creare
coscienze di cittadini.”
Piero Calamandrei
2INDICE
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO pag. 4
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 5
COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO Pag .5
CURRICULUM DEL LICEO CLASSICO pag. 5
QUADRO ORARIO SETTIMANALE pag. 6
PROFILO DELLA CLASSE pag. 6
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO pag. 7
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI pag. 8
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO pag.10
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI pag. 10
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag. 17
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
pag. 18
L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLIL pag. 18
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA pag. 18
ORIENTAMENTO IN USCITA pag. 19
SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA pag. 20
GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE DELLE pag. 20
SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE NEL CORSO
DELL’ANNO SCOLASTICO
LINEE PROGRAMMATICHE DELLE DISCIPLINE p. 26
FIRME DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
(disponibile soltanto nel formato cartaceo)
3PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’ Aristofane nasce come Liceo Classico nel 1979. Dal 1996 è stato attivato l’indirizzo linguistico che, nato
come sperimentazione, si è, successivamente, conquistato una propria stabile identità. La scuola, che ha sede nel
III Municipio, afferente al XII Distretto Scolastico, Ambito Territoriale IX, è composta di due corpi di fabbrica,
circondati da una vasta zona verde, situati nell’area compresa tra via Monte Resegone e via Monte Massico; a
questa storica struttura si è aggiunta, dall’anno scolastico 2013-14, una nuova succursale in via delle Isole
Curzolane 73. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (autobus e la tratta B1 della
metropolitana).
Le studentesse e gli studenti che frequentano il Liceo provengono da diversi quartieri (prevalentemente
Montesacro, Tufello, Nuovo Salario, Talenti, Vigne Nuove, Africano, Fidene, Colle Salario, Serpentara, Settebagni,
Bufalotta) oltre che da comuni limitrofi.
L’istituto fa parte della rete di scuole dei Municipi III e IV e collabora con gli Enti locali e con le scuole del
distretto alla realizzazione di numerosi progetti. L’apertura pomeridiana soddisfa le esigenze socio-culturali degli
studenti che trovano nelle attività extracurricolari, promosse dal Liceo, la risposta ai bisogni che il quartiere non
può soddisfare e fruiscono di un luogo accogliente.
La biblioteca del liceo intitolata a “Carolina Lupi”, che contiene volumi, enciclopedie, riviste, dvd e cd in
numero complessivo di circa settemila unità, è arricchita annualmente con nuove acquisizioni. E’ stata avviata
l’informatizzazione del catalogo con la collaborazione degli studenti. Tutte le classi dispongono inoltre di una
dotazione di dizionari delle lingue studiate. Viene curato con particolare attenzione lo studio delle lingue straniere e
dell’informatica con l’ausilio di laboratori efficienti e attrezzati. Gli studenti vengono preparati anche a sostenere,
nei livelli previsti dal Consiglio d’Europa, gli esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali di lingua
straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR; si organizzano, inoltre, corsi di preparazione agli
esami per il conseguimento della Certificazione informatica europea - Eipass, di cui la scuola è ente certificatore
L’istituto si articola saldamente sul territorio, mediante una rete di collaborazioni sia con enti pubblici, sia con
altre scuole del distretto; un ben organizzato progetto continuità, oltre ad una fitta rete di altre iniziative, unisce il
Liceo Aristofane alle scuole secondarie di primo grado nell’intento di creare un legame di stabilità ed evitare
insuccessi nei passaggi fra i vari ordini di studi. La progettazione dell'Aristofane consente l'individuazione e il
potenziamento delle capacità e delle attitudini di ogni studente che, con la piena realizzazione di se stesso,
acquisisce le potenzialità per inserirsi nella realtà sociale e lavorativa. La continuità fra il liceo e l’università, poi, è
perseguita grazie ad uno strutturato progetto di orientamento in uscita, attuato attraverso numerose convenzioni
con Università del Lazio e italiane; esso prevede sportelli pomeridiani, preparazione ai test di entrata alle facoltà
scientifiche, moduli in alternanza scuola – lavoro, interventi di esperti e di enti specializzati.
In termini didattici il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Aristofane si sostanzia nella scelta libera, ma
collegialmente programmata, di metodologie, strumenti, contenuti, tempi d’insegnamento, adottati nel rispetto
della pluralità progettuale, compresa l’offerta di attività di ampliamento e arricchimento del curricolo, finalizzate al
raggiungimento del successo formativo e scolastico. La scuola si apre così a molteplici attività che vanno dai
progetti scientifici a quelli linguistici dell’UE, ai concorsi letterari, alle rappresentazioni teatrali, alle manifestazioni
sportive. Dal 2009 il Liceo organizza il Praemium Aristophaneum, prova di eccellenza che chiama studenti dei licei
classici italiani a cimentarsi nell’interpretazione e nella valorizzazione di alcuni aspetti dell’opera di Aristofane.
Gli incontri-dibattito con esponenti del mondo del lavoro, gli scambi nazionali ed internazionali, gli stage
linguistici, le visite culturali ed i viaggi d’istruzione, la partecipazione ai campionati studenteschi, l’educazione alla
tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio, l’attenzione all’ambiente, la
partecipazione ad iniziative di volontariato favoriscono la consapevolezza di appartenere ad una società
multiculturale e multietnica e contribuiscono allo sviluppo armonico della personalità degli studenti.
4DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE MATERIA CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
Sandra Martorella IRC Martorella Martorella Martorella
Flaminio Poggi Italiano Marotta Marotta Poggi
Maria Macciocca Latino Macciocca Macciocca Macciocca
Maria Macciocca Greco Macciocca Macciocca Macciocca
Marisa Tilde Di Sibio Inglese Di Sibio Di Sibio Di Sibio
Luciana Piccinni Storia Piccinni Piccinni Piccinni
Luciana Piccinni Filosofia Piccinni Piccinni Piccinni
Giovanni Mele Matematica Mele Mele Mele
Giovanni Mele Fisica Mele Mele Mele
Elvira Pontone Scienze Pontone Pontone Pontone
Enrico Bassan Storia dell’Arte Bassan Bassan Bassan
Rita Girlando Scienze Motorie Girlando Girlando Girlando
COORDINATORE: prof. ssa Maria Macciocca
COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO
Nella seduta del 5/03/2019 il Consiglio di Classe ha designato i seguenti docenti quali Commissari
interni per le rispettive discipline:
DOCENTI DISCIPLINE
Maria Macciocca Latino e Greco
Luciana Piccinni Storia e Filosofia
Elvira Pontone Scienze
CURRICULUM DEL LICEO CLASSICO
Il curriculum proprio del liceo classico permette allo studente di approfondire le diverse discipline attraverso
l’analisi tecnico-linguistica del documento e dei fenomeni naturali e storico sociali. Lo spessore culturale con il
quale si affronta lo studio consente lo sviluppo coerente ed armonioso della personalità dello studente,
permettendogli l’acquisizione di una vera pre-professionalità ed un corretto inserimento in un qualsiasi ambito
specialistico. In tal senso il liceo classico si pone come luogo ideale, nel quale creare, giorno dopo giorno, le ragioni
profonde della propria autonomia di pensiero e le linee portanti di una visione critica della realtà.
Dall’a.s. 2016-2017 è stata attivata, in due sezioni, la sperimentazione Cambridge che consiste nello studio
aggiuntivo di due ore nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio finalizzato al superamento
dell’esame internazionale Cambridge IGCSE. Le materie in lingua inglese per il Liceo classico sono English as a
Second Language e Biology.
Per quanto concerne l’insegnamento CLIL, previsto per il quinto anno del Liceo classico, si rimanda alla sezione
specifica del presente documento.
5QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO CLASSICO
I II III IV V
Materie
Liceo Liceo Liceo Liceo Liceo
Religione 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 5 5 4 4 4
Greco 4 4 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze 2 2 2 2 2
Storia/Geografia 3 3 - - -
Storia - - 3 3 3
Filosofia - - 3 3 3
Storia dell'Arte - - 2 2 2
Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Totale ore 27 27 31 31 31
PROFILO DELLA CLASSE
La 5CC è composta da 21 allievi, 8 femmine e 13 maschi, tutti provenienti dal gruppo classe iniziale di 26 studenti,
che si è ridotto al termine del secondo anno a causa di non promozioni e di un trasferimento al termine del terzo
anno. La classe, corretta nel comportamento e rispettosa delle regole della comunità scolastica, si è caratterizzata
sin dal biennio per la vivacità dell’interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo, manifestata anche con
l’adesione a numerosi progetti promossi dal Liceo e sostenuta, nella maggior parte degli alunni, da una buona
motivazione allo studio. Nel corso del triennio gli studenti hanno continuato a rispondere positivamente alle
sollecitazioni culturali dei docenti, consolidando il proprio metodo di studio ed evidenziando una più consapevole
sistematizzazione dei contenuti. In tutto il quinquennio la partecipazione alla sperimentazione della didattica con
ipad attuata nella scuola ha favorito la realizzazione di percorsi di apprendimento collaborativo, con la produzione
e condivisione di materiali multimediali (alcuni presentati dagli studenti alle manifestazioni del Tablet School
organizzate dall’associazione Imparadigitale). Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa si
segnalano l’impegno di numerosi studenti come tutores o come supporto organizzativo per il progetto Pari -impàri,
il coinvolgimento nelle attività di orientamento in ingresso, la partecipazione a vari certamina di lingue classiche
(con anche alcuni riconoscimenti) e a competizioni letterarie e matematiche, ai corsi di lingua, ai progetti Inda,
Astronomia, Adotta un monumento, Storia del Novecento (in collaborazione con il Museo storico della Liberazione di via
Tasso). Molte di queste attività sono state svolte anche in modalità di alternanza scuola lavoro.
I livelli di preparazione raggiunti sono nel complesso soddisfacenti, pur con le differenze dovute al percorso
individuale di ciascuno; spiccano alcune eccellenze che, grazie ad un impegno serio e rigoroso, hanno conseguito
una preparazione sicura, mostrando vivacità intellettuale, spirito critico e autonomia nella ricerca culturale; un
nutrito numero di studenti ha raggiunto una preparazione adeguata e discrete capacità di rielaborazione, mentre
soltanto alcuni allievi non hanno realizzato livelli pienamente soddisfacenti di preparazione.
Al termine del corso di studi l’intero gruppo classe mostra di aver svolto un percorso formativo significativo, con
la progressiva acquisizione di un discreto grado di autonomia e consapevolezza nelle scelte culturali.
6DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
• Lezione frontale
• Lezione interattiva
• Didattica laboratoriale
• Didattica museale
• Cooperative learning
• Tutoring / peer education
I docenti del C.d.C., durante il percorso quinquennale:
• hanno favorito: le discussione in classe, i lavori di approfondimento individuali e di gruppo, gli esercizi di
autocorrezione, la partecipazione attiva e critica degli allievi alle lezioni, l’acquisizione di un adeguato
metodo di studio.
• hanno abituato gli studenti a: prendere appunti, raccogliere e classificare dati, produrre schemi,
recuperare conoscenze pregresse e porle in relazione con quelle di più recente acquisizione, decodificare
un testo, usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattico, fonti informative.
· hanno chiesto agli studenti di: relazionare, anche attraverso presentazioni multimediali, su interventi,
attività, avvenimenti, riassumere testi, stabilire rapporti di causa-effetto, applicare principi e regole anche in
contesti non banali, individuare sequenze logiche.
MEZZI
• Libri di testo e vocabolari
• Materiali condivisi attraverso Dropbox o Airdrop o tramite registro elettronico o distribuiti in fotocopia
• LIM/videoproiettore, Ipad, pc di classe, lavagna
• Audiovisivi
• Risorse presenti sul territorio
SPAZI
• Aula
• Biblioteca
• Laboratori di scienze ed informatica
• Territorio
TEMPI
Nel corso dell’anno scolastico, suddiviso in un trimestre e un pentamestre, in orario curricolare ed extracurricolare.
7VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
TABELLA TASSONOMICA
VALUTAZ
PREPARAZIONE CORRISPONDENZA
IONE
1 Mancanza di verifica L’alunno rifiuta di svolgere la prova di verifica e non risponde alle sollecitazioni offerte dall’insegnante.
Non conosce gli argomenti trattati. Delle sollecitazioni offerte e delle informazioni fornite durante la prova non sa servirsi o al più tenta
2–3 Scarsa
risposte inadeguate e semplicistiche
Conosce in modo frammentario e molto superficiale gli argomenti proposti. Il linguaggio è stentato e il lessico usato non appropriato. Le
4 Insufficiente
risposte non sono pertinenti.
Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti e, pur avendo conseguito alcune abilità, non è in grado di utilizzarle in
modo autonomo anche in compiti semplici. Il linguaggio è corretto, ma povero e la conoscenza dei termini specifici è scarsa. Anche
5 Mediocre
all’acquisizione mnemonica va attribuita questa valutazione poiché quanto appreso non permane e non permette il raggiungimento di nessuna
abilità.
Conosce gli argomenti fondamentali senza approfondimento; non commette errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici ma non è in
6 Sufficiente grado di applicare le conoscenze acquisite in compiti complessi. Capacità di riutilizzare le conoscenze acquisite, ma solo in compiti semplici o
con le indicazioni dell’insegnante Uso appropriato dei termini specifici e costruzione corretta, anche se semplice, delle frasi.
Conosce e comprende in modo analitico, non commette errori ma solo imprecisioni. Il linguaggio è fluido e pertinente. Comprende con
7 Discreta
facilità e sa rielaborare. Capacità di collegare fra loro conoscenze acquisite in tempi diversi conducendo ragionamenti logici e autonomi.
La conoscenza degli argomenti è completa, arricchita anche con esempi e approfondimenti. Non commette né errori né imprecisioni. Sa
8 Buona
organizzare le conoscenze in situazioni nuove. Riesce a fare collegamenti interdisciplinari se espressamente richiesti.
Come nella valutazione precedente, ma con maggiore sicurezza e spontaneità nell’inserire nella prova tutte le conoscenze e le capacità
9 Ottima
acquisite anche nelle altre discipline. Ha una discreta capacità di astrazione.
Le abilità sono le stesse della valutazione precedente, ma l’alunno elabora, approfondisce e ricollega gli argomenti autonomamente, con
10 Eccellente
originalità e personale apporto critico.
Tabella di valutazione per l’IRC
Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo
Obiettivi completamente raggiunti Buono
Obiettivi raggiunti Discreto
Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente
Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi
Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune Insufficiente
Nessun obiettivo raggiunto
Tabella di valutazione per Attività alternativa
Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti Ottimo
Obiettivi completamente raggiunti Buono
Obiettivi raggiunti Discreto
Obiettivi complessivamente raggiunti Sufficiente
Obiettivi non completamente raggiunti per lacune non gravi Insufficiente
Obiettivi solo parzialmente raggiunti, a causa di gravi lacune
Nessun obiettivo raggiunto
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE:
• Presenza
• Partecipazione
• Progressi
8INDICATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE:
• aspetti comportamentali e relazionali
• motivazione ed interesse per la singola discipline
• temperamento, emotività, affettività
• possesso dei pre-requisití richiesti
• progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei
• partecipazione attiva al dialogo didattico
• livello di conoscenze e competenze
• raggiungimento degli obiettivi comportamentali
• raggiungimento degli obiettivi cognitivi
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE
Verifica formativa
• osservazione
• dialogo
• test
• questionari
• domande flash nel corso di ciascuna unità didattica
Verifica sommativa
• prove scritte non strutturate (questionari, temi, problemi, esercizi, relazioni)
• prove scritte strutturate (test)
• prove orali
• produzione di materiali multimediali
• prove pratiche o grafiche
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Obiettivi comportamentali
• rispettare gli altri, l’ambiente e il patrimonio scolastico, le norme della buona educazione e della civile
convivenza
• lavorare in gruppo
• saper individuare, analizzare e risolvere le situazioni problematiche
• realizzare percorsi di autoapprendimento
Obiettivi cognitivi
• conoscere i contenuti essenziali di ogni disciplina;
• comprendere ed analizzare un testo scritto ed orale e saperne esporre i punti significativi;
• esprimersi in modo adeguato, coerente ed appropriato, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline;
• applicare regole e principi;
• collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni;
• rendere espliciti rapporti di causa - effetto, le impostazioni e le conseguenze;
• saper valutare ed esprimere giudizi personali
• usare correttamente manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, software didattici
9CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
Il Consiglio di classe, nell’attribuzione dei crediti scolastici, fa riferimento
• ai criteri indicati nel PTOF
• alla tabella A (di cui all’art. 15, c.2) del D. LGS. 62/2017 relativa all’attribuzione dei crediti, alla circolare
MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2019 (pag. 3: attribuzione del credito scolastico)
Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.
62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37 e dall’ OM 11 marzo 2019 n. 205, ha proposto agli
studenti i seguenti percorsi pluridisciplinari
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
INTELLETTUALE E POTERE (latino, greco, filosofia, inglese, st.arte)
LATINO E GRECO
• La “collaborazione” tra potere e intellettualità
- I filosofi al governo dello stato: Platone
- il filosofo e l’educazione del principe: Aristotele e Alessandro; Seneca e Nerone
- L’attacco post mortem a Claudio nell’Apocolocyntosis di Seneca
- La storiografia del consenso e quella del dissenso; i roghi dei libri nella prima età imperiale
- Essere magni viri etiam sub malis principibus (Socrate, Seneca, Tacito)
- La collaborazione con il potere imperiale imperiale: Quintiliano e Plinio il Giovane
• Il poeta e il principe
- La poesia cortigiana di età ellenistica (Callimaco, Teocrito) e di età imperiale (Marziale e la dinastia Flavia)
- La poesia elegiaca tra impegno e disimpegno: adesione ai circoli culturali d’età augustea, il programma tibulliano di una vita iners; il
tema della recusatio in Properzio e le sue Elegie Romane
- Lucano e Nerone
FILOSOFIA
- Kant, Per la pace perpetua, secondo supplemento, articolo segreto
INGLESE
G. Orwell, 1984, a warning against totalitarianism
STORIA DELL’ARTE
Avanguardie e contestazione: il Dadaismo tedesco (Schwitters, Höch, Heartfiled)
10UMILI, VINTI, INETTI (italiano, latino, filosofia, inglese)
ITALIANO
I protagonisti dei romanzi otto e novecenteschi e la loro evoluzione:
• Manzoni: gli umili come protagonisti del romanzo (Promessi sposi)
• Verga: il ciclo dei vinti (Prefazione ai Malavoglia; I Malavoglia; Mastro-don Gesualdo)
• Svevo: l’inettitudine da Alfonso Nitti a Zeno Cosini (Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno)
• Pirandello: l’inettitudine e la crisi dell’identità personale (Fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila; I quaderni di Serafino Gubbio
operatore)
LATINO
Seneca: l’humanitas nei confronti degli schiavi
La rappresentazione degli umili nella satira e nell’epigramma
Apuleio: la terribile condizione degli schiavi nelle Metamorfosi
FILOSOFIA
Nietzsche, La morale dei signori e degli schiavi in Al di là del bene e del male
INGLESE
• The Modern Hero in Joyce’s Ulysses.
• T. S. Eliot, The Prufrockian anti-hero
IL REALISMO (italiano, latino, greco, filosofia, inglese, st.arte)
ITALIANO
Il realismo e le funzioni del vero in letteratura:
• Manzoni: «Il santo vero mai non tradir»: gli scritti teorici, i drammi storici, il romanzo storico
• Flaubert: il canone dell’impersonalità (Madame Bovary)
• Zola: il romanziere come scienziato (Romanzo sperimentale)
• Verga e l’artificio della regressione
LATINO E GRECO
- Il realismo di Teocrito
- Il realismo nel romanzo latino (Petronio e Apuleio)
- Persio e Giovenale: il programma di una poesia “concreta”
- Il realismo comico di Marziale
FILOSOFIA
Comte : il metodo positivo, Discorso sullo spirito positivo
INGLESE
Dickens, the Realistic Novel.
STORIA DELL’ARTE
Courbet; i Macchiaioli; Realismo e Simbolismo in Pellizza da Volpedo
VERITÀ RAZIONALI E VERITÀ IRRAZIONALI (italiano, filosofia)
ITALIANO
Vero oggettivo e vero soggettivo in poesia:
• Leopardi e l’arido vero: da una poesia di immaginazione a una poesia di verità
• Le verità irrazionali del poeta simbolista:
• Il veggente di Rimbaud (Lettera del veggente)
• Il fanciullino di Pascoli (Il fanciullino)
• Il superuomo dannunziano (Le laudi)
• Saba: la poesia dello scandaglio, la verità al posto della bellezza
FILOSOFIA
Nietzsche e l'oltreuomo in Al di là del bene e del male
11LA CRISI DEL VERO (italiano, filosofia, inglese, st.arte)
ITALIANO
La crisi del vero nelle poetiche delle avanguardie e degli autori post-avanguardisti:
• I crepuscolari: la fine del privilegio del poeta (Corazzini, Desolazione del povero pota sentimentale)
• Pirandello: la «lanterninosofia» e lo «strappo nel cielo di carta» (Il fu Mattia Pascal)
• Il narratore inattendibile nella Coscienza di Zeno
• La teologia negativa in Montale (Ossi di seppia)
FILOSOFIA
Nietzsche, Il prospettivismo, Genealogia della morale
INGLESE
L. Carroll, Alice in Wonderland Syndrome
STORIA DELL’ARTE
Il Simbolismo in Europa e in Italia
IL MISTERO DI DIO (italiano, filosofia)
ITALIANO
Dio nascosto, svelato o negato:
• Dante di fronte a Dio nel XXXIII del Paradiso; il tema dell’ineffabilità nel Paradiso
• Manzoni, la provvida sventura e il mistero del male nella storia
• Dio come desiderio e i poeti come sacerdoti di eros in Saba
FILOSOFIA
Kierkegaard, Dio, l’ignoto e il paradosso
IL PROGRESSO E LA MODERNITÀ (italiano, greco, filosofia, inglese, st.arte)
ITALIANO
Le ambiguità del progresso:
• Leopardi:
• Il progresso come presa di coscienza dell’inevitabile infelicità umana (il cosiddetto “pessimismo storico”)
• Le «magnifiche sorti e progressive»: il progresso nella Ginestra
• Verga: la fiumana del progresso (la Prefazione ai Malavoglia)
• Il futurismo: la celebrazione del progresso
• Svevo: la previsione della catastrofe (le pagine conclusive della Coscienza di Zeno)
GRECO
L’opposizione natura - civiltà nell’Antigone di Sofocle
FILOSOFIA
Schopenhauer, Il pessimismo cosmico e l'esistenza come infelicità, da Il mondo come volontà e rappresentazione
INGLESE
Dickens, the industrial progress in Coketown, Hard Times
STORIA DELL’ARTE
Il Futurismo; il Bauhaus
LA GUERRA (italiano, latino, filosofia, inglese, st.arte)
ITALIANO
L’uomo e l’artista di fronte alla guerra:
• La guerra risorgimentale: Berchet e Il giuramento di Pontida; Manzoni e il coro dell’atto terzo dell’Adelchi
• Il futurismo e la guerra «sola igiene del mondo»
• Ungaretti, uomo di pena: Allegria
LATINO
La catastrofe delle guerre civili e il dovere dell’impegno nella Pharsalia di Lucano
FILOSOFIA
Hegel, La guerra, Lineamenti di filosofia del diritto
INGLESE
The War Poets, different attitudes to war: idealized patriotism vs condemnation.
STORIA DELL’ARTE
Picasso: Sogno e Menzogna di Franco, Guernica
12LA NATURA (italiano, latino, greco, filosofia, inglese, st.arte)
ITALIANO
La natura come madre, nemica, emblema di indifferenza o specchio dell’uomo:
• Leopardi: dalla benevola creatrice di illusioni all’irriducibile nemica
• Pascoli: gli inquietanti segreti mortuari di Myricae
• D’Annunzio: il panismo in Alcyone
• Ungaretti: la devastazione del paesaggio come specchio della devastazione interiore
• Montale: il correlativo oggettivo del male di vivere in Ossi di seppia
LATINO E GRECO
- Il mondo pastorale in Teocrito
- Il topos del locus amoenus nel romanzo greco
- Il vagheggiamento della vita agreste in Tibullo e Marziale
FILOSOFIA
Hegel, La filosofia della natura, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
INGLESE
T. S. Eliot’s The Waste Land, a metaphor for the spiritual dryness and sterility of the modern world.
STORIA DELL’ARTE
La pittura di paesaggio nell’Ottocento
IL TEMPO E LA STORIA (italiano, latino, greco, filosofia, inglese, st.arte)
ITALIANO
Il tempo come durata o come rivelazione:
• Manzoni: il mancato rispetto dell’unità di tempo nelle tragedie (prefazione al Conte di Carmagnola e Lettera a Monsieur
Chauvet)
• Verga: il tempo della natura e il tempo del progresso (I Malavoglia)
• Futuristi: tempo e velocità (Manifesto del 1909; Manifesto tecnico del 1912)
• Svevo: il «tempo misto» (La coscienza di Zeno)
• Ungaretti: il tempo come illuminazione (Allegria) e il tempo come durata (Sentimento del tempo)
LATINO E GRECO
- Polibio: la funzione educativa della Storia; la Storia come storia universale; la concezione biologica della storia politica:
l’avvicendarsi delle costituzioni; la fine dell’impero romano
- Il valore del tempo in Seneca
- Tacito: senso e non senso della Storia
FILOSOFIA
Bergson, Durata e simultaneità, Saggio sui dati immediati di coscienza
INGLESE
• Subjective time, The Stream of Consciousness and The Interior Monologue: V. Woolf and J. Joyce.
• The meaninglessness of time. S. Beckett, Waiting for Godot.
STORIA DELL’ARTE
La simultaneità nei Futuristi (Boccioni: Gli stati d’animo)
LA MORTE (italiano, latino, greco, inglese)
ITALIANO
La morte come conclusione o come misterioso passaggio:
• Manzoni: la morte come provvida sventura (le ultime parole di Adelchi)
• Leopardi: la morte come prospettiva di liberazione dal male di vivere (A Silvia; Canto notturno di un pastore errante); la morte
come presenza necessaria nel “perpetuo circuito di produzione e distruzione” (Dialogo della natura e di un Islandese)
• Verga: la morte come rivelazione dell’insensatezza del modello di vita borghese (La roba; Mastro-don Gesualdo)
• Pascoli: la morte come richiamo e minaccia (Myricae)
LATINO E GRECO
- “Corteggiare la morte”: Antigone
- Morte e compianto nell’epigramma ellenistico: Callimaco, Meleagro, Anite
- Luciano: la rappresentazione dell’Ade
- Plutarco: la morte di Cesare
- Suicidi “di Stato”: la morte esemplare di Socrate (Platone) e l’ambitiosa mors degli stoici (Tacito)
- Eros e Thanatos nel Satyricon di Petronio
- Il gusto del macabro in Lucano, Persio, Marziale
INGLESE
• The Funeral service in J. Joyce’s Ulysses (The Funeral).
• The Burial of the Dead as a metaphor for the condition of modern man in T. S. Eliot’s The Waste Land.
13L’AMORE, LE PASSIONI (italiano, latino, greco, filosofia, inglese)
ITALIANO
I mille volti dell’amore nell’arte:
• Leopardi: l’illusione d’amore e il ciclo di Aspasia
• Verga: dal binomio amore e morte (La lupa) all’amore sacrificato alla logica della roba (i matrimoni in Mastro-don Gesualdo)
• D’Annunzio: vittorie e insuccessi dell’esteta e del superuomo (Il piacere; Le vergini delle rocce)
• Pascoli: il fanciullino di fronte all’eros (Il gelsomino notturno, Digitale purpurea)
• Svevo: gli inetti di fronte all’amore (Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno)
• Saba: il tema della brama (Canzoniere)
• Montale: Clizia come epifania del valore (Le occasioni)
LATINO E GRECO
- Eros nella riflessione filosofica: il Simposio di Platone
- La rappresentazione della passione d’amore nell’epigramma ellenistico: Callimaco; Asclepiade, Nosside e Meleagro
- L’amore nel romanzo ellenistico
- L’amore nell’elegia romana come negazione dei valori tradizionali
- L’amore e l’abbandono: Medea nelle Argonautiche di Apollonio Rodio e nella tragedia di Seneca; Didone nell’Eneide
- La favola di Amore e Psiche in Apuleio
- La necessità del controllo delle passioni (Seneca)
- La catarsi tragica: depurazione delle passioni? (Aristotele)
FILOSOFIA
Feuerbach, L'io e il tu, Principi di filosofia dell'avvenire
INGLESE
Love, Family ties, Independence in Ch. Brontë’s Jane Eyre.
Tennyson’s Ulysses, the overreacher.
L’INFANZIA (italiano, filosofia, latino, greco, inglese)
ITALIANO
L’infanzia come realtà e come metafora:
• Leopardi e l’infanzia: le illusioni, gli antichi
• Verga e il lavoro minorile: Rosso Malpelo
• Pascoli e la poetica del fanciullino
• Corazzini e il piccolo fanciullo che piange
• Saba come primo poeta post-freudiano dell’infanzia
LATINO E GRECO
- Bambini e adolescenti nell’epigramma ellenistico (Callimaco, Anite) e nell’epigramma latino (Marziale)
nel poema epico ellenistico
nel romanzo greco
- La paideia: il dibattito sul ruolo della filosofia e della retorica nell’educazione dei giovani (Isocrate, Platone; cfr. Quintiliano).
- L’ “invenzione” della pedagogia: la scoperta dell’infanzia in Quintiliano
FILOSOFIA
Nietzsche,Le tre metamorfosi
INGLESE
• Ch. Dickens, The exploitation of children: Oliver Twist.
• L. Carroll, Growing up in Alice’s Adventures in Wonderland.
LA FAMIGLIA (italiano, greco, filosofia, inglese)
ITALIANO
La famiglia come salvezza o come trappola:
• Verga: la religione della famiglia nei Malavoglia
• Pascoli: la famiglia come nido
• Pirandello: la famiglia come trappola (Il fu Mattia Pascal; Il treno ha fischiato)
GRECO
- Uno spaccato di vita familiare dell’Atene del V secolo: Lisia, Per l’uccisione di Eratostene
- I vincoli della philia familiare e la legge dello Stato: Antigone
- Le commedie di Menandro: padri e figli a confronto; l’amore coniugale
FILOSOFIA
Hegel La famiglia, Lineamenti di filosofia del diritto
INGLESE
Eveline in J. Joyce’s Dubliners: family ties.
14IL DOPPIO, IL DUALISMO E LA DISSOCIAZIONE INTERIORE (italiano, filosofia, inglese, st.arte)
ITALIANO
La crisi dell’identità individuale:
• Baudelaire: tra spleen ed elevazione
• Pirandello: la poetica dell’umorismo, Il fu Mattia-Pascal e gli altri romanzi della crisi
• Svevo: gli inetti
• Saba e la psico-analisi
FILOSOFIA
Marx, La coscienza deriva dai rapporti materiali da L'ideologia tedesca
Kierkegaard, La scelta, l'angoscia e la disperazione, Aut-aut
Freud, La frammentazione dell'io in L'io e l'es
INGLESE
• The double in R.L. Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde.
• The Portrait in O. Wilde’s The Picture of Dorian Gray.
STORIA DELL’ARTE
Breton e il primo manifesto del Surrealismo
IL RISO (italiano, latino, inglese)
ITALIANO
Il comico, l’umorismo, la satira:
• Leopardi e le Operette morali: un’opera satirica
• Pirandello e la poetica dell’umorismo: l’avvertimento del contrario e il sentimento del contrario
LATINO E GRECO
Ridere dell’imperatore defunto: Seneca, Apocolocyntosis
Le gallerie di personaggi grotteschi nelle satire di Persio e Giovenale, negli epigrammi di Marziale, nel Satyricon di Petronio
L’ironia dissacrante di Luciano
INGLESE
Ch. Dickens’s Hard Times, the Caricature of Mr Gradgrind.
LA SCIENZA E LE MACCHINE (italiano, filosofia, st.arte)
ITALIANO
La scienza, il metodo sperimentale, le macchine:
• Zola e il Romanzo sperimentale
• Il futurismo e le macchine
• Pirandello e le macchine (I quaderni di Serafino Gubbio operatore)
FILOSOFIA
- Comte, La legge dei tre stadi
- Marx, L'alienazione del lavoratore, Manoscritti economico-filosofici
STORIA DELL’ARTE
Il 1851, le Esposizioni universali e la nascita del Modern Design
LE CITTÀ (italiano, latino, greco, inglese, st.arte)
ITALIANO
L’idea di città e il ruolo di singole città nella letteratura dell’Otto e del Novecento:
• La città come emblema di modernità, velocità, industrializzazione (il Futurismo)
• Milano: La Milano dei Romantici («Il Conciliatore», Manzoni, Milano nei Promessi sposi)
Parigi: -La Parigi dei Naturalisti in contrapposizione alla campagna dei Veristi
• - La Parigi di Baudelaire nei Fiori del male
• - La Parigi come culla delle avanguardie (Manifesto del Futurismo)
•
• Roma: - La Roma decadente del Piacere di d’Annunzio
• - La Roma degradata (da «acquasantiera» a «posacenere») del Fu Mattia Pascal di Pirandello
• - La Roma dei ruderi di Sentimento del tempo di Ungaretti
Trieste: - La Trieste borghese dei romanzi di Svevo
• - La Trieste portuale di Saba
LATINO E GRECO
- Alessandria ne Le Siracusane di Teocrito
- Roma, una città infernale: Giovenale e Marziale
INGLESE
• The fictious Coketown in Ch. Dickens’s Hard Times
• Dublin and the moral paralysis in J. Joyce’s Dubliners.
• Dystopian London in G. Orwell’s 1984.
STORIA DELL’ARTE
La città borghese nell’Ottocento
15L’ARTE E GLI ARTISTI (italiano, latino, greco, filosofia, inglese, st.arte)
ITALIANO
Gli artisti riflettono sul ruolo e le funzioni dell’arte.
• Gli obiettivi dell’arte in Manzoni: l’utile, il vero, l’interessante
• Leopardi e la poesia: bisogna creare o distruggere le illusioni?
• Naturalisti e veristi: il romanzo sperimentale e l’indagine scientifica sulla realtà
• Simbolisti, esteti e decadenti: l’arte come privilegio conoscitivo e valore supremo; l’arte come esclusione e maledizione: la
perdita d’aureola
• Le avanguardie e la morte dell’arte: l’arte come riflessione sulla fine del privilegio dell’artista e sull’incapacità dell’arte di
comunicare una verità (Sei personaggi in cerca d’autore)
LATINO E GRECO
La valutazione della poesia nella filosofia di Platone e di Aristotele
La funzione “didattica” della letteratura: imitazione e emulazione nel canone letterario di Quintiliano
FILOSOFIA
Kant, I caratteri del bello,Critica del giudizio
Nietzsche, Ciò che si deve imparare dagli artisti, La gaia scienza
INGLESE
O. Wilde, ‘All art is quite useless’ from The Preface to The Picture of Dorian Gray.
STORIA DELL’ARTE
Il sistema dell’arte dall’Otto al Novecento; manifesti delle Avanguardie storiche
LA METALETTERATURA (italiano, latino, greco, inglese, st.arte)
ITALIANO
La letteratura riflette su se stessa: manifesti, programmi, scritti teorici
• Manzoni, Prefazione al Conte di carmagnola; Lettera a M. Chauvet; Lettera a Cesare D’Azeglio
• Zola, Il romanzo sperimentale
• Verga, Prefazione al ciclo dei vinti
• Rimbaud, La lettera del veggente
• Pascoli, Il fanciullino
• Marinetti, Manifesto del futurismo (1909), Manifesto tecnico (1912)
• Saba, Quel che resta da fare ai poeti
LATINO E GRECO
Poesia:
- La poetica di Callimaco e la sua polemica contro il poema ciclico;
- Il richiamo alla poetica callimachea nell’elegia programmatica di Properzio
- Il manifesto della poesia bucolica (Teocrito)
- Il programma di una poesia “concreta”: Persio, Giovenale, Marziale
Storiografia e biografia:
- Polibio e il metodo di una storiografia pragmatica e universale; l’imparzialità dello storico
- Plutarco e la scelta della biografia
- Luciano: Come si deve scrivere la storia
- Tacito: l’imparzialità dello storico
Oratoria e retorica:
- Il tema della decadenza dell’eloquenza (Petronio, Quintiliano, Dialogus de oratoribus, Anonimo del Sublime)
INGLESE
T. S. Eliot, the impersonality of the artist.
STORIA DELL’ARTE
La linea analitica dell’arte moderna, dal post- Impressionismo alle Avanguardie
16Il Consiglio di Classe, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 62, dall’articolo 2 del decreto MIUR del 18 gennaio 2019 n. 37 e dall’ OM 11 marzo 2019 n. 205, ha proposto
agli studenti i seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione.
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline Materiali
coinvolte
I presupposti storici della Storia- Magna Charta (1215)
Costituzione italiana filosofia Petizione dei diritti (1628)
Habeas corpus (1679)
Bill of rights( 1689)
Dichiarazione d’indipendenza americana (1776)
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
I fondamenti ideologici della Storia- Montesqieu, Lo spirito delle leggi
Costituzione italiana filosofia Rousseau, Il contratto sociale
Locke, Due trattati sul governo
Il contesto storico: la nascita- Storia Manuale in adozione, Occhipinti, L’arco della storia, Einaudi
della Repubblica. Dal referendum
alla Costituente
I principi fondamentali della Storia- Costituzione italiana (articoli 1-12)
Costituzione italiana filosofia
Diritti e doveri dei cittadini Storia- Costituzione italiana (articoli 13-54)
filosofia
L’ordinamento della Repubblica storia Statuto albertino, Costituzione italiana (55-139)
italiana
I presupposti ideologici del Storia- Kant, Scritto per la pace perpetua
processo di integrazione europea filosofia Rossi, Spinelli, Il manifesto di Ventotene
Dai trattati di Roma all’UE:le Storia Zagrebelsky, Questa Repubblica
tappe storiche dell’Europa unita
Gli organismi dell’UE Storia Zagrebelsky, Questa Repubblica
Gli organismi internazionali: dalla Storia Manuale in adozione, Occhipinti, L’arco della storia
Società delle Nazioni all’ONU Zagrebelsky, Questa Repubblica
I diritti umani Storia- La dichiarazione universale di diritti dell’uomo
filosofia
Educazione alla salute Scienze virus, malattie virali, influenza, HIV e AIDS
batteri e antibioticoresistenza
analisi genetica per l'anemia falciforme
glicemia, insulina e DNA ricombinante
17PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Le attività svolte dagli studenti sono riassunte nel prospetto SIDI (aa.ss. 2016-17, 2017-18, 2018-19) allegato al
formato cartaceo di questo Documento. La relativa documentazione è depositata nei fascicoli personali degli
studenti.
Di seguito sono indicati i progetti che gli studenti hanno scelto di presentare nel corso del colloquio, in
considerazione delle competenze specifiche e trasversali acquisite e della significatività dell’esperienza in un' ottica
orientativa.
Studenti Titolo del percorso ente ospitante
n.1 Scegliere i classici oggi Università di Roma ‘Sapienza’
n.2 Casa Scalabrini Casa Scalabrini
n.3 La storia e il web Università degli studi ‘Roma Tre’
n.4 Attività di canto corale Ass. culturale ‘Fisarmonici Romani’
n.5 La repubblica romana del 1849 Università degli studi ‘Roma Tre’
n.6 Casa Scalabrini Casa Scalabrini
n.7 Progetto di astronomia ASI e Liceo ‘Aristofane’
n.8 La repubblica romana del 1849 Università degli studi ‘Roma Tre’ e Liceo Aristofane
n.9 Corso di chimica Yococu’
n.10 Peer education, ‘Pari-Impari’ Università degli studi ‘Roma Tre’
n.11 Il Museo della liberazione di via Tasso Museo storico della liberazione di via Tasso
n.12 La repubblica romana del 1849’ Università degli studi ‘Roma Tre’
n.13 Il Museo della liberazione di via Tasso Museo storico della liberazione di via Tasso
n.14 Casa Scalabrini Casa Scalabrini
n.15 Percorso ‘Banca Intesa Sanpaolo’ Università ‘Luiss’
n.16 La storia e il web’ Università ‘Roma Tre’
n.17 La ricerca sulla prevenzione dei tumori
ISS, Istituto Superiore di Sanità
cutanei’, percorso BC14
n.18 Adotta un monumento Aps Montesacro e Liceo Aristofane
n.19 Museo della liberazione di via Tasso Museo storico della liberazione di via Tasso
n.20 Corso di chimica ‘Yococu’
n.21 Come aiutare il sistema immunitario a
ISS, Istituto Superiore di Sanità
combattere l’HIV
CLIL
Attività e modalità di insegnamento
Nel corso dell’a.s. 2018- 19 la classe ha utilizzato la modalità CLIL per l’insegnamento della disciplina di Storia
dell’arte in lingua inglese, relativamente ad un modulo sulla Tate Modern e l’ordinamento museale.
Title of module: Tate Modern and Modern and Contemporary Art Museums’ Display.
Main topics concerned: Modern and Contemporary Art, Art Collections, Contemporary Architecture, Display’s criteria, Industrial
Archaeology
Level: 5th year (B1)
Il modulo è stato svolto in sei lezioni in aula in orario curricolare e una visita di tre ore alla Galleria Nazionale
d'arte moderna e contemporanea di Roma
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Attività formative rivolte all’intera classe (a.s. 2018-19)
Visite culturali:
• Mostra alle Scuderie del Quirinale “Ovidio. Amori, miti e altre storie” (2 dicembre)
• Galleria Nazionale d’Arte Moderna (nell’ambito del modulo CLIL) (20 marzo)
• Museo Storico della Liberazione di Via Tasso (12 aprile)
18Manifestazioni, conferenze, dibattiti:
• “Notte Nazionale del Liceo Classico” al Liceo Aristofane (10 gennaio)
• “ CostituzionalMente. Il coraggio di pensare con la propria testa” Facoltà di Economia – Università La
sapienza (29 gennaio)
• " Per uno scambio di idee sull'Europa " Incontro delle classi quinte con Mauro Catasta (Consiglio
dell'Unione Europea) al Liceo Aristofane (15 febbraio)
• “ I valori della Resistenza e dell’antifascismo a fondamento dell’Italia repubblicana” - Incontro delle classi
quinte con il prof. Alessandro Portelli e con il prof. Marcello Vigli al Liceo Aristofane (15 aprile)
Viaggio di istruzione in Andalusia (26 febbraio – 2 marzo)
Attività formative individuali o per gruppi di interesse (nel corso del triennio)
• Certamina di lingue classiche (Praemium Aristophaneum, Taciteum, Epistemai, Eschileo, Agon Hellenikos)
• Olimpiadi di matematica
• Olimpiadi di filosofia
• Concorsi letterari (Certamen Tassianum) e di costituzione e cittadinanza (“Rileggiamo l’articolo 3 della
Costituzione”)
• Certificazioni di lingua inglese (B2/C1)
• Progetto Peer education (Coordinamento dell’attività in staff con la FS e tutoraggio)
• Attività di orientamento in ingresso (presentazione del Liceo agli studenti di terza media in occasione di
Open day e sportelli di orientamento)
• Corsi di matematica e logica, biologia e chimica in preparazione ai test per l’accesso alle Facoltà universitarie
• Progetto Prometeo -Istituto Nazionale del Dramma Antico: intervento al seminario “Il tiranno e l’eroe” e
viaggio a Siracusa per assistere alle rappresentazioni classiche (Eracle e Edipo a Colono)
• “Dal cielo al laboratorio, dal laboratorio al cielo” in collaborazione con Osservatorio astronomico di Roma
- Istituto Nazionale di Astrofisica (anche come attività ASL)
• “La scuola adotta un monumento” Didattica dei Beni Culturali (anche come attività ASL)
• “Storia del Novecento” in collaborazione con il Museo Storico della Liberazione di Via Tasso (anche come
attività ASL)
• Viaggio della memoria ad Auschwitz
ORIENTAMENTO IN USCITA
Attività di orientamento rivolta all’intera classe
Somministrazione dei test di orientamento e colloqui individuali (a cura dell’équipe di psicologi coordinata dal
Dott. Andrea Ciucci Giuliani, nell’ambito del progetto di Orientamento del Liceo)
Incontri con i referenti di 1NFORM4 GIOVAN1 – Roma Capitale per la presentazione di programmi europei
relativi a esperienze culturali, formazione, mobilità, cittadinanza attiva e volontariato.
Attività di orientamento individuali
Gli studenti hanno partecipato individualmente o per gruppi di interesse alle iniziative di orientamento promosse
dalle Università “Sapienza” (Facoltà di Economia, Facoltà di Lettere e Filosofia) e Luiss.
Alcuni studenti hanno sostenuto i test d’ingresso presso le seguenti Università:
- Luiss (alunni nr. 4 e nr. 6)
- Cattolica”, Facoltà di Medicina (alunni nr.13, 17 e 21)
- Bocconi (alunno nr. 4)
19SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA
Simulazioni di prima prova
Gli studenti hanno svolto le due simulazioni di prima prova proposte dal MIUR nelle giornate del 19 febbraio e del
26 marzo. Gli esiti delle due prove sono stati soddisfacenti: nella prima simulazione
3 elaborati sono risultati insufficienti, 3 elaborati si sono complessivamente attestati sulla sufficienza, 4 elaborati
sono risultati discreti, 9 buoni e uno eccellente; nella seconda simulazione un elaborato è risultato lievemente
insufficiente, uno si è attestato sulla sufficienza, 7 sono risultati discreti, 10 buoni e uno eccellente.
Simulazioni di seconda prova
La classe ha svolto soltanto la seconda simulazione nazionale del 2 aprile, a causa della concomitanza del viaggio di
istruzione in Andalusia con la prima simulazione del 28 febbraio (il testo di questa simulazione è stato proposto
nei giorni successivi agli studenti come esercitazione).
La simulazione svolta in classe il 2 aprile, per una durata di sei ore, è stata affrontata con serietà e impegno dagli
studenti, che l’hanno trovata in linea con le proprie competenze di analisi e traduzione, riportando tutti, tranne in
un caso, valutazioni positive.
In relazione al secondo quesito si è osservato che alcuni alunni hanno effettuato l’analisi linguistico-stilistica
prevalentemente sul brano tradotto dal latino; molti studenti hanno trovato insufficiente l’estensione massima di
12 righe per rispondere adeguatamente al secondo e terzo quesito .
GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE DELLE
SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO
SCOLASTICO
Nelle pagine che seguono si riportano le griglie elaborate dai Dipartimenti di Lettere e di Latino e Greco, utilizzate
dal Consiglio di classe per la correzione delle simulazioni di prima e seconda prova; si acclude, inoltre, una
proposta di griglia per la valutazione del colloquio, elaborata da un gruppo di lavoro di docenti dei suddetti
Dipartimenti, ma non testata perché per il colloquio non si sono svolte simulazioni.
20Liceo Classico e Linguistico Aristofane (a.s. 2018-19)
Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario Studente /essa____________________________________________
Ambiti degli indicatori Indicatori Indicatori specifici Descrittori Punti
generali (40 punti)
(60 punti)
Rispetto dei vincoli posti nella consegna Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:
(ad esempio indicazioni di massima circa - non ne rispetta alcuno (1-2)
ADEGUATEZZA la lunghezza del testo – se presenti – o - li rispetta in minima parte (3-4)
indicazioni circa la forma parafrasata o - li rispetta sufficientemente (5-6)
(max 10 punti) sintetica della rielaborazione) - li rispetta quasi tutti (7-8)
Punti 10 - li rispetta completamente (9-10)
- Ampiezza e precisione L’elaborato evidenzia:
delle conoscenze e dei - minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (1-2)
riferimenti culturali - scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (3-4)
- Espressione di giudizi - sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (5-6)
critici e valutazioni - adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (7-8)
personali - buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (9-10)
CARATTERISTICHE Punti 10
DEL CONTENUTO - Capacità di comprendere il testo nel suo L’elaborato evidenzia:
senso complessivo e nei suoi snodi - diffusi errori di comprensione, analisi e interpretazione (1-6)
(max 40 punti) tematici e stilistici - una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori di analisi e interpretazione (7-12)
- Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, - una sufficiente comprensione, pur con la presenza di qualche inesattezza o superficialità di analisi e
stilistica e retorica (se richiesta) interpretazione (13-18)
- Interpretazione corretta e articolata del - una comprensione adeguata e un’analisi interpretazione completa e precisa (19-24)
testo - una piena comprensione e un’analisi e interpretazione ricca e approfondita (25-30)
Punti 30
- Ideazione, pianificazione e L’elaborato evidenzia:
organizzazione del testo - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (1-4)
ORGANIZZAZIONE - Coesione e coerenza - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (5-8)
testuale
DEL TESTO Punti 20
- una sufficiente organizzazione del discorso e un’elementare connessione tra le idee (9-12)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (13-16)
(max 20 punti)
- un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una coerente e appropriata connessione tra le
idee (17-20)
- Ricchezza e padronanza L’elaborato evidenzia:
lessicale - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (1-3)
LESSICO E STILE Punti 15 - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-6)
(max 15 punti) - un lessico semplice ma adeguato (7-9)
- un lessico specifico e appropriato (10-12)
- un lessico specifico, vario ed efficace (13-15)
- Correttezza grammaticale L’elaborato evidenzia:
CORRETTEZZA (ortografia, morfologia, - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (1-3)
sintassi); uso corretto ed - alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-6)
ORTOGRAFICA E efficace della punteggiatura - un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (7-9)
MORFOSINTATTICA Punti 15 - una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (10-12)
(max 15 punti) - una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (13-
15)
OSSERVAZIONI
21Liceo Classico e Linguistico Aristofane (a.s. 2018-19)
Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo Studente /essa____________________________________________
Ambiti indicatori Indicatori Indicatori Descrittori Punti
generali specifici
(60 punti) (40 punti)
Individuazione corretta Riguardo alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione di tesi e argomentazioni, l’elaborato:
della tesi e delle - non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del testo (1-4)
ADEGUATEZZA argomentazioni nel - rispetta in minima parte le consegne e compie errori nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (5-8)
testo proposto - rispetta sufficientemente le consegne e individua abbastanza correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (9-12)
(max 20 punti) Punti 20 - rispetta adeguatamente le consegne e individua correttamente la tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (13-16)
- rispetta completamente le consegne e individua con sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni del testo (17-20)
- Ampiezza e L’elaborato evidenzia:
precisione delle - minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (1-2)
conoscenze e dei - scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (3-4)
riferimenti culturali - sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (5-6)
- Espressione di giudizi - adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (7-8)
critici e valutazioni
CARATTERISTICHE personali
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali (9-10)
DEL CONTENUTO Punti 10
(max 20 punti) Correttezza e L’elaborato evidenzia:
congruenza dei - riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (1-2)
riferimenti culturali - una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (3-4)
utilizzati per sostenere - un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche inesattezza e incongruenza (5-6)
l’argomentazione - una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (7-8)
Punti 10 - un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena correttezza e pertinenza (9-10)
- Ideazione, L’elaborato evidenzia:
pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (1-4)
organizzazione del - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (5-8)
testo - una sufficiente organizzazione del discorso e un’elementare connessione tra le idee (19-12)
- Coesione e coerenza - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (13-16)
ORGANIZZAZIONE testuale - un’efficace e chiara organizzazione del discorso e una coerente e appropriata connessione tra le idee (18-20)
Punti 20
DEL TESTO Capacità di sostenere L’elaborato evidenzia:
(max 30 punti) con coerenza il - un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (1-2)
percorso ragionativo - un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (3-4)
adottando connettivi - un ragionamento sufficientemente coerente, con connettivi semplici e abbastanza pertinenti (5-6)
pertinenti - un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre pertinenti (7-8)
Punti 10 - un ragionamento pienamente coerente, con scelta varia e del tutto pertinente dei connettivi (9-10)
- Ricchezza e L’elaborato evidenzia:
padronanza lessicale - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (1-3)
LESSICO E STILE Punti 15 - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (4-6)
(max 15 punti) - un lessico semplice ma adeguato (7-9)
- un lessico specifico e appropriato (10-12)
- un lessico specifico, vario ed efficace (13-15)
- Correttezza L’elaborato evidenzia:
CORRETTEZZA grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (1-3)
(ortografia, morfologia, - alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (4-6)
ORTOGRAFICA E sintassi); uso corretto - un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (7-9)
MORFOSINTATTICA ed efficace della - una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (10-12)
(max 15 punti) punteggiatura - una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (13-15)
Punti 15
OSSERVAZIONI
22Puoi anche leggere