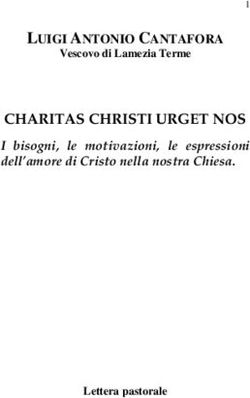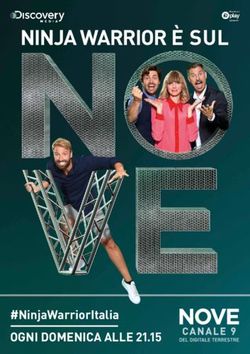CHE STA ACCADENDO IN AMERICA - LATINA? di W. I. Robinson
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CHE STA ACCADENDO IN AMERICA
LATINA? di W. I. Robinson*
È opportuno ogni tanto
dare un’occhiata non
distratta a quanto
accade in America
latina, dove una destra
rampante è tornata al
potere ma dove le
proteste popolari
stanno in compenso
dilagando (Haiti, Honduras, Cile, Ecuador, Colombia …). Un
caso un po’ più complesso quello boliviano, dove una destra
perversa ha approfittato di alcuni errori madornali
dell’ultimo paese dove esisteva l’ultimo dei governi della
‘decade progressista’.
Opportuno non solo per ragioni di solidarietà ma anche per
alcune similitudini di situazione con L’Europa: lo
scavalcamento dei partiti di sinistra da parte dei movimenti
in lotta (decisamente in numero minore in Europa rispetto
all’A.L.) che hanno assunto in prima persona l’iniziativa e la
crescente brutalità della repressione. Mi pare che in questa
complessivamente condivisibile analisi del sociologo
statunitense W.I. Robinson questo richiamo alla nostra
situazione sia ben presente, per cui mi fa piacere segnalarla.
Aldo Zanchetta
NUVOLONI NERI SULL’AMERICA LATINA
UNA PANORAMICA GENERALE
William I. Robinson*
Le lotte popolari contro un risorgente neoliberismo e leaggressioni dell’ultra-destra che negli ultimi mesi hanno preso d’assalto l’America Latina si presentano alla Sinistra globale con un peculiare paradosso: esse avvengono in un momento in cui la Sinistra istituzionale e partitica ha perso l’egemonia che aveva precedentemente conquistato e che ora si trova logorata. Qualsiasi tentativo di spiegare questo paradosso deve inquadrare l’attuale ribellione popolare nel contesto più ampio delle dinamiche politiche dell’espansione capitalista globale e delle crisi nella regione degli anni recenti. Nelle attuali circostanze il capitalismo globale affronta una crisi organica che è ad un tempo strutturale e politica. Dal punto di vista strutturale il sistema si trova in una crisi di sovra-accumulazione e in tutto il mondo si è indirizzato verso un nuovo ciclo di espansione violenta e molto spesso militarizzata, alla ricerca di nuove opportunità di impiego dell’eccedenza di capitale accumulata e prevenire la stagnazione. Politicamente il sistema si trova di fronte a una decomposizione dell’egemonia capitalista e una crisi di legittimità dello Stato. Mentre il malcontento popolare va estendendosi, i gruppi dominanti sono ricorsi in tutto il mondo a modi di dominazione sempre più coercitivi e repressivi per contenere questo malcontento e ad un tempo per aprire con la forza nuove opportunità di accumulazione mediante l’intensificazione delle politiche neoliberiste. Questa duplice crisi è visibile con totale chiarezza in America Latina. Il colpo di Stato del novembre scorso in Bolivia e la tenace resistenza alla conquista fascista del potere, la sollevazione all’inizio ottobre in Ecuador contro la restaurazione liberista, le ribellioni verificatesi a Haiti e in Cile (quest’ultimo vera culla del capitalismo), e ora in Colombia, il ritorno al potere dei Peronisti in Argentina seguito poche settimane appresso dalla sconfitta del Frente Amplio in Uruguay, convergono tutti, assieme ad altri avvenimenti recenti, verso una stagione di grande movimento e incertezza nella regione. Però gli sconvolgimenti attuali devono essere analizzati nel contesto delle dinamiche
politiche della globalizzazione capitalista. Il post-mortem della ‘Marea Rosata’? L’America Latina dalla decade degli anni ’80 in poi si è trovata coinvolta nella globalizzazione capitalista, processo che ha causato una grande trasformazione della sua economia politica e della sua trasformazione sociale. E’ nata una nuova generazione di elite e di capitalisti orientati transnazionalmente a causa della sconfitta dei movimenti rivoluzionari nelle decadi degli anni ’60 e ’70. Questi gruppi transnazionali dominanti condussero la regione verso la nuova epoca globale, caratterizzata dall’accumulazione come una serra calda, la speculazione finanziaria, la valorizzazione creditizia, internet, le comunità chiuse, le catene del cibo spazzatura diffuse ovunque, e i centri commerciali e i mega- negozi che dominano i mercati locali nelle nascenti mega- città. Queste elite e questi capitalisti transnazionali nella decade dei ’90 hanno forgiato un’egemonia neoliberista realizzando un vastissimo programma di privatizzazioni, liberalizzazioni, deregolamentazioni e austerità. Pertanto, la globalizzazione capitalista finì per aggravare la povertà e la disuguaglianza, facendo spostare decine di milioni dalle classi popolari e generando vastissimo sotto-impiego e disoccupazione. Gli impoverimenti scatenarono un’ondata di emigrazioni da paese a paese e nuove ondate di mobilitazione di massa fra coloro che erano rimasti. I governi di sinistra o della cosiddetta ‘Marea Rosata’ giunsero al potere nei primi anni del nuovo secolo sulla spinta della ribellione delle masse contro questo mostro della globalizzazione capitalista. Il giro verso Sinistra in America Latina suscitò grandi attese e ispirò le lotte popolari nel mondo. L’appello che Hugo Chávez fece per un Socialismo del XXI secolo risvegliò le speranze che la regione avrebbe indicato il percorso verso l’alternativa a un capitalismo globale. I governi della Marea Rosata sfidarono e fecero anche retrocedere gli aspetti più noti del programma neoliberista, ridistribuirono la ricchezza verso il basso e ridussero la povertà e la penuria. Tuttavia, gli sforzi degli Stati e dei
movimenti sociali per completare le trasformazioni si scontrarono con l’enorme potere strutturale del capitale transnazionale, e soprattutto dei mercati finanziari globali. Questo potere strutturale spinse gli Stati della Marea Rosata verso un accordo con questi mercati. Lasciando da parte la retorica, i governi della Marea Rosata basarono la loro strategia sulla forte espansione della produzione di materie prime in collaborazione con i contingenti nazionali e locali della classe capitalista transnazionale. Ad eccezione del Venezuela nel periodo di auge della Rivoluzione Bolivariana, si evidenziò l’assenza di qualunque cambiamento sostanziale nelle relazioni fra classi e nella proprietà, nonostante i cambiamenti generati nei blocchi di potere politico, un discorso a favore delle classi popolari e una espansione dei programmi di benestare sociale finanziati dalle imposte sulle industrie estrattive delle corporation. L’accrescimento delle attività minerarie e dell’agroindustria transnazionale di loro proprietà ebbe come risultato una maggiore concentrazione delle terre e del capitale e rafforzò il potere strutturale dei mercati globali sugli Stati con orientamento a sinistra. Come risultato, i paesi della Marea Rosata si trovarono sempre più integrati nei circuiti transnazionali del capitalismo globale e dipendenti dai mercati globali delle commodity e del capitale. Le masse popolari reclamavano trasformazioni più sostanziali. Il giro verso la Sinistra aprì di fatto spazi perché queste masse facessero avanzare le loro lotte. Tuttavia, nel loro impegno per attrarre l’investimento delle corporation transnazionali e espandere l’accumulazione estrattivista, gli Stati compressero molte volte le richieste di quelli in basso verso maggiori trasformazioni. Questi Stati smobilitarono i movimenti sociali, risucchiandone i loro dirigenti nel governo e nello Stato capitalista e subordinarono i movimenti delle masse all’elettoralismo dei partiti della Sinistra. Data
l’assenza di più ampie trasformazioni strutturali che potessero rispondere alle cause profonde della povertà e della disuguaglianza, i programmi sociali furono subordinati ai viavai dei mercati globali sui quali gli stati della Marea Rosata non esercitavano alcun controllo. Allorché a partire dal 2008 esplose la crisi finanziaria globale, questi Stati cozzarono con i limiti di una riforma redistributiva ingabbiata nella logica del capitalismo globale. L’estrema dipendenza dei paesi della Marea Rosata dalle esportazioni di materie prime, allorché i mercati globali delle commodity nel 2012 collassarono, li immerse nell’agitazione economica. Questi paesi ebbero alti livelli di crescita finché l’economia globale proseguì il suo ritmo di espansione e finché i prezzi delle commodity restarono elevati grazie al vorace appetito della Cina verso le esportazioni delle materie prime. La recessione economica erose la capacità dei governi di sostenere i programmi sociali, indicendoli a negoziare concessioni e austerità con le elite finanziarie e le agenzie multilaterali, come è accaduto in Brasile, Argentina, Ecuador e Nicaragua, oltre ad altri paesi. Le tensioni che ne derivarono fecero crescere le proteste e aprirono lo spazio al risorgere della Destra. Sebbene non si possano fare affermazioni generalizzate applicandole uniformemente ai vari paesi, in tutto questo ci sono gli elementi essenziali per analizzare il quadro del recente colpo di Stato in Bolivia, la destituzione del Partito del Lavoro in Brasile e degli altri rovesci della Marea Rosata. Il ritorno della destra Le classi dominanti tradizionali all’inizio del processo della Marea Rosata si videro obbligate a cercare un modus vivendi con i governi di sinistra dato il bilancio delle forze sociali e di classe. Però appena l’economia e i sommovimenti politici offrirono alla Destra uno spazio di manovra, questa passò all’offensiva, spesso violenta, al fine di recuperare il potere politico diretto. La svolta costituzionale e extra-
costituzionale verso Destra ebbe inizio nel 2009 con il colpo di Stato in Honduras, seguito nel 2012 dal golpe suave in Paraguay contro il governo di sinistra di Fernando Lugo; la sconfitta elettorale dei peronisti in Argentina nel 2015; il colpo di Stato parlamentare in Brasile contro il Partito dei Lavoratori nel 2016; il ritorno della destra in Cile con l’elezione nel 2017 del Presidente Sebastián Piñera e la sua coalizione Chile Vamos in Cile nel 2017, l’elezione nel 2018 in Colombia del presidente di estrema destra Iván Duque, che non è altro che la faccia rappresentativa del progetto fascista dell’uribismo, e la sconfitta elettorale all’inizio del 2019 del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional in El Salvador (L’elezione di Andrés Manuel López Obrador e del suo partito Morena in Messico costituisce l’eccezione a questa virata verso destra). Questa forte virata a destra ha comportato un’ondata di repressione in tutta la regione e una mobilitazione dei partiti e delle organizzazioni imprenditoriali dell’estrema- destra, culminando più recentemente nel colpo di Stato a ottobre in Bolivia, per cui la regione sembra tornare all’epoca delle dittature e dei regimi autoritari. L’America Latina torna ad essere un focolaio di violenza statale e privata incentrata sulla repressione della rivolta popolare e un’apertura del continente verso il saccheggio corporativo. La Destra nel suo impegno nel consolidare e espandere il potere transnazionale delle corporation si orienta verso il razzismo, l’autoritarismo e il militarismo. Da questo punto di vista la regione è lo specchio di dove si sta dirigendo il mondo. Se il continente è emblematico dello Stato di polizia globale, lo è anche dell’ondata di resistenza dal basso attraverso il mondo. Ma la sorte era segnata già prima che la destra recuperasse il potere politico diretto. Gli eserciti latinoamericani negli ultimi anni sono accresciuti rapidamente allo stesso ritmo della nuova ondata di espansione corporativa e finanziaria transnazionale nella regione. Spazi territoriali che fino a pochissimo tempo fa godevano ancora di un certo spazio di autonomia, come ad es. gli altipiani indigeni del Guatemala e del Perù, aree dell’Amazzonia e della costa pacifica della
Colombia, sono in fase di invasione violenta e le loro abbondanti risorse naturali e di forza lavoro vengono messi a disposizione del capitale transnazionale. In accordo con il rapporto “Security for sale” (Sicurezza in vendita), pubblicato nel 1918 dall’ Inter-American Dialogue, centro di ricerca situato a Washington, D.C., nel 2017 in America Latina erano presenti oltre 16.000 società private che offrivano servizi militari e di sicurezza che impiegavano 2,4 milioni di persone che frequentemente collaborano con le forze militari e di polizia dello Stato. Praticamente si cancella di fatto la distinzione fra personale militare e polizia in servizio e in pensione da un lato, e dall’altro i dipendenti di queste società private, come ha concluso l’informativa, poiché esiste “una rete interconnessa fra i militari in servizio, i militari in pensione, gli agenti della sicurezza privata, le elite imprenditoriali e i funzionari del governo”. Il numero dei militari è raddoppiato in Brasile, Bolivia, Messico, e negli anni recenti in Venezuela, mentre l’esercito colombiano si è quadruplicato e le forze armate nel resto della regione sono aumentate in media del 35%. I militari sono stati dispiegati nelle mega-città della regione e molte volte collaborano con i cupi squadroni della morte nella ‘pulizia sociale’ dei poveri e nella repressione della dissidenza politica. La destra ora si impegna a utilizzare il potere politico diretto che ha recuperato per imporre con violenza la piena restaurazione del neoliberismo come parte dell’espansione militarizzata del saccheggio delle corporation transnazionali. La scintilla che ha fatto esplodere le più recenti proteste di massa è stato un nuovo giro di misure neoliberiste. La sollevazione in Nicaragua fra l’aprile e l’agosto del 2018 è stata la risposta alla decisione del governo Ortega di imporre riforme al sistema pensionistico. In Ecuador indigeni, contadini e lavoratori si sono sollevati nell’ottobre del 2019 contro gli accordi negoziati dal governo con l’FMI per eliminare i sussidi ai combustibili. La ribellione in Cile contro la struttura totalmente neoliberista si è scatenata per
la decisione del governo di aumentare le tariffe del trasporto pubblico. In Argentina il fattore che finalmente l’ottobre scorso ha portato alla sconfitta elettorale il governo Macri è stato il suo forte programma neoliberista. E in Colombia le proteste di massa sono state originate dalla promulgazione da parte del governo di nuove misure di austerità. L’egemonia contesa Le crisi strutturali del capitalismo mondiale costituiscono storicamente momenti in cui si producono prolungati disordini sociali e più grandi cambiamenti, quali abbiamo visto recentemente in America Latina. A livello mondiale la spirale della crisi dell’egemonia sembra sfociare in una crisi generale del dominio capitalista. A prima vista, questa affermazione appare come contro-intuitiva poiché la classe capitalista transnazionale e i suoi agenti sono passati ovunque all’offensiva contro le classi popolari. Tuttavia, la rinascita aggressiva della destra, in America Latina e nel mondo, è una risposta alla crisi che è poggiata su un terreno instabile. A livello strutturale, le crisi sono dovute appunto all’esistenza di ostacoli alla continua accumulazione del capitale, e pertanto alla tendenza alla stagnazione e al basso livello degli utili. Data una disuguaglianza senza precedenti a livello mondiale, il mercato globale non può assorbire la crescente produzione dell’economia globale, che sta toccando i limiti della sua espansione. La crescita economica in anni recenti è stata basata su un consumo insostenibile basato sull’indebitamento, la frenetica speculazione finanziaria nel casinò globale, e la militarizzazione promossa dallo Stato –cosa che definisco accumulazione militarizzata- mentre il mondo entra in una economia globale di guerra e le tensioni internazionali si intensificano. Mentre l’economia globale è prossima alla recessione,
l’economia latinoamericana è già caduta nella recessione nel 2015 che prosegue fino ad oggi affrontando la stagnazione (perfino in Bolivia, paese che ha registrato gli indici più alti di crescita negli ultimi anni, il tasso della crescita iniziò a contrarsi, cosa che obbligò il governo del MAS a ricorrere alle riserve valutarie). La classe capitalista transnazionale e le sue componenti locali ora tendono a trasferire il peso della crisi sui settori popolari tramite una rinnovata austerità neoliberista nel suo affanno per ristabilire la redditività capitalista. Ma è poco probabile che la destra abbia successo. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro affronta una caduta vertiginosa nei sondaggi, mentre il neoliberista Maurizio Macri ha subito un rovescio nelle recenti elezioni e i governi di Ecuador, Cile e Colombia hanno dovuto fare marcia indietro nelle loro misure di austerità. L’incapacità della destra a stabilizzare il proprio progetto avviene in momenti in cui la Sinistra istituzionale/partitica ha perso la maggior parte del potere e l’influenza che aveva guadagnato. Vi è un evidente sfasamento in America Latina –sintomatico di una situazione della Sinistra a livello mondiale- fra i movimenti di massa che attualmente fioriscono e una sinistra partitica che ha perso la capacità di mediare con un proprio progetto realistico fra le masse e lo Stato. Lo scenario più probabile è un pareggio momentaneo, mentre i nuvoloni neri si addensano. Sebbene sia il momento della solidarietà con le masse delle/dei latinoamericani che sono in piena lotta contro la presa di potere della destra, deve essere anche un momento di riflessione sulle lezioni che l’America Latina offre alla sinistra globale. La Marea rosata –dobbiamo ricordarlo- giunse al potere non per il crollo dello Stato capitalista ma per la via costituzionale, vale a dire tramite processi elettorali grazie ai quali i governi di sinistra assunsero la gestione degli Stati capitalisti. Semplicemente, schiacciare lo Stato
capitalista non era in agenda. Non basta ricordare l’esortazione di Marx che le classi lavoratrici non possono limitarsi a impadronirsi dello Stato capitalista e gestirlo per i propri scopi. Dato il violento ritorno dell’estrema Destra, non sarebbe difficile cadere nella tentazione di considerare come un punto di possibile discussione se i governi della sinistra avrebbero potuto fare di più per realizzare maggiori trasformazioni strutturali anche quando non esistesse la possibilità di rompere col capitalismo mondiale. Ma sono lezioni fondamentali per la sinistra globale. Si tratta della capacità dei movimenti sociali autonomi di massa di obbligare dal basso gli Stati a intraprendere tali trasformazioni. In alternativa, questo comporta la necessità di ripensare la relazione triangolare fra gli Stati, i partiti della Sinistra e i movimenti sociali di massa. Il modello di governance della sinistra basato sull’assorbimento dei movimenti sociali e subordinare l’agenda popolare all’elettoralismo e alle esigenze della stabilità capitalista ci conduce in un vicolo cieco – o peggio ci porta al ritorno della Destra. È solo la mobilitazione di massa autonoma dal basso che può imporre un contrappeso al controllo esercitato dal capitale transnazionale e dal mercato globale dall’alto sugli Stati capitalisti in America Latina, che essi siano governati dalla Sinistra o dalla Destra. Qualunque nuovo progetto di sinistra in America Latina, come anche altrove nel mondo, dovrà vedersela con il problema delle elezioni e dello Stato capitalista. Abbiamo imparato che la subordinazione dell’agenda popolare a vincere elezioni ci porta al fallimento, anche quando dobbiamo partecipare a processi elettorali, quando ciò sia possibile, e anche considerando che l’agone elettorale può essere uno spazio strategico. Dal mio punto di vista, affrontare l’attuale assalto della Destra passa urgentemente attraverso il rinnovamento di un progetto rivoluzionario e un piano per la
rifondazione dello Stato. Le recenti esperienze del partito
Syriza in Grecia e dei governi della Marea Rosata in America
Latina, come i partiti social-democratici che in altre parti
del mondo arrivarono al potere negli ultimi anni del XX
secolo, ci insegnano che qualunque forza di sinistra, una
volta salita al governo, si vede obbligata ad amministrare lo
Stato capitalista e le sue crisi. Questi governi –nonostante
il loro colore di sinistra- si vedono spinti a difendere tale
Stato e la sua dipendenza dal capitale transnazionale per la
sua riproduzione, ciò che li porta in conflitto con le stesse
classi popolari e gli stessi movimenti sociali che li hanno
portati al potere.
*William I. Robinson. Professore di Sociologia, Università
della California di Santa Barbara.
** Fonte: https://twitter.com › w_i_robinson
*** Traduzione a cura di camminar domandando
FOIBE E IPOCRISIA
NAZIONALISTA di Sandokan
Da quando, con la legge
30 marzo 2004 n. 92, è
stato istituito, sulla
falsa riga del “Giorno
della memoria”, quello
del “ricordo” — per
«conservare e rinnovare
la memoria della
tragedia degli italiani
e di tutte le vittime
delle foibe, dell’esododalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale» — abbiamo parlato di foibe alcune volte su questo blog. La prima il 16 febbraio 2010. L’ultima l’anno scorso. Abbiamo detto l’essenziale, ma data l’insopportabile ipocrisia nazionalistica — gli stessi che inneggiano all’orgoglio italiota sono gli stessi che svendono la sovranità italiana e inneggiano all’Unione europea— sento che debbo tornarci su. Politici e pennivendoli di regime accusano chiunque osi sfidare la vulgata pseudo-patriottica sulle foibe, di “negazionismo” — ancora una volta sulla falsa riga della shoah. A scanso di equivoci: non nego un bel niente. I partigiani titoisti iugoslavi effettivamente gettarono nelle foibe, in una prima ondata nel 1943 e poi nella seconda del 1945, i corpi di centinaia di italiani precedentemente fucilati. Fu una barbarie? Sì, lo fu. MA QUI CERTE “COSETTE” VANNO DETTE… Come gli storici di ogni tendenza hanno confermato, si trattava nel 90% dei casi di italiani che svolgevano funzioni apicali (militari e civili) nell’occupazione italiana e (dopo il 1943) nazi-fascista, e che furono direttamente e/o indirettamente responsabili di eccidi di massa ai danni delle popolazioni slave. Eccidi, crimini e repressione sistematici, che vennero avanti sin dalla fine della prima guerra mondiale.
Dopo la Grande Guerra, si ritrovarono entro i confini del Regno d’Italia 490mila tra croati e sloveni, ed anche serbi abitanti in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Lo Stato italiano, lungi dal rispettare i loro diritti, diede avvio ad una politica imperialistica di assimilazione forzata di questi gruppi slavi. Con l’avvento al potere del partito nazionale fascista, questa politica di assimilazione divenne brutale, anzi criminale. – tutti gli slavi vennero esclusi dagli impegni pubblici, assegnato solo ad italiani; – Con l’adozione della riforma scolastica gentile (1 ottobre 1923) fu abolito nelle scuole l’insegnamento delle lingue croata e slovena. Tutte le scuole slovene e croate vennero chiuse, e la lingua italiana la sola ammessa; – furono imposti (Decreto regio del 29 marzo 1923) nomi italiani a tutte le centinaia di località, comprese quelle abitate solo da slavi; – con Decreto regio del 7 aprile 1926 vennero imposti cognomi italiani a decine di migliaia di croati e sloveni, – con legge del 1928 a parroci e uffici anagrafici venne fatto divieto di iscrivere nomi slavi nei registri delle nascite. Dite un po’? voi non vi sareste incazzati per questa “bonifica etnica”? Io sì, e se fossi stato sloveno o croato, da patriota, avrei raggiunto la resistenza, che infatti subito sorse. E se provo vergogna per quello che l’Italia fece allora, sono forse un “negazionista”?
Non è finita qui… Con l’invasione della Iugoslavia (aprile 1941) da parte degli eserciti tedesco e italiano, il Paese venne smembrato e i suoi territori anessi alla Germania e all’Italia. I crimini compiuti da occupanti fascisti e nazisti furono inenarrabili. Furono compiuti (e ampiamente documentati) dalle truppe fasciste e naziste svariati massacri per debellare la resistenza titoista. «Si procede ad arresti, ad incendi (…) fucilazioni in massa fatte a casaccio e incendi dei paesi fatti solo per il solo gusto di distruggere (…) la frase “gli italiani sono diventati peggiori dei tedeschi” che si sente mormorare dappertutto, compendia i sentimenti degli sloveni verso di noi». [1] Se foste stati sloveni o croati voi che avreste fatto? Contro la Resistenza iugoslava le autorità fasciste si diedero alla deportazione sistematica nei campi di concentramento e a ulteriori massacri indiscriminati: «. . . Si informano le popolazioni dei territori annessi che con provvedimento odierno sono stati internati i componenti delle suddette famiglie, sono state rase al suolo le loro case, confiscati i beni e fucilati 20 componenti di dette famiglie estratti a sorte, per rappresaglia contro gli atti criminali da parte dei ribelli che turbano le laboriose popolazioni di questi territori . . .» . [2]
Il 12 luglio 1942, nel
villaggio di Podhum, per
rappresaglia furono fucilati da
reparti militari italiani, su
ordine del Prefetto della
Provincia di Fiume Temistocle
Testa, tutti gli uomini del
villaggio di età compresa tra i
16 e i 64 anni. Il resto della
popolazione fu deportata nei
campi di internamento italiani
e le abitazioni furono
incendiate.
Cartina a sinistra: Dopo l’8 settembre del 1943 i nazisti
prendono il controllo della Venezia Giulia e dell’Istria,
sottraendolo alla Repubblica Sociale Italiana
Dopo l’8 settembre, quando i tedeschi rimpiazzarono i
fascisti, le cose non migliorarono. L’esercito nazista,
sostenuto dalle autorità locali italiane e dagli Ustascia
croati, continuò la politica di sterminio già adottata verso
le altre popolazioni slave sotto occupazioni. Vale la pena
ricordare che rispetto agli abitanti, i popoli iugoslavi
subirono nella seconda guerra mondiale le maggiori perdite in
vite umane (1milione e 200mila).
Non voglio giustificare le rappresaglie compiute dalla
Resistenza iugoslava (dopo quelle del 1943, quelle dopo la
ritirata dei nazisti della fine del 1944), ma esse vanno
contestualizzate, altrimenti si fa demagogia da quattro soldi.
Una demagogia che serve ai satrapi dell’Unione europea per
salvarsi la faccia dandosi una patina di retorico patriottismo
— si inneggia all’italianità dei dalmati e degli istriani
mentre si smantella la sovranità nazionale. Per la cronaca:
l’esercito partigiano iugoslavo (di cui facevano parte anche
italiani, vedi Porzus), una volta occupati la Venezia Giulia,
Trieste, l’Istria ecc., eliminò anche diversi esponenti delCLN italiano. C’era in queste ritorsioni un’odio nazionalistico? Si, c’era, ma c’era anche quella che gli storici hanno chiamato “vendetta sociale e di classe”, visto che contrariamente a Togliatti, Tito congiungeva lotta di liberazione nazionale e passaggio al socialismo. Inutile continuare. Il tutto serve a dire che un Paese serio e rispettoso davvero dei valori della pace e della fratellanza tra i popoli, se proprio deve istituire il “giorno del ricordo”, non dovrebbe ricordare solo i propri morti (e dire la verità su chi fossero e cosa avessero fatto) ma pure quelli altrui, quelli caduti proprio per mano fascista italiana. PS Mi chiederete: e dell’esodo degli italiani che hai da dire? Segnalo soltanto che esso ebbe enormi proporzioni (una minoranza restò entro i confini della nuova Iugoslavia) solo dopo il febbraio 1947, come conseguenza del “Trattato di Parigi” fra l’Italia e le potenze alleate. Il Trattato incluse non solo la rinuncia ai possedimenti coloniali in Africa ma anche lo scambio tra Italia e Iugoslavia di diverse aree. Scambio provvisoriamente sancito dal “Memorandum di Londra” del 1954 [vedi Cartina a destra: zona A amministrata dagli Alleati e quella B dalla Iugoslavia], definitivamente formalizzato dal “Trattato di Osimo” del novembre 1975. Le responsabilità per questo esodo non sono solo delle autorità titine, ma pure di quelle italiane le quali a Parigi
accettarono la clausola che dava la facoltà allo Stato, al quale il territorio era ceduto, di esigere il trasferimento in Italia dei cittadini che avessero esercitato questa opzione. Domandatevi: Non è forse vero che esso incoraggiò l’esodo? Perché il governo italiano accettò questa clausola e avallò l’esodo quando poteva impugnare un’altra clausola del “Trattato di Parigi” che stabiliva il pieno rispetto dei diritti delle minoranze?NOTE [1] Riportato da due riservatissime personali del 30 luglio e del 31 agosto 1942, indirizzate all’Alto Commissario per la Provincia di Lubiana Emilio Grazioli, dal Commissario Civile del Distretto di Longanatico (in sloveno: Logatec) Umberto Rosin. [2] Dalla copia del proclama prot. 2796, emesso in data 30 maggio 1942 dal Prefetto della Provincia di Fiume Temistocle Testa, riportata a pagina 327 del libro di Boris Gombač, Atlante storico dell’Adriatico orientale. DOPO LA BREXIT, LA RUSSIA COME ALTERNATIVA? di Manolo Monereo
Manolo Monereo Enric Juliana è un giornalista unico e, per molti versi, diverso. Il suo stile è quello di collocare storicamente il fatto, i dati, le notizie; cercando di andare oltre il giorno per giorno, inquadrando ciò che accade in un contesto più ampio. Qualche giorno fa ha collegato la Brexit alla geopolitica assumendo come riferimento Halford Mackinder. Non ha detto molto di più. Mi aspettavo che sviluppasse questa idea, ma non l’ha fatto. Quindi tiro questo filo sapendo che, sicuramente, il noto giornalista catalano non sarà d’accordo con molte delle cose che scrivo. Sir Halford Mackinder (1861-1947) fu un notevole geografo britannico e un politico molto influente. Questa doppia condizione deve essere sempre presa in considerazione; egli ha cercato di conoscere la realtà, sempre al servizio degli interessi strategici del suo paese. Sebbene non abbia mai usato il termine geopolitica, ha influenzato in modo decisivo questa disciplina che alcuni considerano la scienza e altri un’arte politica dello Stato. Nel 1904 pubblicò una noto saggio dal titolo “Il perno geografico della storia”. Nel 1919 sviluppò queste idee in un libro molto importante ai suoi tempi, chiamato “Idee e realtà democratica”. Non è facile spiegare in un articolo come questo la complessità, la profondità e le ipotesi di una concezione geografica che ha segnato, per più di un secolo, i dibattiti strategici e politici di un mondo in perpetuo cambiamento. Forse questo è
ciò che sorprende di più. Il “problematico Mackinder” ritorna ancora e ancora, e ritorna — precisamente — quando i teorici della globalizzazione ritengono che il territorio e la geografia abbiano perso la loro rilevanza nelle relazioni internazionali. Per capire bene cosa Mackinder continua a dirci oggi, dobbiamo partire da due idee centrali. La prima è l’opposizione strutturale della geopolitica mondiale tra potere marittimo (talassocrazia) e potere terrestre (tellurocrazia); Questa opposizione è sostanziale e influisce sulle strategie politiche e militari e ha conseguenze per la costruzione e lo sviluppo degli Stati. La seconda, ampiamente sviluppata nel saggio sopra citato di Mackinder, ha a che fare col sopraggiungere di una nuova fase della geografia mondiale, fase che potremmo chiamare post-colombiana. Le scoperte di Cristoforo Colombo segnarono un’intera fase storico-sociale delle potenze dell’Europa (che è una penisola dell’Eurasia) che si espansero in tutto il mondo attraverso gli oceani diventando vasti imperi in collisione permanente. Mackinder crede che questo stadio si sia cocnluso. Il mondo si era chiuso, essendo distribuito tra le grandi potenze, con una chiara egemonia dell’impero britannico. La chiave — siamo così in cuore del dibattito — è che i poteri talassocratici avevano perso parte del loro vantaggio strategico e che il territorio era ancora una volta un elemento centrale (tellurocrazia). Il geografo britannico identifica un territorio fondamentale
che chiama l’isola del mondo composta da Europa, Asia e Africa. Al suo centro, un perno geografico che, in seguito, avrebbe chiamato Heartland o Cuore Continentale. Da questo centro nascono due grandi linee, una interna e una esterna. L’Heartland occuperebbe un ampio spazio di ciò che chiamiamo Siberia e Asia centrale; cioè, dal Volga allo Yangtze e dall’Himalaya all’Oceano Artico. La conclusione di Mackinder segna un’intera era ed è ben nota. «Quando i nostri statisti stanno conversando con il nemico sconfitto, qualche angelo alato dovrebbe sussurrare loro di volta in volta: chiunque domini l’Europa orientale controlla il cuore continentale; chi domina il cuore continentale controlla l’isola del mondo; che domina l’isola del mondo, controlla il mondo». Una piccola nota: ciò che si stava decidendo in quel momento (1919) era il nuovo ordine concordato a Versailles. Torniamo alla Brexit. Questo mese ho pubblicato su El Viejo Topo un saggio sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Mi riferisco ad esso per le altre considerazioni. Una cosa vorrei sottolineare: la ferocia della classe dirigente e dei media europei contro una decisione democratica e legittima non ha una spiegazione facile. Insulti e disprezzo hanno raggiunto limiti difficilmente sopportabili, al punto che la secessione della Scozia è incoraggiata in un momento in cui la questione territoriale è un grave problema in Spagna. A ciò hanno partecipato sia la destra che la sinistra. Nessun leader importante si è chiesto perché, dal 1992 (referendum francese), nessuna consultazione sull’Europa abbia vinto. E’ accaduto solo in Spagna, il che non è un caso. La mancanza di autocritica delle élite europee è allarmante. Il paradosso di tutto questo dibattito è che per gli europei più federalisti la partenza dalla Gran Bretagna avrebbe dovuto essere vissuta come un’opportunità. La costruzione neoliberista dell’Europa è stata giustificata, in larga misura, dalla presenza della Gran
Bretagna; l’involuzione sociale, la predominanza delle libertà comunitarie e la deregolamentazione dei mercati sono state tradizionalmente attribuite alla presenza di un’isola percepita più come una quinta colonna che come costruttore leale di un processo di integrazione unitaria. Si può capire cosa sta succedendo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna sulla base del fatto che nel mondo stanno cambiando le basi geopolitiche e che siamo (in questo mondo chiuso) di fronte a una grande transizione che ha al suo centro una grande ridistribuzione del potere. Per dirla in altro modo, ciò che abbiamo chiamato globalizzazione è alò tramonto. Non sarà facile capire le mutazioni che stiamo vivendo; non sarà facile capirle e, tanto meno, avere una piattaforma ideo- politica in grado di guidarci in un mondo in rapido cambiamento. Ciò che sta accadendo lo abbiamo davanti ai nostri occhi: un potere (USA) che rifiuta di accettare la sua decadimenza, che non è disposto a condividere, in nuove condizioni, la sua egemonia mondiale e che affronta un potere emergente (Cina) che è destinato a cambiare l’ordine mondiale. Lo dirò come lo disse Kaplan: gli Stati Uniti non accetteranno il dominio di una grande potenza nell’emisfero orientale. Lo combatterà con ogni mezzo e fino alla fine. La “trappola di Tucidide” è ancora presente. In questo mondo che cambia, le grandi potenze economiche britanniche vogliono camminare da sole; mettono al centro i loro interessi strategici e, dalla loro autonomia, cercheranno alleanze con l’Europa; o meglio, con alcuni paesi europei. Nessuno mette in discussione gli accordi sostanziali con gli Stati Uniti, e il Regno Unito li perseguirà con la propria voce e difendendo i propri interessi. L’altro lato della questione dovrebbe sollevare qualche riflessione agli europeisti che ci accerchiano. I dati più rilevanti per gli uomini e le donne che si trovano nella UE è che maggiore è l’integrazione, minore è la capacità europea di essere un soggetto autonomo e differenziato nelle relazioni
internazionali in cui le grandi potenze definiscono interessi e quadri d’azione. Con Mackinder ritorna la Russia. Per gli Stati Uniti il fronte europeo è secondario, ora sono occupati in qualcos’altro: contrastare l’egemonia della Cina nel Pacifico. La NATO ha questo scopo, subordinare una UE senza anima e senza un progetto, dividerla e impedire un partenariato duraturo con la Russia. La “casa comune europea” è stato un progetto fallito delle élite russe che facevano affidamento su un’alleanza con le democrazie occidentali. Putin è il figlio di quel fallimento. Prese atto e trasse le opportune conseguenze strategiche. Gli Stati Uniti hanno provato — e continueranno a provare — a trasformare la Russia in un grande potere avversario dei popoli europei. È la ricerca di un nemico che giustifica l’esistenza della NATO, la corsa agli armamenti e l’inimicizia tra Germania e Russia. L’espansione a est della NATO, la rapida integrazione degli ex paesi socialisti nella UE e il loro rigido allineamento con l’amico americano è lo stesso processo, dobbiamo insistere, per impedire qualsiasi associazione economica e politica con la Russia; vale a dire, con il perno geografico mondiale o Heartland continentale. Più di 20 anni fa, Brzezinski, parlando dei futuri pericoli per gli Stati Uniti, scrisse quanto segue: «Lo scenario potenzialmente più pericoloso sarebbe quello di una grande coalizione tra Cina, Russia e forse Iran, una coalizione” anti-egemonica “unita non da un’ideologia ma da torti complementari. Ricorderei, a causa delle sue dimensioni e portata, la minaccia rappresentata, ad un certo momento, dal blocco sino-sovietico, anche se questa volta la Cina sarebbe probabilmente il leader e la Russia il gregario. Evitare questa contingenza, per quanto remota possa essere, richiederà un dispiegamento simultaneo di abilità strategiche statunitensi nel perimetro occidentale, orientale e meridionale dell’Eurasia».
Il noto analista geopolitico americano aveva ragione ed fu in grado di intravedere il futuro. Quando si tratta di soluzioni, riappare sempre Rimland o l”anello continentale” di Spykman. Europa e Germania hanno geoeconomie complementari e potrebbero avere strategie geopolitiche convergenti. Esistono conflitti (come quello in Ucraina) ma sarebbero risolvibili nel quadro di un accordo di partenariato economico, energetico e politico. Il presupposto è che l’Europa abbia un suo progetto autonomo nelle relazioni internazionali; cioè, di disimpegno dalla NATO, definendo i suoi interessi strategici e cercando il suo posto in un mondo che transita, con enormi difficoltà, verso la multipolarità. Il mio vecchio insegnante Samir Amin ha parlato fino al’ultimo di un asse Parigi-Berlino-Mosca- Pechino. Mackinder ritorna e, con lui, l’Eurasia. La storia, non solo non è finita, ma ricomincia. Madrid, 10 febbraio 2020 BARCELLONA, 11 FEBBRAIO: CONFERENZA SULLA GEOPOLITICA DI MANOLO MONEREO * Traduzione a cura della Redazione ** Fonte: Cuarto Poder I TEDESCHI PIÙ POVERI D’EUROPA?
Vale la pena segnalare
un’indagine della Bce
del 2013. Essa prendeva
in considerazione
anzitutto il tasso di
proprietà immobiliare
delle famiglie.
Era già noto che esso è
in Germania tra i più
bassi, mentre nei paesi mediterranei è decisamente più alto,
così noi, ma anche greci e spagnoli, risultavamo più ricchi
dei tedeschi. Per di più il tasso d’indebitamento dei
cittadini tedeschi era tra i più alti della Ue.
Di acqua ne è passata sotto i ponti. Una nuova indagine
mostrerebbe di sicuro che le politiche austeritarie adottate
per stampellare l’eurozona, hanno causato un impoverimento dei
paesi mediterranei (a cominciare dalla Grecia) a tutto
vantaggio della Germania.
* * *
Uno studio della Bce mostra che i tedeschi sono tra i più
poveri d’Europa
di Shai Ahmed*
I tedeschi sono una delle popoalzioni più povere d’Europa,
persino più povere di quelle nelle travagliate nazioni
periferiche di Grecia, Spagna e Italia, ciò secondo i
sorprendenti risultati di un sondaggio congiunto di diversi
dipeartkenti della Banca centrale europea.
L’indagine sulle finanze e i consumi delle famiglie (HFCS) ha
esaminato la ricchezza delle famiglie in alcuni paesi chiave
dell’area dell’euro.
Secondo il rapporto, “la composizione della ricchezza netta è
determinata principalmente da beni reali”, di cui la
componente principale è la ricchezza abitativa occupata dai
proprietari.Per i paesi che non hanno alti tassi di proprietà della casa e non hanno registrato aumenti significativi dei prezzi delle case, la ricchezza netta appare più marcatamente ridotta, come la Germania, che è “più povera” in termini di ricchezza netta rispetto ad alcuni paesi che invece finanziano programmi di salvataggio. L’indagine ha identificato il tasso di proprietà in immobili delle famiglie in cinque categorie: residenza principale, altre proprietà immobiliari, veicoli, oggetti di valore e attività di lavoro autonomo. Rispetto a tutti i paesi indagati questo tasso è in Germania il più basso. La Germania ha infatti uno dei tassi di proprietà più bassi quando si tratta di residenza principale ed anche uno dei più bassi in termini di altre proprietà immobiliari. Grecia, Cipro e Spagna hanno mostrato tassi più elevati e quindi una maggiore ricchezza netta. Un fattore, che avrebbe potuto distorcere i risultati, è che il sondaggio ha esaminato la ricchezza delle famiglie e non degli individui. Pertanto, quei paesi che hanno una tradizione e una preferenza culturale per le famiglie più numerose, prevalentemente nell’Europa meridionale, possono sembrare più ricchi. La ricchezza netta secondo i risultati è sostanzialmente più elevata a Cipro a 671.000 euro rispetto ai 195.000 euro alquanto irrisori per i tedeschi. Anche la Spagna supera la Germania con una ricchezza netta pari a 291.000 euro e l’Italia a 275.000 euro. Alla luce dei fatti macroeconomici sul campo, potrebbe essere sorprendente apprendere che la Germania, nel suo insieme, è “più povera” di Cipro, un paese in ginocchio, o della Spagna
dove la disoccupazione si attesta al 26 percento, rispetto al tasso della zona euro del 12 percento. Scrive la BCE: «La misurazione della ricchezza è subordinata al fatto che la variazione della ricchezza è influenzata dalle istituzioni e da macrodinamiche che recentemente hanno differito sostanzialmente tra le varie famiglie, regioni e paesi sia con dell’eurozona che fuori». L’idea che i cittadini delle nazioni periferiche abbiano sperperato la loro ricchezza e siano stati frivoli, è stata anche smentita dalla ricerca. Gli italiani risultano essere i più parsimoniosi nello studio con il tasso d’indebitamento più basso.. Il settantacinque percento delle famiglie italiane non ha alcun debito, rispetto a circa il 53 percento in Germania e il 34 percento in Olanda. * Fonte: CNBC ** Traduzione a cura della redazione LA RICETTA DELLA M.M.T. di Gianluigi Paragone
Venerdì scorso ho avuto
modo di organizzare
assieme all’amico
Thomas Fazi un
incontro/dibattito con
Bill Mitchell, uno dei
massimi esponenti
mondiali della Modern
Monetary Theory (Mmt),
teoria macroeconomica
di cui sempre più si
stanno affermando gli
spunti e gli strumenti per uscire dal fanatico rigore
neoliberista incistato nei trattati europei. Di Mmt ne hanno
discusso recentemente sia Mario Draghi (che in quanto
“allievo” di Federico Caffè conosce bene la dottrina di
Keynes, che sta alla base del postulato Mmt), sia colei che ne
ha preso il posto alla Bce, Christine Lagarde.
Ma è negli Stati Uniti che da anni il dibattito sollevato da
questa teoria anima accademici e classe dirigente, tanto che i
democratici eretici Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez
hanno sottoscritto parecchi documenti proposti dalla Mmt,
anche – e soprattutto – alla luce di quanto sollecitato da
parecchie banche centrali (quelle vere non la Bce) e di quanto
sta accadendo in Giappone dove la leva a deficit è ormai un
“must” del premier Shinzo Abe (13mila miliardi di yen appena
sfornati per investimenti pubblici).
Per farci capire, i teorici della Mmt ribaltano completamente
il paradigma di Bruxelles, il pareggio di bilancio,
l’austerity e il maniacale controllo del deficit pubblico. Più
volte ho scritto che il coraggio di uscire dall’inganno
neoliberista (fondato sul controllo della spesa pubblica,
imponendo così privatizzazioni, liberalizzazioni, depressione
sociale, mancata crescita eccetera eccetera) ha premiato
diversi capi di governo; persino quel Donald Trump la cuielezione fu salutata dal mainstream di fede clintoniana come una sciagura che avrebbe provocato il collasso delle Borse e dell’economia reale americana. Sciagure per nulla verificatesi. Tanto per capirci, a deficit Trump ha varato la sua riforma fiscale. Tutto questo però non basta, pensano in Mmt: i governi non devono minimamente avere il problema del deficit finché non si raggiunge piena occupazione e quindi profitto e sviluppo per le imprese. Le grandi sfide dell’impatto lavoratore/robot o la green economy non possono essere giocate senza la scommessa della spesa pubblica. Qual è però il requisito fondamentale della Mmt? Avere una moneta sovrana e una banca centrale che possa ripagare il debito pubblico creando nuova moneta fino a quando non si verifica una situazione di alta inflazione, condizione di cui al momento non si vede assolutamente il pericolo. L’architettura che sorregge l’Unione europea di fatto impedisce tutto questo e sta costringendo l’Italia a ragionare sullo zero virgola in più o in meno, creando un tappo alla crescita, all’occupazione e allo sviluppo. È solo un problema italiano? No, visto che tutti gli economisti convengono sul dato che l’eurozona è la parte del mondo sviluppato che cresce di meno. Quindi, che fare? Questa è la sfida di cui abbiamo parlato appunto con Bill Mitchell, uno dei massimi esperti mondiali della Mmt. Partendo da un dato “politico”: il sovranismo non è né di destra né di sinistra, ma è una condizione necessaria se si vuole sovvertire il maleficio neoliberista incistato nelle
stupidissime regole dell’Unione europea. Regole che nessuno vuole rompere davvero. Bill Mitchell non sfugge al dato politico e sociale, nel senso che “la generalizzata rivolta anti-establishment ha sancito il fallimento delle élite”. Tocca allora alla politica raccogliere il dolore dei cittadini, degli imprenditori, delle famiglie e pure di chi, per conto della finanza, ha ben chiaro che solo gli Stati possono riprendere in mano la politica fiscale, fare politiche espansive, cioè in deficit. La Abenomics è la prova vivente che la teoria dominante è fallace. Tutto questo ovviamente viene nascosto dal mainstream che non ha altre armi se non quella della propaganda (la imbarazzante pagina comprata da firme del giornalismo italiano per ringraziare supinamente Mario Draghi…) o della paura (i mercati, lo spread…). Tutto sotto la regia di una cultura pseudo-riformista, di cui il Pd in Italia è alfiere. Le notizie di questi giorni lo confermano: il governo italiano potrebbe essere condannato per i mancati pagamenti della Pubblica amministrazione; i venti miliardi di clausole di salvaguardia da coprire entro l’anno prossimo (per cui si parla di aumentare l’Iva ad albergatori e ristoratori, già massacrati dal fisco e dalla concorrenza delle nuove piattaforme digitali); l’occupazione che batte in testa, le imprese soffocate da tasse e burocrazia. Insomma, fintanto che si resta dentro questa gabbia si muore a piccole dosi. È certo. Per questo con Bill Mitchell ho voluto riprendere in mano il tema dei temi: ha senso restare dentro l’eurogabbia? No. Lo penso anch’io. Per questo mi sono rimesso in movimento fuori dal Movimento. * Fonte: IL PARAGONE
LA PROSSIMA GUERRA MONDIALE
di Giulietto Chiesa
Si è svolto sabato scorso a
Foligno il previsto incontro
con Giulietto Chiesa.
Sala gremita [vedi foto accanto
]e pubblico molto attento, a
dimostrazione dell’interesse
per i temi riguardanti la
complicata situazione
internazionale e geopolitica.
Prima di dare la parola a Giulietto Chiesa, hanno introdotto
l’incontro Giacomo Zuccarini a nome dei Comitati Popolari
Territoriali umbri di Liberiamo l’Italia, quindi Armando
Mattioli, portavoce di Futuro Collettivo (associazione
politico-culturale molto attiva in città).
Armando Mattioli, Giulietto
Chiesa, Giacomo Zuccarini
Chiesa ha svolto un’articolata prolusione con uno sguardo sui
diversi scacchieri di tensione geopolitica, chiamando alla
lotta contro il rischio di una nuova guerra mondiale che
alcuni settori ultra-imperialisti dell’Occidente stannopreparando, e per far si che l’Italia esca dalla NATO e
diventi un Paese neutrale.
Chiesa ha avuto poi modo di sottolineare la grande importanza
della mobilitazione che sta iniziando contro il 5G e
l’installazione delle antenne sui diversi terrritori.
A seguire diverse le domande e quindi la replica di Giulietto
Chiesa.
IL VIDEO DELL’INCONTRO
PERCHÉ NO! Il MES in parole
povere
Comunicato n. 2/2020
del Comitato centrale
di P101
(1) Se prima il M.E.S. (il cosiddetto “Fondo salva stati”),
finanziato dai singoli stati della Ue, faceva capo all’Unione
medesima, con la “riforma” il MES diventerà né più e né meno
che una super-banca d’affari privata indipendente, la quale
potrà prestare denaro agli stati solo a condizione che ne
tragga un lauto guadagno. Di più: sarà un organismo di rangosuperiore agli stati nazionali e che avrà potere di vita o di morte su quelli che dovessero ricorrere al suo “aiuto” (come la troika lo fu per la Grecia). Si tratterebbe per l’Italia di un’altra palese cessione di sovranità in aperta violazione dell’art. 11 della Costituzione, dell’ennesimo crimine per tenere in via il mostro liberista dell’Unione europea. (2) La “riforma” stabilisce due linee di credito, dividendo così paesi di serie A e B, quelli considerati solvibili (che cioè rispettano i famigerati parametri ordoliberisti del 3% e del 60%) e quelli con alto debito pubblico (che non li rispettano) considerati ad alto rischio. Abbiamo quindi, col nuovo MES, un doppio paradosso: a) paesi come la Germania con banche piene zeppe di titoli tossici godrebbero, per l’accesso al credito del MES, di una corsia preferenziale e di condizioni molto vantaggiose; mentre l’Italia, per usufruire dello “aiuto”, dovrebbe impegnarsi ad adottare draconiane misure di riduzione del debito pubblico, quindi austerità, tagli alla spesa sociale ed ai diritti, privatizzazioni; b) l’Italia, ratificando il Trattato, sarebbe un grande finanziatore del MES ma ciò a tutto vantaggio dei paesi considerati di seria A. Né più e né meno che una colossale rapina. (3) Tutti gli analisti concordano che una conseguenza inevitabile dell’eventuale richiesta di “aiuto” provocherebbe una brutale svalutazione del valore dei titoli pubblici italiani a danno dei tanti risparmiatori che hanno acquistato Bot o Btp. Anzi! già solo l’entrata in funzione del MES, quindi l’adozione dei suoi parametri — quelli per cui l’Italia sarebbe considerata un Paese di serie B —, potrebbe innescare ex ante una fuga generalizzata dai titoli di stato italiani, con conseguente fuga di capitali dall’Italia verso altri paesi a tripla A, con l’inevitabile svalutazione del valore dei titoli di debito italiani.
(4) In questo caso sarebbe dunque altamente probabile il collasso generale del sistema bancario italiano. Le banche italiane posseggono oggi circa 400 miliardi di titoli pubblici. Una forte decurtazione del loro valore (come detto, possibile ancor prima che si dovesse chiedere “aiuto” al MES) causerebbe quindi crolli bancari a catena. (5) Le conseguenze inevitabili sarebbero dunque: a) che il MES si comporterebbe come uno strozzino con facoltà di pignorare i beni italiani; b) che lo Stato sarebbe costretto non solo ad applicare una violenta austerità, ma, sempre per rimborsare il credito, a vendere a prezzi stracciati proprietà e patrimoni; c) che le banche, per non fallire, dovrebbero ricorre al bail- in, ovvero ricorrere ad espropri forzosi non solo degli azionisti ma pure dei correntisti, con conseguente stop all’erogazione di prestiti ad aziende e cittadini. Una recessione violenta sarebbe dunque inevitabile con chiusura di aziende, crollo degli investimenti pubblici e privati, aumento generale della disoccupazione. In poche parole: un disastro nazionale. Fermare il MES è quindi questione di interesse nazionale. I governanti, venduti allo straniero, hanno già firmato la capitolazione. Sarà il Parlamento tuttavia, nella prossima primavera, a dover ratificare il nuovo Trattato. Prepariamo una grande mobilitazione per impedirlo! Usciamo dalla gabbia dell’euro, prepariamo l’Italexit! Il Comitato centrale del Movimento Popolare di Liberazione – Programma 101 10 febbraio 2019
Puoi anche leggere