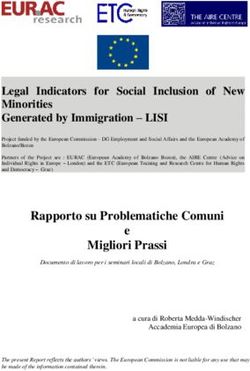GUERRE COMMERCIALI E TENSIONI GEOPOLITICHE LO SCENARIO 2019 PER GLI INVESTITORI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
GUERRE COMMERCIALI E TENSIONI GEOPOLITICHE
LO SCENARIO 2019 PER GLI INVESTITORI
Un decennio dopo la Grande Crisi Finanziaria, il sistema globale si trova ad affrontare una nuova
sfida: quella del libero commercio di beni e servizi, che ha rivoluzionato il mondo negli ultimi
trent’anni. Si ergono barriere doganali, si applicano dazi per salvaguardare il sistema nazionale. La
giustificazione addotta è: mettere al primo posto i lavoratori, le imprese, i cittadini del Paese a fronte
delle minacce straniere. Il leader indiscusso di tale linea politica è il Presidente degli Stati Uniti,
Donald Trump, ma essa si sta diffondendo a livello globale, facendo parte del programma politico di
un gruppo di leader sempre più numeroso. L’esempio Brexit è indicativo: nel 2016 la maggioranza
dei cittadini del Regno Unito ha deciso di abbandonare l’Unione Europea, e con ciò il libero accesso
ad uno dei mercati più importanti del mondo, in termini di merci e servizi. Ad essere messa in
discussione è la globalizzazione, fenomeno tra i più rilevanti negli ultimi decenni. Si tratta di una
semplice pausa all’interno di un trend inarrestabile, quello di un “Villaggio sempre più globale”,
oppure di un vero cambio di paradigma economico? Della prima idea sono i sostenitori della visione
di un mondo sempre più interconnesso, non solo commercialmente, ma soprattutto da un punto di
vista dello scambio dei dati, grazie ad internet e all’evoluzione delle nuove tecnologie. Della seconda,
coloro che ritengono si stia scrivendo una nuova pagina della Storia. Fra quest’ultimi vi è Giulio
Tremonti, che in una recente intervista a il Sole 24ore, alla domanda – Che cosa sta succedendo nel
mondo? – ha risposto: “Al suo inizio la globalizzazione è stata global order, oggi è global disorder.
E al posto del vecchio abbiamo un opposto e crescente . Il vecchio mondo era stabile, perché immobile: Occidente contro Oriente, liberalismo
contro comunismo. Anche il mondo globale è stato finora stabile, ma per la ragione opposta: stabile
perché tutto era continuamente e liberamente mobile. Oggi il mondo è diventato instabile per una
ragione diversa: per i conflitti trans-continentali che trovano espressione tra l’altro con i dazi e le
quote”. Sotto questa luce si rende necessario approfondire l’analisi del tema, in quanto in grado di
modificare gli equilibri preesistenti con impatti rilevanti sull’economia globale e, conseguentemente,
sui mercati finanziari e le varie asset class. A tale riguardo, si procederà attraverso i seguenti punti:
1. L’architettura monetaria globale: dal gold standard al gold exchange standard fino al fiat
money;
2. Protezionismo e Free Trade nella storia;
3. Il WTO, l’iper-globalizzazione e l’elefante grafico di Milanovic;
4. Scontro USA-Cina: cosa si nasconde dietro le tensioni commerciali?
5. I rapporti UE-Cina e la nuova Via della Seta;
6. I cambiamenti in atto e gli impatti sulle asset class
1. Secondo gli storici dell’economia, le ragioni delle Guerre Mondiali nel secolo scorso furono
attribuibili in buona parte alle conseguenze nefaste dei controlli sui tassi di cambio e
all’applicazione di barriere commerciali. La Grande Depressione degli anni Trenta del ‘900
fu infatti preceduta dall’abbandono del gold standard che nacque formalmente nel 1821,
quando l’Inghilterra ripristinò la convertibilità in metallo della propria moneta, scegliendo
come unico standard l’oro. Essendo l’Inghilterra il Paese dominante nel commercio mondiale,
il sistema aureo si impose nel corso dell’Ottocento in quasi tutti gli Stati inseriti nei grandi
circuiti di questo commercio. Al sistema del gold standard è stato attribuito il merito della
1stabilità delle monete, dei prezzi e del libero movimento dei capitali fino alla Prima Guerra
mondiale, oltre al pregio di una intrinseca capacità di autoregolazione attraverso il
meccanismo dei flussi di oro. Il gold standard, secondo gli economisti classici, aveva il
vantaggio di mantenere l’equilibrio nel commercio internazionale: eventuali deficit della
bilancia dei pagamenti di un paese provocavano infatti un deflusso di oro, una diminuzione
dei prezzi, l’aumento delle esportazioni, il ritorno del metallo pregiato ed un nuovo equilibrio
(meccanismo di price-specie-flow, sintetizzato dalla figura sotto riportata).
In tale processo, il sistema bancario non doveva che adeguarsi ai flussi aumentando o
diminuendo il tasso di sconto in relazione alla scarsità o abbondanza di riserva metallica
(rispetto delle cosiddette "regole del gioco"). La ricerca storica ha però mostrato come fossero
frequenti le violazioni di queste regole nel movimento dei capitali, e come gli squilibri della
bilancia dei pagamenti fossero compensati, più che dai flussi di oro, da movimenti di capitale
a breve termine e, viceversa, afflussi di metallo fossero frequentemente sterilizzati per non
accrescere la quantità di moneta all'interno. Il sistema si interruppe nel 1914 allo scoppio della
Guerra Mondiale, quando le monete nazionali vennero dichiarate inconvertibili nei confronti
dell’oro. Non più convertibile in oro, la sterlina inglese nel post-bellico si deprezzò sia verso
l’oro, che nei confronti delle principali merci e delle valute più stabili. I magnati della finanza
e i politici conservatori di Londra, convinti che la sterlina-oro fosse il principale simbolo
dell’impero britannico, decisero di affidare a Churchill la restaurazione del gold standard nel
1925, progetto che venne portato a termine, malgrado la ferma opposizione dell’economista
John Maynard Keynes. Per poterlo fare bisognava ridurre il livello dei prezzi del Paese,
elevare il valore della sterlina sul mercato mondiale, migliorare la bilancia dei pagamenti,
incrementare l’afflusso di oro e limitare l’emissione di banconote. Ma per ottenere la parità
ufficiale della sterlina con l’oro e il vecchio rapporto col dollaro, il prezzo che venne pagato
fu la disoccupazione di massa, forti decrementi salariali e sensibili riduzioni dei servizi
pubblici. Il corso della sterlina risultò artificiosamente elevato e l’export diventò molto
difficile; i prezzi delle merci erano molto più alti di quelli americani, per cui il deficit della
bilancia commerciale e dei pagamenti divenne insostenibile. Nel 1926 la produzione
industriale inglese era del 30% inferiore al livello del 1913 e la disoccupazione interessava il
12% della forza lavoro. Londra fu costretta a ridurre drasticamente l’import di materie prime:
in poco tempo, la Gran Bretagna degli anni Venti del ‘900 era diventata l’anello debole
dell’intera economia occidentale. Secondo un nutrito gruppo di economisti, le svalutazioni sei
tassi di cambio e le loro conseguenze economiche furono alla base della Grande Depressione
2globale, iniziata nel 1929 con il crollo di Wall Street e che sfociò nelle tensioni nazionaliste
che si inasprirono fino all’avvento del Secondo Conflitto Mondiale. A Guerra non ancora
conclusa, ma quando la Storia aveva già assegnato la palma del vincitore agli Stati Uniti
d’America, il mondo si trovò a Bretton Woods: è in questa cittadina del New Hampshire che,
presso il Mount Washington hotel si svolse la Conferenza di Bretton Woods, dal 1 al 22 luglio
1944, che stabilì regole per le relazioni commerciali e finanziarie tra i principali Paesi del
mondo. Gli accordi che ne scaturirono furono il primo esempio nella Storia di un ordine
monetario totalmente concordato, pensato cioè per governare i rapporti valutari tra Stati
indipendenti. I principali obbiettivi di Bretton Woods furono perciò: creare le condizioni per
una stabilizzazione dei tassi di cambio rispetto al dollaro (eletto a valuta principale) ed
eliminare le condizioni di squilibrio determinate dai pagamenti internazionali (tale compito
fu affidato al Fondo Monetario Internazionale). Furono presentati due progetti: quello di Harry
Dexter White, delegato USA e di John Maynard Keynes, delegato inglese: tra i due, stante
l’affermazione della forza emergente americana, fu scelto il primo. Si tratta del cosiddetto
gold exchange standard, secondo il quale l’unica valuta convertibile in oro era il dollaro
americano (a 35 dollari per oncia); tutte le altre valute, assoggettate ad un regime di cambi
fissi, dovevano quindi essere convertite in dollari, prima di poter acquistare oro, e con esso
tutte le materie prime (sintesi nell’immagine sottostante).
Si trattava, in altri termini dell’affermazione globale del biglietto verde: da quel momento in
avanti moneta di riferimento per gli scambi commerciali mondiali (valuta di signoraggio
mondiale). Le altre valute avevano, di fatto, un ruolo ancillare rispetto al dollaro americano,
come si evince dalla figura sotto riportata che sintetizza un esempio dell’applicazione del gold
exchange standard nel 1955.
Il gold exchange standard non tardò a manifestare i suoi limiti, tra i quali le antiche questioni
già note con il sistema precedente, riassumibili nella deflazione monetaria. Dato cioè che
potevano essere emesse quantità di dollari limitate alla detenzione di riserve auree, la carenza
3di moneta danneggiava gli scambi internazionali e la capacità dell’economia americana di
aumentare il suo deficit commerciale. In realtà gli Stati Uniti, per evitare ripercussioni
negative sul loro sistema economico, disattesero gli Accordi di Bretton Woods, creando una
quantità di dollari superiore rispetto alle riserve d’oro detenute. Il Presidente francese, il
Generale De Gaulle, già all’inizio degli anni Sessanta cominciò a dire che i dollari in
circolazione erano troppi e a chiedere la conversione in oro delle riserve detenute dalla Banca
di Francia. Con il passare del tempo, i dubbi sulla effettiva capacità degli Stati Uniti di far
fronte a tutte le richieste di conversione in oro dei dollari in circolazione, aumentarono
notevolmente e tanti Paesi cominciarono a chiedere la conversione delle proprie riserve di
dollari. La situazione si fece esplosiva quando le esigenze della guerra del Vietnam imposero
agli Stati Uniti la necessità di stampare sempre più dollari che furono immessi sui mercati
mondiali per comprare da ogni angolo del globo le merci necessarie a soddisfare l’immenso
fabbisogno dell’esercito americano. L’Amministrazione americana si trovò davanti ad un
bivio: svalutare il dollaro e risalire la china della crescita produttiva oppure fare saltare
l’Accordo di Bretton Woods. Scelse la seconda. Il 15 agosto 1971, in un discorso alla Nazione,
il Presidente americano Richard Nixon annunciò la temporanea sospensione della
convertibilità aurea del dollaro, motivandola con la necessità di salvaguardare il biglietto
verde dagli attacchi degli speculatori internazionali. Il discorso, infarcito di patriottismo,
proclamò anche il blocco dei salari e dei prezzi ed il ritorno ai cambi flessibili. Quel giorno
fu il vero spartiacque della storia monetaria moderna, con conseguenze sintetizzate nella
figura sottostante.
Si è trattato di un cambio epocale, perché da quel momento in avanti la Federal Reserve è in
grado di creare la quantità di dollari che ritiene più opportuna, per il raggiungimento degli
obbiettivi di crescita economica e di controllo dell’inflazione. E’ l’era del fiat moneta, in cui
la moneta in circolazione ha perso ogni vincolo di conversione in un bene fisico, come
descritto nell’immagine sotto riportata.
4Da quel momento in avanti la moneta viene cioè stampata (per meglio dire, creata, dato che
oramai la maggiore parte di essa è di natura elettronica) dalle Banche Centrali e da esse
trasmessa al sistema (statale, bancario e produttivo) con l’esercizio del signoraggio monetario,
cioè del potere di emissione e del guadagno ad esso associato. La fiat moneta ha creato
numerosi effetti distorsivi, tra i quali la continua tentazione di procedere ad una svalutazione,
finalizzata alla ripresa dell’economia attraverso il rilancio dell’export. La cooperazione
globale è spesso riuscita ad arginare tale processo; a riguardo va ricordato l’Accordo stipulato
presso l’Hotel Plaza di Manhattan, il 22 settembre 1985. La premessa era un dollaro
eccessivamente forte sul mercato dei cambi che si accompagnava ad un forte deficit della
bilancia commerciale a stelle e strisce. L’obbiettivo delle cinque Nazioni firmatarie
dell’accordo era l’indebolimento del biglietto verde, attraverso l’intervento coordinato delle
rispettive Banche Centrali, anche al fine del riequilibrio commerciale americano. Come
sintetizzato nella tabella sottostante, il risultato fu conseguito soprattutto sul fronte dei cambi:
il dollaro infatti si deprezzò di circa il 50% nei confronti dello yen giapponese nei due anni
successivi.
L’Accordo del Plaza portò quindi a delle conseguenze rilevanti soprattutto nel rapporto
dollaro/yen, con un forte impatto recessivo per il Sol Levante (causato dal significativo
apprezzamento della propria moneta e quindi dalla perdita di competitività internazionale
conseguente). Tale processo obbligò la Banca Centrale Giapponese a mettere in atto, nella
seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso, misure di stimolo monetario senza precedenti,
5il cui risultato fu la creazione della bolla azionaria e dei prezzi immobiliari, da cui l’economia
giapponese, a distanza di trent’anni, non si è ancora ripresa.
2. L’esempio più spesso citato di guerra commerciale è quella innescata dagli Stati Uniti con lo
Smoot-Hawley Act, approvato dal Congresso americano nel 1930, all’indomani del crollo di
Wall Street del 1929. Nonostante il parere contrario di 1.028 economisti, la legge alzò i dazi
applicati dagli USA dal 38 al 45%, con l’obiettivo di proteggere gli agricoltori americani
colpiti dalla crisi economica. I dazi furono estesi a quasi mille categorie di beni e provocarono
un crollo della domanda, aggravando la Grande Depressione già in atto. Anche perché
venticinque Paesi reagirono con rappresaglie a colpi di dazi e svalutazioni della moneta.
L’interscambio commerciale globale crollò del 60%; la crisi economica alimentò l’ascesa dei
movimenti nazionalisti in Europa e fu una delle cause principali della Seconda Guerra
Mondiale. Ma il protezionismo non nasce nel 1930, bensì molto prima. Nell’immaginario
collettivo, il XIX secolo è comunemente percepito come il periodo dell’affermazione e del
trionfo del libero scambio nel sistema delle relazioni economiche internazionali. Il Regno
Unito rappresenta per tutto il secolo il simbolo vivente e operante del liberoscambismo con le
profonde trasformazioni sociali ed economiche della sua rivoluzione industriale giunta ormai
alla maturità e con la propria straordinaria e ininterrotta crescita economica. Se ciò resta a
tutt’oggi un elemento radicato nel pensiero economico, le ricerche e la letteratura scientifica
degli ultimi decenni hanno ampiamente dimostrato come nulla, o quasi, di questa immagine
corrisponda alla realtà storica degli scambi e dei mercati nell’Ottocento, della loro costruzione
e della loro affermazione nel corso del secolo. La prima affermazione sul piano politico
internazionale del principio del libero scambio è rappresentata dal trattato commerciale tra
Francia e Gran Bretagna del 1786, dove si richiamano esplicitamente i principi economici
ispirati da Adam Smith. Sebbene la Rivoluzione francese del 1789 e il successivo ventennio
di guerre europee portino al rapido fallimento del trattato, è significativo ricordare come sia
un trattato anglo-francese nel 1860 a caratterizzare il momento di maggiore affermazione e
successo del Free Trade nel corso del XIX secolo. Ma agli inizi dell’Ottocento le guerre
Napoleoniche portano su scala internazionale l’affermazione di politiche protezioniste come
conseguenza dei blocchi continentali imposti da Francia e Regno Unito nel 1806. Il culmine
dell’orientamento protezionista nel Regno Unito si manifestò nel 1815 con l’approvazione
della Corn Laws (Leggi sul grano), un sistema di tariffe doganali variabile con il variare dei
prezzi del grano, e dei cereali in generale, sui mercati interni. Lo scopo evidente del
provvedimento fu quello di mantenere alti i prezzi del grano nel caso di abbondanza dei
raccolti e di abbassarli considerevolmente, grazie alle importazioni dall’estero, nel caso di
carestie e raccolti insufficienti.
6L’introduzione delle tariffe sul grano, come si osserva dall’immagine sopra riportata, presentò
un duplice effetto: benefico per i proprietari terrieri ed i lavorati agricoli inglesi, che videro il
valore delle proprietà (i primi) e del lavoro (i secondi) aumentare; al contrario per le industrie
e per i capitalisti (la classe borghese) vi fu un danno, causato dall’aumento del costo del lavoro
(per le prime) e da una diminuzione dei profitti (per i secondi). Le tariffe sul grano hanno
come effetto quello di indurre non solo il mantenimento di alti prezzi per quanto riguarda i
cereali, ma di estendere questo effetto a tutti i generi alimentari di prima necessità e ciò ha
come ulteriore conseguenza quella di spingere verso un aumento generalizzato dei livelli
salariali necessari a equiparare anche solo i minimi costi di sussistenza. L’adozione delle
prime tariffe stabilite dalla Corn Law del 1815 può simboleggiare il momento in cui ha inizio
la polemica economica e il contrasto politico tra interessi manufatturieri e agrari che
caratterizza buona parte del secolo, nel Regno Unito così come negli altri Paesi occidentali.
Come già visto la protezione dei prezzi dei cereali avvantaggia i proprietari terrieri, che nel
Paese tanto peso politico mantiene e avrebbe mantenuto nel corso del secolo. Allo stesso
tempo essa colpisce gli interessi degli industriali volti sia alla richiesta di una maggiore libertà
in materia di commercio internazionale, dove a causa degli aumenti dei dazi sul grano si
temono ritorsioni su altri prodotti, sia al mantenimento di un basso livello dei salari, reso più
difficile, a causa degli aumenti dei prezzi dei beni primari. Il contrasto tra la natura dei due
diversi interessi, la sua intensità, o il loro combinarsi insieme in determinati momenti, è alla
radice delle oscillazioni tra libero scambio e protezionismo che caratterizzano le vicende
economiche del Regno Unito, così come di tutta l’Europa continentale, degli Stati Uniti e delle
colonie di insediamento europeo, per tutto l’arco del XIX secolo. Le prime vittorie dei
sostenitori del libero scambio sono dovute agli economisti che si fanno portavoce degli
interessi industriali richiamandosi alle idee di Smith, organizzando veri e propri gruppi di
pressione, come il Political Economy Club, fondato da David Ricardo, e che riusciranno
gradualmente a imporre la propria influenza sulla Camera dei Comuni e sull’azione del
governo. Nonostante ulteriori misure di liberalizzazione del commercio, il principale nodo
politico della contrapposizione tra liberisti e protezionisti resta la questione delle Corn Laws,
non solo perché da queste gli industriali fanno direttamente discendere la questione dei livelli
salariali, ma anche per la trasformazione del contrasto tra interessi chiaramente identificabili,
in una battaglia ideologica per o contro il libero mercato, grazie soprattutto alla Anti Corn
Laws League, nata nel cuore industriale del Paese (Manchester, 1836). La Lega, con una
sistematica campagna propagandistica, andando oltre le argomentazioni strettamente
economiche, presenta la questione delle tariffe del grano come una più generale battaglia per
7la libertà del genere umano e per l’affermazione dei suoi diritti. La libertà di commercio
diventa la panacea di ogni male e perfino un elemento decisivo per la futura pace del mondo,
come sintetizzano le parole di Richard Cobden, suo principale portavoce: “[…] vedo il
principio del libero scambio che svolge, nel mondo morale, la stessa funzione del principio
della gravitazione universale: quello di attrarre gli uomini tra loro, respingendo gli
antagonismi di razza, di fede, di lingua, unendoci con il legame della pace perpetua”. Il
modificarsi dei rapporti di forza tra i due settori dell’economia britannica rende ormai matura
l’affermazione del Free Trade nel Regno Unito: se nel 1810 la ricchezza prodotta dal settore
agricolo supera del 70% quella prodotta dal settore manifatturiero, nel 1840 è quest’ultimo a
superare con il proprio valore aggiunto del 60% quello prodotto in agricoltura. Ma a decidere
l’abbandono di ogni forma di protezionismo tariffario saranno i cattivi raccolti del 1845 e
soprattutto la disastrosa carestia che colpisce l’Irlanda, causata dai pessimi raccolti delle
patate. Nel giugno del 1846 viene votata, non senza seri contraccolpi politici, l’abrogazione
delle Corn Laws, e il libero scambio diventa per la prima volta l’orientamento cui si uniforma
l’azione politica ed economica britannica nel sistema delle relazioni internazionali. Con
l’eccezione di tre Paesi minori - Portogallo, Danimarca e, soprattutto, Paesi Bassi - fino al
1846 nell’Europa continentale prevalgono invece politiche di tipo protezionistico, seppure
con diverse gradazioni. Agli occhi degli osservatori che dal Continente guardano a quanto
succede nel Regno Unito, il problema è abbastanza chiaro: la crescita dell’economia
britannica, lo sviluppo industriale che la caratterizza e il progressivo affermarsi del principio
del libero scambio sono la conseguenza di una graduale evoluzione che dura da oltre un secolo
e che ha beneficiato di un capillare sistema di protezioni, andato allentandosi solo nei due
decenni precedenti, per essere abbandonato tra il 1846 ed il 1849. Per recuperare il divario e
consentire l’avvio, il consolidarsi e la sopravvivenza di propri sistemi industriali in grado di
competere sul piano internazionale, è quindi indispensabile la protezione doganale delle
proprie manifatture dalla concorrenza dei prodotti industriali a basso costo che provengono
da oltre Manica. Il protezionismo resta il fondamento delle politiche economiche del
continente, con le eccezioni sopra ricordate, fino al 1851, anno in cui viene concluso il trattato
commerciale tra Belgio e Regno Unito che rappresenta una delle prime aperture al libero
scambio da parte di uno Stato del continente fino ad allora protezionista. La vera svolta a
favore del libero scambio si ha solo nel 1860 con il trattato commerciale anglo-francese,
voluto da Napoleone III, convinto sostenitore della libertà dei commerci, e negoziato
dall’economista Michel Chevalier. La sottoscrizione del trattato è un vero e proprio colpo di
mano, poiché viene preparato segretamente e imposto scavalcando l’opposizione della
Camera dei deputati e la maggioranza dell’opinione pubblica e degli interessi economici
nazionali contrari al liberoscambismo. Il trattato rappresenta un vero passaggio d’epoca:
introduce per la prima volta il principio della nazione più favorita, ovvero l’estensione
automatica, al Paese con cui si è stipulato un accordo che preveda tale principio, di ogni
vantaggio ottenuto in accordi bilaterali con Paesi terzi. Oltre a ciò, prevede la rimozione di
ogni ostacolo al commercio bilaterale, fatto salvo il mantenimento del diritto di imporre tariffe
sul valore delle importazioni con un tetto massimo del 30%, dunque ancora elevato.
L’apertura del continente europeo al liberoscambismo, con l’eccezione della sola Russia, e
l’abbattimento delle tariffe doganali nei commerci continentali avviene per via indiretta tra il
1860 e il 1866 per effetto della clausola della nazione più favorita e a seguito di accordi
8bilaterali con la Francia. Va notato però che fino al 1875, con l’eccezione del Regno Unito (le
cui tariffe sono pari a zero), dei Paesi Bassi, della Svezia, della Germania e della Svizzera,
tutti gli altri Paesi mantengono il livello delle proprie tariffe doganali tra il 10 e il 20%. Come
il trattato del 1860 è il simbolo del trionfo dell’epoca del libero scambio, così l’abbandono di
tale politica da parte della Germania nel 1879, preceduta nel 1877 dal Belgio, dall’Austria,
dalla Spagna, dalla Russia e dall’Italia nel 1878, simboleggia il ritorno del continente europeo
al protezionismo. La decisione tedesca è dovuta alla crescente crisi del settore agricolo che
non ha visto benefici dalle politiche di libero scambio e dall’ininterrotta opposizione degli
industriali alla sua adozione; ma è soprattutto la questione del forte deterioramento delle
condizioni di vita e dei redditi dei contadini ad avere un peso decisivo. Il peggioramento,
comune a quasi tutti i Paesi del continente, è dovuto in gran parte alle importazioni crescenti
di cereali dai Paesi extraeuropei, in primo luogo dagli Stati Uniti, che del resto mantengono
per tutto il XIX secolo una coerente politica protezionista e non si fanno coinvolgere dalla
svolta libero scambista degli anni Sessanta, nonostante il dissenso degli Stati del Sud. Questi,
a prevalenza agricola, hanno un chiaro interesse verso una legislazione doganale orientata al
libero mercato, così da garantire le proprie esportazioni verso l’Europa e consentire
un’importazione di prodotti industriali a basso costo. Come già indicato nel punto precedente
della disamina, per molti economisti è questo l’elemento decisivo alla radice della “Grande
Depressione” degli anni ’30 del secolo scorso: il marcato rallentamento della crescita
economica che si registrerà nel ventennio 1872/73-1892/93. Se nel Regno Unito il settore
agricolo è ormai secondario e la popolazione impiegata in tale settore si riduce drasticamente,
nel continente resta pari a circa il 60% (tra il 1870 e il 1890), ed è evidente che il suo
impoverimento non può non avere conseguenze sulle scelte dei singoli Stati. La svolta
definitiva avviene nel 1892 con l’adozione da parte della Francia di un nuovo regime tariffario
che annulla il trattato del 1860 e inaugura la fase di crescente intensificazione delle politiche
protezionistiche che si estende fino al 1914. Sole eccezioni il Regno Unito e i Paesi Bassi, che
restano fedeli al Free Trade fino agli inizi degli anni ’30 del XX secolo.
3. A Bretton Woods, come descritto nel primo punto della trattazione, vennero definiti gli
equilibri mondiali che hanno governato il sistema economico post Seconda Guerra mondiale.
Uno degli obbiettivi di Bretton Woods fu proprio evitare il ripetersi degli errori che avevano
condotto alle due catastrofi belliche, tra i quali il protezionismo commerciale veniva
considerato il più rilevante. Gli accordi rifletterono cioè l’approccio culturale delle potenze
anglosassoni dell’epoca: il libero commercio internazionale, regolamentato grazie alla
cooperazione internazionale istituzionalizzata, crea sviluppo e pace tra le Nazioni. Il libero
commercio internazionale però, presuppone che i Paesi adottino politiche funzionali al libero
mercato e ciò significa far esporre i Paesi ai rischi del mercato stesso. Per far fronte a questi
rischi furono istituite due organizzazioni finanziarie internazionali, e precisamente:
• Il Fondo Monetario Internazionale
Al Fondo Monetario Internazionale (FMI) furono affidati i compiti di controllare che i
Paesi aderenti rispettassero le regole concordate in ambito commerciale e finanziario e di
concedere prestiti ai Paesi che presentassero rilevanti deficit nella bilancia dei pagamenti.
Doveva quindi tamponare crisi congiunturali di breve periodo. Molti dei compiti del FMI
9vennero però meno nel 1971, quando gli USA posero fine al sistema dei cambi fissi (vedi
primo punto della trattazione);
• La Banca Mondiale
Il compito principale della Banca Mondiale (World Bank) fu inizialmente quello di
reperire le risorse finanziarie necessarie alla ricostruzione postbellica, in particolare in
Europa. Una volta assolto questo obiettivo, ha iniziato a finanziare progetti di sviluppo
nei Paesi del sud del mondo e dopo la caduta dei sistemi comunisti ha fornito prestiti anche
ai Paesi dell’Europa dell’Est.
Subito dopo gli Accordi di Bretton Woods, nel 1947 fu istituto il General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT), al fine di “contribuire alla riduzione delle tariffe doganali e degli
altri ostacoli agli scambi”. I risultati più concreti si sono ottenuti a partire dagli anni ‘60 con
il Kennedy Round e si stima che nel corso degli ultimi cinquanta anni le barriere tariffarie
siano state abbattute di ben il 90%. Solo nel 1975-80 con il Tokyo Round si è invece iniziato
ad affrontare il difficile nodo delle barriere non tariffarie mentre con l’Uruguay Round (1988-
94), i Paesi hanno convenuto il definitivo passaggio da un sistema di accordi internazionali
basato sulle tariffe e sui prezzi, ad un nuovo accordo che ha portato – nel 1994 - alla nascita
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO - World Trade Organization) dotata di
un’autonoma capacità giuridica di regolazione delle controversie relative al commercio
internazionale, con l’intento di:
• migliorare le condizioni di accesso ai mercati, attraverso la riduzione delle barriere
doganali;
• promuovere la concorrenza leale con i governi che possono imporre misure
compensative contro le forme di concorrenza sleale, quali il dumping e le sovvenzioni
alle esportazioni;
• sostenere le riforme economiche dei Paesi Emergenti per favorirne lo sviluppo
economico e commerciale.
Come già detto in precedenza, nel post Bellico la crescita del commercio globale venne
considerata un obbiettivo prioritario dai Grandi della Terra, nella piena consapevolezza che,
come recita il vecchio adagio: “se le merci non varcheranno i confini, lo faranno i carri
armati”. Il GATT prima, ed il WTO poi, favorirono pertanto lo sviluppo dei traffici
commerciali dei beni e dei servizi, uno dei driver più rilevanti della crescita economica globale
degli ultimi decenni. In realtà, come si osserva dal grafico sottostante, la vera accelerazione
negli scambi commerciali è avvenuta a partire dall’inizio del nuovo millennio.
10La ragione di tale sviluppo è da ricondurre ad una data spartiacque: l’11 dicembre 2001,
quando la Cina è entrata nel WTO. E’ un evento della portata storica, spesso dimenticato, ma
i cui effetti dirompenti si sono dispiegati fino ad ora nel sistema globale, alterandone gli
equilibri preesistenti. E’ ancora avvolto nel mistero il motivo che spinse i Paesi membri del
WTO ad accettare l’ingresso della Cina, dopo oltre quindici anni di anticamera. I passi avanti
fatti da Pechino infatti non risultavano affatto soddisfacenti per definire la Cina un’economia
di mercato, condizione ritenuta essenziale per l’ingresso nell’Organizzazione del Commercio
Mondiale. Quella decisione fu aspramente criticata da alcuni economisti, che misero l’accento
proprio sul fatto che alla Cina veniva offerto l’accesso al mercato globale, senza avere ottenuto
dalla stessa un’adeguata controparte, in termini di rispetto dei diritti dei lavoratoti, della
proprietà intellettuale, della libera concorrenza e dei limiti all’intervento pubblico nel sistema
economico privato. Nel 2005 Giulio Tremonti, in un intervento all’ASPEN a Firenze, non
esitò nel definire pazzi quelli del WTO, per la scelta di adesione cinese, affermando: “[..]
quell’apertura degli scambi sta producendo le sue ondate di ritorno, alcune importanti, altre
drammatiche”. In effetti la Cina portò nell’area di libero scambio 700 milioni circa di nuovi
lavoratori a costo infinitamente più basso rispetto a quelli Occidentali, con la diretta
conseguenza di attirare l’intero sistema capitalistico ad investire in essa, in primo luogo
delocalizzando le struttura produttive manifatturiere. L’impatto, come facilmente prevedibile,
è stato rilevantissimo: in un decennio la Cina si è trasformata nella manifattura del mondo
intero, con ripercussioni sul commercio globale: si veda il grafico sottostante, che mostra
l’esplosione dell’import (e del conseguente deficit commerciale) degli USA nei confronti di
Pechino.
11E’ difficile pensare che uno sconvolgimento di questo tipo potesse lasciare inalterati gli
equilibri macro e microeconomici preesistenti: l’impatto per i Paesi Occidentali è stato
significativo soprattutto su tre fattori:
• Supply chain: le catene di fornitura dei prodotti sono diventate più lunghe e
frammentate. Il capitale ha cioè dirottato le produzioni di ogni singolo componente
puntando al massimo efficientamento del prezzo, nella consapevolezza di poter
beneficiare dei vantaggi del cosiddetto “Villaggio globale”, cioè di un mondo sempre
più interconnesso;
• Prezzi: la riduzione significativa del fattore di produzione lavoro ha impattato in
primo luogo sui costi alla produzione, riducendoli, trasmettendo – pur in misura
inferiore – tale beneficio al consumatore finale;
• Occupazione: le delocalizzazioni verso la Cina di interi apparati produttivi ha
alimentato uno spostamento della forza lavoro dell’industria manifatturiera, con forti
impatti negativi per l’occupazione nei Paesi Occidentali.
Tali macro-fenomeni si sono inaspriti negli ultimi anni, favorendo un processo di iper-
globalizzazione. Essi hanno nel contempo prodotto una serie di conseguenze economiche e
sociali a livello sistemico, che sono state sintetizzate dal cosiddetto “elefante grafico di
Milanovic”, dalla forma della sua figura (vedi grafico sotto riportato).
Branko Milanovic, economista serbo-americano, ha osservato la variazione percentuale del
reddito reale della popolazione mondiale, distinta in percentili (dai più poveri ai più ricchi),
nel ventennio 1988-2008. Il risultato è il grafico a forma di elefante sopra rappresentato.
Milanovic ha riscontrato cioè che si è verificato un incremento significativo dei redditi reali
sia nei percentili minori (i più poveri – la parte retrostante dell’elefante, a sx nel grafico), che
in quelli maggiori (i più ricchi – la proboscide dell’elefante, a dx nel grafico); il punto dolente
è che la parte centrale nella distribuzione a percentili (la classe media – la parte anteriore ed
il volto dell’elefante, il centro del grafico) ha visto crollare la crescita del proprio reddito reale,
se non addirittura segnare un andamento negativo (nei percentili 75-85). E’ l’effetto dell’iper-
globalizzazione, i cui benefici – pur con modalità e distribuzione differenti – sono andati ai
più poveri del mondo, molti dei quali sono riusciti ad affrancarsi dalla fame ed ai più ricchi
del pianeta, che hanno visto le loro ricchezze aumentare sempre di più. A pagare il conto di
12tale processo è stata però la classe media dei Paesi Sviluppati, che – causa la precarietà del
posto di lavoro e/o la difficoltà di un reinserimento professionale attivo – ha visto schiacciare
il proprio reddito reale, cioè il proprio potere d’acquisto effettivo. A fronte di tale situazione,
non è sorprendente che proprio quella classe media, che rappresenta la percentuale maggiore
di popolazione nei Paesi Sviluppati, abbia mostrato un crescente malcontento verso la classe
politica, chiedendo una discontinuità nella gestione dell’economia globale. Tale indicazione
si vede chiaramente dal grafico sotto riportato, che sintetizza i dati di un’indagine promossa
nei principali Paesi del mondo nel 2018.
Ad un campione indicativo di cittadini, è stata posta la seguente domanda: “Ritieni che il tuo
Paese dovrebbe proteggere la sua economia in maniera più forte rispetto ai competitors
esteri?”. L’esito è stato clamoroso: il 70% della popolazione del mondo è a favore di una
maggiore difesa interna, contro un esiguo 13% che si dichiara contrario (il resto sono gli
indecisi); in Francia i protezionisti sono il 75%, negli USA e nel Regno Unito circa il 60%,
mentre negli Emerging la percentuale sale addirittura oltre l’80%. Si tratta di un segnale molto
chiaro del rifiuto dell’iper-globalizzazione, paradossalmente non solo in quei Paesi che ne
hanno subito le maggiori conseguenze negative, bensì anche in quelli che ne hanno tratto i
maggiori benefici. Si potrebbe quindi ritenere che alcuni fenomeni epocali, quali Brexit o
l’affermazione a livello globale delle cosiddette forze politiche populiste sia in qualche modo
da fare risalire all’elefante grafico di Milanovic e ad un rugetto nei confronti dell’iper-
globalizzazione.
4. L’avvento alla Casa Bianca del Presidente Donald Trump è stato accompagnato da uno
slogan: “Make America great again”. In effetti, a detta di numerosi osservatori politici, il
tycoon newyorkese è riuscito a diventare l’uomo più potente della Terra, grazie alla sua
capacità di parlare all’ “America profonda”, cioè al/la cittadino/a medio/a americano che,
sentitosi tradito dall’élite dominante, ha pagato il maggiore conto della Grande Crisi
Finanziaria. Dietro quello slogan, c’erano numerose proposte, ma tutte legate da un unico filo
conduttore: l’America, e l’americano, devono risvegliarsi dal torpore, per tornare a
rivendicare un ruolo, di supremazia globale, che a loro spetta. A qualunque costo! Nella sua
semplicità, è risultato vincente, perché in grado di arrivare in maniera diretta alla cittadino
medio statunitense. Nei rapporti con il mondo, Trump ha individuato uno dei grandi errori da
correggere: il deficit commerciale troppo alto degli Stati Uniti. Il ragionamento viene
13affrontato con la massima semplicità: gli Stati Uniti importano molte più merci e servizi dal
mondo rispetto a quanti ne esportano; ciò rende Washington debitrice verso il globo,
derubando posti di lavoro che vengono delocalizzati fuori dal territorio americano. E’ pertanto
necessario invertire tale rotta. Il messaggio di Trump, nella sua rudezza, colpisce direttamente
l’elemento che ha trainato il sistema economico mondiale: la globalizzazione o, quantomeno,
l’iper-globalizzazione selvaggia, senza regole. La maggiore parte degli osservatori riteneva
che, una volta raggiunta la Casa Bianca, l’atteggiamento del Presidente non avrebbe potuto
essere lo stesso, perché uscendo dalla campagna elettorale, avrebbe dovuto confrontandosi
con le difficoltà dei temi trattati, e con le pieghe dei loro formalismi. In realtà, sbagliandosi.
Trump inizia fin da subito ad attaccare gli Accordi commerciali multilaterali, prendendoli
come un’esemplificazione del danno che gli Stati Uniti avevano creato a loro stessi.
L’obbiettivo è rigettarli, rinegoziandoli attraverso accordi bilaterali. La strategia, pur brutale,
del Presidente americano, presenta una sua logica: meglio negoziare accordi bilaterali, in
modo da far sentire in essi tutto il peso dell’America, come prima potenza economica globale.
Alle parole, seguono i fatti. Il 27 gennaio 2017 gli Stati Uniti escono dall’accordo TPP (Trans
Pacific Partnership), firmato nel 2015 ed a cui aderiscono altri undici Paesi dell’Area Pacifica
(Canada, Giappone, Australia, Brunei, Cile, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù,
Singapore e Vietnam). Il 2 ottobre 2018, il NAFTA (North American Free Trade Agreement),
trattato di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico in vigore dal 1994, dopo numerosi
attacchi lanciati dall’Amministrazione americana, viene smantellato e sostituito dall’USMCA
(US-Mexico-Canada Agreement), in cui l’industria automobilistica a stelle e strisce ne esce
vincitrice. Esso infatti prevede che il 75% delle componenti delle auto siano prodotte nella
regione nordamericana affinché i prodotti non vengano sottoposti a regime di dazi; un’altra
clausola è che il 40-45% del veicolo sia prodotto da operai che guadagnano almeno 16 dollari
americani l’ora. Pochi giorni prima, il 24 settembre 2018, lo stesso Trump aveva firmato un
nuovo accordo commerciale con la Corea del Sud. Dalle parole del Presidente, si comprende
la sua soddisfazione ed i vantaggi per gli USA: "Il nuovo accordo - ha detto il capo della Casa
Bianca - apporta miglioramenti significativi all'accordo di libero scambio del 2012 perché
riduce il deficit commerciale tra i paesi e crea nuove opportunità per esportare prodotti Usa
nella Corea del Sud, dalle automobili ai prodotti farmaceutici, fino ai prodotti agricoli
statunitensi che otterranno un migliore accesso ai mercati coreani". In realtà, si tratta di scelte
tattiche, rivolte a Paesi comunque importanti per lo zio Sam, ma che fin da subito non riescono
a celare i target effettivi: si tratta delle Nazioni verso le quali gli Stati Uniti presentano rapporti
commerciali di massimo rilievo, naturalmente, in forte deficit. La strategia di Trump fatta a
colpi di messaggistica istantanea, è messa in chiaro in un tweet del 4 aprile 2008, sotto
riportato.
14Trump dice di non essere in una guerra commerciale con la Cina, perché essa è stata persa
molti anni prima, dai pazzi o incompetenti che hanno rappresentato gli Stati Uniti d’America.
Si tratta, sempre a detta del Presidente USA, di prendere atto che Washington ha un deficit
commerciale di 500 miliardi dollari con Pechino, subendo inoltre furto di proprietà
intellettuale per altri 300 miliardi dollari. La chiosa è tranchant: “Non possiamo permettere
che ciò continui!”. La logica dell’Amministrazione a stelle e strisce è disarmante, nella sua
semplicità, basandosi su dati che indicano con chiarezza i partners globali con i quali il
rapporto commerciale degli Stati Uniti risulta essere più sbilanciato.
Come si può facilmente osservare nella figura sovrastante, si tratta della Cina e dell’Unione
Europea. In particolare modo, verso Pechino, Washington vanta un poco ragguardevole
primato: un deficit commerciale annuo di circa 340 miliardi dollari. In linea con quanto
promesso, Trump mette in atto un attacco nei confronti del Celeste Impero, grazie
all’introduzione di dazi all’import, attuati attraverso una vera e propria escalation di tensione,
che è ben sintetizzata nella tabella cronologica sottostante.
15Si tratta della tattica della guerriglia, più che di una vera e propria guerra, in cui alle minacce
talvolta seguono le decisioni; in altre invece delle ritirate strategiche. In questa disputa,
l’ultimo colpo di scena risale a lunedì 25 febbraio scorso, quando Trump ha annunciato la
sospensione temporanea dell’imposizione di nuovi dazi commerciali sulle importazioni di
beni dalla Cina. In assenza di tale decisione, infatti dal 1 marzo sarebbero entrati in vigore
dazi aggiuntivi su beni cinesi (con un aumento dal 10% al 25%) per 200 miliardi dollari. Il
Presidente americano ha detto alla stampa che i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina
hanno fatto progressi sostanziali e che ciò avrebbe potuto portare ad un summit in Florida con
il presidente cinese Xi Jinping. Questione confermata anche dall’agenzia di stampa ufficiale
cinese Xinhua che ha parlato di rilevanti progressi nel negoziato, soprattutto per quanto
riguarda la protezione della proprietà tecnologica e l’agricoltura. Mentre si sta scrivendo, la
definizione di un accordo pare essere vicina; il 4 aprile infatti Donald Trump ha annunciato
che un’intesa potrebbe essere raggiunta "entro le prossime quattro settimane, forse qualcosa
di più o forse qualcosa di meno", senza però indicare se sia stato già convocato un summit. Il
vice premier cinese Liu He, ha invece detto che le due parti si stanno avvicinando ad un
accordo e ha definito gli ultimi incontri fruttuosi. In merito agli ambiti commerciali, le
indiscrezioni relative al “potenziale deal” indicano che Pechino dovrebbe abbassare dei dazi
recentemente introdotti ed alcune storiche barriere non tariffarie, in settori dalla chimica
all’agricoltura, dall’energia all’auto. In cambio, Washington si impegnerebbe ad eliminare del
tutto, o quasi, le ritorsioni introdotte dal 2018 su circa 200 miliardi dollari di import dal Paese
asiatico. I temi centrali, sui quali la discussione rimane accesa, e l’esito incerto, rimangono i
seguenti:
• Partnership nell’auto: la richiesta della Casa Bianca è che Pechino cancelli i limiti
al controllo diretto, da parte delle imprese straniere, al controllo delle partnership, in
particolare nell’automotive. Sarebbe inoltre necessaria una riduzione dei dazi
sull’import in Cina dei veicoli “made in US”, attualmente al 15%;
16• Stato ed aziende: Washington chiede una separazione più netta, in Cina, tra società
private e Stato. Il nodo riguarda di fatto il sostegno statale di Pechino alle grandi
imprese, a prescindere dal fatto che siano private;
• Proprietà intellettuale: La difesa del copyright e della proprietà intellettuale da
violazioni e furti viene ritenuta cruciale dalla Casa Bianca, a fronte dell’attuale obbligo
in essere di trasferimento di tecnologia, da parte delle società americane, ai loro
partners cinesi;
• Definizione delle dispute: dovrebbe nascere un nuovo meccanismo per la risoluzione
delle eventuali dispute sino-americane, ma i tratti formali dello stesso sono ancora tutti
da decidere;
• Energia ed alleati: una delle offerte più significative di Pechino a Washington è
l’acquisto di gas naturale per 18 miliardi dollari, della durata potenziale di un
decennio. L’eventuale deal farebbe però emergere il “tallone d’Achille” degli accordi
bilaterali, cioè gli effetti collaterali sugli altri partners commerciali. In tale caso, si
stima che ciò danneggerebbe in particolare modo gli interessi di Paesi alleati storici
degli Stati Uniti, quali Canada ed Australia.
In caso di accordo, si stima che Pechino potrebbe aprire le proprie frontiere ad un import di
circa 1.350 miliardi dollari nel prossimo lustro. Nonostante l’indiscutibile rilevanza di tali
numeri, alcuni osservatori sono scettici sull’esito favorevole dei negoziati. O, peggio, temono
che l’accordo si riveli solo un’intesa di immagine; una partita dalle cifre appariscenti, ma
giocata al ribasso che in realtà non esorcizzi le tensioni né assicuri effettivi e duraturi passi in
avanti nei rapporti Washington-Pechino. Questa visione prudente è stata confermata di fatto
dallo stesso Trump, che ha affermato: “…una volta che l’accordo venisse firmato, sarà
necessario che la Cina mantenga le promesse, altrimenti si tonerà alla rottura”. L’analisi dei
fatti porta in effetti ad osservare un livello diverso, rispetto all’ambito commerciale, nello
scontro sino-americano. A tale riguardo, risulta di interesse l’editoriale del numero di LIMES
del novembre dello scorso anno dedicato alla Cina. Dal titolo “Not a Chinaman’s chance”,
esso ancia un messaggio chiaro: “Cina e Stati Uniti stanno divorziando senza essersi sposati,
né mai avere sognato di farlo. Non sarà rottura pacifica, tantomeno concordata, malgrado le
rassicuranti recitazioni mediatiche, acrobazie diplomatiche, tregue tattiche. La posta in gioco
è troppo alta: la titolarità geopolitica di questo secolo. Da stabilire restano tempo, raggio e
intensità dello scontro [..] Chi continua a interpretare la partita sino-americana quale guerra
commerciale è fuori pista. Siamo nel preriscaldamento di un match al termine del quale uno
dei due contendenti vedrà drasticamente ridotto il suo status. Perché avrà perso la guerra o
si sarà ritirato per paura di perderla. Terza ipotesi: Stati Uniti e Cina si infliggeranno danni
tali da rendere poco appetibile la sorte del vincitore – forse dell’umanità. E’ quest’incubo a
frenare gli impulsi bellicisti a Washington e a Pechino. Ma cullarsi nell’illusione che la
degenerazione militare dello scontro sia esclusa significa sovrapporre il buon senso alla
sobria analisi di una crisi in avvitamento. Di sicuro non andrà secondo quanto cinesi o
americani possono oggi prevedere. L’energia sprigionata dalla collisione fra i due giganti è
incalcolabile. Mai nella storia la competizione per il primato del mondo ha visto un detentore
e uno sfidante di tanta taglia. Profondamente imbricati nella dimensione economica, ma
opposti nella geopolitica e totalmente alieni quanto ad etica e cultura…”.In linea con tale
17indicazione, è un articolo di Marco Valsania, pubblicato da Il Sole24 Ore il 30 novembre
2018, dal titolo “Ma la guerra vera viene combattuta per la leadership tecnologica”.
Anch’esso merita il riporto di alcuni tratti: “Il banchiere lavora per uno dei principali istituti
americani e adesso sorseggia tranquillo un aperitivo in un grattacielo di Manhattan. Ma il
suo pensiero è ancora rivolto alla Cina, da cui è appena tornato. E quando ne parla,
chiedendo l’anonimato, fatica a non tradire la meraviglia: descrive la grande avanzata, i
balzi tecnologici della potenza asiatica anche nella finanza; dai servizi al consumo per
pagamenti ai trasferimenti dei fondi; tutto interamente sui network mobili, via smartphone,
senza cash, conti correnti, carte di credito sostituiti da ecosistemi digitali targati Alipay,
costola di Alibaba, o WeChat di Tencent. Vede un futuro plasmato a Pechino e Shanghai
quanto o più che sull’asse New York, Washington e Silicon Valley. E’ un esempio rivelatore
della grande e complessa sfida sotterranea in corso tra le due principali potenze al mondo,
che appare assai più intrattabile e duratura delle schermaglie economiche e commerciali
esplose in superficie tra Stati Uniti e Cina. Una sfida che precede Donald Trump e la sua
dottrina di America First e che probabilmente sopravviverà a lui – e a eventuali tregue. E’
una gara con in palio il primato hi-tech. Intelligenza artificiale, robotica, biotecnologia,
nano-ingegneria, nano-manifattura, integrazione tra economia reale e digitale. L’analisi di
Valsania entra nel merito del tema, con precisione: “Più che delle dichiarazioni della politica,
gridate o scritte, le radici di questa sfida affondano così nelle strategie ed azioni economiche.
Pechino ha messo in campo il piano industriale Made in China 2025, inteso a stimolare una
leadership in dieci settori d’avanguardia nell’hi-tech aumentando la percentuale di content
locale del 70% entro quel traguardo. Una parallela road-map tecnologica prescrive
autosufficienza nei veicoli di nuova generazione e elettrici come nei robot industriali, nei
sistemi aerospaziali e nei chip per il “mobile”. Abbastanza da rappresentare, ha concluso il
Council of Foreign Relations, una “minaccia esistenziale alla guida americana nel tech” [..]
Washington ha risposto aumentando le difese. In estate l’Ufficio della Casa Bianca dedicato
alla politica commerciale e manifatturiera ha dato alle stampe un rapporto significativamente
intitolato “all’aggressione economica cinese” e alla sua minaccia “per tecnologie e
proprietà intellettuali statunitensi e mondiali”: denuncia furto e spionaggio, strategie quali
il forzato trasferimento di tecnologie per avere accesso al mercato locale, e investimenti in
sei anni per 20 miliardi in oltre 600 asset hi-tech degli Stati Uniti. E’ stato seguito dalle 525
pagine della US China Economic and Security review, prodotta dal Congresso nelle ultime
settimane, forte di 26 raccomandazioni tra cui, accanto a generali strette di sicurezza,
intelligence e difesa, ci sono specifiche misure economiche: da verifiche annuali di
vulnerabilità nelle catene di fornitura legate alla Cina a ricorsi contro pratiche distorsive
degli scambi in seno al WTO, dalla protezione delle nuove reti mobili di tlc 5G da rischi posti
da tecnologie cinesi, al riesame di collaborazioni tecniche. Se questo disagio ha trovato
espressione anche nelle prese di posizione su deficit commerciale e dazi, il confronto-scontro
sempre più concreto e dalle incerte conseguenze si è manifestato sulle frontiere aziendali: lo
scorso marzo (2018, per chi legge) la Casa Bianca ha bloccato nei microchip – comparto
strategico per entrambi i Paesi – l’acquisizione da 117 miliardi dell’americana Qualcomm
da parte della Broadcom di Singapore, per i troppo stretti rapporti di quest’ultima con
Pechino. Più di recente ha stretto d’assedio la cinese ZTE, produttore di smartphone e
attrezzature tlc, mutilandola per violazioni dell’embargo a Iran e Nord Corea e portandola
18sull’orlo della chiusura. Trump si è poi mosso contro un altro gigante cinese delle tlc, Huawei,
bloccando acquisti delle sue tecnologie wireless, sospettate di porre rischi alla sicurezza
nazionale, spionaggio e furto dei dati. E ha lanciato una campagna, per convincere gli alleati,
europei e non, a fare altrettanto”. Lo scontro tra Stati Uniti e Cina è quindi sulla leadership
globale, in termini economici, militari e finanziari. Ma lo è soprattutto in termini tecnologici,
in quanto il dominio della trasmissione dei dati super veloce e della sua infrastruttura (il 5G)
porterà ad un vantaggio competitivo senza precedenti. E’ anche per questo che i due
contendenti hanno deciso di investire massicciamente nell’Artificial Intelligence (AI),
interpretando alla lettera il postulato del Presidente russo Putin, secondo il quale “chi
dominerà l’AI, dominerà il mondo”.
Ed è sotto questa luce che va visto lo scontro di Trump verso Huawei, il colosso cinese che su
scala globale sta costruendo le reti 5G. Pare, senza esclusione di colpi: il 7 dicembre 2018 è
stata arrestata in Canada Meng Wanzhou, CFO del gruppo e figlia del gruppo cinese delle
TLC, sui cui pende la richiesta di estradizione americana, la cui Giustizia l’accusa di avere
violato le sanzioni contro l’Iran. Per Pechino e Huawei si tratta di un atto motivato da ragioni
politiche, di fatto sostenendo implicitamente la tesi di una partita molto più ampia che riguarda
lo sbarramento americano rispetto al tentativo del colosso cinese di gestire il sistema di
raccolta dei dati più sensibili, a livello globale. Una conferma a riguardo è arrivata anche da
IHS Markit, global information provider londinese, che ha dichiarato: “Il controllo della
tecnologia 5G comporta potere ed interessi inestimabili. Chi arriva prima con le nuove reti e
chi fissa gli standard globali si garantisce un vantaggio competitivo che durerà decenni”.
5. La visita del Premier cinese Xi Jinping, avvenuta nell’ultima decade del mese di marzo, ha
segnato un potenziale punto di svolta nei rapporti sino-italiani. Ciò è avvenuto in quanto
l’Italia è stato il primo Paese del G7 a rendersi disponibile alla firma di un accordo con
Pechino, riguardo allo sviluppo della “Belt&Road Initiative”. Si tratta di un progetto, anche
chiamato “Nuova Via della Seta”, che si pone come obbiettivo lo sviluppo di una rete di
collegamento, via mare e terra, tra la Cina e l’Europa, finalizzata al miglioramento dei rapporti
di interscambio commerciale, come osservabile nella figura sotto riportata.
19Puoi anche leggere