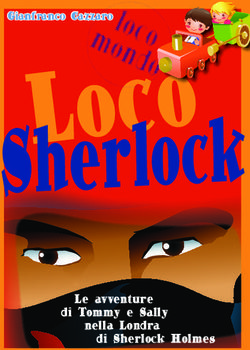Mio fratello Mattia Muscatello - The Wall - Scuola Holden
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Sinossi:
Ettore vive con la madre nella periferia di Torino e lavora con lei nel bar che hanno preso
in gestione. Enea, il fratello minore, torna dall'India senza bagagli e senza soldi. La madre
è la prima ad accoglierlo freddamente sul portone di casa ed Ettore cerca di fare da
mediatore nella difficile comunicazione tra madre e fratello. La sera del ritorno, Enea esce
con i vecchi amici e non rientra a casa. Ettore, spinto dalla madre, esce a cercarlo e lo
ritrova in mezzo alla strada in un lago di sangue: è stato picchiato da alcuni spacciatori a
cui doveva dei soldi da prima di partire, Ettore quindi lo porta al pronto soccorso. Da quel
momento i due instaurano un rapporto di complicità, riportando alla luce vecchi ricordi.
Enea senza lavoro cade in depressione ed Ettore gli propone una gita al fiume. Durante
l’uscita, Enea racconta finalmente al fratello i suoi problemi di droga e il tentativo di
suicidio in India, parla di vecchi traumi irrisolti come l’abbandono del padre e il peso della
competizione nei confronti di un fratello “perfetto”. A questo punto Enea, senza denaro,
propone al fratello un ultimo colpo per rimediare dei soldi con la vendita di una partita di
droga. Ettore depresso per l’abbandono da parte di Bianca, sua ragazza storica, si lascia
quasi convincere a causa del momento di debolezza. Ettore, ritornato in sé, si rende conto
che non farebbe mai una cosa del genere e, tornando a casa dopo una giornata al bar,
racconta tutto alla madre. In un raptus violento Enea colpisce in testa Ettore e scappa.
Ettore furioso, dopo aver percorso la stessa strada che all’inizio della storia lo ha portato
a salvare la vita al fratello, lo trova sul cornicione di un ponte: da quel momento ha
un’amnesia e non saprà mai se Enea è caduto dal ponte a causa di un incidente oppure si
è suicidato.
“Chiedo scusa per quello che ho scritto,
per ciò che è omesso
e non ho dimenticato”
Marcel Proust, La Recherche
Intro - Lost Boy
In seguito, ho cercato a lungo di ricostruire i fatti, ancora oggi provo a ricordare le ultime
parole che avevo rivolto a mio fratello. Di quello che è successo prima e di ciò che è stato
dopo ricordo tutto, ogni minimo particolare, ma incredibilmente, ogni volta che cerco di
ripercorrere quel preciso istante, il ricordo sfuma in suoni ovattati e immagini
inconsistenti. Per anni ho cercato di aggiungere pezzi alla mia storia, non che fosse
necessario, per me era importante capire come erano andate realmente le cose e perché
proprio in quel modo.
Mio fratello è tornato a casa il 21 novembre, intorno alle dieci del mattino. Mia madre era
troppo sconvolta per ricordare l’ora esatta. L’ha incontrato per strada, mentre usciva da
2casa per venire a lavoro, lui aveva citofonato e si era nascosto dall’occhio della telecamera
di sicurezza che dava sul portone d’ingresso. Non vedendo nessuno sullo schermo in
bianco e nero, mia madre ha pensato al postino o a uno scherzo. Ha ripreso la serie di
azioni meccaniche per arrivare fino al marciapiede, dov’era parcheggiata la Panda verde
lime ereditata dal nonno esattamente quindici mesi prima, quando mio fratello era partito.
Si sono ritrovati inaspettatamente uno di fronte all’altro: lui, accovacciato dietro
l’automobile, è scattato in piedi e lei, immobile col mazzo di chiavi in mano, intenta ad
aprire la portiera. Sono rimasti in silenzio. Colmare una distanza che fino al giorno prima
era di 8.602 chilometri equivaleva a qualche secondo di pausa.
- Non dici nulla?
- Non aspettavo di vederti.
- Non sei contenta?
- Non hai nemmeno avvertito.
- Volevo farvi una sorpresa.
- Hai bisogno di soldi? - ha detto lei indicandogli i piedi nudi.
Probabilmente mio fratello si era immaginato un’accoglienza diversa. Nessun vitello
grasso è stato sacrificato, nessun banchetto in onore del suo ritorno. Si è presentato coi
capelli lunghi, schiariti dal sale dell’Oceano Pacifico e dai colpi di sole dell’emisfero
Australe. Capelli portati all’indietro con una fascia elastica dai colori lisergici,
probabilmente comprata su una bancarella fricchettona sulla spiaggia di Kerala, dello Sri
Lanka o di Bangkok, non ne ho idea. Non aveva né i bagagli né le scarpe, solo una folta
barba non curata. Mia madre sconvolta non tanto per la sorpresa di trovarselo lì, senza
preavviso, quanto per un incubo che aveva fatto poche notti prima. In quel sogno
camminava per Corso Vercelli e a un certo punto vedeva il figlio minore dormire sui
cartoni.
- Puzzava come i sacchetti dell’umido d’estate e non aveva le scarpe - aveva detto il mattino
seguente, con gli occhi lucidi e trattenendo le lacrime come sempre. La cosa assurda è che
mio fratello si è presentato come nel sogno. In realtà non proprio senza scarpe, aveva degli
infradito logori, fatti di foglie di banano intrecciate, non puzzava e non mostrava segni di
decadenza fisica, anzi. Aveva la pelle colore del cuoio e profumava di curcuma. Indossava
un camicione di cotone indiano con i bottoni in legno da cui si intravedevano i muscoli e
pantaloni larghi da yoga colore del chakra della radice (così ha detto), e sfoggiava un sorriso
a trentadue denti, di quelli veri che sembrano finti. Cioè, non ho mai capito questa cosa
dei sorrisi di mio fratello, sembrava fingesse anche nei momenti in cui pareva impossibile.
Si notava soprattutto dalle fotografie. Appese al frigorifero con i magneti, ce n’erano
alcune di lui da piccolo dove sorrideva in modo naturale poi, crescendo, è come se avesse
disimparato. Enea era così bello da sembrare uscito dal mondo patinato della televisione,
tanto che i parenti cercavano di convincerlo a farne parte con facili lusinghe.
3- Si’ proprio bell! Devi andare da Maria! – dicevano, con accento napoletano mitigato dal
piemontese, tipico delle famiglie meridionali emigrate a Torino durante il boom
economico della FIAT. L’idea di provare a sfondare nella televisione non l’aveva mai
sfiorato, anche se nei momenti di maggiore sconforto pensava che in qualche modo
avrebbe dovuto sfruttare quella sua fortuna, che a volte considerava una condanna.
Quindi mio fratello stava bene, ma in fondo mia madre sperava di no. Forse perché così
si sarebbe finalmente fermato, avrebbe accettato un lavoro qualsiasi e nel frattempo
avrebbe preso quel benedetto diploma da perito meccanico, smettendo di cacciarsi nei
guai. Mia madre ragionava in quel modo per far fronte a un senso di impotenza. Voleva
tornare mamma chioccia per un Peter Pan mai cresciuto, un figlio che cercava la sua
indipendenza attraverso i viaggi, privandola così dell’ultimo senso che dava alla vita,
l’ultima speranza di esercitare controllo su di lui. Ma questo non posso saperlo e
probabilmente lei non lo ammetterebbe mai.
L’accoglienza che Enea si aspettava è arrivata la sera, quando ci siamo incontrati dopo la
chiusura del bar. Gli ho chiesto come stava stringendolo forte e a lungo sul pianerottolo
di casa.
- La mamma non mi ha salutato così. Ha parlato subito di soldi, capisci? Sempre e solo di
soldi sa parlare.
Ho esitato, ma non troppo.
- Sarà stata sorpresa di vederti. Forse ha accusato il nuovo look – ho detto guardandolo
da capo a piedi.
Ero stato avvertito del suo arrivo da una chiamata cui inizialmente avevo risposto con un
semplice - sto lavorando, me lo dici quando arrivi -, ma che poi non ero riuscito a liquidare.
Subito dopo ho telefonato a Bianca, le ho comunicato la notizia e detto che non sarei
passato più a trovarla per stare un po’ con lui.
- Non ho solo cambiato look. Poi ti racconto.
Per un attimo ho creduto che non avrebbe spiccicato una parola, come al solito, e sarebbe
stato un vero peccato perché in fondo aspettavo un resoconto del viaggio, aneddoti
divertenti, racconti di scopate pazzesche con ragazze dai nomi esotici, esperienze spirituali
impensabili, magari anche qualche concerto sulla spiaggia. Perlopiù speravo di strappare
informazioni riguardo gli ultimi due mesi. Poi ho pensato che avrei voluto incontrarlo per
primo.
- Mi ricordi una canzone dei Be Forest, si chiama Lost Boy mi pare. La conosci?
Ha tirato fuori lo smartphone da una sacchetta in pelle che portava a tracolla, ha digitato
il titolo su Spotify e avvicinato il telefono all’orecchio destro attraversato da un dilatatore
di bamboo. Dopo qualche secondo di ascolto il giudizio:
- Spaccano! Mi ricordano gli Alt-J e gli XX, ma molto più tribali.
4- Pensa che sono italiani – ho risposto. Non aveva perso l’orecchio. Tutto ciò che
riuscivamo a comunicarci era una manciata di titoli, album e artisti. E dire che avevo
provato in ogni modo ad avvicinarmi a lui prima che partisse, soprattutto con la musica,
credo. L’unica lunghezza d’onda che cavalcavamo insieme era quella delle melodie
distorte, dei beat sincopati, dei bassi avvolgenti, come quelli della canzone che continuava
a suonare dalle casse del suo smartphone.
- Hai cambiato telefono? – ho detto notando l’I-Phone.
- Sì, è nuovo. L’ho preso a Bangkok, l’altro l’ho perso.
- Ecco perché non riuscivo a chiamarti.
- Ah, sì. Ho un nuovo numero – ha concluso in fretta.
- Comunque ti vedo bene.
- Mai stato meglio - ha risposto sorridendo. Gli ho creduto.
Quella sera non ha raccontato nient’altro. È uscito con i suoi amici poco prima che finissi
la doccia. Offeso e stanco com’ero sono andato a rilassarmi in camera, sdraiato sul divano
letto. Pensavo che paradossalmente avevo più notizie di lui quando eravamo lontani, fino
all’assenza di sue notizie. Quando era in India videochiamava spesso, soprattutto la sera
finito il turno alla piantagione di cocco, dopo dieci/dodici ore di raccolta.
- Non puoi capire cosa è successo oggi. Per poco un ragno gigante non mi assaliva.
Mi aveva raccontato dallo schermo dello smartphone, seduto su una panca di legno in
veranda. È sempre stato aracnofobico. Quando si alzava il vento vedevo dalle finestre le
zanzariere svolazzare. Lui stava lì, a bere birra in lattina e fumare Bidi, sigarette indiane
avvolte nelle foglie di tabacco secco. In quell’ostello vivevano in quaranta tra cinesi,
taiwanesi, australiani ed europei. Ogni tanto Enea mi mostrava il tramonto che filtrava da
dietro le palme della foresta pluviale, stavamo in silenzio e per qualche minuto ci
godevamo i colori della sera riempire gli spazi d’ombra tra un albero e l’altro, il canto degli
uccelli tropicali nascosti nel buio, o il ronzio degli insetti giganti.
Una volta mi aveva chiamato dalla spiaggia di Kerala, aveva un cappello blu da pescatore
e una noce di cocco spaccata in mano, dalla quale beveva con una cannuccia colorata.
- Com’è lì il latte di cocco? - gli avevo chiesto.
- Buonissimo, ma non è latte di cocco – aveva risposto senza pensare. Poi ha continuato:
- Non ho mai vissuto un’esperienza così bella, sono felice ma nello stesso tempo sono
triste. So che tutto questo prima o poi finirà – mi ha detto, seduto su un tronco che
spiccava scuro sulla sabbia bianchissima.
- Goditela, finché sei lì. – avevo risposto.
- Forse per gli incubi – aveva aggiunto – ma da quando sono qua sono sempre meno
frequenti – poi aveva sorriso.
5In quel momento avevo sperato si innamorasse di una ragazza, trovasse un buon lavoro o
qualsiasi cosa che potesse prolungare la sua permanenza in quei luoghi. Il nostro rapporto
era cresciuto giorno dopo giorno e anch’io cominciavo a star meglio a Torino. Ero felice
e poi mi sentivo in colpa. Ora il bar girava meglio, io e mia madre avevamo ripreso a
dormire.
Mentre ricordavo quei momenti sbucciavo un mandarino, il primo della stagione. Gli oli
essenziali si sprigionavano dalla buccia butterata, diffondendo un aroma piacevole e
inconsistente tanto da volatilizzarsi in un attimo, lasciando nell’aria un odore di frescume.
In piemontese “frescume” è l’odore di umido, di bicchieri che puzzano d’uovo o di cane
bagnato. La stanza era piena di oggetti, tutti miei. Quelli di mio fratello li avevo messi in
una scatola in garage. Avevo cambiato anche disposizione dei mobili e tinteggiato,
dall’arancione che aveva accompagnato tutta la nostra infanzia/adolescenza, ero passato a
una tinta grigio chiaro per il soffitto e tre pareti, mentre per la quarta avevo scelto un blu
petrolio. Avevo sviluppato una sorta di dipendenza da quel colore, aveva il potere di
calmarmi. L’impianto stereo collegato allo smartphone suonava limpido, riempiendo il
vuoto tra una pila di libri e una di vecchi manga, tra la coppola consunta del nonno e una
bottiglia di gin vuota trasformata in abatjour. Avevo l’impressione di essere collegato
anch’io a tutti quegli oggetti cui in qualche modo volevo bene. Ho chiuso gli occhi
cercando di far scivolare via quella sensazione di delusione e dopo qualche minuto mia
madre ha aperto di colpo la porta della camera, con il telefono stretto in mano. Ero
sdraiato sul letto a fissare la parete blu, mentre ascoltavo la canzone che avevo suggerito a
Enea poche ore prima, avevo pensato di creare una playlist di canzoni che avrei voluto
fargli ascoltare. Da piccolo registravo su musicassetta le canzoni che passavano in radio,
poi le regalavo a lui. Usavo lo stereo di mio padre, era uno strumento gigantesco e
affascinante, formato da due grandi blocchi mangiacassette con i tasti meccanici in fila
sotto una finestrella, dalla quale vedevo girare le ruote dentellate e il nastro magnetico
riavvolgersi. A testimoniare l’esistenza di mio padre erano quello stereo e il suo nome.
Lino. Poco più che un suono. Ogni volta che premevo un pulsante lo stereo si azionava
con un sordo clack. Il tasto rec. e rewind erano i più consumati. Già allora credevo che
quelle cassette mio fratello non le avesse mai ascoltate.
- Vai a vedere dov’è, per favore -, mi ha detto.
Le ho risposto di non preoccuparsi, che sarebbe tornato presto.
Track 01 – Heroin
Tre ore più tardi ho preso il cellulare, il portafogli e le chiavi della Panda. Ho chiuso la zip
della giacca di pelle pizzicandomi il mento senza avvertire dolore. Mentre montavo in
macchina pensavo a dove cercarlo: era a piedi e senza scarpe, non avrebbe potuto
6allontanarsi più di tanto a meno che non gli avessero dato un passaggio, ma conoscendo i
suoi amici non dovevo preoccuparmi di questo. Al primo incrocio non ho dato la
precedenza e per poco finivo contro una Jeep nera. Ho deciso di darmi una calmata.
La mia auto, nonostante fosse un modello piuttosto moderno, aveva montato su ancora
lo stereo col lettore cd. Niente Bluetooth, niente aux, niente usb. L’ho acceso. Per fortuna
ho beccato i Velvet Underground. Non li sopportavo più, ma poteva andarmi molto
peggio, anni fa mia madre ascoltava solo disco dance anni 70/80. Da adolescente credevo
addirittura che quella band fosse più importante della mia famiglia. Quindi ho lasciato il
disco, non avevo voglia di cercarne un altro rischiando non funzionasse, spesso erano
masterizzati o rigati.
Ero partito da Barriera di Milano, Corso Vercelli è lungo circa cinque chilometri e
attraversa quattro quartieri di Torino nord. Ogni cento/duecento metri rallentavo,
controllavo se all’interno dei bar H24 c’era una figura esotica ma familiare. Niente.
Arrivato all’incrocio con via Botticelli una puttana ballava ondeggiando il culo con le mani
in tasca. Probabilmente moriva di freddo. Aveva delle lunghe treccine che le sfioravano le
natiche coperte dagli shorts bianchi, le gambe affusolate da giovane cerva. Forse era
africana. Non ricordavo l’ultima volta che avevo fatto sesso e ho stretto forte le mani sul
volante. In compenso a ventisei anni avevo iniziato a fumare. Sigarette rollate, Golden
Virgina verde, un tabacco umido difficile da girare, molto aromatico. Ora sono passato al
Senza nome bianco. Sulla scheda del dentista sono sempre indeciso se crocettare sì o no
sulla casella fumatore, ne giro al massimo due al giorno e non sempre, a eccezione del
weekend. Alla fine segno sempre sì, penso che in ogni caso il dentista se ne accorgerebbe,
non avrebbe senso mentire. Sigarette.
Ho iniziato a fare la ronda per i tabacchini della zona. Se l’avessi trovato ai distributori
automatici avrei potuto comprare un pacco di Golden e proporgli di fumare l’ultima per
stare un po’ insieme prima di tornare a casa. Poco più avanti ho incrociato un paninaro
infreddolito che si sfregava le mani. Sul camper/panineria c’era scritto “Da Mimmo”.
Probabilmente Mimmo era il dirimpettaio di Amhid o Mohammed, ovvero l’attuale
proprietario del camper. Mimmo si era stufato di prendere del freddo alle quattro di
mattina oppure era andato in pensione. Per come andavano le cose probabilmente la
prima. Anche lui aspettava clienti, ma almeno aveva le piastre accese. Mi chiedevo se
cucinare il maiale e vendere birre a terzi gli era concesso. Credo di no, ma dio, ragionando
sulle regole, non aveva pensato al futuro e all’effetto ridicolo che avrebbero comportato,
lo stesso delle serie fantascientifiche o distopiche tipo Black Mirror, viste anni dopo essere
state girate.
Una sirena in lontananza mi ha scosso, speravo non fosse per lui. Ho riportato l’attenzione
alla strada e ho deciso di tentare con un’ultima ronda: a ogni incrocio controllavo se, tra
le silhouette nere sul marciapiede, c’era anche Enea. Gli spaccini erano soli o in piccoli
gruppi, li potevi trovare in qualunque periodo dell’anno: col gelo nelle ossa o col sudore
acre, un odore che sapeva di cibo speziato, che evaporava dalla pelle nera. Immobili,
voltavano la testa come gufi al passaggio delle automobili, aspettando il loro uomo.
D’altronde i gufi non sono quello che sembrano, ho pensato.
I muri in quella zona erano diventati una bacheca a cielo aperto dove i residenti postavano
pensieri e critiche. Palazzi tappezzati di scritte come “DIGOS BOIA” e “RELAX, TAKE
IT ISIS”. Condividevano storie, disegni, amori, a volte anche musica. “Space Oddity” e a
7fianco il disegno stilizzato di una canna accesa, “Anarquia Tropical”, una semicitazione
inaspettata del maestro Conte. Qualche frase in arabo, anche un “mi manchi… Io non ti
dimentico” firmato @livi97.
Mia madre prendeva le cose sempre troppo tragicamente, mi stavo facendo condizionare.
Uscendo di casa l’avevo rassicurata, dopo tutto quel tempo era normale che Enea non
vedesse l’ora di salutare i suoi amici, ho aggiunto che dall’aspetto sembrava stesse bene.
The Velvet Underground & Nico suonava il lato B, stavo ascoltando le chitarre molli e i
colpi di grancassa incalzanti, sempre più frenetici di Heroin mentre svoltavo dall’arteria
principale verso viuzze secondarie. La mia guida seguiva il ritmo della canzone, la
ripetizione ipnotica della melodia mi portava in uno stato di leggera trans meditativa. Va
tutto bene, pensavo, non gli sarà successo niente, mia madre esagera.
Poi in una piazzetta dove avevano appena aperto un Domino’s Pizza, ho trovato mio
fratello in ginocchio, circondato da ragazzi in tuta d’acetato, bomber e cappellini dalle
visiere piatte. Quando si sono accorti dei fari dell’automobile sono scappati in ogni
direzione. Mio fratello sembrava un cristo sulla via crucis, il volto e i vestiti pieni di sangue.
Dallo zigomo sinistro fracassato sgorgava sangue. La casacca di cotone indiano sembrava
una garza emostatica, per un attimo ho pensato che gli avessero sparato. Ho vacillato in
una vertigine di paura ma in quel momento non potevo permettermi di svenire. Una
scarica di adrenalina ha attraversato il mio corpo e ho iniziato a rincorrere uno dei tizi in
fuga. Rendendomi conto dell’inutilità di quella reazione sono tornato da mio fratello. Era
immobile e si guardava le mani. Mi sono diretto verso la macchina e ho aperto il baule.
Dentro c’erano due bacchette d’acciaio che mia madre aveva comprato per quelle stupide
camminate di gruppo in collina. Ne ho lanciata una sull’asfalto vicino a lui. Gli ho urlato
di prenderla, che dovevamo spaccargli la faccia.
- Lo merito – ha detto, guardando la bacchetta.
- Che cazzo dici? Alzati che li spacchiamo quei figli di puttana!
- Non capisci – ha detto, con gli occhi fissi davanti a sé.
- Li ammazzo quei bastardi, li ammazzo!
Intanto la canzone si concludeva e i fari dell’automobile ci illuminavano. Si stava
consumando uno dei drammi più banali della storia del cinema poliziottesco, eppure mio
fratello sembrava aver raggiunto il Nirvana con la sua calma del cazzo e i suoi modi da
santone indiano. Il guru di Barriera di Milano, il messia della periferia. Io invece mi
comportavo come una scimmia che lancia urla primitive come pietre smussate nel buio
dei viali di cemento, come se qualcuno stesse assistendo a quel ridicolo spettacolo.
Tornato in me l’ho portato al pronto soccorso. Era domenica mattina, la cassetta era
ricominciata da capo e da quel giorno non l’ho più riascoltata.
Track 02 – Dear Prudence
Quella sera la ricordo bene, avevo deciso di scrivere a mia madre. Aspettavo una risposta
da Bianca, le avevo chiesto di fare due passi fino alla Gran Madre per prendere del fresco
così finalmente saremmo riusciti a vederci fuori dal bar. Un vento caldo come un phon
8introduceva il suono delle campane della parrocchia Passione di Cristo, era una vuota sera
d’estate. Torino in agosto era particolarmente calma, la gente scappava dalla città per non
soffrire il caldo. Di giorno l’asfalto accumulava calore fino a diventare rovente, rendendo
le serate afose.
Ero rimasto in città, avevo acceso la radio e cambiavo canale alla ricerca di una melodia
interessante o quantomeno familiare. Radio 2 aveva deciso di sorprendermi passando Dear
Prudence, la seconda canzone dell’Album Bianco dei Beatles, che tutt’ora non stanca mai.
Avevo strappato una pagina da un’agenda, una di quelle che regalano le banche quando
chiedi un prestito, con la copertina morbida marrone che ricorda tutto a parte la vera pelle.
Avevo trovato una bic dalla punta sporca nel cassetto della credenza di noce. Mio nonno
faceva il falegname e l’aveva costruita come regalo per il primo matrimonio di nostra
madre, come il resto dei mobili che arredavano l’appartamento. Mamma diceva sempre
che era un gran lavoratore, venuto da Napoli con la valigia di cartone (che ho visto in
seguito in cantina di casa sua) e dieci lire da restituire al padre. Era riuscito, dopo anni di
sacrifici, ad aprirsi una falegnameria. Seduto in cucina avevo iniziato a scrivere.
Cara mamma,
questa cosa di scrivere una lettera mi sembra davvero strana. Viviamo nello stesso appartamento,
lavoriamo insieme al bar, e gli unici momenti in cui potremmo chiacchierare li sprechiamo a parlare di
lavoro e rotture di coglioni, tanto che temo quei tempi morti, tanto che cerco sempre qualche bicchiere da
lavare, o una bottiglia da spolverare. Il fatto è che in questo momento sto ascoltando una canzone e il sole
è in quel punto del cielo il cui le ombre si allungano. Ho pensato di scriverti un biglietto, una specie di
lettera per trovare la forza di chiederti come stai. Che poi è una stronzata perché, cosa mi aspetto? Che tu
la legga, prenda carta e penna e tra uno sbattimento e l’altro mi scriva una risposta che puoi
tranquillamente darmi a voce, se solo avessi il coraggio di chiedertela. Ora che Enea se n’è andato, almeno
posso tentare di cacciare via questa sensazione che provo non so più nemmeno da quanto. Come quando
hai trangugiato alcol come un cretino, e ti maledici perché sai esattamente dove andrai a finire. E mentre
sei abbracciato al cesso a ruttare vomito e bestemmie, ti rendi conto che sei lì per eliminare tutto quello che
hai accumulato da troppo tempo fino a bloccarti anche i pensieri. Ecco, questo biglietto servirà a sboccare
ciò che avrei potuto digerire distillandolo goccia a goccia ogni giorno. Il punto è che ho sempre pensato che
durante questo brutto periodo dovessi essere io quello forte. L’ho capito la sera in cui a cena hai detto seria
a Enea: “Sai una cosa? Non sono più orgogliosa di te”. L’hai detto senza rabbia, con la voce piena di
vibrante tristezza, come se la delusione avesse ucciso ogni speranza. Forse è anche per questo che se n’è
andato, non voglio dire che sia colpa tua, non voglio infierire. Ma ora sento come se potessi permettermi di
mollare la presa, e parlare. Tu non molli, invece, a quanto pare sei più lucida di me.
Sarà sempre a causa di questa canzone, ma volevo dirti che in fondo penso che la sua partenza sia stata
un bene. Ha fatto bene per sé e per noi. Vedrai che d’ora in poi andrà tutto bene.
Ettore
9Ettore e Enea. La strana la decisione di nostra madre di chiamarci come due eroi
dell’Iliade. Non era particolarmente istruita né lettrice, probabilmente quei nomi erano
l’unico ricordo della scuola primaria, quando studiava Epica e stava evidentemente dalla
parte dei Troiani. Forse aveva scelto quei nomi per darci un tono “aristocratico”, i bambini
di Barriera si chiamavano tutti Bruno o Nicola, peggio ancora Maicol o Braian scritto
all’italiana.
Avevo piegato il biglietto e appeso al frigorifero con la calamita di Amsterdam. Bianca
aveva risposto che ci saremmo incontrati alle nove. Avevo sorriso e dopo qualche minuto
ero tornato in cucina, avevo ripreso in mano il foglio e poi stracciato. Niente biglietti, le
avrei parlato. Solo che quella sera mia madre aveva ricevuto la notizia della morte del
nonno.
Track 03 – Stuck In The Middle With You
Enea sorrideva seduto sul lettino in fondo allo stretto corridoio del pronto soccorso, con
le mani abbandonate sul lenzuolo bianco che gli copriva le gambe, manco fosse un
infermo. L’odore di sangue rappreso si diffondeva dalla sua camicia per le stanze del San
Giovanni Bosco.
In silenzio al suo fianco, attendevo dicesse qualcosa. Esattamente sotto l’occhio sinistro
punti di sutura neri e spessi si annodavano ad avvicinare i lembi di pelle che ricoprivano
lo zigomo ammaccato. Il colpo aveva scalfito l’osso; i medici avevano estratto la scheggia
spiegando che sotto la cicatrice sarebbe rimasto il solco. Sembrava un cazzo di pirata.
Strano come oggi quella cicatrice a forma di fulmine manchi così tanto.
La testa mi pulsava al pensiero di avvertire la mamma, ma non sapevo cosa dirle. Arrivati
al pronto soccorso l’avevo chiamata dicendole che avevo trovato Enea, di stare tranquilla
e andare a dormire se si doveva svegliare per aprire il bar. Per evitare di pensarci avevo
spento il cellulare.
Non parlava, Enea, sembrava ancora in trance. Dal lettino davanti a noi, stipato nel
corridoio insieme alle altre barelle, una signora anziana ha rotto il silenzio sporcato dal
brusio della gente che affollava il pronto soccorso. La donna era sola, sdraiata in posizione
supina, sembrava morta e sepolta nelle sue stesse rughe. Unico segno di vita i suoi lamenti,
provenienti dalla bocca sdentata e semiaperta. Donne marocchine e senegalesi si giravano
a guardarla, le famiglie dell’est Europa si zittivano.
- Come stai? – Ho chiesto infine a Enea.
- Tutto ok.
- Sicuro? Sembri spento.
10- Stavo pensando…
- A cosa? – Volevo aggiungere: a quanto sei stupido a immischiarti in questi casini? Mi
sono trattenuto.
- Che ora mi sento davvero libero.
- In che senso ti senti libero? – ho chiesto, sorpreso dalla risposta.
- Ora non devo più niente a nessuno – ha risposto sorridendo. La cucitura rendeva ancora
più inquietante la sua espressione. Poi ha fatto una smorfia, probabilmente l’effetto
dell’antidolorifico stava terminando e la ferita ha iniziato a fargli male.
- Enea, chi erano quei tizi? – Volevo vomitargli addosso una cascata di domande, ma la
paura che si chiudesse in se stesso mi rendeva più cauto. Dovevo fargli capire che in fondo,
ero contento stesse meglio di quello che pensavo.
- Spacciatori.
- Perché ti hanno picchiato?
- Volevano i soldi.
- Hai comprato qualcosa?
- No, no. Gli dovevo dei soldi da prima che partissi.
Ho lasciato sfuggire una faccia che non dovevo. Quella gente aspettava che Enea si
ripresentasse nei territori sbagliati, nell’attesa avevano pensato al modo migliori per
accoglierlo, e lui si era consegnato personalmente alla giustizia della giungla urbana
ricevendo un pugno sul viso con un tirapugni. Intanto la vecchia continuava a mugugnare.
- Ecco vedi, subito a preoccuparvi. Ma adesso è finita, ho pagato il debito. Dio santo! Ma
non c’è nessuno? Questa tra un po’ ci lascia le penne! – Ha sbottato poi Enea.
- Con quali soldi?
- Questi sono cazzi miei, non ti devi immischiare.
- Coi soldi che hai guadagnato in India? Quanto gli dovevi?
- Pensate solo ai soldi voi, siete uguali.
- Cosa cazzo dovrei pensare?, scommetto che non hai più un soldo, dovrai trovarti in fretta
un lavoro.
-…
- Adesso cosa raccontiamo a mamma? – ho chiesto.
- Non le devi dire niente, hai capito? – d’improvviso la sua espressione si è fatta più seria,
mi ha fissato con sguardo intimidatorio. Una volta quegli occhi verdi mi facevano paura.
11- … quindi che cosa dovremmo fare? Presentarci da lei dopo una notte passata in giro
senza farci vivi, con la tua faccia aperta e la camicia piena di sangue e fare finta di niente?
Sembri uscito da un film di Tarantino. Cosa ti aspetti, che non faccia domande?
Enea è piombato di nuovo in uno stato catatonico, questa volta preoccupato, come se
avesse pensato per la prima volta alle conseguenze di quello che era appena successo.
Continuavo a pensare alla scena delle Iene, quella dove Vic “Sorriso” Vega nascosto
all’interno del capannone, aveva acceso la radio e a tempo di musica tagliava l’orecchio
allo sbirro sequestrato, solo che in questo caso era Vic “Sorriso” a essere coperto di
sangue. Avevo cominciato a canticchiare nella mia testa la melodia di Stuck in The Middle.
Era più forte di me, ogni volta che pensavo a una canzone non potevo fare a meno di
cantarla, anche nei momenti peggiori. Forse facevo così per allentare la tensione. Intanto
la vecchia si lamentava come Mr. Orange che, crivellato di colpi, moriva dissanguato in
fondo alla stanza.
- Dai, non fare così. Un modo lo troviamo – gli ho detto infine.
- Gli diciamo che c’è stata una rissa al bar e per difenderti mi sono preso un pugno con
un tirapugni – ha risposto dopo un po’.
- Che stai dicendo?
- Massì, siamo in Barriera, ‘ste cose capitano tutti i giorni. Alla fine più o meno è andata
così. Dobbiamo solo metterci d’accordo su cosa dire.
Mi sentivo bloccato tra l’incudine e il martello. Da una parte mia madre, che dopo tutto
quello che era successo e le sue ansie, non avrebbe sopportato una situazione del genere,
dall’altra parte Enea che, nonostante tutti i problemi, le delusioni e le bugie, rimaneva pur
sempre mio fratello. Un compromesso era la cosa migliore, avrei mentito per il bene di
tutti. In fondo da poco le avevo mentito per tranquillizzarla e la storia della rissa era una
mezza verità.
- Ok, ok.
Enea ha sorriso.
- Comunque, la mamma si starà preoccupando, appena arrivano sti fogli di dimissione
maledetti ce ne andiamo ok? – ho continuato.
- Aspetta, non andiamo subito a casa, non riuscirei a sopportare le domande ho la testa
che esplode. Andiamo a mangiare qualcosa, ho una fame assurda.
- È quasi ora di pranzo, prendiamo un hamburger?
- Sono vegano.
- Vegano? Sarai mica diventato anche gay?
-…Ettore, ricordi tre anni fa quando eri venuto a trovarmi ad Amsterdam?
- Cosa c’entra Amsterdam adesso?
12- Anche quella volta mi avevi coperto.
La vecchia strillava e ci siamo voltati a guardarla. Ha cominciato a contorcersi e sbavare,
sembrava tarantolata. Tutti in corridoio si sono agitati, qualcuno ha chiamato aiuto, gli
idiomi diversi si sovrapponevano fino a confondersi in un grottesco tunnel di Babele.
Quando l’infermiere è arrivato era ormai troppo tardi. In pochi secondi l’anima della
vecchia è fuggita dalla bocca aperta dalla quale si vedevano solo le gengive, con un ultimo
lamento neonatale, ma l’infermiere l’ha riportata indietro a colpi di defibrillatore. Peccato,
ho pensato, finalmente aveva smesso di soffrire.
Track 04 – Special Needs
Avevo un’idea fissa: quando mi ricapita di dormire gratis ad Amsterdam, girare la città con
chi ci vive e presumibilmente la conosce bene (così credevo). Era dai tempi delle gite
scolastiche che non visitavo una capitale. Enea aveva diciannove anni aveva appena
lasciato la scuola a pochi mesi dal diploma e si era trasferito lì, inizialmente non avevo
capito di preciso cosa stesse facendo, alle domande rispondeva vagamente.
- È stato un anno faticoso – mi aveva detto al telefono mesi dopo il suo trasferimento, -
hai bisogno di una vacanza, vieni a trovarmi.
- Non lo so, ho gli esami.
- Lo so io.
- E poi devo dirlo a Bianca.
Ero al terzo anno di università, lui invece lavorava come pizzaiolo in un ristorante italiano,
aveva lasciato l’appartamento ad Amsterdam e si era trasferito fuori città. Farneticava di
organizzare feste, come faceva a Torino, gli avevo detto di lasciar perdere, in Olanda la
polizia era tutt’altro che indulgente.
- Ma figurati! – diceva, - vedrai che questa volta faccio i soldi. Se non ci riesco almeno mi
diverto.
Con settanta euro andata e ritorno partivi comodamente da Caselle e prendendo un treno
da Madonna di Campagna arrivavi fino all’interno dell’aeroporto. Avevo uno zaino della
Decathlon da trenta euro, carico come se dovesse frantumarsi da un momento all’altro
come un guscio d’uovo. Per mantenermi gli studi lavoravo come barista in un locale serale,
avevo incastrato i giorni come un Tetris: lunedì partenza e giovedì ritorno, giusto in tempo
per iniziare il turno all’Astoria, le lezioni le avrei tranquillamente balzate. Il piano era quello
di rimanere quattro giorni e tre notti ma per visitare la città rimanevano effettivamente
solo più due: potevo partire domenica, ma i prezzi sarebbero saliti vertiginosamente.
Volavo sull’Airbus 737-800 diretto all’aeroporto di Schiphol, rilassato e soddisfatto, con
13Sleeping With Ghosts dei Placebo nelle orecchie e Il tempo è un bastardo a cinquanta pagine
dalla fine.
Dell’alloggio si era occupato Enea. Aveva avvertito il suo ex-coinquilino col quale aveva
mantenuto buoni rapporti. Avevo detto che se ci fossero stati problemi avremmo potuto
prenotare due letti in ostello oppure affittare un Airbnb a poco prezzo. Stai tranquillo,
aveva risposto. Sembrava tutto perfetto, finché io e Enea ci siamo trovati alle due di notte,
strafatti, a suonare il campanello di Lauro nella profonda periferia di Amsterdam.
- Hai avvertito il tuo amico?
- Certo, mi ha assicurato che non ci sono problemi a dormire da lui. Mi ha detto di
chiamare una volta arrivato, ma sto coso è scarico – Enea, visibilmente nervoso, cercava
di accendere il telefono che non dava segnali di vita. Non sarebbe stata l’unica notte passata
all’aperto di quella vacanza.
- Anche il mio è scarico.
Arrivato in Olanda alle dieci di sera avevo notato che il mio telefono era al trenta per cento
di batteria, poi si era scaricato durante la tappa al coffee shop. Fatto com’ero non avevo
pensato a ricaricarlo.
- Gli hai detto il giorno giusto?
- E che cazzo, mica sono scemo! – Enea con le mani in tasca per il freddo, scendeva dal
marciapiede per guardare oltre i terrazzi che sporgevano sulla strada. Controllava se per
caso qualcuno al quinto piano si affacciava dalla finestra. È inutile, pensavo, a quest’ora
staranno tutti dormendo.
- Magari sono usciti, aspettiamo qui sotto prima o poi torneranno –, ho proposto.
- Ok, dai. Facciamone su una.
Il coffee shop dove avevamo preso l’erba era il tempio della psichedelia posticcia, ma
sembrava un posto tranquillo e, a quanto pare, era il preferito di mio fratello. Avevamo
acquistato cinque grammi di White Widow e cinque di Moby Dick.
- Ma non è un po’ troppa? – Gli avevo detto.
- Ma va! Questa è buona, va giù come l’acqua, poi non possiamo smezzarla col tabacco.
Dopo tre purini e due succhi al mango, serviti dalla barista dai dread arrotolati sulla testa
come gli spaghetti impiattati dagli chef stellati, si era fatta l’una di notte. Stonati avevamo
perso la cognizione del tempo e per un pelo non perdevamo anche l’ultimo pullman per
arrivare in quel posto dimenticato da Dio.
Enea, inarcando le sopracciglia, ha tirato una boccata di fumo. La brace della canna
bruciava producendo un particolare scoppiettio, una flebile luce ha illuminato il suo profilo
lasciando intravedere l’espressione seria.
14- Come stai fra? Sono contento che sei venuto a trovarmi – ha detto con la canna ancora
stretta tra le labbra.
- Lo slang di Barriera ti è rimasto, mi aspettavo di sentire un po’ d’inglese.
- Cosa vuoi che ti dica, non è che con le pizze ci parlo in inglese – ha detto, soffiando il
fumo bianco dal naso.
- Non stai organizzando feste? – ho detto, prendendo tra le dita la canna che mi stava
passando.
- Ci stiamo lavorando, anche se adesso ci sono stati dei casini.
Enea si è appoggiato con le spalle alla parete liscia del palazzo e si è lasciato scivolare a
terra; io a fianco a lui. In fondo alla strada un’auto della polizia a lampeggianti accesi ha
attraversato l’incrocio sparendo velocemente dall’inquadratura.
- Come sta la mamma?
- Tutto ok, ha iniziato a fare le pulizie. Si è fatta il suo giro di famiglie in Crocetta - la
cenere si è staccata dall’estremità della canna.
Il THC stava salendo e noi lentamente dimenticavamo il motivo per cui ci trovavamo in
strada al freddo. Enea, improvvisamente colto da mutismo, si è bloccato a guardare un
punto fisso nel panorama urbano davanti a sé. Io invece stavo elaborando un classico
esempio di quelli che vengono chiamati pensieri da marijuana, ovvero quello di osservare
dall’esterno i propri ragionamenti schizzare attraverso un labirinto di specchi mentali. Man
mano che mi avanzavo nelle spire del pensiero, non mi stavo accorgendo di arrivare fino
a un punto di estrema vertigine cerebrale dove tutto svaniva in una nuvola di fumo e ci si
trova a possedere consapevolezze limpide come il giorno, con la strana sensazione di non
essere in grado di riprodurre il ragionamento. Per poi risvegliarmi ad Amsterdam, seduto
ai piedi di un palazzo altissimo senza riuscire a capire come c’ero arrivato. Avrei voluto
chiedere molte cose a mio fratello, per esempio perché snobbasse ogni contatto profondo,
ogni tentativo di aiutarlo, soprattutto quando ci trovavamo a casa. In quel momento avrei
voluto proporgli di mollare tutto, partire insieme per un viaggio zaino in spalla, una di
quelle idee “shanti” che tanto odiavo e che in fondo non avevo mai avuto il coraggio di
sognare. L’avrei fatto per il nostro rapporto, che si poteva chiamare così inspiegabilmente
solo dopo aver raggiunto una certa distanza da Torino/casa-base, dopo esserci allontanati
dalle frenetiche onde-pensiero (vritti) generate dalla mente, di cui blateravano
costantemente i miei compagni di università. Avrei voluto digli tutto questo, alla fine sono
riuscito a spiccicare solo qualche parola.
- Bella Amsterdam.
- Già.
- Non hai freddo?
15- Un pochino, sono senza felpa – aprendo la zip del bomber ha mostrato che sotto aveva
una t-shirt. Ho aperto lo zaino a rallentatore. Ho preso la felpa blu con la scritta, era la più
nuova e più calda che avevo, gliel’ho passata.
- Nono tranquillo, sto bene così.
- Dai smettila, stai tremando.
- È il THC.
Gliel’ho lanciata addosso, qualche secondo dopo l’ha indossata.
- Così quando tornerò in Italia ti ricorderai di chiamarmi.
- Avete tutti voglia di regalarmi qualcosa, qualche giorno fa un ragazzo napoletano mi ha
regalato queste scarpe – ha detto indicandosi i piedi.
Alle cinque e mezzo di mattina Lauro non era ancora rientrato. Eravamo ancora sotto il
suo portone, l’effetto della ganja era passato e mi aveva lasciato solo. Enea camminava
avanti e indietro, nervoso come un animale in gabbia.
- Porca puttana, quando lo vedo lo ammazzo.
- Dai tranquillo, è colpa nostra, dovevamo ricaricare i telefoni.
- Hi guys, do you need help? – Due ragazzi che passavano di là si sono avvicinati, parlando un
inglese con accento arabeggiante.
- No, thank’s – Ho risposto in fretta. Pazzesco, anche qua, ho pensato.
- Are you ok? Coca? Hashish? – Ha aggiunto quello col berretto di lana nero e il cappuccio,
sorridendo ha mostrato i denti ingialliti e sporchi.
- No, really. We are fine – ho risposto.
- Ok, no problem – ha detto quello coi baffetti. I due hanno iniziato a parlare nella loro
lingua, rimanendo vicino a noi.
- Che cazzo vogliono sti due – ha detto Enea.
Quello col cappellino si è accovacciato per legarsi le scarpe. In una mano stringeva un
coltello a serramanico, così ho preso Enea per il bomber trascinandolo via. Abbiamo
attraversato di corsa qualche viuzza fino ad arrivare nei pressi della stazione dei pullman.
Pensavo che Amsterdam fosse una città pericolosa, più avanti ho capito che mio fratello
era una calamita per i guai.
Durante una delle nostre videochiamate da una spiaggia australiana aveva raccontato: -
Sono con Pippo, abbiamo comprato un’automobile e vogliamo attraversare la costa per
arrivare al deserto. Qualche sera fa eravamo accampati su una spiaggia e un gruppo di
raver ha organizzato un free party, avevano montato il muro di casse a due passi da noi.
Pazzesco –, aveva commentato – volevamo stare tranquilli e quelli si sono messi proprio
lì con duecento chilometri di spiaggia a disposizione, sto pensando di essere io ad attirare
il caos.
16Alla stazione ho avuto un’idea. Entriamo nello Starbucks, mettiamo sotto carica i telefoni
e intanto facciamo colazione.
- Non è possibile – ha detto Enea mentre controllava dopo tanto tempo la chat di
Facebook, - Lauro non rispondeva al citofono perché è rotto – ha detto ridendo.
Scoppiai anch’io a ridere, non potevo e non volevo fare altro. Intanto mio fratello
componeva il numero.
- Ué testina, sveglia. Stiamo arrivando.
Track 05 – Lust for Life
- Mooo e c je mo t si arricrdat? D’ajier c’aviv a vnì.
Il ragazzo con i dread corti si stropicciava un occhio con la mano, con l’altra teneva aperta
la porta dell’appartamento. Quei capelli sembravano tanti piccoli stronzi attaccati sulla sua
testa, aveva una t-shirt con una foglia di ganja dei colori della bandiera jamaicana stampata
sul petto, un paio di pantaloncini sintetici da calcio e gli infradito.
- E tu chi cazzo sei? – ha esordito Enea ridendo, ho creduto stesse pensando la stessa cosa
riguardo i capelli.
- Giacomo - ha detto il barese tendendoci la mano. Mentre la stringevo Enea è sgusciato
dentro la casa. Le pareti del salotto erano coperte da teli colorati con divinità indiane o il
simbolo dell’Ohm, di fronte al divano il tavolino in legno era sommerso di oggetti: bonghe
piene d’acqua sporca, scatoline di legno, sigarette aperte e bustine di tabacco, posaceneri
stracolmi di mozziconi, tazze e cartoni della pizza con avanzi di croste. Avrei voluto
scattare una foto e inviarla alla pagina Instagram de “il coinquilino di merda”. In fondo al
salotto, sotto la finestra, una piscina gonfiabile rettangolare vuota, al suo interno quello
che ho scoperto poco più tardi fosse Lauro. Sonnecchiava e vicino ai suoi piedi un
televisore 42 pollici LCD acceso con la schermata di GTA in pausa, collegato a una PS2.
Ero quasi convinto di aver attraversato un varco spaziotemporale ed essere piombato negli
anni ’90, sul set di Trainspotting.
- Volete il caffè? – ha chiesto Giacomo dalla cucina. Vedevo i piatti sporchi spuntare anche
da lì.
- No, grazie. Vorrei solo andare a dormire.
Mentre Giacomo mi faceva vedere la stanza Enea è saltato addosso a Lauro, i due si sono
rotolati nella piscina facendo quasi cadere il televisore, si davano degli schiaffi e ridevano.
Ho deciso che avrei posticipato il momento della presentazione dopo una dormita. Mezza
giornata da dedicare alla visita di Amsterdam era praticamente persa e questo mi
innervosiva. La mia stanza neanche a dirlo era un porcile. In un angolo, da una serra
17artigianale sgangherata, la luce delle lampade alogene filtrava da fessure larghe come un
dito. All’interno era giorno da sempre. Ho spostato il pollo di gomma che occupava il
materasso e steso il sacco a pelo. Prima di addormentarmi ho pregato non prendermi le
piattole.
Abbiamo passato le giornate successive a visitare la città e qualche museo, senza
dimenticare le frequenti tappe ai coffee shop e quella al negozio di souvenir per acquistare
qualche oggetto inutile a dimostrare la nostra effettiva esplorazione turistica, inoltre mio
fratello non aveva visitato praticamente nulla, anche per lui era tutto nuovo. Lauro, che
sembrava non si fosse mosso da quella piscina per tre giorni di fila senza spostarsi
nemmeno per mangiare, aveva riservato una chicca per mercoledì.
- Questa sera vi porto a una mia festa. Passami la cocca, ne facciamo su una e vi spiego.
- Mi sa che io salto, domattina ho l’aereo presto – ho risposto.
- Dai, ti porti il bagaglio in discoteca, fai after e in mattinata prendi l’aereo. Dormirai
durante il viaggio.
Non è servito a nulla declinare l’offerta, con tutto il THC che avevo in corpo avrebbero
potuto farmi fare quello che volevano.
Il giro delle feste era semplice: ingaggiavi un Dj alle prime armi, di quelli che mettono
musica commerciale, house o techno, lo pagavi in consumazioni e gli offrivi qualche raglia
(solo se necessario). Poi chiamavi un fotografo perché l’immagine è tutto, gli riservavi lo
stesso trattamento facendo qualche battuta sul fatto che fotografi e Dj scopano più di tutti,
e raccomandavi di immortalare momenti in cui la gente si diverte o limona, e le ragazze si
spogliano davanti all’obiettivo, incitandole con giochini e provocazioni. Poi viene il turno
dei PR a cui promettere un tavolo e una bottiglia da sbocciare, ma solo se arrivavano a
cinquanta persone in lista. A questo punto i grafici improvvisati progettano la locandina
per Facebook e il formato flyer, il logo per gli adesivi da attaccare su tette e culi. Tu dovevi
solo preoccuparti che tutte le pedine portino a termine il loro lavoro, convincere più gente
possibile a partecipare, creare l’evento e invitare studenti, Erasmus e turisti contattando
gli ostelli, portare la bamba da smazzare. Quello era il vero guadagno, il resto serviva
malapena a pagare l’affitto della discoteca.
Lo ha raccontato Lauro a serata inoltrata proprio durante la festa, lui aveva creato il brand
“Family Entertainment” – Dà un senso di appartenenza e nello stesso tempo di
divertimento, non credi? – mi ha detto. Ho pensato che c’era di meglio.
- Sai Ettore, mi sei simpatico, è un peccato che domani scappi già, sembri un ragazzo in
gamba – Lauro veniva da Milano da una famiglia “ricca”, dal suo aspetto trasandato non
sembrava affatto, ma così aveva detto Enea. Quel ragazzino aveva l’apparecchio ai denti
e un occhio massonico tatuato sul dorso della mano sinistra, con una serie di simboli che
si disperdevano sulle nocche, la barbetta rada e i capelli lisci e lunghi raccolti in un puccio
sotto un cappello di lana due taglie più grande, ai lati della testa era rasato tanto che gli si
vedeva la pelle tatuata, aveva quattro anni in meno di me e si atteggiava come il boss della
18città. La verità è che con quei tatuaggi sembrava che qualche amico particolarmente
simpatico gli avesse pasticciato la faccia con l’indelebile una volta addormentato ubriaco.
Mentre Lauro parlava nel privé, poco lontano da noi Enea era occupato a baccagliare
un’olandesina biondissima col suo inglese stentato. A ogni battuta pronunciata vicino
all’orecchio lei sorrideva. La musica era orribile, avevo buttato giù due vodka sour per
cercare di sopportarla.
- Mi sa che stasera tuo fratello scopa – ha detto Lauro indicandolo, ho fatto un cenno con
la testa.
- Senti, hai mai pensato di lavorare ad Amsterdam, per gli italiani è il paese dei balocchi,
noi tre potremmo fare del business, dobbiamo solo accontentare i turisti, dargli esattamente
quello che vogliono – mentre parlava Lauro ha tirato fuori dalla tasca una pallina grossa
come un’arachide, forse un po’ più grossa, era avvolto in un pezzo di busta biodegradabile,
quelle del supermercato. L’ha aperta con due dita e versato il contenuto su un piattino che
prima conteneva dei tovagliolini da cocktail. Dal portafogli ha tirato fuori una PostePay
nera e la tessera sanitaria italiana, ha sminuzzato le piccole scaglie con gesti veloci e precisi,
fino a ottenere una polvere finissima. Poi ha allineato tutto in tre righe parallele, le prime
due lunghe e la terza più corta. In silenzio e concentrato sembrava stesse compiendo un
rito come il Cha no yu, ovvero la cerimonia del tè giapponese. Infine ha arrotolato una
banconota da venti euro e tirato la prima riga. Alzando di colpo la testa e girato gli occhi
all’indietro. Si è afferrato il naso con la mano tatuata, emettendo suoni orgasmici. Dopo
una scrollata di spalle è tornato in sé.
- Vuoi?
- No, grazie.
- Sicuro? Questa è stra-buona, altrimenti col cazzo che lo farei.
- No davvero, domani ho l’aereo – ho risposto.
Le pupille di Lauro si sono dilatate, ha cambiato completamente espressione.
- Saresti addirittura più affidabile di quella testa di tuo fratello.
Il sospetto, sotto forma della punta di una lama d’acciaio, ha percorso tutta la schiena a
partire dal fondo, percorrendola in lungo e in largo come a scegliere il punto in cui avrebbe
colpito. Intanto Lauro ha cambiato narice e tirato anche l’altra riga.
- Sai, la verità è che se tutti si concentrassero sulle cose davvero importanti non ci
sarebbero guerre e nemmeno il razzismo. Sì perché, prendi la Coca Cola per esempio – ha
detto indicando la lattina sul tavolino -, vende a tutti, mica fa distinzioni. La trovi nei paesi
arabi come in Russia e Cina, se potesse anche in Corea del Nord. Puoi avere la pelle rossa,
nera o blu che a loro non frega un cazzo di niente, l’importante è pagare in anticipo –
Lauro è scoppiato in una risata, poi ha tirato fuori una Marlboro dal pacchetto morbido,
l’ha leccata come per aprirla e farci una canna, invece l’ha appoggiata sulla terza riga, quella
19più corta. La polvere si è attaccata alla sigaretta, quando l’ha accesa ho avuto paura che il
fumo intossicasse anche me.
In quel momento Enea si è avvicinato e notando il piattino si è incazzato.
- Brutto pezzo di merda, ti sei sparato tutta la bamba e non mi hai neanche chiamato.
- Cosa cazzo dici, questa è la mia, la tua parte te l’ho già data.
La lama, dopo avere giocato sadicamente con il mio corpo, ha finalmente affondato il
colpo. Enea strafatto, non si preoccupava più di nascondersi di fronte ai miei occhi. Ho
pensato di raccontarlo subito a nostra madre.
- Sei un balordo come al solito, in due ore sei riuscito a pippare mezza Colombia. E poi
che cazzo ti arrabbi che mi devi ancora cento euro.
- Io non ti devo proprio niente, sei tu che devi darmi ancora i soldi della scorsa festa.
- Ti ho già detto che quella storia è chiusa, capita a tutti di perdere una pallina.
- Mi pigli per il culo? Dove li hai presi i soldi per questa serata, te li ha dati il papino?
- Non dire cazzate.
- Allora mi hai inculato – Enea era serio, aveva abbassato la voce. Lauro si è alzato dal
divanetto, la sua testa si è avvicinata troppo a quella di mio fratello. Ho afferrato un
tumbler vuoto dal tavolino stringendolo forte tra le dita.
- Sei proprio un terrone di merda.
Non ho fatto in tempo ad alzarmi che Enea gli era saltato addosso abbracciandolo in una
presa da boxeur. Quando Lauro ha urlato di dolore mio fratello si è divincolato sputando
qualcosa sul tavolino. Un pezzo di lobo con ancora attaccato il brillante è finito sul piattino
imbiancandosi nella polvere. Le mani di Lauro hanno coperto l’orecchio mutilato. Enea
lo guardava immobile, con le pupille dilatate e i denti macchiati di sangue.
- Figli di troia! – Lauro ha preso il cellulare e tentato di chiamare qualcuno, la paura che
potesse succederci qualcosa di davvero brutto ha fatto in modo che lo finissi spaccandogli
il tumbler sulla testa.
- Porca puttana Ettore lo hai ammazzato.
Lauro disteso per terra e noi a guardarlo. La musica copriva ogni rumore, quello dei nostri
cuori pulsanti di terrore e quello del ragazzo disteso per terra. Ho dovuto mettergli una
mano davanti alla bocca per controllare se respirasse, ricevendo la conferma che i bastardi
sono sempre quelli più duri a morire, questa volta per fortuna. L’ho preso per le caviglie e
trascinato lungo il privé fino a dietro i divanetti, Enea ha cancellato la scia di sangue lasciata
sul pavimento bianco dal suo orecchio mutilato.
L’alba è arrivata in aeroporto, il sole olandese filtrava attraverso le vetrate. Noi, sdraiati
nella hall, venivamo svegliati in continuazione dagli addetti alle pulizie che passavano la
lucidatrice sul pavimento, io cercavo di tranquillizzarmi ascoltando la musica, ma non
20serviva a niente. Abbiamo preso un taxi nella notte, mio fratello ha detto che non aveva
niente di importante da riportare a casa, allora ho comprato un biglietto di ritorno anche
per lui spendendo tutti i miei risparmi. Non ci siamo rivolti parola per tutto il viaggio.
- Per favore Ettore, non dire niente a mamma – mi ha detto davanti alla porta d’ingresso
dell’appartamento.
La mamma era contenta di rivederlo, mi ha ringraziato in privato per averlo riportato a
casa – Non sei contento? – mi ha chiesto. Ho risposto di sì.
Track 06 – Verme
- Cosa ci fai sul pavimento?
- Guardo il soffitto.
- Stai bene?
- Benissimo.
- A me non sembra.
- Come vuoi che stia? Non faccio niente, come tutti i giorni.
Ho cercato tra i dischi stipati nelle cassette da vino appese alla parete, ero sicuro di aver
comprato quel disco al concerto dei Gomma allo sPAZIO211, un ex-asilo che organizza
eventi in Via Cigna, proprio vicino casa nostra. Chissà se oggi esiste ancora. Il disco si
chiamava Sacrosanto, in copertina c’era un ragazzo con una maglietta tirata sopra la testa,
fotografato in mezzo al bosco. Il flash riflesso dal suo petto pallido e dalla maglietta bianca
produceva un effetto ectoplasma, un fantasma di luce. L’ho inserito nello stereo e skippato
fino alla traccia tre, Verme. Le chitarre punk hanno prodotto un effetto sveglia.
- Cos’è sta roba? – ha detto Enea redivivo.
- Sei tu.
Erano passati alcuni mesi dal ritorno di mio fratello, mia madre non era del tutto convinta
della storia della rissa, l’avevo capito dalla sua espressione mentre raccontavamo, ma non
aveva fatto altre domande. Questo da un lato aveva sollevato me e Enea, dall’altro aveva
fatto cadere lui in depressione. I due si rivolgevano parola solo se necessario, scambiandosi
monosillabi o, nel caso di mio fratello, grugniti. Ogni tanto mia madre entrava in camera
chiedendogli se avesse trovato un lavoro, oppure tirava fuori il discorso a tavola, senza
mai alterarsi, con un timbro monotonale. Avevamo ripreso a vivere tutti insieme, le
giornate passavano indistinte e la notte io e Enea dividevamo il divano letto.
In quel periodo Bianca aveva finalmente trovato lavoro come infermiera in una clinica
privata, iniziava una vita fatta di turni di notte, matti da sedare, ma anche di uno stipendio
21degno di tale nome e ferie accumulate da sfruttare. Ogni tanto partiva con qualche amica,
mi portava sempre un regalo, una volta una tazza con un panda hipster da Berlino, un’altra
volta una macchina fotografica Polaroid da Londra, ma ci vedevamo sempre più di rado.
Spesso proponevo a mia madre di lasciare che Enea lavorasse ogni tanto con noi, almeno
fino a quando avesse trovato un altro lavoro, così anch’io avrei potuto riposarmi un po’ e
viaggiare insieme a Bianca. La risposta era sempre negativa
– Così poi non ce lo leviamo più di torno – aveva detto una volta al bar, mentre infilava il
cestello pieno di tazzine sporche nella lavastoviglie. Una fumata di vapore caldo le aveva
inumidito il viso coperto di piccole goccioline di condensa, che eliminava passando il
dorso della mano sulla fronte. Nonostante fosse ancora giovane, sulle mani di nostra
madre iniziavano a intravedersi delle piccole macchioline scure. I suoi ricci ondeggiavano
e si facevano più crespi con l’umidità, da anni ormai li portava corti.
- Dorme fino a tardi, si alza, mangia, poi torna a chiudersi nella stanza. Cosa fa tutto il
giorno non lo so. Poi la sera esce e torna tardi, se torna. Meno male che non ha soldi, in
ogni caso io non gli do una lira neanche se mi prega in cinese.
Ero d’accordo con lei, ma non poteva andare avanti così ancora a lungo. C’erano giorni in
cui Enea sembrava al massimo delle forze, faceva progetti, era propositivo, a volte
addirittura voleva riprendere a studiare. Altri giorni invece, che poi erano sempre quelli
dopo le serate in cui tornava tardi o addirittura non tornava proprio, era a pezzi. Non
sapevo come comportarmi. La cosa peggiore era stata abituarsi alla puzza di alcol che
sentivo quando tornava a dormire. Odiavo il rumore della bottiglia di plastica nella notte,
sempre vicino al letto. Spesso al mattino trovavo delle pozzanghere sul pavimento, a volte
le annusavo credendo fossero urina, in realtà era solo lui che versava l’acqua. A volte mi
svegliava in piena notte in paranoia.
- Dove sono le sigarette – aveva detto stringendomi il piede.
- Ettore, mi spìano lo so, ho visto le telecamere – aveva detto un’altra volta.
- Enea lo fai ancora? – gli avevo chiesto in un momento di coraggio.
- Nono, adesso sto bene, sono solo attacchi di panico.
Pochi giorni dopo la partenza per il suo viaggio in India mi ero accorto che aveva preso
duecento euro dal cassetto dei miei risparmi. Estremamente deluso, l’avevo chiamato e gli
avevo detto che se avesse avuto bisogno sarebbe bastato chiedere. Non ha saputo
rispondere. Da quella volta non ho più nascosto soldi in casa, non perché non mi fidassi
di lui ma per evitare di ripensare a quella storia.
A parte questo era come se dopo quello che gli era successo in Corso Vercelli non potesse
succedere nulla di peggio, forse si comportava in quel modo solo perché non aveva niente
da fare, nei momenti in cui stava peggio beveva un po’ di più per non pensare.
- Alzati da lì, – gli avevo detto un lunedì mattina, stava tornando la primavera – andiamo
al fiume.
22Puoi anche leggere