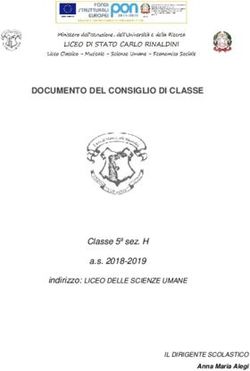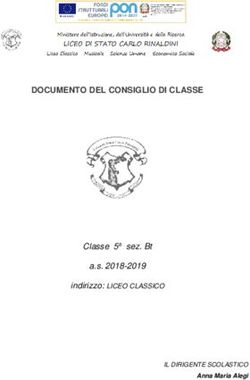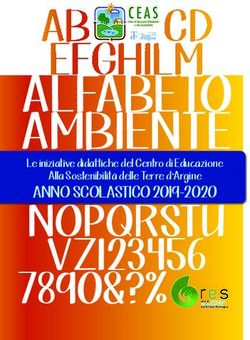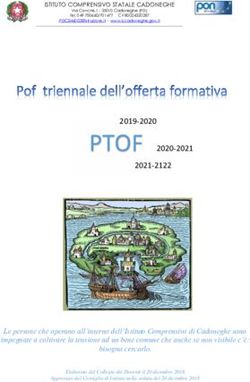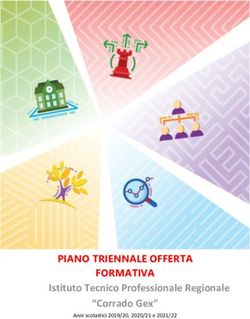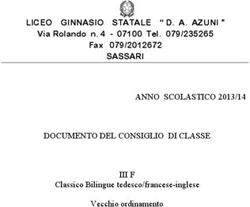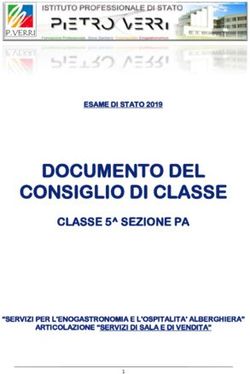DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Classe 5a sez. G a.s. 2018-2019 indirizzo: LICEO DELLE SCIENZE UMANE - Liceo Carlo Rinaldini
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe 5a sez. G
a.s. 2018-2019
indirizzo: LICEO DELLE SCIENZE UMANE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Alegi
1Esame di Stato Anno Scolastico 2018-2019
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. G
Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane
Docenti del Consiglio di Classe Firma
1. ANITORI Rosella*
2. ALESSANDRELLI Alessandra
3. ALESSANDRELLI Montenovo Marco
4. DEFENDI Rossella
5. GABRIELLONI Natalia
6. GRECO Ombretta
7. MANUALI Roberta
8. MIGLIETTA Cosimina
9. MONTEVECCHI Mariangela
10. PASSARINI Annalisa
11. SANTACROCE Maria Maddalena
*Coordinatore di Classe
Rappresentanti degli alunni Firma
1.
__________________________
2.
__________________________
Ancona, 15 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Alegi
2DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. G
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE
PARTE PRIMA
1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1. Piano di studi, finalità istituzionali pag. 5
2. Quadro orario pag. 7
2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
1. Elenco dei candidati pag. 8
2. Variazioni numeriche della classe pag. 9
3. Continuità dei docenti della classe pag. 9
4. Presentazione della classe pag. 10
5. Strategie e metodi per l’inclusione pag. 11
3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Metodologie e strategie didattiche pag. 11
2. CLIL: attività e modalità di insegnamento pag. 11
4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) pag. 12
2. Cittadinanza e Costituzione pag. 12
3. Progetti significativi; visite e viaggi di istruzione pag. 12
4. Simulazioni prove d'esame pag. 14
5. Valutazione: scala dei punteggi e descrittori pag. 14
a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta pag. 14
b) Modalità di attribuzione del credito scolastico pag. 16
c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico pag. 17
6. Griglia di valutazione della prima prova scritta pag. 18
7. Griglia di valutazione della seconda prova scritta pag. 23
3PARTE SECONDA
1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
1. Lingua e letteratura italiana pag. 23
2. Lingua e cultura latina pag. 26
3. Storia pag. 29
4. Filosofia pag. 33
5. Scienze Umane pag. 35
6. Lingua e cultura straniera (Inglese) pag. 37
7. Matematica pag. 39
8. Fisica pag. 41
9. Scienze naturali pag. 43
10. Storia dell’arte pag. 44
11. Scienze motorie e sportive pag. 47
41. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI
Liceo delle Scienze Umane
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane “indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali
(Indicazioni Nazionali dei Nuovi Licei)” è caratterizzato dallo studio dell'uomo nella sua di-
mensione: sociale, antropologica, psicologica e pedagogica.
Il Liceo delle Scienze Umane presenta un percorso innovativo, non tradizionale, che supera
la centralità dello studio della pedagogia, e pone come finalità, invece, l'integrazione dello
studio delle Scienze Umane (sociologia, psicologia, antropologia e pedagogia) con i diversi
ambiti del sapere scientifico, storico-filosofico, linguistico-letterario ed artistico, garantendo
così una completa formazione liceale. Nuclei fondanti e contenuti imprescindibili del Liceo
delle Scienze Umane sono la conoscenza, l'interpretazione e la valorizzazione di ogni forma
di pensiero, linguaggio e cultura, lo studio delle differenze e delle somiglianze tra culture e
società, lo sviluppo del pensiero critico, la comprensione delle problematiche della contem-
poraneità attraverso la conoscenza della storia nella consapevolezza che il presente è il ri-
sultato di processi di lunga durata e l'analisi ed il confronto tra idee politiche e visioni del
mondo, ma anche tra modelli istituzionali ed assetti organizzativi e funzionali dei sistemi poli-
tici.
Le Scienze Umane, del tutto assenti nei curricoli degli altri indirizzi liceali, sono un gruppo di
discipline (antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia) il cui studio è indispensabile per
una lettura critica e consapevole dei temi più urgenti della realtà contemporanea: Che cos’è
e che conseguenze ha la globalizzazione? Quali sono le cause e le conseguenze dei recenti
movimenti migratori? Che rapporto c'è tra l'ambito locale (le culture particolari) e l'ambito
globale (la natura umana universale, ovvero la rete di connessioni che unisce le persone di
luoghi diversi)? Che cosa significa vivere in una società multiculturale? Che cos’è cambiato
nel mondo del lavoro e nelle politiche sociali? Qual è l’impatto delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione? Come cambiano gli stili di apprendimento e come
devono cambiare gli stili di insegnamento?
Le Scienze Umane sono considerate a pieno titolo discipline scientifiche in quanto procedo-
no con metodi quali: l’esperimento, l’osservazione sistematica, le indagini campionarie e la
ricerca “sul campo”, tuttavia studiano l’uomo nelle sue diverse dimensioni, condividendo il
loro oggetto di studio con l’area della cultura umanistica (filosofia, storia, lingue classiche),
consentendo un costruttivo incontro tra discipline umanistiche e scientifiche ed un approccio
interdisciplinare. Caratterizzato, quindi, da una solida presenza di discipline scientifiche, sto-
rico-filosofiche, linguistico-espressive, psico-pedagogiche, antropologiche e sociologiche, il
Liceo delle Scienze Umane garantisce una completa formazione liceale.
L’uomo, fruitore e produttore di conoscenze, attore consapevole e responsabile, essere so-
ciale e relazionale che è radicato nella storia e proiettato nel domani, per raggiungere tale
fine deve sviluppare contemporaneamente la propria identità personale e la propria identità
sociale in modo critico e libero.
La conoscenza è lo strumento e la condizione fondamentale per la formazione dell’uomo,
perché egli realizza pienamente la propria umanità e libertà solo attraverso il sapere. Essere
5uomo e cittadino coinvolge tutti gli aspetti dell’esistenza: quello cognitivo, quello affettivo e
relazionale, quello etico e quello metacognitivo. E’ per questo che il Liceo delle Scienze
Umane si impegna a favorire la crescita attraverso una progettualità dei processi formativi
che valorizza e integra tutte le dimensioni dell’esistenza, concentrandosi in particolare sulla
centralità della Persona.
L’incontro con l’Altro, nell’attuale società complessa, impone una riflessione dell’uomo su se
stesso, come protagonista di scelte responsabili e come portatore di uno spessore culturale
e storico che viene da lontano. L’individuo, impegnato nel conoscere e valorizzare la propria
storia e la propria identità, ha il compito di costruirsene una nuova, che gli permetta di diven-
tare l’attore principale della sua esistenza.
In quest’ottica assumono grande importanza la riflessione e lo studio della relazione e della
comunicazione, nonché di tutte le discipline che favoriscono un approccio critico. Obiettivo è
quello di valorizzare non solo i progressi, ma anche i contrasti e le difficoltà attraverso i quali
si traccia il sentiero della cultura, promuovendo il contatto con la contemporaneità come con
il passato, in un percorso che aiuta a comprendere il presente e a diventarne parte attiva.
La finalità ultima del processo educativo è sicuramente la formazione armonica ed integrale
della persona in tutte le sue potenzialità ed aspetti; finalità che si declina in molteplici ulteriori
obiettivi educativi fra cui intendiamo specificare:
conoscenza ed accettazione di sé in un’ottica di espressione e potenziamento delle
proprie risorse;
partecipazione consapevole e costruttiva alle esperienze sociali sia nella dimensione
interpersonale che a livello sociale più allargato;
acquisizione di un habitus cognitivo e comportamentale ispirato al senso civico, alla
consapevolezza della complessità, alla problematizzazione del reale;
maturazione di un pensiero e di un’azione ispirati al valore e al rispetto dell’altro
nell’orizzonte della solidarietà umana.
La proposta del Piano degli Studi del Liceo delle Scienze Umane si caratterizza per:
1 l’insegnamento della lingua e letteratura italiana e latina, della filosofia e della storia
dell’arte, che garantiscono una sicura preparazione umanistica;
2 una ben definita area d’indirizzo (psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia),
ambito del sapere del tutto assente negli altri percorsi liceali;
3 la presenza di un asse scientifico-matematico (scienze naturali, matematica, fisica)
indispensabile per garantire un serio supporto alla ricerca e la preparazione necessa-
ria per un’ampia scelta universitaria;
4 l’insegnamento della lingua e letteratura inglese per l’intero quinquennio con la possi-
bilità di accedere alle certificazioni linguistiche Cambridge;
5 l’introduzione, oggi indispensabile, allo studio del Diritto e dell’Economia;
6 la proposta di percorsi pomeridiani facoltativi coerenti con il profilo liceale, finalizzati
ad arricchire e caratterizzare il curricolo. La positiva frequenza di tali percorsi concor-
re alla crescita complessiva dello studente;
7 l’attenzione all’individuo e alla valorizzazione delle inclinazioni personali. Il Liceo delle
Scienze Umane ha come obiettivo primario la piena realizzazione dello studente ed il
suo benessere nell’ambiente scolastico;
68 la partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che
prevedono la partecipazione a stage formativi presso enti, istituzioni e aziende pre-
senti sul territorio.
Il profilo d’uscita atteso
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologi-
ca e socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significa-
tivi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educati-
ve, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, fi-
losofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedago-
gico-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi for-
mativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi al-
la persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica,
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla
media education.
1.2 QUADRO ORARIO
ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI I Biennio II Biennio
PER TUTTI GLI STUDENTI 5°
1° 2° 3° 4° anno
anno anno anno anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Scienze Umane* 4 4 5 5 5
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Matematica con Informatica nel I Biennio 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze Naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30
72.INFORMAZIONI SULLA CLASSE
2.1 ELENCO DEI COMPONENTI LA CLASSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
82.2 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE
Anno di corso N° alunni N° alunni tra- N° alunni tra- N° alunni re- Totale Alunni
iscritti sferiti da altre sferiti ad altre spinti
scuole o sezioni sezioni o scuole
o ritirati
III 30 1 - - 30
IV 30 - - 2 28
V 29 1 - - 29
2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE
MATERIA DOCENTI DOCENTI DOCENTI
CLASSE III CLASSE IV CLASSE V
Lingua e Letteratura Gabrielloni Natalia Gabrielloni Natalia Gabrielloni Natalia
italiana Giugliano Erica
Lingua e Cultura La- Santacroce Maria Mad- Santacroce Maria Mad- Santacroce Maria Madda-
tina dalena dalena lena
Storia Gabrielloni Natalia Gabrielloni Natalia Gabrielloni Natalia
Giugliano Erica
Lingua e Cultura In- Manuali Roberta Manuali Roberta Manuali Roberta
glese
Scienze Umane Fagnani Stefania Passarini Annalisa Passarini Annalisa
Filosofia Gnocchini Marco Martini Romano Alessandrelli Montenovo
Marco
Matematica Sallustro Valeria Franca Sallustro Valeria Franca Greco Ombretta
Fisica Sallustro Valeria Franca Sallustro Valeria Franca Greco Ombretta
Scienze naturali Bruglieri Donatella Defendi Rosella Defendi Rosella
Storia dell’arte Anitori Rosella Anitori Rosella Anitori Rosella
Prencipe Monica
Scienze motorie Damiani Pierpaolo Baldini Nadia Alessandrelli Alessandra
Religione Montevecchi Mariangela Montevecchi Mariangela Montevecchi Mariangela
Sostegno - - Miglietta Cosimina
92.4PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo storico
La classe 5a G è composta da 29 alunni, 24 femmine e 5 maschi.
Nei cinque anni di corso, si è avuto l’avvicendamento di docenti diversi in alcune discipline.
Tale discontinuità didattica ha comportato per la classe la necessità di adattarsi di volta in
volta a differenti metodi di insegnamento.
Ciò tuttavia non ha impedito, almeno per alcuni, una sensibile crescita umana e culturale:
un gruppo di alunne particolarmente attente e motivate è infatti riuscito a realizzare un effi-
cace e proficuo approccio allo studio, rispondendo sempre positivamente all’attività didattica
e al dialogo formativo.
Le variazioni numeriche della classe negli anni non hanno ostacolato la formazione di una
fisionomia abbastanza omogenea del gruppo, anche se nel corso del quinquennio esso non
sempre si è mostrato coeso e solidale.
Alcuni alunni hanno partecipato con assiduità, per tutto il corso liceale, alle attività di appro-
fondimento disciplinari, curricolari ed extra-curricolari, previste dal PTOF o scelte individual-
mente, sviluppando così progressivamente interessi diversificati, anche direzionati verso le
future scelte di studio e lavoro.
Particolare il quarto anno di corso, in cui la classe ha trovato prima nuovi equilibri per il pro-
getto di scuola all’estero di tre componenti (per l’intero anno scolastico) e poi, al rientro in
quinto, un arricchimento culturale ed una nuova stabilità.
Nell’attuale anno di corso la classe è stata coinvolta nell’insegnamento in modalità CLIL del-
la disciplina storia dell’arte che, limitatamente ad alcune attività indicate dalla programma-
zione, è stata insegnata in lingua inglese.
Nel corso del triennio, tutti gli studenti, anche quelli che avevano partecipato ad esperienze
di scuola all’estero, hanno svolto regolare attività di PCTO, comprensiva di formazione co-
mune e attività pratica.
Per quanto riguarda i bisogni educativi speciali, si rimanda ai documenti allegati.
Il profitto
I risultati di apprendimento conseguiti sono soddisfacenti per gran parte della classe: un
buon numero di alunni ha raggiunto una conoscenza dei contenuti disciplinari discre-
ta/buona; alcuni hanno maturato livelli più alti di rendimento, mostrando un’adeguata padro-
nanza delle conoscenze, degli strumenti critici e della capacità di rielaborazione; altri ele-
menti, invece, hanno manifestato una motivazione non sempre appropriata, conseguendo le
mete e gli obiettivi didattico-formativi prefissati con un profitto mediamente sufficiente.
La condotta
Nel complesso la classe ha tenuto un comportamento rispettoso ed educato nei confronti
degli insegnanti, anche se la condotta di alcuni alunni è stata alle volte non del tutto corretta.
102.5 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali sono state utilizzate strategie particolari,
atte ad includere tutti gli alunni nel processo formativo, quali:
- Accompagnamento degli esercizi con lettura ad alta voce delle consegne
- Uso di sintesi, schemi, mappe concettuali all’occorrenza anche durante le verifiche
- Predilezione delle verifiche orali rispetto alle scritte, o compensazione con verifica
orale di una scritta
- Verifiche orali programmate
- Prove di valutazione formativa in aggiunta alle prove sommative
- Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e
collegamento piuttosto che alla correttezza formale
- Utilizzo di tempi aggiuntivi o, in alternativa, riduzione del numero degli esercizi
Per gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati nello specifico si rimanda
alle relazioni sugli alunni con BES allegate al presente Documento.
3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Sempre in ottica inclusiva, in aggiunta alla lezione frontale sono state approntate altre tipolo-
gie di lezione quali:
• Lezione dialogata con approccio problematico ai contenuti disciplinari (brainstorming,
sussidi ulteriori al libro offerti dall’insegnante, utilizzo di mappe concettuali)
• Esercitazioni guidate svolte dai singoli o in piccoli gruppi finalizzate a rinforzare e sta-
bilizzare le nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di imparare ad applica-
re le nozioni teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni ef-
ficaci (didattica laboratoriale, problem solving)
• Apprendimento cooperativo, secondo cui gli studenti, in piccoli gruppi, apprendono
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del percorso (ricerche, peer
tutoring, cooperative learning)
• Uso delle tecnologie per attività didattiche ordinarie (LIM) e laboratoriali unitariamente
all’uso del registro elettronico come fonte di materiale didattico
• Integrazione del percorso di studio con visite guidate
• Sollecitazione dei processi metacognitivi e delle competenze (lezioni metacognitive,
flipped classroom)
• Valutazioni di tipo formativo in aggiunta a valutazioni di tipo sommativo
3.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
Nel quinto anno di corso la classe è stata coinvolta nell’insegnamento in modalità
CLIL della disciplina storia dell’arte che, limitatamente ad alcune attività indicate dalla
programmazione, è stata insegnata in lingua inglese.
114.PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL)
Nel corso del triennio, tutti gli studenti hanno svolto regolare attività di PCTO, comprensi-
va di formazione comune e attività pratica ben oltre le 90 ore previste dall’attuale norma-
tiva (Legge n.145, 30/12/18 comma 784). Per maggiori dettagli relativi alle attività com-
plementari e integrative dei singoli alunni si rimanda al relativo allegato.
4.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel quadro delle iniziative varate dal Liceo per accompagnare gli studenti al riformato
Esame di Stato, la prof.ssa Sandra Angelini, Docente di Diritto dell’Istituto, ha tenuto un
seminario di approfondimento della durata di due ore, propedeutico al colloquio, relativo
alle seguenti tematiche:
• Costituzione italiana: struttura e commento ai principi fondamentali;
• Parlamento italiano: funzionamento e organizzazione, la legislazione ordinaria e co-
stituzionale, la responsabilità dei parlamentari;
• Governo: struttura, formazione, il rapporto di fiducia, il potere normativo;
• Presidente della Repubblica: ruolo, poteri presidenziali, responsabilità
• Cenni sulla magistratura.
Le misure di accompagnamento sono state arricchite da tre ulteriori incontri della durata
di due ore ciascuno:
1. Prof. Giorgio Marongiu: “Cittadinanza e Costituzione nel nuovo Esame di Stato” –
Prof. Giancarlo Vilella: “Essere Europei”;
2. Prof. Ugo Cardinale: “Il cammino della democrazia nella società e nella scuola: la le-
zione di Tullio De Mauro, insostituibile Maestro”;
3. Prof. Cristiano Bellei e prof.ssa Maria Gabriella Pediconi: “Sì alle regole, no alle di-
pendenze - le idee dei giovani”.
4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Progetti
Progetto “La scuola incontra il Carcere” (Prof.ssa Giostra):
- incontro con il Garante,
- con l'UEPE,
- con l’educatrice del Carcere di Pesaro e presentazione del libro "La chiave di cioccola-
ta"
Progetto “Fare Comunità” (Prof.ssa Giostra):
-educazione alle differenze di genere e documentario su Joyce Lussu,
12incontri su: terremoto, psicologia dell’emergenza, carcere, guerra in Siria, movimenti
femminili
Progetto Cinema (Prof.ssa Ciambrignoni): Lo schermo racconta: incontro con il regista
Giorgio Treves che ha presentato docufilm sulle Leggi razziali
Approfondimenti e seminari:
- incontro, il 29 novembre 2018, con il Professor Corrado Bologna, docente di Letteratura
italiana presso la Scuola Normale di Pisa, sul tema “Duecento anni di Infinito”
-potenziamento in orario pomeridiano delle classi quinte del “Liceo Rinaldini” (Matemati-
ca, Inglese).
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
-Viaggio di istruzione a Barcellona dall’8 al 13 aprile 2019
-Visita didattica al carcere di Barcaglione (in programma per fine maggio)
134.4 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME
Sono state effettuate le seguenti simulazioni:
• Prima prova:
1) (durata: 5 ore) – effettuata in data 19/02/2019
2) (durata: 5 ore) – effettuata in data 26/03/2019
• Seconda prova:
1) (durata: 4 ore) – effettuata in data 28/02/2019
PROVE INVALSI (CIRC. 339)
16/03/2019 Italiano
18/03/2019 Matematica
23/03/2019 Inglese
4.5 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI
a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
AREA DELL’EDUCAZIONE VOTO 10 VOTO 9 VOTO 8 VOTO 7 VOTO 6 VOTO 5
CIVICA - Frequenza -Frequenza - Frequenza - Frequenza - Frequenza - Frequenza
Rispetto del regolamento assidua (as- assidua (as- nel complesso non sempre irregolare irregolare (as-
senze 0%-8%) senze 9-12%) regolare (as- regolare (as- (assenze senze oltre il
- Puntualità -Puntualità senze13-16%) senze 17- 21-25%) 25%)
• Frequenza
- Comporta- -Comporta- - Occasionale 20%) - Ritardi - Ritardi abi-
• Puntualità
mento lodevo- mento corretto mancanza di - Ritardi abi- abituali non tuali e frequen-
• Rispetto persone e arre-
le e corretto verso tutti puntualità tuali giustificati ti
di
verso tutti - Totale as- - Comporta- - Comporta- - Comporta- - Numero ele-
• Rispetto delle disposi- - Uso respon- senza di note mento gene- mento non mento non vato di assen-
zioni del Regolamento sabile delle disciplinari ralmente cor- sempre cor- sempre ze non giustifi-
d’Istituto strutture e dei retto verso retto verso corretto cate
materiali tutti tutti verso tutti -Provvedi-
- Totale as- - Qualche - Rispetto - Rispetto menti discipli-
senza di note richiamo ver- parziale delle parziale nari
disciplinari bale regole delle regole
- Nessun ri- - Richiami - Richiami
chiamo sul scritti sul regi- scritti sul
registro di stro di classe registro di
classe o scrit- classe
to
14AREA PEDAGOGICO- -Ruolo colla- - Ruolo colla- - Ruolo non - Ruolo scar- - Partecipa- - Partecipa-
RELAZIONALE borativo e pro- borativo in sempre colla- samente col- zione zione passiva
positivo in classe borativo laborativo occasionale - Generale
Partecipazione al dialogo classe - Buon livello - Interesse e - Interesse e disturbo
educativo - Partecipa- di partecipa- partecipazio- partecipazio- dell’attività
• Partecipazione al lavoro zione costrutti- zione alle ne selettivi ne
didattico in classe va attività didatti- superficiali
• Senso di responsabilità - Ottima socia- che
durante visite e viaggi lizzazione
d’istruzione e nel corso
di attività extrascolasti-
che
• Collaborazione con i
compagni
AREA DELL’ISTRUZIONE - Impegno - Buon impe- - Impegno nel - Impegno - Impegno - Ripetuta
E DELLA FORMAZIONE lodevole con- gno complesso discontinuo e saltuario mancanza di
sapevole e - Diligente costante superficiale - Scarso rispetto delle
CULTURALE maturo svolgimento - Generale - Rispetto rispetto consegne
Impegno nello studio - Puntuale e delle conse- adempimento parziale delle delle con-
• Rispetto delle con- serio svolgi- gne scolasti- delle conse- consegne segne
segne mento delle che gne scolasti-
• Presenza alle veri- consegne sco- che
fiche lastiche
• Impegno nella di-
dattica curricolare
• Partecipazione alle
iniziative scolasti-
che
Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per
ciascuna colonna.
15b) Modalità di attribuzione del credito scolastico
Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i
criteri su indicati, considerate le nuove tabelle fissate dal d. lgs. 62/2017 (che sostituisce il
D.M. n° 99 del 16/12/2009), attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito scolasti-
co secondo le bande e i criteri allegati, fino ad un massimo di 40 punti complessivi nel trien-
nio (e non più 25 come in precedenza).
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede
di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formati-
ve.
L’attribuzione del credito scolastico al quinto anno di corso è avvenuta secondo la
normativa di riferimento (art. 15 e Allegato A del d.lgs. 62/2017) come riportato nella
tabella seguente:
CREDITO SCOLASTICO
Media dei Fasce di credito
voti V anno
MIl punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un
numero intero e deve tenere conto di:
• media dei voti
• curricolo dello studente;
• crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto);
• credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa);
• particolari meriti scolastici.
Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di apparte-
nenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport.
La documentazione relativa deve comprendere:
• un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno
ha svolto l’attività;
• una sintetica descrizione dell’esperienza stessa;
• convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero.
c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico (deliberati dal
Collegio dei Docenti nell’a.s. 2009- 2010 e modificati nell’a.s. 2016-2017)
Il Collegio Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri in
base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e dei cre-
diti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente ed
oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti punti:
1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola):
• Un singolo credito formativo, in una media di profitto che si attesti al minimo della fa-
scia, è da considerarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo su-
periore della fascia stessa, laddove l’oscillazione sia di un solo punto.
• Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con
sospensione del giudizio.
2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività in-
terne (Progetti del Piano dell’Offerta Formativa):
• La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Pro-
getti del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella valutazio-
ne complessiva dell’allievo.
• Verranno attribuiti crediti in relazione alla durata dei progetti come segue:
- ore 10: punteggio fino a un massimo di 0,10;
- ore 20: punteggio fino a un massimo di 0,20;
- ore 30: punteggio fino a un massimo di 0,30.
174.6 Griglia di valutazione della prima prova scritta (italiano)
INDICATORI Classe:
COMUNI Alunno/a: PUNTI
LIVELLI DESCRITTORI
Tipologie
ABC Data:
Ideazione, pianifi- L5 Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate (9-10)
cazione e orga- L4 Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata (7-8)
nizzazione del L3 Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6)
testo L2 Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5)
(max 10) L1 Il testo presenta una pianificazione molto carente e non giunge a una conclusione (2-3)
1
L5 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi appropriati (9-10)
Coesione e coe- L4 Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi (7-8)
renza testuale L3 Il testo è nel complesso coerente, con il ricorso ai connettivi basilari (6)
(max 10) L2 In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione ed i connettivi non sono utilizzati in modo appropriato (4-5)
L1 In molti punti il testo manca di coerenza e coesione, scorretto l’uso dei connettivi (2-3)
L5 Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10)
Ricchezza e pa-
L4 Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8)
dronanza lessica-
L3 Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (6)
le
L2 Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5)
(max 10)
L1 Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio (2-3)
Correttezza L5 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10)
2
grammaticale (or- L4 Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8)
tografia, morfolo- L3 Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura (6)
gia, sintassi); uso L2 Il testo è a tratti scorretto, con alcuni gravi errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione alla punteggiatura
corretto ed effica- (4-5)
ce della punteg- L1 Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione alla punteg-
giatura (max 10) giatura (2-3)
Ampiezza e pre- L5 Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali(9-10)
cisione delle co- L4 Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8)
noscenze e dei L3 Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari (6)
riferimenti culturali L2 Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5)
(max 10) L1 Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e piuttosto confusi (2-3)
L5 Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili, emerge originalità nella rielaborazio-
3
ne/interpretazione (9-10)
Espressione di L4 Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti di originalità nella rielaborazio-
giudizi critici e ne/interpretazione (7-8)
valutazioni perso-
L3 Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale nella rielaborazione/interpretazione (6)
nali (max 10)
L2 Non presenta spunti critici; le valutazioni sono scarsamente originali e approssimative (4-5)
L1 Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative (2-3)INDICATORI SPECIFICI Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Classe:
INDICATORI
Alunno/a:
SPECIFICI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI
Tipologia A
Data:
Rispetto dei vin- L5 Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna (9-10)
coli posti nella
consegna (ad es., L4 Rispetta adeguatamente tutti i vincoli della consegna (7-8)
indicazioni di
massima circa la L3 Lo svolgimento rispetta sufficientemente i vincoli della consegna (6)
lunghezza del
L2 Si attiene in minima parte alle richieste della consegna (4-5)
testo - se presenti
1
- o indicazioni
circa la forma pa-
rafrasata o sinte- L1 Non si attiene alle richieste della consegna (2-3)
tica della rielabo-
razione)
(max 10)
Capacità di com- L5 Analizza in modo completo il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici (9-10)
prendere il testo L4 Analizza il testo in modo adeguato e coglie gli snodi tematici e stilistici (7-8)
nel suo senso Analizza il testo non cogliendo tutte le informazioni essenziali, o, pur cogliendole, commettendo qualche errore di
complessivo e nei L3
interpretazione (6)
2
suoi snodi temati- L2 Lo svolgimento denota una parziale comprensione del testo (4-5)
ci e stilistici
(max 10) L1 Non ha compreso il senso complessivo del testo (2-3)
Puntualità L5 L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è molto puntuale, ricca, pertinente e approfondita (9-10)
nell’analisi lessi- L4 L’analisi è puntuale, accurata e adeguata (7-8)
cale, sintattica, L3 L’analisi è essenziale ma sufficientemente corretta (6)
3
stilistica e retorica L2 L’analisi trascura alcuni aspetti ed è in parte errata (4-5)
(max 10) L1 L’analisi è del tutto errata (2-3)
L5 L’interpretazione del testo è ricca e personale, ed evidenzia capacità critiche (9-10)
Interpretazione
L4 L’interpretazione è corretta e arricchita da considerazioni personali (7-8)
corretta e articola-
4 L3 L’interpretazione è adeguata e presenta qualche considerazione personale (6)
ta del testo
L2 L’interpretazione è stata trattata in modo limitato (4-5)
(max 10)
L1 L’interpretazione è stata trattata in modo limitato e sono del tutto assenti considerazioni personali (2-3)
TOTALE
/ MAX 100 In decimi:INDICATORI SPECIFICI Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Classe:
INDICATORI
Alunno/a:
SPECIFICI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI
Tipologia B
Data:
Individuazione L5 Individua con acume tesi e argomentazioni presenti nel testo (14-15)
corretta di tesi e L4 Individua correttamente tesi e qualche argomentazione del testo (11-13)
argomentazioni L3 Individua con qualche fatica tesi e qualche argomentazioni (9-10)
1
presenti nel testo L2 Individua con fatica tesi ma non individua le argomentazioni (5-8)
proposto.
(max 15) L1 Non sa operare l’individuazione di tesi e argomentazioni o le individua in modo errato (2-4)
Capacità di Argomenta un percorso ragionativo in modo approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto pertinente i
L5
sostenere con connettivi (14-15)
coerenza un Argomenta un percorso ragionativo in modo articolato e organico, ricorrendo in modo appropriato ai connettivi
L4
percorso (11-13)
2 ragionativo Argomenta un percorso ragionativo in modo sufficientemente coerente utilizzando qualche connettivo con perti-
adoperando L3
nenza (9-10)
connettivi L2 L’argomentazione è a tratti e incoerente e impiega connettivi inappropriati(5-8)
pertinenti
(max 15) L1 Non è in grado di sostenere un percorso ragionativo con coerenza e utilizza in modo errato i connettivi (2-4)
Correttezza e L5 I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale e risultano del tutto congrui (9-10)
congruenza dei L4 Possiede riferimenti culturali corretti e congrui (7-8)
riferimenti culturali L3 Possiede riferimenti culturali sufficientemente corretti talvolta non del tutto congrui (6)
3 utilizzati per L2 Possiede riferimenti culturali non sempre corretti o non congrui (4-5)
sostenere
l’argomentazione L1 Utilizza riferimenti culturali scorretti e poco congrui (2-3)
(max 10)
TOTALE
/ MAX 100 In decimi:INDICATORI SPECIFICI Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Classe:
INDICATORI Alunno/a:
LIVELLI DESCRITTORI PUNTI
Tipologia C
Data:
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia, efficace nella formulazione del titolo e funzionale
L5
Pertinenza del nell’eventuale paragrafazione (14_15)
testo rispetto alla Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafa-
L4
traccia e coeren- zione (11-13)
za nella formula- Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e accettabile nella formulazione del titolo e
1 L3
zione del titolo e dell’eventuale paragrafazione (9-10)
dell'eventuale Il testo è pertinente rispetto alla traccia in modo parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione non risultano
L2
paragrafazione coerenti (5-8)
(max 15) Il testo non è per nulla pertinente alla traccia. Il titolo è completamente inefficace e incoerente. La paragrafazione
L1
è del tutto disfunzionale (2-4)
L5 L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. (14-15)
Sviluppo ordinato e
L4 L’esposizione si presenta organica e lineare (11-13)
lineare
2 L3 L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare. (9-10)
dell’esposizione
L2 L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o debolmente connesso (5-8)
(max 15)
L1 L’esposizione è del tutto disordinata e incoerente (2-4)
L5 Le conoscenze sull’argomento risultano ampie e solide; i riferimenti culturali sono del tutto articolati. (9-10)
L4 Le conoscenze sull’argomento risultano corrette; i riferimenti culturali sono abbastanza articolati. (7-8)
Correttezza e
Le conoscenze risultano abbastanza corrette in relazione all’argomento; i riferimenti culturali non sono del tutto
articolazione delle L3
articolati. (6)
3 conoscenze e dei
Le conoscenze risultano limitate in relazione all’argomento; i riferimenti culturali sono imprecisi e/o poco articola-
riferimenti culturali L2
ti. (4-5)
(max 10)
Le conoscenze risultano fortemente carenti in relazione all’argomento; i riferimenti culturali sono scorretti e non
L1
sostengono l’argomentazione (2-3)
TOTALE
/ MAX 100 In decimi:4.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Indicatori Descrittori Pesi Livelli Punteggi per livelli
Gravemente insufficiente 1
Conoscere
Conoscere le categorie Mediocre 2
concettuali delle scienze
umane, i riferimenti teo- Conosce le informazioni Sufficiente 3
7
rici, i temi e i problemi, richieste dalla traccia.
le tecniche e gli stru- Discreto-buono 4
menti della ricerca affe-
renti agIi ambiti discipli-
nari specifici. Ottimo 5
Gravemente insufficiente 1
Comprendere
Riesce a svolgere la trac-
cia e a rispondere ai que- Mediocre 2
Comprendere il conte-
siti cogliendo gli aspetti
nuto ed il significato del- Sufficiente 3
essenziali degli argomenti 5
le informazioni fornite
coinvolti mantenendo
nella traccia e le conse- Discreto-buono 4
l’aderenza alle consegne
gne che la prova preve-
date.
de. Ottimo 5
Gravemente insufficiente 1
Interpretare
Sa collegare le informa- Mediocre 2
Fornire un'interpretazio- zioni e applicarle al con-
ne coerente ed essen- testo proposto utilizzando Sufficiente 3
4
ziale delle informazioni e valorizzando quanto
apprese, attraverso l'a- contenuto nei documenti Discreto-buono 4
nalisi delle fonti e dei allegati.
metodi di ricerca. Ottimo 5
Gravemente insufficiente 1
Argomentare
È in grado di rielaborare Mediocre 2
Effettuare collegamenti
le conoscenze acquisite,
e confronti tra gli ambiti
esprime giudizi, effettua
disciplinari afferenti alle Sufficiente 3
collegamenti interdiscipli- 4
scienze umane; leggere
nari, utilizzando corretta-
i fenomeni in chiave cri- Discreto-buono 4
mente il linguaggio speci-
tico riflessiva; rispettare
fico delle discipline.
i vincoli logici e linguisti-
ci. Ottimo 5
NB: La scuola ha adottato per la valutazione delle simulazioni le griglie proposte dai Quadri di Riferi-
mento del MIUR (D.M. 769 del 26 novembre 2018, All. A e B), declinando gli indicatori in descrittori.1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
1.1LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALI ANA
CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Anno scolastico 2018/2019
Prof. Natalìa Gabrielloni
Contenuti
Il Romanticismo: cenni sul movimento romantico italiano e confronti con i caratteri gene-
rali del Romanticismo europeo.
Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica, le opere.
dallo Zibaldone
Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Teoria del piacere.
dai Canti
- L’infinito
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
- A Silvia
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- A se stesso
- La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-86; 111-157; 297-317)
dalle Operette morali
- Dialogo di Plotino e di Porfirio
La Scapigliatura: inquadramento del fenomeno, temi, scelte linguistiche.
Igino Ugo Tarchetti
da Fosca
- L’attrazione della morte
Il Naturalismo francese: lo sfondo storico, i fondamenti teorici, gli intellettuali di riferimen-
to
Gustave Flaubert
- I sogni romantici di Emma, da Madame Bovary
Edmond e Jules de Goncourt
da Germinie Lacerteux
- Un manifesto del Naturalismo
23Giovanni Verga e il Verismo: la poetica del Verismo italiano, la tecnica narrativa di Ver-
ga, l’ideologia.
Dalle Novelle:
- Rosso Malpelo
da I Malavoglia
- Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso”
- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
da Mastro Don Gesualdo
- La tensione faustiana del self-made man
Il Decadentismo e il Simbolismo: l'origine del termine, le coordinate storiche, la visione
del mondo decadente, i temi della letteratura.
Charles Beaudelaire e il disagio dell'intellettuale nella società: lo spleen.
Gabriele D’Annunzio: l’autore, il pensiero, la poetica.
da Il piacere
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
da Le vergini delle rocce
- Il programma politico del superuomo
da Alcyone
- La sera fiesolana
- La pioggia nel pineto
APPROFONDIMENTO: D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento
Giovanni Pascoli: le idee, la visione del mondo, la poetica.
da Il fanciullino
- Una poetica decadente
da Myricae
- X agosto
- L’assiuolo
- Temporale
- Il lampo
dai Canti di Castelvecchio
- Il gelsomino notturno
MICROSAGGIO: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari”
Contro la tradizione: il Futurismo e la stagione delle avanguardie
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Luigi Pirandello: l’autore, la visione del mondo, la poetica, i romanzi, la rivoluzione teatra-
le.
da L’umorismo
- Un’arte che scompone il reale
da Le novelle per un anno
- Il treno ha fischiato
da Il fu Mattia Pascal
- La costruzione della nuova identità e la sua crisi
- Non saprei proprio dire ch’io mi sia
24Italo Svevo: l’autore, la formazione e il contesto culturale, la poetica
da Una vita
- Le ali del gabbiano
da Senilità
- Il ritratto dell'inetto
da La coscienza di Zeno,
- La morte del padre
La poesia lirica del 900:
I crepuscolari: modelli e tematiche
Ungaretti
da L’Allegria
- Il porto sepolto
- Veglia
- San Martino del Carso
- Mattina
- Soldati
Montale
da Ossi di seppia
- I limoni
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
L’ermetismo: il significato storico e le caratteristiche
Divina Commedia, Paradiso Canti I, II, III, VI
Il Docente
Prof.ssa Natalìa Gabrielloni
251.2LINGUA E CULTURA LATINA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Anno scolastico 2018/2019
Prof.ssa Maria Maddalena Santacroce
Introduzione all’età giulio-claudia
L’evoluzione del rapporto dei letterati con il potere rispetto alla precedente età.
Fedro e la favolistica
Testi dall’italiano: dalle Fabulae, Il prologo p. 704;
La novella del soldato e della vedova p. 707;
Il lupo e l’agnello p. 707-08;
Seneca
La vita, il rapporto con il potere, la vocazione all’otium filosofico.
Lettura del racconto del suicidio di Seneca negli Annales di Tacito (p. 718).
Le opere: Dialoghi, Trattati, Epistulae morales ad Lucilium, tragedie, Apocolokyntosis.
Testi in latino: De brevitate vitae, 1- 4 La vita è davvero breve? p. 744-46
Testi dall’italiano: De brevitate vitae, Il valore del passato p. 751-52, La galleria degli oc-
cupati p. 752-54;
Consolatio ad Polybium, 7 “Elogio di Claudio” (in fotocopia);
Epistulae morales ad Lucilium: Epistola 1 “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”;
Epistola 8, 1-6, “I posteri”; in fotocopia
Epistola 47 “Come trattare gli schiavi” (par. 1-4 p. 738-40);
dalla Phaedra: “La passione distruttrice dell’amore” (in fotocopia); dall’Apocolokyntosis,
Claudio sale in cielo (in fotocopia)
Lucano
La vita e il rapporto controverso con Nerone.
Il poema del dissenso: puntuale confronto tra l’Eneide e il Bellum civile o Pharsalia.
Testi dall’italiano: Proemio p. 809-11, l’Elogio di Nerone (in fotocopia);
dal I libro: Descrizione di Cesare e Pompeo p. 801-802;
dal VI libro Una funesta profezia p. 813.
Petronio
Il “personaggio” di Petronius elegantiae arbiter alla corte di Nerone: lettura da Tacito, An-
nales, XVI, 18 – 19 (in fotocopia)
26Il Satyricon di Petronio: la trama, i modelli, il realismo dell’autore
Testi dall’italiano:
La decadenza dell’eloquenza pag. 822
da p. 832: Trimalcione entra in scena p. 833;
La presentazione dei padroni di casa p. 835;
Riflessioni sulla morte (in fotocopia);
Trimalcione fa sfoggio di cultura p. 839;
Il testamento di Trimalcione, p. 841-42;
La matrona di Efeso, p. 842-44.
Aulo Persio Flacco
La vita e la produzione satirica, il verum oggetto di poesia.
Testi dall’italiano: dalla Satira V, vv. 14-18 p. 804;
dalla Satira III, La morte di un mangione, p. 806;
Versi Coliambi come dichiarazione di poetica, in fotocopia.
Introduzione all’età dei Flavi
Il rapporto dei letterati con il potere
Marziale
La vita di un poeta cliens. La poetica degli Epigrammata.
Testi dall’italiano da pag. 876:
Dichiarazioni di poetica: X, 4 Una poesia che “sa” di uomo, e I, 4 Distinzione tra letteratura
e vita
I, 15, Vivi oggi (in fotocopia)
III, 26 Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie!
V, 34 Erotion;
X, 10 Il console cliente
X, 47 La ricetta della felicità (in fotocopia)
XII, 18 La bellezza di Bilbili;
Quintiliano e la nascita della pedagogia
La vita e le opere; l’Institutio oratoria, struttura e temi (in particolare il I, il X e il XII libro).
Testi dall’italiano da p. 903: Inst. or. I, 2 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale:
anche a casa si corrompono i costumi, p. 903-04; Vantaggi dell’insegnamento collettivo, p.
905.
Dal X libro: Un excursus di storia letteraria (in fotocopia).
Il principato adottivo
Coordinate storiche: un nuovo rapporto con il potere.
Decimo Giunio Giovenale
La vita e la produzione satirica.
Testi dall’italiano:
dalla Satira I “Il manifesto poetico di Giovenale” in fotocopia;
dalla Satira III “Roma, città crudele con i poveri” p. 930-931;
27dalla Satira VI, “Eppia la gladiatrice. Messalina, augusta meretrice” (in fotocopia).
Plinio il Giovane, un intellettuale integrato nel suo tempo
La vita e le opere: Il panegirico a Traiano e l’epistolario.
Testi dall’italiano: dal carteggio con l’imperatore Traiano: uno scambio di pareri sulla que-
stione dei cristiani p. 936-938.
Publio Cornelio Tacito
La vita e il rapporto con il principato. L’Agricola, la Germania e la produzione storiografica.
Il Dialogus de oratoribus.
Testi dall’italiano da pag. 956:
dall’Agricola, La prefazione; Il discorso di Càlgaco;
dalla Germania,: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani; “La fedeltà coniugale”;
dagli Annales, Il proemio (nella traduzione di Azelia Arici);
“La tragedia di Agrippina”
“La città in fiamme” “Nerone benefattore o incendiario?”
“La persecuzione dei Cristiani”
Libro di testo: Garbarino - Pasquiarello, VELUTI FLOS 2 Paravia;
Fotocopie e appunti forniti dall’insegnante
Il Docente
Prof.ssa Maria Maddalena Santacroce
281.3STORIA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA
a
CLASSE 5 G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Anno scolastico 2018/2019
Prof. Natalìa Gabrielloni
Contenuti
L’età giolittiana
Giovanni Giolitti e la strategia dello Stato liberale; Giolitti e i socialisti: una politica di colla-
borazione; l’inizio dello sviluppo industriale; i meccanismi del potere e le critiche a Giolitti;
l’Italia alla conquista della Libia; la riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico.
La nascita del sistema delle alleanze
Il congresso di Berlino; gli schieramenti difensivi: il sistema delle alleanze.
Le ambizioni del regno di Serbia e l’inizio della guerra nei Balcani
Il colpo di stato: 1903; le crisi di Bosnia, Marocco e Libia; le conseguenze delle guerre bal-
tiche; l’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo; l’ultimatum di Vienna; il
fallimento dell’offensiva austriaca contro la Serbia; la sconfitto della Serbia.
Le scelte strategiche dell’Impero tedesco e l’inizio della guerra
Il piano Schlieffen; il generale consenso alla guerra; un nuovo senso di appartenenza alle
comunità nazionali; l’invasione del Belgio; le trincee e la guerra di posizione.
L’Italia dalla neutralità all’intervento
L’iniziale neutralità italiana; l’Italia divisa tra neutralisti e interventisti: gli interventisti di sini-
stra; il Patto di Londra; la crisi del sistema parlamentare.
Una guerra di logoramento
La guerra di trincea; le battaglie di Verdun e della Somme; Gran Bretagna e Germania: il
blocco navale e la guerra sottomarina
Il fronte italiano
Il generale Cadorna e le carenze organizzative dell’esercito italiano; la guerra nel Carso.
Gli ultimi anni di guerra
La Russia esce dalla guerra; gli Stati Uniti entrano in guerra; la fine della prima guerra
mondiale.
29Da Caporetto a Vittorio Veneto
L’offensiva austro-tedesca; le cause della sconfitta; le conseguenze politiche e la fine della
guerra.
La Rivoluzione di febbraio in Russia
Arretratezza e rifiuto della modernità; proteste e ammutinamenti: la proclamazione della
repubblica; l’opposizione tra il governo provvisorio e i soviet; il marxismo russo: monscevi-
chi e bolscevichi
Lenin, la Rivoluzione d’ottobre e i bolscevichi al potere
Il ritorno in Russia di Lenin e l’ascesa dei bolscevichi; verso la dittatura del proletariato; il
trionfo del socialismo e l’estinzione dello Stato; la conquista del potere; la dittatura del par-
tito bolscevico; il comunismo di guerra e l’Armata rossa; Nep e repressione; la successio-
ne di Lenin; l’industrializzazione della Russia; l’eliminazione dei kulaki; il grande terrore
staliniano
La nascita della Repubblica di Weimar in Germania
La Repubblica di Weimar; Versailles e le durissime condizione di pace
L’Italia dopo la prima guerra mondiale
Una vittoria deludente; D’Annunzio e Fiume; un paese povero e uno stato indebitato; i ti-
mori di una rivoluzione russa; correnti e divisioni del partito socialista; il Partito popolare di
don Luigi Sturzo.
Mussolini e il movimento fascista
Mussolini e il suo percorso politico; i Fasci italiani di combattimento; l’ultimo governo Giolit-
ti e i timori della borghesia; le squadre d’azione fasciste.
Politica ed economia degli anni Venti
La Società delle nazioni e la posizione americana; il trattato di Rapallo tra Germania e
Unione Sovietica; l’inflazione del 1923 in Germania;gli Stati Uniti dei ruggenti anni Venti; i
nuovi metodi dell’industria americana.
Adolf Hitler e Mein Kampf
La formazione; la fondazione del Partito nazionalsocialista; marxisti ed ebrei nella conce-
zione di Hitler
Il fascismo al potere
Il Duce e il Partito nazionale fascista; la marcia su Roma: Mussolini al governo; la realiz-
zazione di uno Stato fascista; il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura; la distruzione dello
Stato liberale; le corporazioni
30La grande depressione negli USA
Dall’agricoltura alla Borsa: l’inizio della crisi economica; Roosevelt e il New Deal; tra libera-
lismo e democrazia.
Hitler al potere in Germania
Gli effetti della crisi: il successo elettorale del Partito nazista; Hitler, salvatore della Ger-
mania; l’incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale; l’inizio della dittatura
Lo Stato totalitario in Germania e in Italia
Il principio del fuhrer; la notte dei lunghi coltelli; i lager e i caratteri specifici dello sterminio
nazista; il problema della disoccupazione: le opere pubbliche, la ripresa economica e la
preparazione della guerra; economia e politica nel Terzo Reich.
I concetti di base del fascismo: Stato e nazione; il consenso: l’illusione della partecipazio-
ne attiva; il mito di Mussolini; lo Stato totalitario fascista; la politica economica del regime
Le tensioni internazionali degli anni Trenta
Le ambizioni giapponesi in Asia; le prime sfide tecniche all’ordine di Versailles;
l’imperialismo fascista; il razzismo e la legislazione razziale
La sfida di Hitler all’ordine di Versailles
La politica estera di Hitler; la conferenza di Monaco; il patto Molotov-Ribbentrop; l’Italia
dalla non belligeranza all’intervento
L’invasione dell’URSS
La preparazione all’attacco tedesco e le motivazioni; l’avanzata tedesca e le risposte so-
vietiche; la Gran Bretagna in soccorso all’Urss; Giappone e USA in guerra; la battaglia di
Stalingrado
La vittoria degli Alleati
La Conferenza di Casablanca; il calo dei consensi per il regime fascista; lo sbarco degli
Alleati in Sicilia; l’arresto di Mussolini e la caduta del fascismo; l’armistizio e l’8 settembre;
la Repubblica di Salò; liberazione del sud d’Italia e i partiti antifascisti
La sconfitta della Germania e la conclusione del conflitto
La Conferenza di Teheran; L’estate del ‘44; il movimento di Resistenza in Italia; la caduta
di Berlino; la fine della guerra in Italia; la guerra in Iugoslavia e i partigiani di Tito; le foibe;
l’attacco nucleare contro il Giappone
Il dopoguerra: un mondo diviso tra USA e URSS
La nascita dell’ONU; la Dottrina Truman e il Piano Marshall; l’inizio della guerra fredda.
31Puoi anche leggere