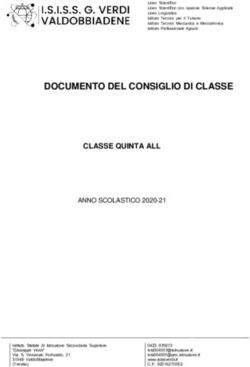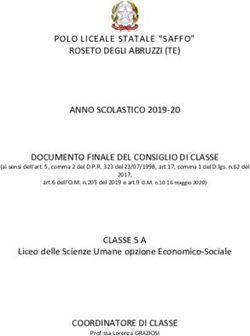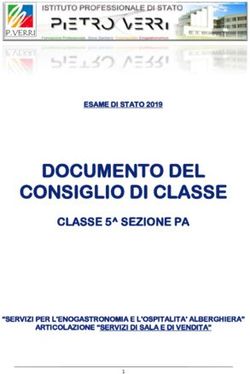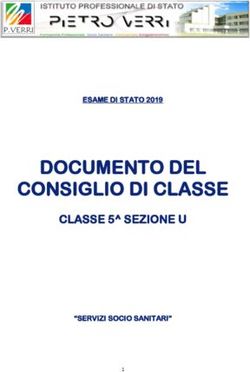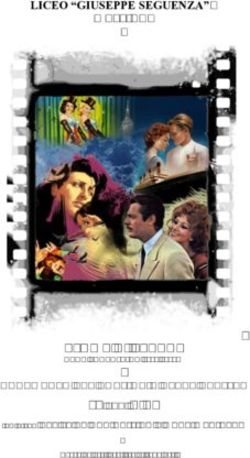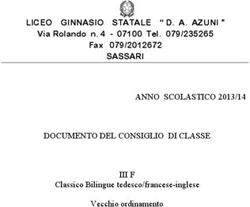DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Classe 5a sez. Bt a.s. 2018-2019 indirizzo: LICEO CLASSICO - Liceo Carlo Rinaldini
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe 5a sez. Bt
a.s. 2018-2019
indirizzo: LICEO CLASSICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria AlegiEsame di Stato
Anno Scolastico 2018-2019
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. Bt
Indirizzo: Liceo Classico
Docenti del Consiglio di Classe Firma
1. Prof. D'Amico Matteo*
__________________________
2. Prof. Brunelli Mirco
__________________________
3. Prof. Colonnelli Raniero
__________________________
4. Prof.ssa Di Giacomo Roberta
__________________________
5. Prof.ssa Manuali Roberta
__________________________
6. Prof.ssa Mercuri Laura
__________________________
7. Prof.ssa Sandroni Claudia
__________________________
8. Prof.ssa Santacroce Maria Maddalena
__________________________
9. Prof. Tortorella Gaetano
__________________________
*Coordinatore di Classe
Rappresentanti degli alunni Firma
1.
__________________________
2.
__________________________
Ancona, 15 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Alegi
1DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. Bt
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO
PARTE PRIMA
1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1. Piano di studi, finalità istituzionali pag. 4
2. Quadro orario pag. 5
2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
1. Elenco dei candidati pag. 6
2. Variazioni numeriche della classe pag. 7
3. Continuità dei docenti della classe pag. 7
4. Presentazione della classe pag. 8
5. Strategie e metodi per l’inclusione pag. 8
3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Metodologie e strategie didattiche pag. 8
2. CLIL: attività e modalità di insegnamento pag. 9
4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) pag. 10
2. Cittadinanza e Costituzione pag. 11
3. Progetti significativi; visite e viaggi di istruzione pag. 11
4. Simulazioni prove d'esame pag. 13
5. Valutazione: scala dei punteggi e descrittori pag. 14
a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta pag. 14
b) Modalità di attribuzione del credito scolastico pag. 15
c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico pag. 16
6. Griglia di valutazione della prima prova scritta pag. 17
7. Griglia di valutazione della seconda prova scritta pag. 21
2PARTE SECONDA
1. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
1. Lingua e letteratura italiana pag. 22
2. Lingua e cultura latina pag. 30
3. Lingua e cultura greca pag. 33
4. Lingua e cultura straniera (Inglese) pag. 36
5. Storia pag. 39
6. Filosofia pag. 40
7. Matematica pag. 41
8. Scienze naturali pag. 42
9. Fisica pag. 45
10. Storia dell’arte pag. 47
11. Scienze motorie e sportive pag. 50
12. Insegnamento della Religione Cattolica pag. 51
31. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO
1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI
Liceo Classico ordinamentale
Il Liceo Classico è il nucleo storico del Liceo “Rinaldini”, fondato nel 1861, illustre per tradi-
zioni e storia.
La sua fisionomia particolarmente flessibile ha via via acquisito e inglobato tutte le riforme
che hanno investito la Scuola italiana dal 1927, anno della sua formalizzazione da parte del
filosofo Giovanni Gentile. Nato come corso di studi destinato a formare la nuova classe diri-
gente, nel corso degli anni ha visto innovazioni sul fronte della didattica, dei risultati attesi e
ottenuti e del curricolo, mantenendo fermi alcuni principi fondanti: l’acquisizione di un meto-
do di studio e lavoro produttivo, la creazione di una mente critica, la capacità di leggere e
interpretare la realtà.
Nelle Indicazioni nazionali si legge che “il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio
della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e
filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occi-
dentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto
di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno
di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a matu-
rare le competenze a ciò necessarie”.
Il profilo d’uscita atteso
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, dovranno:
1. Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significati-
vi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di com-
prensione critica del presente;
2. Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua
italiana in relazione al suo sviluppo storico;
3. Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline
specificamente studiate;
4. Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
4Alla luce di quanto anticipato dal DM 769 del 26/11/2018 e dal Quadro di riferimento dei Licei
allegato alla Nota Prot. 19890 del 26/11/2018, che regolamentano le nuove modalità
dell’Esame di Stato conclusivo degli studi secondari di secondo grado, per garantire agli stu-
denti del secondo biennio e del monoennio finale una corretta preparazione nella disciplina
“Cittadinanza e Costituzione”, prevista quale oggetto della prova orale dell’Esame di Stato,
saranno riproposti e ampliati i seminari opzionali di Diritto. Per quanto attiene alla seconda
prova scritta, le nuove prescrizioni, che prevedono, oltre alla traduzione dal latino o dal gre-
co, la contestualizzazione del testo attraverso tre quesiti a risposta aperta, vertenti anche
sull’analisi stilistica e retorica, nonché una seconda modalità che mette a confronto il brano
tradotto con un testo nell’altra lingua classica analogo per argomento e genere, in lingua ori-
ginale e in traduzione, confermano la necessità, già individuata e soddisfatta, di corsi di po-
tenziamento nel monoennio finale in preparazione a detta prova, per lo svolgimento dei quali
persiste la necessità di poter disporre di personale in aggiunta all’organico necessario per la
sola attività didattica curricolare.
1.2 QUADRO ORARIO
ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
I BIENNIO II BIENNIO
PER TUTTI GLI STUDENTI 5°
1° 2° 3° 4° anno
anno anno anno anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 3 3 3
Filosofia - - 3 3 3
Matematica con Informatica nel I Biennio 3 3 2 2 2
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Storia dell’Arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31
52. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
2.1 ELENCO DEI CANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
62.2 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE
Anno di corso N° alunni N° alunni N° alunni N° alunni am-
iscritti trasferiti da trasferiti ad messi alla
altre scuole o altre sezioni o classe
sezioni scuole o successiva
ritirati
III 15 1 14
IV 14 13
V 13
2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE
DOCENTI DOCENTI DOCENTI
MATERIA
CLASSE III CLASSE IV CLASSE V
Lingua e letteratura italiana Santacroce Santacroce Santacroce
Lingua e cultura latina Di Giacomo Di Giacomo Di Giacomo
Lingua e cultura greca Di Giacomo Di Giacomo Di Giacomo
Lingua e cultura straniera (Inglese) Manuali Manuali Manuali
Storia D'Amico D'Amico D'Amico
Filosofia D'Amico D'Amico D'Amico
Matematica Mercuri Mercuri Mercuri
Scienze naturali Colonnelli Colonnelli Colonnelli
Fisica Mercuri Mercuri Mercuri
Storia dell’arte Sandroni Sandroni Sandroni
Scienze motorie e sportive Brunelli Brunelli Brunelli
Religione cattolica Tenti Tenti Tortorella
72.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo storico
Nel corso del triennio la classe è sicuramente cresciuta sul piano della consapevolezza cul-
turale: da uno stato iniziale di fragilità e insicurezza abbastanza marcate, è giunta a rappor-
tarsi alle diverse discipline e ai diversi temi trattati in modo più autonomo e profondo. Capa-
ce di interessarsi in modo personale sugli argomenti che la coinvolgono maggiormente, va in
genere stimolata dal docente ad una partecipazione attiva in classe e a un dialogo educativo
più personale. Nel secondo anno del secondo biennio due allieve hanno frequentato le le-
zioni all’estero.
Il profitto
Quanto al profitto la classe ha avuto nel corso del triennio un rendimento piuttosto differen-
ziato: a un gruppo significativo di studenti capace di conseguire ottimi risultati grazie ad uno
studio assiduo e profondo degli argomenti assegnati e alla rielaborazione personale, si è af-
fiancato un insieme di studenti dal rendimento discreto e un ristretto numero di studenti che
ha talora manifestato qualche difficoltà nel raggiungere una piena sufficienza in tutte le di-
scipline.
La condotta
Uno dei punti di forza della classe è sempre stata la disponibilità al lavoro, la grande discipli-
na, lo spirito di collaborazione con i docenti, la serietà nel gestire le consegne e nella rielabo-
razione personale. Rara la necessità di richiamare la classe durante le attività scolastiche ed
esemplare il comportamento anche nei viaggi di istruzione. Davvero positiva l'unione fra gli
studenti e il clima di amicizia che ne è il portato.
2.5 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Si rimanda agli allegati per quanto riguarda gli interventi didattici del consiglio di classe.
3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Discipline Metodologie didattiche
Materie umanistiche Lezioni frontali, lavagna, LIM; libro di testo, fotocopie, au-
diovisivi; biblioteca e mediateca (anche on line); Internet;
visite presso musei, biblioteche, archivi. Cooperative lear-
ning.
Discipline scientifiche e di Lezioni frontali, lavagna, LIM; lezione dialogata; libro di
calcolo testo, fotocopie, audiovisivi; laboratori, sessioni in gruppo.
Lingue antiche e moderne Lezioni frontali, lavagna, LIM; libro di testo, fotocopie, au-
diovisivi; Internet; lavori di gruppo, interazioni con figure
8professionali della scuola.
3.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
Durante il triennio, la classe non si è avvalsa di tale metodologia.
94. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL)
Il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex ASL) ha lo sco-
po di integrare la metodologia dell’alternanza nella pratica didattica quotidiana del liceo
classico adottando una strategia di attuazione dei percorsi che possa diversificare le mo-
dalità e gli approcci, rispondendo alle esigenze e ai bisogni formativi degli studenti. Mira a
sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento permanente: imparare ad imparare,
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabi-
le; risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare
l’informazione.
Il curricolo di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento si svolge
nell’arco del triennio e prevede acquisizione di conoscenze specifiche per la sicurezza, in-
formazione sul mondo del lavoro e orientamento, attività di stage.
Le attività di stage del secondo biennio e del monoennio sono riportate in tabella.
Primo anno Secondo anno Monoennio
Centro di salute Orientamento
Ausili Irene Archivio di Stato
mentale universitario.
Orientamento
Becchetti Sarah Archivio di Stato Teatro (Inghilterra)
universitario
Orientamento
Fabietti Riccardo Archivio di Stato Archivio di Stato
universitario
Centro di salute Orientamento
Grilli Margherita Archivio di Stato
mentale universitario
Riqualificazione Riqualificazione
Orientamento
Lenti Alessio degli spazi interni ed degli spazi interni ed
universitario
esterni dell’Istituto esterni dell’Istituto
Riqualificazione Riqualificazione Orientamento
Palpacelli Emiliano degli spazi interni ed degli spazi interni ed universitario,
esterni dell’Istituto esterni dell’Istituto Progetto Sorprendo
Riqualificazione Orientamento
Ripanti Tommaso degli spazi interni ed Giornalismo sportivo universitario,
esterni dell’Istituto Progetto Sorprendo
Riqualificazione
Centro di salute Orientamento
Rondelli Francesco degli spazi interni ed
mentale universitario
esterni dell’Istituto
Riqualificazione
Orientamento
Rotelli Giulia degli spazi interni ed Scuola elementare
universitario
esterni dell’Istituto
Percorso “imparare
Orientamento
a camminare”:
Sampaolesi Jacopo Museo archeologico universitario,
organizzazione e
Progetto Sorprendo
gestione eventi
Riqualificazione
Ospedale di Vila Orientamento
Scalseggi Benedetta degli spazi interni ed
Real - Portogallo universitario
esterni dell’Istituto
Riqualificazione
Scuola e chiesa Orientamento
Solustri Ines degli spazi interni ed
negli USA universitario
esterni dell’Istituto
10Giornalismo
Orientamento
sportivo:
Zagaglia Lorenzo Archivio di stato universitario,
organizzazione di
Progetto Sorprendo
eventi
Le attività curricolari del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento sono
state programmate tenendo conto di finalità complementari, quali lo sviluppo di cono-
scenze specifiche, specialmente in ambito informatico e linguistico. L’attivazione di com-
petenze trasversali è ottenuta attraverso l’assunzione di crescenti responsabilità: i pro-
getti sono stati seguiti da tutor esperti. Nei percorsi individuali si evidenzia la valenza
orientativa rispetto alle future scelte di studio e di lavoro.
La maggior parte delle ore del P.C.T.O. è stata impiegata in strutture pubbliche come
l’archivio di stato e il Centro di Salute Mentale e il nostro Istituto. Ci sono stati studenti
che hanno sviluppato un percorso di P.C.T.O presso strutture estere.
Tra le iniziative promosse per l’orientamento, si segnala la grande adesione manifestata
dalla classe per le giornate dedicate all’orientamento universitario.
4.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel quadro delle iniziative varate dal Liceo per accompagnare gli studenti al riformato
Esame di Stato, la prof.ssa Patrizia Serangeli, Docente di Diritto dell’Istituto, ha tenuto un
seminario di approfondimento della durata di due ore, propedeutico al colloquio, relativo
alle seguenti tematiche:
• Costituzione italiana: struttura e commento ai principi fondamentali;
• Parlamento italiano: funzionamento e organizzazione, la legislazione ordinaria e costi-
tuzionale, la responsabilità dei parlamentari;
• Governo: struttura, formazione, il rapporto di fiducia, il potere normativo;
• Presidente della Repubblica: ruolo, poteri presidenziali, responsabilità
• Cenni sulla magistratura.
Le misure di accompagnamento sono state arricchite da tre ulteriori incontri della durata
di due ore ciascuno:
1. Prof. Giorgio Marongiu: “Cittadinanza e Costituzione nel nuovo Esame di Stato” –
Prof. Giancarlo Vilella: “Essere Europei”;
2. Prof. Ugo Cardinale: “Il cammino della democrazia nella società e nella scuola: la le-
zione di Tullio De Mauro, insostituibile Maestro”;
3. Prof. Cristiano Bellei e prof.ssa Maria Gabriella Pediconi: “Sì alle regole, no alle di-
pendenze - le idee dei giovani”.
4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Formazione di dibattito; EEE; FAI; Corsi di medicina; Simposio; Certamen taciteum; Simpo-
sio; Semestre all’estero (USA); Agone placidiano; Tutoring di problem solving; Olimpiadi Lin-
gua Classica; Colloqui fiorentini; Campus UniBo; Olimpiadi della matematica.
11• Viaggio di istruzione a Sarajevo/Mostar
• Visita guidata (Firenze) alla Mostra “Marina Abramovic. The Cleaner
• Visita Mostra Genesi di Salgado alla Mole Vanvitelliana
Progetti del monoennio
PON Geologia; Incontro con Corrado Bologna: duecento anni di In-
Ausili Irene
finito; Incontro con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura.
Incontro con Corrado Bologna: duecento anni di Infinito; Incontro
Becchetti Sarah
con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura.
Colloqui fiorentini; Incontro con Corrado Bologna: duecento anni di
Fabietti Riccardo
Infinito; Incontro con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura.
Incontro con Corrado Bologna: duecento anni di infinito; Incontro
Grilli Margherita
con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura.
Olimpiadi di civiltà classica; Incontro con Corrado Bologna: duecen-
Lenti Alessio to anni di Infinito; Incontro con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura;
Olimpiadi della matematica.
Palpacelli Emiliano Colloqui fiorentini.
Olimpiadi di civiltà classica; Incontro con Corrado Bologna: duecen-
Ripanti Tommaso to anni di Infinito; Incontro con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura;
Olimpiadi della matematica; Colloqui fiorentini.
Rondelli Francesco Colloqui fiorentini.
Scacchi; Incontro con Corrado Bologna: duecento anni di Infinito;
Rotelli Giulia
Incontro con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura.
Corto dorico; Giornate del FAI di Primavera; Incontro con Corrado
Sampaolesi Iacopo Bologna: duecento anni di Infinito; Incontro con Pierluigi Vaccaneo:
TwLetteratura.
Colloqui fiorentini; Incontro con Corrado Bologna: duecento anni di
Scalseggi Benedetta Infinito; Incontro con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura; Incontro
con le autrici.
Corsi di Inglese preparazione CAE; Colloqui fiorentini; Incontro con
Solustri Ines Corrado Bologna: duecento anni di Infinito; Incontro con Pierluigi
Vaccaneo: TwLetteratura.
Incontro con Corrado Bologna: duecento anni di Infinito; Incontro
Zagaglia Lorenzo
con Pierluigi Vaccaneo: TwLetteratura; incontro con le autrici.
124.4 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME
Sono state effettuate le seguenti simulazioni in concomitanza con la simulazione nazionale
• Prima prova:
1) (durata: 6 ore) – effettuata in data 19 febbraio 2019
2) (durata: 6 ore) – effettuata in data 26 marzo 2019
• Seconda prova:
1) (durata: 6 ore) – effettuata in data 28 febbraio 2019
2) (durata: 6 ore) – effettuata in data 2 aprile 2019
134.5 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI
a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
AREA DELL’EDUCAZIONE VOTO 10 VOTO 9 VOTO 8 VOTO 7 VOTO 6 VOTO 5
CIVICA - Frequenza -Frequenza - Frequenza - Frequenza - Frequenza - Frequenza
Rispetto del regolamento assidua (as- assidua (as- nel complesso non sempre irregolare irregolare (as-
senze 0%-8%) senze 9-12%) regolare (as- regolare (as- (assenze senze oltre il
- Puntualità -Puntualità senze13-16%) senze 17- 21-25%) 25%)
• Frequenza
- Comporta- -Comporta- - Occasionale 20%) - Ritardi - Ritardi abi-
• Puntualità
mento lodevo- mento corretto mancanza di - Ritardi abi- abituali non tuali e frequen-
• Rispetto persone e arre-
le e corretto verso tutti puntualità tuali giustificati ti
di
verso tutti - Totale as- - Comporta- - Comporta- - Comporta- - Numero ele-
• Rispetto delle disposi- - Uso respon- senza di note mento gene- mento non mento non vato di assen-
zioni del Regolamento sabile delle disciplinari ralmente cor- sempre cor- sempre ze non giustifi-
d’Istituto strutture e dei retto verso retto verso corretto cate
materiali tutti tutti verso tutti -Provvedi-
- Totale as- - Qualche - Rispetto - Rispetto menti discipli-
senza di note richiamo ver- parziale delle parziale nari
disciplinari bale regole delle regole
- Nessun ri- - Richiami - Richiami
chiamo sul scritti sul regi- scritti sul
registro di stro di classe registro di
classe o scrit- classe
to
AREA PEDAGOGICO- -Ruolo colla- - Ruolo colla- - Ruolo non - Ruolo scar- - Partecipa- - Partecipa-
RELAZIONALE borativo e pro- borativo in sempre colla- samente col- zione zione passiva
positivo in classe borativo laborativo occasionale - Generale
Partecipazione al dialogo classe - Buon livello - Interesse e - Interesse e disturbo
educativo - Partecipa- di partecipa- partecipazio- partecipazio- dell’attività
• Partecipazione al lavoro zione costrutti- zione alle ne selettivi ne
didattico in classe va attività didatti- superficiali
• Senso di responsabilità - Ottima socia- che
durante visite e viaggi lizzazione
d’istruzione e nel corso
di attività extrascolasti-
che
• Collaborazione con i
compagni
AREA DELL’ISTRUZIONE - Impegno - Buon impe- - Impegno nel - Impegno - Impegno - Ripetuta
E DELLA FORMAZIONE lodevole con- gno complesso discontinuo e saltuario mancanza di
sapevole e - Diligente costante superficiale - Scarso rispetto delle
CULTURALE maturo svolgimento - Generale - Rispetto rispetto consegne
Impegno nello studio - Puntuale e delle conse- adempimento parziale delle delle con-
• Rispetto delle con- serio svolgi- gne scolasti- delle conse- consegne segne
segne mento delle che gne scolasti-
• Presenza alle veri- consegne sco- che
fiche lastiche
• Impegno nella di-
dattica curricolare
• Partecipazione alle
iniziative scolasti-
che
Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per
ciascuna colonna.
14b) Modalità di attribuzione del credito scolastico
Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i
criteri su indicati, considerate le nuove tabelle fissate dal d. lgs. 62/2017 (che sostituisce il
D.M. n° 99 del 16/12/2009), attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito scolasti-
co secondo le bande e i criteri allegati, fino ad un massimo di 40 punti complessivi nel trien-
nio (e non più 25 come in precedenza).
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede
di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formati-
ve.
L’attribuzione del credito scolastico al quinto anno di corso è avvenuta secondo la
normativa di riferimento (art. 15 e Allegato A del d.lgs. 62/2017) come riportato nella
tabella seguente:
CREDITO SCOLASTICO
Media dei Fasce di credito
voti V anno
MIl punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un
numero intero e deve tenere conto di:
• media dei voti
• curricolo dello studente;
• crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto);
• credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa);
• particolari meriti scolastici.
Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di apparte-
nenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport.
La documentazione relativa deve comprendere:
• un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno
ha svolto l’attività;
• una sintetica descrizione dell’esperienza stessa;
• convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero.
c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico (deliberati dal
Collegio dei Docenti nell’a.s. 2009- 2010 e modificati nell’a.s. 2016-2017)
Il Collegio Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri in
base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e dei cre-
diti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente ed
oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti punti:
1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola):
• Un singolo credito formativo, in una media di profitto che si attesti al minimo della fa-
scia, è da considerarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo su-
periore della fascia stessa, laddove l’oscillazione sia di un solo punto.
• Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con
sospensione del giudizio.
2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività in-
terne (Progetti del Piano dell’Offerta Formativa):
• La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Pro-
getti del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella valutazio-
ne complessiva dell’allievo.
• Verranno attribuiti crediti in relazione alla durata dei progetti come segue:
- ore 10: punteggio fino a un massimo di 0,10;
- ore 20: punteggio fino a un massimo di 0,20;
- ore 30: punteggio fino a un massimo di 0,30.
164.6 Griglia di valutazione della prima prova scritta (italiano)
INDICATORI Classe:
COMUNI Alunno/a: PUNTI
LIVELLI DESCRITTORI
Tipologie
ABC Data:
Ideazione, pianifi- L5 Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate (9-10)
cazione e orga- L4 Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata (7-8)
nizzazione del L3 Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente (6)
testo L2 Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con difficoltà a una conclusione (4-5)
(max 10) L1 Il testo presenta una pianificazione molto carente e non giunge a una conclusione (2-3)
1
L5 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi appropriati (9-10)
Coesione e coe- L4 Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi (7-8)
renza testuale L3 Il testo è nel complesso coerente, con il ricorso ai connettivi basilari (6)
(max 10) L2 In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione ed i connettivi non sono utilizzati in modo appropriato (4-5)
L1 In molti punti il testo manca di coerenza e coesione, scorretto l’uso dei connettivi (2-3)
L5 Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10)
Ricchezza e pa-
L4 Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico (7-8)
dronanza lessica-
L3 Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato (6)
le
L2 Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico generico e ripetitivo (4-5)
(max 10)
L1 Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio (2-3)
Correttezza L5 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata (9-10)
2
grammaticale (or- L4 Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata (7-8)
tografia, morfolo- L3 Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura (6)
gia, sintassi); uso L2 Il testo è a tratti scorretto, con alcuni gravi errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione alla punteggiatura
corretto ed effica- (4-5)
ce della punteg- L1 Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione alla punteg-
giatura (max 10) giatura (2-3)
Ampiezza e pre- L5 Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali(9-10)
cisione delle co- L4 Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali pertinenti (7-8)
noscenze e dei L3 Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari (6)
riferimenti culturali L2 Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi (4-5)
(max 10) L1 Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e piuttosto confusi (2-3)
L5 Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili, emerge originalità nella rielaborazio-
3
ne/interpretazione (9-10)
Espressione di L4 Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale, con spunti di originalità nella rielaborazio-
giudizi critici e ne/interpretazione (7-8)
valutazioni perso-
L3 Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale nella rielaborazione/interpretazione (6)
nali (max 10)
L2 Non presenta spunti critici; le valutazioni sono scarsamente originali e approssimative (4-5)
L1 Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e approssimative (2-3)
17INDICATORI SPECIFICI Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Classe:
INDICATORI
Alunno/a:
SPECIFICI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI
Tipologia A
Data:
Rispetto dei vin- L5 Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna (9-10)
coli posti nella
consegna (ad es., L4 Rispetta adeguatamente tutti i vincoli della consegna (7-8)
indicazioni di
massima circa la L3 Lo svolgimento rispetta sufficientemente i vincoli della consegna (6)
lunghezza del
L2 Si attiene in minima parte alle richieste della consegna (4-5)
testo - se presenti
1
- o indicazioni
circa la forma pa-
rafrasata o sinte- L1 Non si attiene alle richieste della consegna (2-3)
tica della rielabo-
razione)
(max 10)
Capacità di com- L5 Analizza in modo completo il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici (9-10)
prendere il testo L4 Analizza il testo in modo adeguato e coglie gli snodi tematici e stilistici (7-8)
nel suo senso Analizza il testo non cogliendo tutte le informazioni essenziali, o, pur cogliendole, commettendo qualche errore di
complessivo e nei L3
interpretazione (6)
2
suoi snodi temati- L2 Lo svolgimento denota una parziale comprensione del testo (4-5)
ci e stilistici
(max 10) L1 Non ha compreso il senso complessivo del testo (2-3)
Puntualità L5 L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è molto puntuale, ricca, pertinente e approfondita (9-10)
nell’analisi lessi- L4 L’analisi è puntuale, accurata e adeguata (7-8)
cale, sintattica, L3 L’analisi è essenziale ma sufficientemente corretta (6)
3
stilistica e retorica L2 L’analisi trascura alcuni aspetti ed è in parte errata (4-5)
(max 10) L1 L’analisi è del tutto errata (2-3)
L5 L’interpretazione del testo è ricca e personale, ed evidenzia capacità critiche (9-10)
Interpretazione
L4 L’interpretazione è corretta e arricchita da considerazioni personali (7-8)
corretta e articola-
4 L3 L’interpretazione è adeguata e presenta qualche considerazione personale (6)
ta del testo
L2 L’interpretazione è stata trattata in modo limitato (4-5)
(max 10)
L1 L’interpretazione è stata trattata in modo limitato e sono del tutto assenti considerazioni personali (2-3)
TOTALE
/ MAX 100 In decimi:
18INDICATORI SPECIFICI Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Classe:
INDICATORI
Alunno/a:
SPECIFICI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI
Tipologia B
Data:
Individuazione L5 Individua con acume tesi e argomentazioni presenti nel testo (14-15)
corretta di tesi e L4 Individua correttamente tesi e qualche argomentazione del testo (11-13)
argomentazioni L3 Individua con qualche fatica tesi e qualche argomentazioni (9-10)
1
presenti nel testo L2 Individua con fatica tesi ma non individua le argomentazioni (5-8)
proposto.
(max 15) L1 Non sa operare l’individuazione di tesi e argomentazioni o le individua in modo errato (2-4)
Capacità di Argomenta un percorso ragionativo in modo approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto pertinente i
L5
sostenere con connettivi (14-15)
coerenza un Argomenta un percorso ragionativo in modo articolato e organico, ricorrendo in modo appropriato ai connettivi
L4
percorso (11-13)
2 ragionativo Argomenta un percorso ragionativo in modo sufficientemente coerente utilizzando qualche connettivo con perti-
adoperando L3
nenza (9-10)
connettivi L2 L’argomentazione è a tratti e incoerente e impiega connettivi inappropriati(5-8)
pertinenti
(max 15) L1 Non è in grado di sostenere un percorso ragionativo con coerenza e utilizza in modo errato i connettivi (2-4)
Correttezza e L5 I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale e risultano del tutto congrui (9-10)
congruenza dei L4 Possiede riferimenti culturali corretti e congrui (7-8)
riferimenti culturali L3 Possiede riferimenti culturali sufficientemente corretti talvolta non del tutto congrui (6)
3 utilizzati per L2 Possiede riferimenti culturali non sempre corretti o non congrui (4-5)
sostenere
l’argomentazione L1 Utilizza riferimenti culturali scorretti e poco congrui (2-3)
(max 10)
TOTALE
/ MAX 100 In decimi:
19INDICATORI SPECIFICI Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Classe:
INDICATORI Alunno/a:
LIVELLI DESCRITTORI PUNTI
Tipologia C
Data:
Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia, efficace nella formulazione del titolo e funzionale
L5
Pertinenza del nell’eventuale paragrafazione (14_15)
testo rispetto alla Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafa-
L4
traccia e coeren- zione (11-13)
za nella formula- Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e accettabile nella formulazione del titolo e
1 L3
zione del titolo e dell’eventuale paragrafazione (9-10)
dell'eventuale Il testo è pertinente rispetto alla traccia in modo parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione non risultano
L2
paragrafazione coerenti (5-8)
(max 15) Il testo non è per nulla pertinente alla traccia. Il titolo è completamente inefficace e incoerente. La paragrafazione
L1
è del tutto disfunzionale (2-4)
L5 L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. (14-15)
Sviluppo ordinato e
L4 L’esposizione si presenta organica e lineare (11-13)
lineare
2 L3 L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare. (9-10)
dell’esposizione
L2 L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o debolmente connesso (5-8)
(max 15)
L1 L’esposizione è del tutto disordinata e incoerente (2-4)
L5 Le conoscenze sull’argomento risultano ampie e solide; i riferimenti culturali sono del tutto articolati. (9-10)
L4 Le conoscenze sull’argomento risultano corrette; i riferimenti culturali sono abbastanza articolati. (7-8)
Correttezza e
Le conoscenze risultano abbastanza corrette in relazione all’argomento; i riferimenti culturali non sono del tutto
articolazione delle L3
articolati. (6)
3 conoscenze e dei
Le conoscenze risultano limitate in relazione all’argomento; i riferimenti culturali sono imprecisi e/o poco articola-
riferimenti culturali L2
ti. (4-5)
(max 10)
Le conoscenze risultano fortemente carenti in relazione all’argomento; i riferimenti culturali sono scorretti e non
L1
sostengono l’argomentazione (2-3)
TOTALE
/ MAX 100 In decimi:
204.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO E GRECO)
Punt. Livelli Livelli
Indicatori Descrittori
max. (valore) (punti)
Comprensione assai limitata del senso del brano e/o
1 1,2
testo incompleto
Errori che determinano una comprensione del senso
2 2,4
nell’insieme modesta e/o lievi omissioni
1. Comprensione del Comprensione del senso generale complessivamente
3 3,6
significato globale e 6 accettabile nonostante alcune incertezze
puntuale del testo Comprensione globale adeguata e corretta del senso
4 4,8
generale seppure con qualche inesattezza
Comprensione completa e articolata del testo 5 6
Errori numerosi e diffusi di natura morfosintattica 1 0,8
Alcuni errori nelle strutture morfosintattiche di base 2 1,6
Individuazione delle strutture morfosintattiche più signifi-
3 2,4
2. Individuazione del- cative
le strutture morfosin- 4 Adeguata individuazione delle strutture morfosintattiche,
4 3,2
tattiche pur in presenza di qualche lieve inesattezza
Individuazione nel complesso sicura delle strutture mor-
5 4
fosintattiche
Comprensione limitata del lessico specifico 1 0,6
Comprensione modesta del lessico specifico 2 1,2
Comprensione accettabile del lessico specifico seppur
3 1,8
3. Comprensione del con alcuni errori
3 Comprensione corretta della maggior parte dei vocaboli
lessico specifico 4 2,4
specifici
Comprensione adeguata del lessico specifico 5 3
La resa presenta errori diffusi ed è generalmente inap-
1 0,6
propriata.
La resa non è sempre corretta e appropriata. 2 1,2
4. Ricodificazione e La resa è semplice e complessivamente corretta. 3 1,8
resa nella lingua d'ar- 3 La ricodificazione è generalmente corretta, sebbene la
rivo 4 2,4
resa non sia sempre puntuale.
La ricodificazione e la resa sono appropriate e fluide 5 3
Risposte incomplete e/o non pertinenti 1 0,8
Risposte frammentarie e/o con inesattezze 2 1,6
5. Pertinenza delle Risposte sintetiche, complessivamente pertinenti e cor-
3 2,4
risposte alle doman- 4 rette
de in apparato Risposte corrette ed esaurienti 4 3,2
Risposte puntuali ed articolate e/o con spunti di riflessio-
5 4
ne personale
Punteggio parziale
Punteggio totale
NB: La scuola ha adottato per la valutazione delle simulazioni le griglie proposte dai Quadri di Ri-
ferimento del MIUR (D.M. 769 del 26 novembre 2018, All. A e B), declinando gli indicatori in de-
scrittori.
215. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
5.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALI ANA
CLASSE 5a BT - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2018/2019
Prof.ssa Maria Maddalena Santacroce
GIACOMO LEOPARDI
(vol 2B)
La vita, il pensiero, la poetica, il classicismo romantico dell’autore.
La produzione poetica: i Canti, genesi, struttura e titolo, le partizioni interne.
La produzione in prosa: lo Zibaldone; le Operette morali.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
dallo Zibaldone (a integrazione della illustrazione della poetica e del pensiero dell’autore)
Letture: La teoria del piacere (pag. 659); Poetica del vago, e della lontananza (pagg. 663-
664)
La teoria della visione; Teoria del suono; La doppia visione; La rimembranza (materiale
fornito dall’insegnante)
dai Canti:
L’ultimo canto di Saffo: contenuto; analisi dell’ultima strofa (pagg. 514-517)
L'infinito (pag. 525);
A Silvia; (pagg. 539-541)
Il sabato del villaggio (pagg. 566-568)
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (pagg. 554-558);
A se stesso (pag. 571)
La ginestra: caratteri generali, lettura e commento dei vv. 297-317 (da pag. 575)
dalle Operette morali:
Dialogo della natura e di un islandese (da pag. 608 a 614); Dialogo di Plotino e di Porfirio
(pagg. 632-637)
Dialogo della Moda e della Morte (pagg. 597-600)
Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere (pagg. 639-640)
(questi ultimi dialoghi sono stati affidati come lettura autonoma ai ragazzi, seguita da un
confronto partecipato in classe)
22Per completare la trattazione dell’autore è stata effettuata la visita guidata alla Biblioteca di
Palazzo Leopardi e Colle dell’Infinito a Recanati; Casa di Silvia. La classe ha inoltre parte-
cipato alla lectio magistralis del professor Corrado Bologna sul tema “Duecento anni di
infinito”.
LA CULTURA DEL POSITIVISMO (riferimenti a Comte e Darwin)
(Vol 3A)
Il Naturalismo: lo sfondo storico, i fondamenti teorici, i modelli letterari (in particolare le
premesse realiste della letteratura francese, riferimenti a Flaubert e alla teoria
dell’impersonalità pagg. 36-37)
Emile Zola e il romanzo sperimentale:
Romanzo e scienza: uno stesso (pagg. 16-17)
QUADRO STORICO E CULTURALE DELL’ITALIA POSTUNITARIA
La Scapigliatura: i temi della letteratura scapigliata, (pagg. 131e segg.).
E. Praga, Preludio, pagg. 141-142
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO
La poetica del Verismo italiano, la tecnica narrativa di Verga (impersonalità; regressione e
straniamento) l'ideologia, confronto tra il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano.
Lettura e analisi dei seguenti testi:
Dedicatoria a Salvatore Farina” (da: “L’amante di Gramigna”) pagg. 248-49
Caratteristiche delle raccolte Vita dei campi e Novelle rusticane.
Lettura e analisi delle novelle “Fantasticheria” (rr. 149-186) pag. 272, “Rosso Malpelo” da
pag. 274, “La roba” da pag. 295
I Malavoglia: la composizione, la genesi sociale del romanzo, la struttura e la vicenda, il
sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, la lingua, lo stile, il punto di vista, l’ideologia:
la religione della famiglia e l’impossibilità di mutare stato.
Lettura e analisi dei brani:
“La prefazione ai Malavoglia” pagg. 257-259,
“L’inizio dei Malavoglia” (cap. I) pagg. 318-320,
“L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV) pagg. 345-348.
Mastro don Gesualdo: struttura e trama, personaggi, temi e ideologia.
23Lettura e analisi: cap. IV,5 “La morte di mastro – don Gesualdo” (dalla riga 47) pagg. 372-
375
LA CRISI DEL POSITIVISMO.
Charles Baudelaire e il disagio dell'intellettuale nella società:
La caduta dell’aureola (pagg. 417-418)
L'albatro (pag. 421 )
Corrispondenze (pag. 423)
Spleen (pag. 425)
Il Decadentismo: l'origine del termine, le coordinate storiche e le radici sociali, la visione
del mondo decadente, i temi della letteratura.
L’estetismo e il romanzo di Huysmans: A rebour (trama e temi dell’opera).
I poeti maledetti: Paul Verlaine, Languore (in fotocopia); A. Rimbaud, La metamorfosi del
poeta, dalla Lettera del veggente. (pagg. 435-436).
La poesia simbolista: caratteri.
GIOVANNI PASCOLI
La vita: tra il “nido” e la poesia.
La poetica del Fanciullino: lettura del testo “La poetica pascoliana, III” (pag. 589).
Le soluzioni formali. La visione del mondo tra Positivismo e Simbolismo.
L’ideologia politica tra socialismo umanitario e nazionalismo.
Myricae: composizione e titolo; struttura e temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; la
poetica: il simbolismo impressionistico. Lettura e analisi di:
Lavandare pag. 601
X Agosto pagg. 603-604
L'assiuolo pagg. 608-609
Novembre pag. 611
Temporale (in fotocopia)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pagg. 625-626);
I poemetti: Italy (in fotocopia) strofe IV – VII
I poemi conviviali: Ulisse, L’ultimo viaggio parti XXIII (in fotocopia) e XXIV (pagg. 649-
650). Confronto con l’Ulisse di Dante (Inferno, XXVI, vv. 85-142)
24Gabriele D'Annunzio:
La vita inimitabile di un mito di massa.
L’ideologia e la poetica.
Fase estetizzante - da Il piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli pagg. 491-492; Il verso è tut-
to (in fotocopia)
Fase superomistica: I romanzi del superuomo; da Le vergini delle rocce, Il programma
politico del superuomo, dalla r. 39 (in fotocopia)
Struttura e contenuti delle Laudi.
da Maia, L’incontro con Ulisse vv. 43-105 (in fotocopia)
da Alcyone, La sera fiesolana (pagg. 537-538), La pioggia nel pineto (pagg. 541-544) ,
approfondimento: La pioggia sul cappello di L. Folgore (in fotocopia)
Il Notturno: Il cieco veggente (pag. 518)
IL “DISAGIO DELLA CIVILTÀ”: LE AVANGUARDIE DEL ‘900
Il Primo Novecento: società, cultura, ideologie.
La nuova condizione sociale degli intellettuali.
Le nuove scienze e le nuove tendenze filosofiche.
CONTRO LA TRADIZIONE: IL FUTURISMO E LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo (pagg. 769-771)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (pagg. 773-774)
(VOL 3B)
Il Crepuscolarismo: tematiche, forme, modelli.
Aldo Palazzeschi: Chi sono? (pag. 14)
E lasciatemi divertire! (Canzonetta) (pagg. 16-19)
G. Gozzano: Totò Merùmeni pagg. 54-56
LA POESIA TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO
Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione. La poetica della parola e dell’attimo.
L'Allegria: composizione, significato del titolo, temi. Lettura e analisi dei seguenti testi:
In memoria pagg. 116-117;
Il porto sepolto pag. 119;
Veglia pag. 120;
25Fratelli (redazione del 1942) pag. 125
Sono una creatura pag. 127;
I fiumi pagg. 130-132;
San Martino del Carso pagg. 134-135;
Commiato pag. 139;
Mattina pag. 146;
Soldati pag. 148.
Eugenio Montale: la vita e la formazione culturale, la ricerca intellettuale, la funzione della
poesia
Ossi di seppia: Il significato del titolo; la condizione dell’io; l’”indifferenza” e il “varco”;
l’attraversamento di D’Annunzio e la crisi del simbolismo; la poetica della negatività. Lettu-
ra e analisi de:
I limoni (pagg. 188-190);
Non chiederci la parola… (pag. 192);
Meriggiare pallido e assorto (pagg. 194-195);
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 199);
Forse una mattina andando in un’aria di vetro (pagg. 200-201);
Umberto Saba: La vita e il rapporto con la psicoanalisi. La poetica dell’onestà.
Il Canzoniere: una biografia in versi. Struttura, temi, poetica. Lettura e analisi de:
A mia moglie (pagg. 268-271)
Città vecchia (pag. 306)
Mio padre è stato per me l’assassino (pagg. 292-293)
Amai (pag. 298)
Ulisse (pag. 300)
LO SCENARIO DEL PRIMO NOVECENTO – LA NUOVA PROSA
(vol 3A)
Italo Svevo
La vita; la fisionomia intellettuale e il rapporto con la scrittura e con la psicanalisi (lettura
della Lettera a Valerio Jahier del 27 dicembre 1927 (pagg. 873-874) ; i maestri filosofici e
letterari; la lingua.
Caratteri dei primi romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita e Senili-
tà.
26La coscienza di Zeno: analisi del romanzo (la struttura narrativa, la vicenda, i temi, il nar-
ratore, il tempo “misto”, l’evoluzione dell’inettitudine)
Lettura e analisi dei testi:
Prefazione (pag. 876)
Il fumo (rr. 46-121, pagg. 881-883)
Lo schiaffo (pagg. 889-890)
Il finale (da pag.902, rr. 57-97)
Luigi Pirandello, il riso amaro.
La formazione, la visione del mondo: vitalismo, frantumazione dell’io, rifiuto della socialità,
relativismo conoscitivo.
Il saggio L'Umorismo: le caratteristiche principali dell'arte umoristica; la differenza tra
umorismo e comicità; lettura e analisi del passo “Il sentimento del contrario” (Parte secon-
da, cap. II pagg. 927-928).
Il fu Mattia Pascal: la dissoluzione del romanzo tradizionale; la vicenda, i temi, la struttu-
ra, il protagonista. Lettura e analisi di passi scelti:
“Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa” pagg. 960-963
“Lo strappo nel cielo di carta” pag. 973
“Il fu Mattia Pascal: la conclusione del romanzo” pag. 979.
Uno, nessuno, centomila: trama e significato. Lettura e analisi del testo Non conclude
(pagg. 995-996).
da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna (pag. 900)
LA NARRATIVA E LA POESIA TRA STORIA E MITO
Cesare Pavese
La vita. Il disagio intellettuale ed esistenziale.
Da Il mestiere di vivere lettura e analisi di:
Ricordare: vedere le cose una seconda volta (pagg. 474-475),
“La vita, l’amore e la morte” (pagg. 476-478)
27La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana. La funzione del Mito.
Da Lavorare stanca lettura e analisi de “I mari del Sud” (pagg. 431-434)
Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi lettura e analisi di “Verrà la morte e avrà i tuoi oc-
chi” (pag. 444)
Dialoghi con Leucò: lettura e analisi de “L’inconsolabile” e “L’isola” (entrambi in fotoco-
pia).
I romanzi. La casa in collina. Lettura e analisi di “Forse lo sanno unicamente i morti”
(cap.XXIII) pagg. 458-459.
La luna e i falò: lettura integrale del romanzo seguita da confronto partecipato in classe
partendo dalla lettura della pagina “Un paese ci vuole” a pag. 453.
Per completare la trattazione dell’autore la classe ha partecipato al laboratorio di social
reading sul tema Ho cercato me stesso. Non si cerca che questo. Dialoghi con Pave-
se tenuto dal Direttore della Fondazione Cesare Pavese, dott. Pierluigi Vaccaneo.
Il filone memorialistico del Neorealismo: Primo Levi
La vita. La letteratura per non dimenticare.
Da Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse (pagg. 543-546)
Beppe Fenoglio: l’epopea partigiana
Una questione privata: il romanzo della Resistenza così com’era.
Lettura e analisi della pagina finale dell’opera: L’ultima fuga di Milton (pagg. 400-403).
LA SCRITTURA COME SFIDA AL LABIRINTO
Italo Calvino
La vita, la letteratura come visione del mondo nelle varie fasi della narrativa calviniana.
Lettura e analisi di Non arrendersi al labirinto (pagg. 861-862).
Il Neorealismo fiabesco de Il sentiero dei nidi di ragno. Lettura e analisi del testo Le rifles-
sioni del commissario Kim sul significato della Resistenza (in fotocopia)
Il filone fantastico: la trilogia dei nostri antenati: trame e temi.
Il filone realistico.
Le Lezioni americane: il testamento letterario dell’autore.
Lettura e analisi dei passi riportati nel volume dalla Leggerezza (pagg. 813-815).
28Spunti di Cittadinanza e Costituzione: l’analisi di opere come La casa in collina di Pave-
se, Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino e Una questione privata di Fenoglio ha permesso
di riflettere sul valore delle testimonianze letterarie relative alla Resistenza, alla luce delle
quali abbiamo provato a rileggere i primi tre articoli della Costituzione italiana.
La Divina commedia
Il Paradiso
È stata eseguita, nell’anno in corso, la lettura commentata dei seguenti Canti:
Canto I
Canto II (vv. 1-18)
Canto III (vv. 1-120)
Canto VI
Nel corso dell’anno la trattazione di alcuni autori ha consentito di riflettere su come
la figura di Ulisse sia stata ripresa e variamente reinterpretata nella storia della lette-
ratura: Dante, Inferno, XXVI, vv. 85-142, U. Foscolo, A Zacinto, G. Pascoli, da I poemi
conviviali: Ulisse, L’ultimo viaggio, parti XXIII (in fotocopia) e XXIV (pag 649-650);
G. D’Annunzio, da Maia, L’incontro con Ulisse vv. 43-105 (in fotocopia)
U. Saba, dal Canzoniere, Ulisse. Primo Levi, Il canto di Ulisse tratto da Se questo è un
uomo. C. Pavese, Dai Dialoghi con Leucò: L’isola (in fotocopia)
l Docente
Prof. Maria Maddalena Santacroce
295.2 LINGUA E CULTURA LATINA
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
CLASSE 5a Bt - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2018/2019
Prof.ssa Roberta Di Giacomo
L’ETA’ AUGUSTEA
Orazio: ripasso sul suo profilo letterario (programma del quarto anno), sugli Epodi e sulle
Satire
Letture in latino: Sermones I, 9, vv. 1-60 (Un incontro sgradevole); Sermones I, 1, vv. 106-
121 (Est modus in rebus); Carmina II, 10 (Aurea mediocritas); Carmina I, 11 (Carpe diem)
Letture in italiano: Sermones I, 6, vv. 1-29; 45-64; 65-99 (Mecenate e il padre: due modelli
di vita); Carmina III, 10
LE ORIGINI DELL’ELEGIA LATINA
Cornelio Gallo e gli Amores
Tibullo: aspetti biografici e opere
Properzio: aspetti biografici, i libri di elegie, l’ “integrazione difficile”
Letture in italiano: Elegiae, III, 3, vv. 1-24; 37-52 (La recusatio dell’epica); Elegiae, IV, 4
(Un’elegia eziologica: l’amore colpevole di Tarpea).
Ovidio: note biografiche, Amores, Heroides, Metamorfosi, Ars amatoria e Fasti
Letture in italiano: Ars amatoria I, vv. 611-614; 631-646; Epistulae ex Ponto, IV, 2; Meta-
morfosi, IV, vv. 56-166 (Piramo e Tisbe).
Lettura, traduzione e commento dal latino: Metamorfosi, I, vv.1-20; Apollo e Dafne, I, vv.
548-567; Tristia, I, 3, vv. 1-24; 49-62; 89-102 (Tristissima noctis imago).
Storiografia, oratoria e retorica, prosa tecnica nel periodo augusteo (quadro generale).
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA
LA PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE
Contesto storico, politico e culturale
SENECA: La vita.
Dialogi: caratteristiche, i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi-trattati, i temi
Trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones
Epistole a Lucilio: caratteristiche e contenuti
Le tragedie
30Apokolokyntosis ed Epigrammi.
Lettura, traduzione e commento: De brevitate vitae, 1; 2, 1-2 (E’ davvero breve il tempo
della vita?); Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3 (Solo il tempo ci appartiene); Epistulae ad Luci-
lium, 24, 17-19 (La morte come esperienza quotidiana); De tranquillitate animi, 2, 12-15 (I
rimedi per lenire l’inquietudine); Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4 (Come devono essere trat-
tati gli schiavi). Altri brani sono stati tradotti dal versionario.
Lettura in traduzione italiana: De ira, III, 36, 1-4 (L’esame di coscienza).
LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE
Lucano: note biografiche e opere perdute, Bellum civile, le caratteristiche dell’epos di Lu-
cano, i rapporti con l’epos virgiliano, i personaggi, il linguaggio poetico, lo stile.
Lettura in traduzione italiana: Bellum civile, VI, vv. 719-735; 750-808 (Una scena di ne-
cromanzia); I, vv. 129-157 (I ritratti di Pompeo e Cesare); II, vv. 284-325 (Il discorso di Ca-
tone); II, vv. 380-391 (Il ritratto di Catone).
Persio: note biografiche, la poetica della satira, i contenuti, forma e stile
Petronio: note biografiche, la questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera,
la questione del genere letterario, il realismo petroniano, lo stile.
Lettura in traduzione italiana: Satyricon, 32-34 L’ingresso di Trimalchione; 37,1-38,5 Pre-
sentazione dei padroni di casa;I-4;L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza;111-
112,8 La matrona di Efeso.
LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI
Marziale: note biografiche, la poetica, le prime raccolte; gli Epigrammata: tecnica compo-
sitiva, i temi, forma e lingua.
Lettura, traduzione e commento: Epigrammata, I, 10 (p. 305); VIII, 79 (p. 307); XI, 35 (p.
309).
Priapea
LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL SECOLO
Plinio il Vecchio: note biografiche, la Naturalis historia.
Quintiliano: note biografiche e cronologia dell’opera, l’Institutio oratoria, la decadenza
dell’oratoria secondo Quintiliano, lo stile.
Lettura, traduzione e commento: Institutio oratoria, proemio 9-12 (Retorica e filosofia nella
formazione del perfetto oratore); I, 2, 1-2 (Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo); II,
1, 4-8 (Il maestro come secondo padre).
Altri brani sono stati tradotti dal versionario.
Lettura in traduzione italiana: Institutio oratoria I, 2, 11-13; 18-20 (I vantaggi
dell’insegnamento collettivo).
31Puoi anche leggere