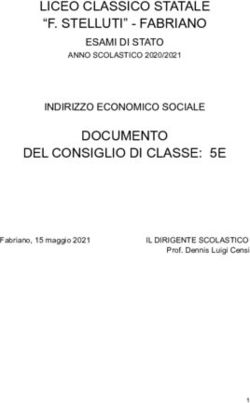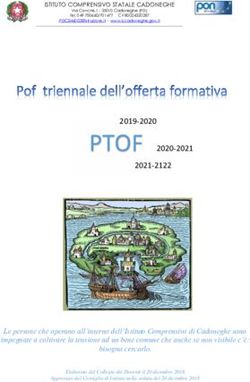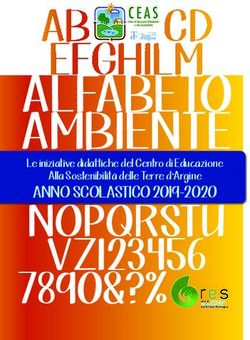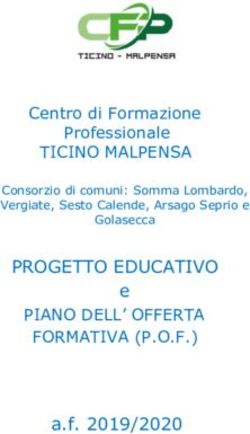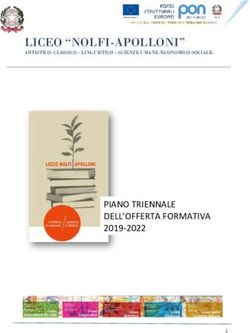ANNO SCOLASTICO 2013/14 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE III F - Classico Bilingue tedesco/francese-inglese Vecchio ordinamento - LICEO GINNASIO ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LICEO GINNASIO STATALE “ D. A. AZUNI ”
Via Rolando n. 4 - 07100 Tel. 079/235265
Fax 079/2012672
SASSARI
ANNO SCOLASTICO 2013/14
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
III F
Classico Bilingue tedesco/francese-inglese
Vecchio ordinamentoSINTETICA DESCRIZIONE DELLA CLASSE La classe è composta di N. 29 alunni, provenienti dalla II F dello scorso anno scolastico, eccezion fatta per Francesca Orani, che ha ripreso gli studi dopo un’interruzione di due anni determinata da motivi di famiglia. La classe ha seguito con coerenza l’indirizzo bilingue (Tedesco/Francese-Inglese) con certificazione internazionale delle competenze. Chiara Morganti, pur regolarmente iscritta nell’elenco, ha completato all’estero il percorso di studio già intrapreso nello scorso anno scolastico. Per Federica Bonomo, Eleonora Cuccuru, Marta Lepuri, Alba Massaiu, Irene Ruggieri, che lo scorso anno hanno frequentato all’estero e che hanno sostenuto all’inizio del secondo quadrimestre un colloquio finalizzato all’integrazione del Credito scolastico, si sono programmati percorsi di recupero dell’attività didattica relativa alla seconda liceo nelle discipline non studiate all’estero. Per l’alunna Calvia Luigina Irene il C.d.C. ha attuato il piano didattico personalizzato per le sue esigenze di apprendimento (vedi documentazione nei verbali delle sedute del Consiglio di classe). Diversi alunni sono pendolari e provengono da Nulvi, Porto Torres, Ossi, Ploaghe, Ittiri, mentre gli altri risiedono in città. La classe ha seguito nell’arco del quinquennio il Piano di Studi riportato sotto:
Liceo classico ad opzione linguistica (Tedesco/Francese-Inglese);
Materie Classe Classe Classe Classe Classe
IV V I II III
Ore Ore Ore Ore Ore
Italiano 5 5 4 4 4
Latino 5 5 4 4 4
Greco 4 4 3 3 3
Tedesco/Francese 3 3 3 3 4
Inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 3 3 3
Filosofia - - 3 3 3
Geografia 2 2 - - -
Scienze naturali, - - 4 3 2
chimica e geografia
Matematica 2 2 3 2 2
Fisica - - - 2 2
Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Educazione fisica 2 2 2 2 2
Religione 1 1 1 1 1
TOTALE 31 31 35 35 34
La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un comportamento
osservante del Regolamento d’Istituto, regolare è stata la frequenza
delle lezioni (le pochissime eccezioni sono state determinate da gravi
motivi di famiglia o di salute, sempre certificati), fermo è stato il
rispetto di tutte le regole.
Nell’arco del triennio, rispetto al livello di partenza gli alunni
(sebbene a diversi livelli) hanno dimostrato una crescita in ordine alle
competenze, alle capacità di applicare e rielaborare le conoscenze,alle abilità linguistiche ed espressive ed al rafforzamento della motivazione allo studio. Si è mantenuta, rispetto al triennio, la continuità didattica per gli insegnamenti di italiano, scienze, francese, inglese, latino, storia dell’arte, matematica e fisica, educazione fisica, religione. Si segnala la sistematica discontinuità didattica nell’insegnamento di storia e filosofia. Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività ritenute dal Consiglio di classe significative per il conseguimento degli obiettivi dell’area cognitiva e di orientamento: • Attività per l’orientamento universitario promosse dall’Istituto; • Rappresentazioni teatrali e mostre d’arte; • Conferenze e partecipazione ad eventi di interesse culturale; • Olimpiadi della matematica; • Monumenti aperti; • Conferenze e concorsi interni del Liceo.
ELENCO ALUNNI
Cognome Nome Lingua
1 Amuganu Silvia Francese
2 Bonomo Federica Francese
3 Calvia Luigina Irene Francese
4 Calvisi Michele Francese
5 Carta Ilaria Tedesco
6 Cau Alessandra Tedesco
7 Chessa Silvia Tedesco
8 Cuccuru Eleonora Tedesco
9 D’Amora Alessandra Tedesco
10 Dessì Ernesto Tedesco
11 Falzoi Veronica Francese
12 Lepuri Marta Tedesco
13 Madau Ekaterina Tedesco
14 Marastoni Laura Francese
15 Massaiu Alba Tedesco
16 Orani Francesca Tedesco
17 Pazzola Gemma Francese
18 Piga Cristina Tedesco
19 Pilo Elena Francese
20 Pinna Daniele Sebastiano Tedesco
21 Pinna Daniele Tedesco
22 Piredda Giulia Francese
23 Ruggieri Irene Tedesco
24 Ruggiu Paola Francese
25 Satta Laura Francese
26 Sechi Federico Francese
27 Solinas Carla Tedesco
28 Soro Marta Tedesco
29 Trenta Federica Tedesco
SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE IMPOSTATA
I docenti hanno posto la massima attenzione nell’analisi delle
componenti individuali della classe, al fine di accertare il recupero
delle carenze pregresse, consolidare le acquisizioni e le competenze
culturali. Successivamente hanno impostato la programmazione di
classe con riferimento alle finalità espresse nel POF, ai variprogrammi curriculari, alle linee programmatiche dei vari Dipartimenti disciplinari. Si è fatto ricorso a strategie metodologiche diverse senza rigidità o esclusivismo: sistematicità, deduttivismo/ induttivismo, analisi dei testi contestualizzati e non contestualizzati, lezione frontale, lezione interattiva, modulo, unità didattica. Privilegiando il principio della “centralità dei rapporti”, si è cercato di stabilire, in un clima di fiducia, di intesa e di proficua collaborazione, un dialogo costante tra allievi e docenti e di sollecitare un attivo feedback per rendere più incisiva e funzionale l’azione didattica, anche tramite i rapporti tra il consiglio di classe e le famiglie degli alunni. Il monitoraggio continuo dei livelli di apprendimento e di potenziamento delle capacità elaborative ha consentito di volta in volta di apportare i necessari correttivi agli interventi didattici e alle programmazioni individuali. OBIETTIVI RAGGIUNTI Rispetto ai seguenti obiettivi della programmazione: a) Obiettivi dell’area cognitiva a)Acquisizione di conoscenze complete, coordinate e ampliate; b) Potenziamento delle capacità di riflessione e sviluppo dell’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite; c)Potenziamento della consapevolezza della specificità dei linguaggi e conseguente sviluppo delle capacità di utilizzare linguaggi e registri linguistici specifici delle discipline; d) Potenziamento delle competenze sia di produzione di testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni e costruiti secondo adeguate tecniche compositive, sia di riflessione su testi letterari e non, sui quali operare analisi e contestualizzazioni; e)Sviluppo e potenziamento delle capacità critiche e di rielaborazione; f) Potenziamento dell’educazione visiva.
b) Obiettivi dell’area non cognitiva a) Favorire lo sviluppo delle potenzialità; b) Favorire la collaborazione tra i docenti e gli alunni; c) Favorire il lavoro di gruppo, anche attraverso la costituzione di gruppi eterogenei. c) Obiettivi di orientamento a) Lettura della realtà con gli strumenti appresi a scuola; b) Conoscenza del sé. Si ritiene che gli alunni abbiano raggiunto sostanzialmente, secondo diverse fasce di livello, oscillanti tra l’ottimo e il quasi sufficiente, i suddetti obiettivi. GLI SPAZI E I TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO Sono state utilizzate, oltre le aule normali, anche aule speciali (laboratori, biblioteche, palestra). I tempi sono stati scanditi dai moduli e dalle unità didattiche in ciascuna disciplina. I CRITERI E GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI Per la valutazione si è tenuto conto degli indicatori valutativi e della scala di misurazione elaborata e fatta propria dal Collegio dei docenti in fase di redazione del POF (vedi tavole allegate). Oggetto della valutazione sono stati, oltre che i risultati in termini di profitto, i seguenti fattori: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, impegno, progressi rispetto al livello iniziale, livello medio della classe, situazione personale. I docenti hanno confrontato sistematicamente le proprie proposte con la rete cognitiva degli alunni, al fine di verificare che esse avessero per loro significato e fossero effettivamente percorribili, permettendo una progressiva conquista di autonomia e fiducia nelle proprie capacità di apprendimento da parte di ciascun alunno. La verifica dei livelli di
apprendimento raggiunti da ciascun alunno, costante e continua, è stata effettuata con prove orali, scritte, questionari, testi, produzione di lavori ed osservazione sistematica dei comportamenti. SITUAZIONE CULTURALE RAGGIUNTA DALLA CLASSE Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di maturità, consolidato un alto senso di responsabilità ed hanno vissuto il percorso scolastico come un’esperienza di crescita intellettuale e grazie ad una forte motivazione e ad un impegno tenace hanno raggiunto una preparazione di ottimo livello in tutte le discipline. Un’altra fascia di alunni ha raggiunto accettabili livelli di maturità, pur non sempre supportato da un coerente senso di responsabilità, ma in virtù delle proprie competenze, capacità e della disponibilità dei Docenti ad un dialogo educativo aperto al confronto e alla valutazione di tutte le componenti della persona e del suo percorso formativo, ha conseguito risultati discreti e sufficienti nelle varie discipline. Altri, che pure hanno incontrato difficoltà soprattutto negli scritti di alcune discipline, hanno comunque partecipato al dialogo educativo, ma con un impegno continuo, conseguendo risultati complessivamente sufficienti in tutte le discipline. Rispetto al corso del triennio i docenti che hanno avuto continuità didattica hanno rilevato un sensibile progresso del clima generale, delle competenze, della maturità e della motivazione allo studio della classe. Tutti gli alunni hanno acquisito, anche se a diversi livelli, le capacità logico-espressive.
LE INFORMAZIONI SULLA TERZA PROVA E SIMULAZIONI EFFETTUATE Si sono svolte due simulazioni aventi le medesime caratteristiche: • Tipologia B In data 8 marzo 2014, la simulazione ha coinvolto le seguenti discipline: latino, storia dell’arte, inglese, matematica, filosofia. Tempo a disposizione 2.45 ore. In data 22 maggio è prevista la seconda simulazione. I testi delle prove vengono allegati al presente documento. ALLEGATI: 1. Griglia di valutazione della I prova scritta; 2. Griglia di valutazione della II prova scritta; 3. Griglia di valutazione della III prova scritta; 4. Testo della prima simulazione della III prova; 5. Testo della seconda simulazione della III prova
LINGUA E LETTERATURA LATINA E GRECA
Docente: Prof.ssa Maria Livia Alivesi
Profilo della classe.
La maggior parte degli allievi ha dimostrato di essere in possesso
delle conoscenze definite come necessarie per il conseguimento
di una preparazione adeguata agli obiettivi fissati. Dal punto di vista
linguistico tutti hanno dimostrato di sapersi orientare, nel
riconoscimento delle strutture morfosintattiche dei testi in poesia e
prosa loro proposti; in ambito storico-letterario, tutti hanno
raggiunto una buona conoscenza degli autori e delle opere analizzate
sviluppando ottime competenze nel dibattere le tematiche letterarie
con spirito critico. Si distinguono le eccellenze che ad un metodo di
studio efficace hanno affiancato una significativa rielaborazione
critica.
Nella traduzione autonoma diversi alunni hanno manifestato
difficoltà, a causa del permanere di incertezze linguistiche e carenze
metodologiche pregresse, evidenziatesi soprattutto di fronte a testi
complessi. Tuttavia tutti gli allievi hanno dimostrato di essere in
possesso degli strumenti per decodificare il testo greco e latino dal
punto di vista morfosintattico e di essere in grado di renderlo con
sufficiente chiarezza in lingua italiana.
La scrivente è in continuità didattica rispetto all’insegnamento della
lingua latina ma non nella lingua greca.
L’insegnamento della lingua greca è avvenuto in discontinuità
didattica nell’arco del triennio.
Tutti gli alunni hanno dimostrato sistematicità di impegno e desiderio
di apprendere.
Criteri didattici seguitiObiettivi
Letteratura
• Saper riconoscere i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di
stile, i topoi;
• Individuare i caratteri salienti della letteratura latina e greca e
collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia
letteraria;
• Conoscere il contenuto di opere fondamentali, sia per la loro
importanza intrinseca, sia per la forza della loro permanenza nella
storia della cultura europea;
• Selezionare e valutare criticamente le informazioni linguistiche,
letterarie e storiche, connettendole in un percorso organico;
• Acquisizione di organicità espressiva.
Testi
• Approfondire lo studio della lingua come sistema attraverso
l’analisi dei testi;
• Riconoscere le strutture sintattiche, retoriche, morfologiche e
lessicali-semantiche;
• Giustificare la traduzione effettuata come frutto di una ricerca
esegetica, come scelta tra ipotesi diverse anche in relazione alle
possibilità espressive e stilistiche della lingua italiana;
• Dare al testo una collocazione storica, cogliendo legami
essenziali con la letteratura e la cultura coeve.
Competenze
• Saper tradurre e interpretare testi in lingua latina e greca
dimostrando di essere in possesso di adeguate competenze
morfologiche, sintattiche, lessicali e stilistiche;
• Padroneggiare la morfologia e la sintassi;• Dibattere organicamente le tematiche letterarie e artistiche;
• Utilizzare correttamente il dizionario;
• Saper stabilire confronti intertestuali e individuare autonomamente
percorsi di ricerca.
Metodi
• Studio sistematico della morfosintassi, con esercizi mirati al
riconoscimento delle regole apprese;
• Avvio al commento dei brani: analisi degli aspetti contenutistici;
riconoscimento del genere letterario; nuclei informativi; analisi
della struttura sintattica, dei meccanismi linguistici e stilistici,
contestualizzazione con il pensiero e la produzione dell’autore,
studio della morfosintassi a partire dal testo;
• Esemplificazione del metodo di traduzione (suddivisione del
brano in periodi, riconoscimento di verbi e connettivi, analisi
logica del periodo e della frase, prima traduzione “letterale” e
traduzione più raffinata, ecc);
• Interdisciplinarità tra il greco e il latino;
• Studio della letteratura accompagnato da letture antologiche,
prevalentemente in traduzione.
Morfologia – Sintassi – Traduzione
• Forme nominali del verbo
• Sintassi del nome
• Sintassi del verbo
• Sintassi del periodo Tecniche di analisi morfosintattica e
lessicale
• Tecniche di traduzione
• Uso del dizionario: tecniche e prassi
Autori_Tematiche_TestiAutore Attività– Tematica
Publio Virgilio La vita
Marone Bucoliche
Georgiche
Eneide: contenuto e temi
Percorsi:
il fatum:
l’epos celebrativo
Marco Anneo La vita
Lucano Pharsalia: struttura, contenuto, temi
Lucio Anneo Caratteri generali dello stoicismo
Seneca La vita, il contesto
Dialogi : struttura, i temi dello stoicismo in De ira,
De vita beata, De providentia, De brevitate vitae,
De clementia.
Consolationes: struttura, temi, motivi, destinatari.
Epistulae ad Lucilium: struttura, temi, contenuto.
Esercizio di traduzione di passi tratti dalle varie
opere
Publio Cornelio La vita, il contesto
Tacito Historiae, Annales, Germania, Agricola: struttura,
contenuto, temi.
Esercizio di traduzione di passi tratti dalle varie
opere
Percorsi:
L’idealizzazione dei barbari: Germania 6, 14; 25;
27
Romani e barbari a confronto: Germania 18-20
Annales 13, 44
Il romanzo Caratteri del genere
Petronio Il problema dell’autore e della datazione
Satyricon: l’intreccio, la struttura, i personaggi, itemi.
Apuleio La vita e le opere
Metamorfosi: l’intreccio, la struttura, i personaggi,
i temi
Testi
Autori - Opera Analisi morfosintattica, lessicale Indicazione
stilistica, traduzione e commento passo
Lucio Anneo Epistulae morales ad Lucilium Ep. 47, 1-
Seneca 4;10
Epistulae morales ad Lucilium Ep. 70,14-
18
Consolatio ad Marciam 19, 3-6
Cornelio Tacito De situ et origine Germanorum 4; 18; 23;
25
GRECO
Morfologia e sintassi traduzione
1. Sintassi del verbo
2. Sintassi del periodo
3. Tecniche di analisi morfosintattica e lessicale
4. Tecniche di traduzione
5. Uso del dizionario: tecniche e prassi
Letteratura
Contenuti Tematiche Testi (in traduzione)
La commedia antica La questione Aristotele Poetica:dell’origine, la passi relativi ad origine
struttura, i caratteri e sviluppo del genere
Aristofane • la satira Acarnesi: passim
-La vita, il contesto politica Cavalieri: agone
-Acarnesi,Cavalieri, • la critica alle passim
Nuvole,Pace, Uccelli, istituzioni
Rane, Ecclesiazuse educative e
culturali
• l’utopia
Menandro • motivi e Dyskolos: prologo-
-Vita, il contesto caratteristiche monologo di Cnemone
storico e sociale della nea ; Epitrepontes:
Dyskolos,Epitrepontes • il teatro arbitrato, passim-
borghese: motivi
e destinatari
• temi, motivi
ricorrenti.
ORATORIA • Origine,
generi,
uditorio,
finalità
• il diritto e il
processo in
Grecia
Poesia dell’età • Cenni storici
ellenistica • Filologia ed
erudizione
letteraria
Callimaco • la poetica • Prologo dei
cenni biografici • il giocoso, Telchini, Acontio e
Aitia • l’erudizione Cidippe,Ecale, • le polemiche• La chioma di
letterarie Berenice
• Passi
programmatici
La poesia bucolica Caratteri ed
evoluzione del
genere
Teocrito • Idilli: Talisie
-la vita tematiche, struttura Idillio V
-rapporti con motivi Idillio VI
l’ambiente culturale• Poetica
siciliano e alessandrino
Il mimo • Origine, caratteri,
motivi, tipologie
del genere;
Teocrito Realismo Le Siracusane 1-43
Magia L’incantatrice 1-63;
76-111
Eroda Caratteri formali e Mimiambo VIII
tematici dei
mimiambi
La poetica
Apollonio Rodio • il mito III libro: Passim
- cenni biografici • confronti con
- Argonautiche l’epos omerico
l’amore
• l’eroe
• tecniche
narrative
L’epigramma • origine ed gli epigrammi erotici e
evoluzione del funerarigenere :
l’epigramma
arcaico e
classico
• struttura,
tematiche e
motivi
dell’epigramm
a alessandrino,
• l’Antologia
Palatina e
l’Antologia
Planudea :
struttura
• caratteri
tematici,
stilistici,
filosofici delle
scuole dorico-
peloponnesiac
a, ionico-
alessandrina,
fenicia.
Il Romanzo • Caratteri, letture libere da
• struttura, Luciano, Longo
• motivi, Sofista, Caritone,
• lo spazio e il Eliodoro, Achille
tempo , Tazio.
• la questione
delle origini
Polibio • la storiografia Passi programmaticila vita, il contesto pragmatica
• la storia universale;
l’anakyklosis
• la costituzione
“mista” .
Testi
Autori - Opera Analisi morfosintattica, lessicale Paragrafi
stilistica, traduzione e commento Versi
Isocrate • analisi morfosintattatica, lessicale, Parr.14-17;
Elena stilistica 49-58
• traduzione
• commento
Euripide • lettura metrica (trimetro giambico) vv. 1-67
Elena • analisi morfosintattatica, lessicale,
stilistica
• traduzione
• commento
ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Si è proposto un percorso di recupero e approfondimento delle
competenze morfosintattiche e di traduzione.
Verifiche
Orali: esposizione e discussione degli argomenti di studio, prove
strutturate e semistrutturate. Oggetto di valutazione nelle prove orali
sono state l’analisi e l’interpretazione del testo (attraverso
l’individuazione dei diversi livelli che lo costituiscono e
l’identificazione delle coordinate culturali in cui l’autore e l’opera sicollocano) e la riflessione critica, che rispecchi l’acquisizione degli
strumenti di analisi, le autonome capacità di giudizio in relazione a
testi, autori, problemi e fenomeni della letteratura.
Scritte : esercizio di traduzione.
Materiali didattici
Sono stati puntualmente utilizzati i testi in adozione:
• G.B. Conte - E. Pianezzola, Corso integrato di letteratura latina
, Le Monnier vol.3° e 4°
• L.E.Rossi - R.Nicolai, Storia e testi della letteratura greca, voll.
2 e 3, Le Monnier
• I volti di Elena a cura di C. Azan, V. Fascia, M.Pallante 2 tomi
_ Simone
VALUTAZIONE
Si allegano le griglie di valutazione delle prove orali e scritte
approvate dai dipartimenti delle lingue classiche dell’Istituto.
Verifiche scritte
Criteri Punteggio Punteggio Punteggi Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio
o
L’allievo 10 9-8 7 6 5 4 3
Dimostra
Comprensione Ottima Buona Discreta Sufficiente Parziale Approssimativ Scarsa
globale a
del testo
Resa in Ottima Buona Adeguata Globalment Imprecisa Approssimativ Inadeguata
italiano e e a
precisione Sufficiente
lessicale
Conoscenza della Ottima Buona Discreta Sufficiente Mediocre Lacunosa Gravement
morfologia e della e lacunosa
sintassi del nome
e del verbo
Risponde alle note Approfondit Approfondit Adeguato Sufficiente Mediocre Molto Gravement
di o e articolato o ma non con qualche e/o superficiale e
accompagnament molto imprecision incomplet incompleto
o del questionario articolato e o
in modoVerifiche orali
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ
VALUTAZIONI UTILIZZAZIONE E PROPRIETÁ CAPACITÁ DI FLUIDITÁ
COLLEGAMENTO TERMINOLOGICA DISCUTERE ED ED EFFICACIA
DELLE APPROFONDIRE ESPOSITIVA
CONOSCENZE SOTTO I VARI
ACQUISITE PER PROFILI I
RISPONDERE ALLE DIVERSI
CONSEGNE ARGOMENTI
ECCELLENTE/ AMPIA ED UTILIZZA IN MODO SEMPRE SA TRATTARE I VARI SPICCATI
OTTIMO ESURIENTE SICURO PRESENTE E ARGOMENTI CON ELEMENTI DI
10/9 LE CONOSCENZE SICURA SPIRITO CRITICO E ORIGINALITÁ ED
ACQUISITE E LE PERSONALE EFFICACIA
COLLEGA INTERESSE; ESPOSITIVA
IN MODO PERTINENTE PUNTUALI ED
E COESO ARTICOLATI GLI
APPROFONDIMENTI
BUONO ADEGUATA E UTILIZZA IN MODO SEMPRE SICURA SA DISCUTERE IN ESPOSIZIONE
8 COMPLETA CORRETTO LE MODO PERSONALE E FLUIDA CON
CONOSCENZE CRITICAMENTE ALCUNI SPUNTI
ACQUISITE E LE IMPOSTATO I VARI ORIGINALI
COLLEGA ARGOMENTI;
COERENTEMENTE PUNTUALI GLI
APPROFONDIMENTI
DISCRETO SOSTANZIALMENTE COMPLESSIVAMNENTE PRESENTE DIFFUSI MOMENTI DI ESPOSIZIONE
7 COMPLETA CORRETTO L’UTILIZZO NONOSTANTE DISCUSSIONE ABBASTANZA
NONOSTANTE DELLE CONOSCENZE QUALCHE PERSONALE DEI SCORREVOLE CON
QUALCHE ACQUISITE; IMPRECISIONE VARI ARGOMENTI SPUNTI PERSONALI
TRAVISAMENTO GENERALMENTE SOSTANZIALMENTE
CORRETTI, ANCHE SE APPROFONDITI
TALORA SCHEMATICI I ANCHE SE IN MODO
COLLEGAMENTI NON COMPLETO
SUFFICIENTE LIMITATA MA L’USO DELLE PRESENTE PUR QUALCHE ESPOSIZIONE
6 ESSENZIALE CONOSCENZE É CON QUALCHE TENTATIVO DI SOSTANZIALMENTE
LIMITATO MA NON ERRORE DISCUTERE IN MODO EFFICACE PUR CON
SCORRETTO; TALORA PERSONALE I VARI QUALCHE
IMPRECISI MA NON ARGOMENTI CHE DUREZZA
SCORRETTI I APPAIONO
COLLEGAMENTI APPROFONDITI IN
MODO SCHEMATICO
ED ESSENZIALE
INSUFFICIENTE INCOMPLETA E UTILIZZA IN MODO MANCANTE IN PIÚ NO SA SUPERARE ESPOSIZIONE
5 FRAMMENTARIA LIMITATO E PUNTI UNA VISIONE IMPACCIATA E
MECCANICO LE MECCANICA DEI TALORA POCO
CONOSCENZE VARI ARGOMENTI CHIARA
ACQUISITE E LE CHE APPAIONO
COLLEGA CON AFFRONTATI IN
NUMEROSE MODO GENERICO E
INCONGRUENZE NON APPROFONDITO
GRAVEMENTE ASSENTE O CON LE CONOSCENZE ASSENTE MANCA ESPOSIZIONE
INSUFFICIENTE GRAVI MANCANZE ACQUISITE SONO CONSAPEVOLEZZA CONFUSA
4-1 INADEGUATE O NEI CONFRONTI DEI
INESISTENTI PER CUI I DIVERSI ARGOMENTI
COLLEGAMENTI SONO ED
DEL TUTTO É ASSENTE OGNI
FRAMMENTARI O FORMA DI
ASSENTI APPROFONDIMENTOPROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE
Anno scolastico 2013-2014
Classe III Sezione F (V. O.) Gruppo bilingue Francese/Inglese
Gli alunni della III F hanno seguito la materia con interesse per tutto il quinquennio, la partecipazione
alle attività proposte è stata viva e il lavoro domestico regolare. Alla fine del percorso, le competenze
sono diversificate ma gli studenti sono in grado complessivamente di:
• comprendere una varietà di messaggi orali attinenti a situazioni relativamente complesse, prodotti
a velocità normale;
• esprimersi in modo complessivamente adeguato al contesto sugli argomenti relativi ai contenuti
didattici svolti;
• comprendere il senso e lo scopo di testi scritti di una certa complessità;
• produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale con sostanziale padronanza di
strutture e di lessico;
• operare l’analisi di testi di narrativa, visti in sé e in relazione all’autore, al genere di appartenenza
e al contesto.
Si riportano qui di seguito gli obiettivi perseguiti, come da programmazione disciplinare, e stabiliti negli
anni precedenti dal dipartimento di francese
Finalità
Sul piano formativo
• L'acquisizione di una competenza pragmatico-comunicativa, intesa come capacità di interagire in
modo significativo e adeguato al contesto;
• La formazione umana, sociale e culturale attraverso il contatto con realtà diverse dalla propria;
• L'educazione alla diversità e al cambiamento;
• La riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa con altre lingue e
culture;
• lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio.
Sul piano cognitivo
Al termine del terzo anno lo studente deve essere in grado di:
• interagire con scioltezza e spontaneità, usando le strutture della lingua straniera anche se conqualche imprecisione;
• individuare i tipi testuali e il loro contesto di produzione;
• decodificare criticamente vari tipi di testi tratti da quotidiani, riviste e pubblicazioni;
• leggere e decodificare un testo letterario nei suoi aspetti stilistici e contenutistici;
• collocare testi letterari di epoche storiche diverse nel loro contesto di produzione;
• scrivere testi di varia estensione su un argomento noto, oggetto di discussione in classe.
Deve conoscere
• le principali funzioni linguistiche e strutture morfosintattiche della lingua;
• un lessico adeguato al contesto pragmatico comunicativo;
• il sistema fonologico;
• le caratteristiche principali degli autori e dei periodi storici;
• gli elementi formali e stilistici che caratterizzano il genere letterario.
Deve saper
• comunicare con sufficiente scioltezza usando le strutture della lingua pur con qualche
imprecisione;
• comprendere, analizzare e riassumere semplici testi orali e scritti appartenenti a tipologie diverse;
• scrivere testi con sufficiente correttezza su temi letterari e culturali studiati;
• individuare le caratteristiche principali degli autori e dei periodi storici;
• riconoscere, guidato, gli elementi formali e stilistici di base che distinguono il genere letterario.
Deve essere in grado di
• effettuare collegamenti e confronti fra autori e periodi.
CONTENUTI
Durante il terzo anno, in base agli accordi presi nelle riunioni degli anni precedenti dal dipartimento di
lingue per il francese, sono stati esaminati il XIX° e parte del XX° secolo. I due secoli sono stati
presentati principalmente attraverso lo studio dell’evoluzione del romanzo, fulcro del discorso didattico,
attorno al quale sono stati organizzati i vari contenuti, in base a percorsi storici e culturali all'interno dei
quali sono stati contestualizzati gli autori e i loro testi. L’unica eccezione, in queste selezione degli autori
è rappresentata dal poeta Baudelaire, la cui presentazione è stata sollecitata dagli studenti.
Durante il triennio, l’approccio all’insegnamento della letteratura si è conformato sostanzialmente a
quello per la lingua sottolineandone la continuità. Le strategie di lettura dei vari tipi di testi sono state
impiegate nell’analisi testuale dei brani letterari organizzati secondo moduli diacronici. Si è sempre
partiti dal testo per l’analisi delle scelte stilistiche degli autori e dalle condizioni materiali di produzione
del messaggio. Sono state sempre sollecitate e incoraggiate le osservazioni personali degli studenti
riconducendole al testo per vagliarle sulla base di dati concreti.
IL TESTO
La struttura del testole discours rapporté (le discours direct, le discours indirect, le discours indirect libre).
Le texte narratif et descriptif
Organisation et caractéristiques lexicales et grammaticales.
Les formes du récit
Le roman, un genre multiforme : origines et public
Les techniques romanesques : l’organisation du temps et de l’espace, le point de vue du narrateur
AUTORI, OPERE E CONTESTO STORICO
LE XIX° SIÈCLE
LES ANNÉES ROMANTIQUES
Quadro storico e sociale
• La situazione socio-politica della Francia durante e all' indomani della Rivoluzione;
• Gli avvenimenti storici;
• I diversi regimi che si sono avvicendati nella prima metà del XIX; le rotture e le continuità con
l’ideale rivoluzionario e la situazione dello stato alla fine del secondo impero
Ø La Restauration
Ø L’enchaînement des régimes
Ø Le cadre social
Le roman romantique
Le caratteristiche del romanzo popolare, i fattori del successo del genere narrativo.
Victor Hugo
Les Misérables (Victor Hugo)
Analisi dei seguenti brani:
« Une tempête sous un crane»« L’Alouette » « La mort de Gavroche » Claude Gueux Analisi del brano : « Quand voler devient une nécessité » Notre -Dame de Paris Analisi del seguente brano : « Une larme pour une goutte d’eau » L’ÂGE DU RÉALISME (1848-1870) Quadro storico e sociale • La posizione della Francia nel quadro politico e culturale europeo degli anni 1848-1870; • Il secondo impero • Napoléon III • Parigi e le trasformazioni di Haussmann Il romanzo realista • Gli apporti del realismo nel romanzo, le tecniche narrative e lo statuto del narratore; • I principi che caratterizzano la scrittura realista. Gustave Flaubert Madame Bovary Analisi dei seguenti brani: « Les lectures d’Emma »; « Un long corridor tout noir »; « Le bal à la Vaubyessard ». L’éducation sentimentale « leurs yeux se rencontrèrent » LE NATURALISME Il romanzo naturalista • I rapporti fra la produzione letteraria e le dottrine scientifiche e filosofiche; • Le caratteristiche del romanzo naturalista.
Emile Zola
L’ Assommoir
Analisi del brano : « L’Alambic »
Au bonheur des Dames
Analisi del brano : « La ruine d’un petit commerce »
Durante il mese di maggio è prevista la presentazione della parte conclusiva del programma che
viene riportata qui di seguito
Baudelaire
Analisi delle seguenti poesie:
Speen
Chant d’automne
LE XX° SIÈCLE
Le nouveau roman
Organizzazione del tempo e dello spazio
Statuto e punto di vista del narratore
Analisi del seguente brano :
Marguerite Duras : « Le silence de Robert L. » (La Douleur, 1985)
Strumenti di lavoro
I libro di testo in adozione nella classe: Écritures di Bonini, Jamet, Bachas, Vicari (edizioni Valmartina),
2° volume.
Laboratorio audiovisivo;
Fotocopie ad integrazione del manuale
VerificheLe verifiche scritte sono state effettuate secondo quanto riportato nel P.O.F. e stabilito nel dipartimento
di lingue.
Per le abilità orali, è stato chiesto allo studente di saper parlare in modo sufficientemente fluente e
corretto su un argomento di civiltà o di letteratura
Per le griglie di valutazione si rimanda al POF d’istituto.
Disciplina: SCIENZE
Docente: Paolo Abis
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : I. Neviani, C. Pignocchino Feyles. “Pianeta
tre “ . Volume Unico – S.E.I.
CONTENUTI
Il sistema nervoso
L’organizzazione generale del sistema nervoso.
Sistema nervoso centrale e periferico. La divisione simpatica e quella parasimpatica.
La struttura dei neuroni. Le cellule gliali. I neuroni sensoriali, motori e gli interneuroni.
Il potenziale di riposo. Il potenziale d’azione. La sinapsi eccitatoria e la sinapsi inibitoria.
Neurotrasmettitori e neuromodulatori.
Struttura e funzioni dello scheletro.
Lo scheletro assile. Lo scheletro appendicolare e i cinti.
Osteociti, osteoblasti e osteoclasti.
I tessuti che formano le ossa.
La struttura dell’osteone; osso compatto e osso spugnoso.
Le articolazioni.
Struttura e funzioni del sistema muscolare.
Ruoli strutturali e funzionali dei muscoli scheletrici.
Le coppie di muscoli antagonisti.
La struttura delle fibre muscolari: sarcolemma, miofibrille e sarcomeri.
Le proteine contrattili: actina e miosina.
Lo scorrimento delle miofibrille nel sarcomero.L’azione dei neuroni motori: la giunzione neuromuscolare. L’universo Ipotesi sulla genesi dell’ universo : l’universo stazionario, il Big Bang; Le prove a favore del big bang. Espansione dell’Universo e legge di Hubble. Effetto Doppler e Red Shift. Le possibili evoluzioni dell'Universo. Recenti teorie sulla struttura e composizione dell’universo. Le Stelle Composizione delle stelle. Materia interstellare e nebulose. La luminosità delle stelle e le classi di magnitudine - Magnitudine apparente e magnitudine assoluta. L'analisi spettrale della luce delle stelle, composizione chimica, temperatura. L’effetto Doppler e gli spettri delle stelle. Massa e dimensioni delle stelle. Evoluzione dei corpi celesti. Il Diagramma H .R. Interpretazioni del diagramma HR. La nascita delle stelle. Le stelle della sequenza principale. Le reazioni termonucleari nelle stelle di sequenza principale. Dalla sequenza principale alle giganti rosse. La "morte" di una stella: nane bianche, stelle a neutroni e buchi neri. Sistema Solare Il sistema solare: Origine e composizione. I pianeti e i loro movimenti: le leggi di Keplero. La spiegazione delle leggi di Keplero, secondo Newton. La posizione dei pianeti. Generalità sulle caratteristiche fisico-chimiche dei pianeti terrestri e pianeti gioviani. I moti della Terra Introduzione. Il movimento di rotazione. Le prove della rotazione terrestre: l'esperienza di Guglielmini, l'esperienza di Foucault. Le conseguenze della rotazione terrestre: l'alternarsi del dì e della notte, l'apparente movimento giornaliero della sfera celeste. Il movimento di rivoluzione. Le conseguenze della rivoluzione terrestre: giorno solare e giorno sidereo, il movimento apparente del Sole sullo sfondo dello zodiaco. Le stagioni astronomiche. Le zone astronomiche dl globo terrestre. I moti secondari della Terra: il moto conico dell'asse e la precessione degli equinozi, le nutazioni, lo spostamento della linea degli apsidi, la variazione dell'eccentricità dell'orbita, la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre. Metodi d’insegnamento: Lezioni frontali e dialogate, lavori individuali ed in piccoli gruppi, sviluppo di tematiche particolari attraverso l’elaborazione autonoma degli allievi favorendo gli apporti personali ed originali. Mezzi e strumenti di lavoro: Uso del testo in adozione, computer portatile e video proiettore, lavagna, rappresentazioni grafiche. Le Lezioni svolte sono state messe a disposizione degli studenti in formato Power Point nel sito internet http://abitec.altervista.org/. Strumenti di verifica: Le prove di valutazione si sono basate su test oggettivi e strutturati ma anche su prove libere, saggi pratici e interrogazioni orali.
Matematica
Libro di testo adottato: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi
La trigonometria
Moduli Verdi Elementi di matematica-Modulo O– Zanichelli.
Obiettivi conseguiti:
• Acquisizione dei contenuti proposti.
• Esposizione chiara che si avvale di un appropriato linguaggio specifico.
• Abilità nelle tecniche di calcolo algebrico e goniometrico.
• Risoluzione di semplici problemi di geometria piana riconducibili alla risoluzione di un
triangolo.
• Risoluzione di equazioni goniometriche.
• Capacità di elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti.
Contenuti:
GONIOMETRIA
• Gli angoli, gli archi e la loro misura.
• Le funzioni goniometriche: seno , coseno, tangente e cotangente di un arco orientato;
• La circonferenza goniometrica: la prima relazione fondamentale(dimostrazione), la
funzione tangente,la seconda relazione fondamentale, le funzioni goniometriche di angoli
particolari(π/6, π/4, π/3);
• Relazioni fra le funzioni goniometriche di angoli associati.
• Le formule goniometriche: Le formule di addizione e sottrazione (dimostrazione),
le formule di duplicazione (dimostrazione), le formule di bisezione, le formule parametriche
(dimostrazione).
• Le equazioni goniometriche: equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in seno
e coseno, equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno.
TRIGONOMETRIA
• Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo: teoremi relativi al triangolo
rettangolo; risoluzione di un triangolo rettangolo.
• Relazioni fra gli elementi di un triangolo qualunque: teorema della corda e teorema dei
seni (dimostrazione), teorema di Carnot (dimostrazione); risoluzione di un triangolo
qualunque.
• Alcune applicazioni: calcolo dell’area di un triangolo, calcolo dell’area di un quadrilatero.
Metodi di insegnamento: Le lezioni hanno sempre coinvolto i ragazzi sia durante le spiegazioni
della teoria che durante lo svolgimento degli esercizi proposti alla lavagna. Numerose ore sono
state dedicate all’applicazione degli argomenti trattati, anche per cercare di sopperire alle difficoltà
manifestate dai ragazzi.
Strumenti di verifica: Sono state svolte esercitazioni scritte,contenenti esercizi tradizionali, problemi
e quesiti teorici, ed interrogazioni per testare la capacità sia di risolvere esercizi che di esporre la
teoria.Fisica
Libro di testo adottato: Ugo Amaldi
La fisica di Amaldi: Termologia - Elettromagnetismo – Zanichelli.
Obiettivi conseguiti:
• Acquisizione dei contenuti proposti.
• Definizione corretta e completa delle grandezze.
• Descrizione ed individuazione delle componenti essenziali di un fenomeno.
• Uso corretto del linguaggio specifico avvalendosi degli strumenti matematici richiesti.
• Esposizione chiara e rigorosa.
Contenuti:
• I fluidi: solidi, liquidi e gas, la pressione, la pressione nei liquidi, la pressione della forza
peso nei liquidi, i vasi comunicanti, la spinta di Archimede, la pressione atmosferica, la
misura della pressione atmosferica, la corrente di un fluido, l’equazione di continuità,
l’equazione di Bernoulli.
• La temperatura: il termometro, la dilatazione lineare dei solidi, la dilatazione volumica dei
solidi e dei liquidi; le trasformazioni di un gas, la prima legge di Gay-Lussac, la legge di
Boyle, la seconda legge di Gay-Lussac, il gas perfetto, l’equazione di stato del gas perfetto.
• Il calore: Calore e lavoro, capacità termica e calore specifico, il calorimetro, le sorgenti di
calore e il potere calorifico, conduzione, convezione e irraggiamento.
• I cambiamenti di stato: i passaggi tra stati di aggregazione, la fusione e la solidificazione,
la vaporizzazione e la condensazione, il vapore saturo e la sua pressione, la condensazione
e la temperatura critica, il vapore d’acqua nell’atmosfera, la sublimazione.
• Il primo principio della termodinamica: Gli scambi di energia, l’energia interna di un
sistema fisico, il principio zero della termodinamica, trasformazioni reali e trasformazioni
quasi statiche, il lavoro termodinamico, enunciazione del primo principio della
termodinamica, applicazioni del primo principio, i calori specifici del gas perfetto, le
trasformazioni adiabatiche.
• Il secondo principio della termodinamica: le macchine termiche, primo enunciato (lord
Kelvin), secondo enunciato(Rudolf Clausius), terzo enunciato(il rendimento), trasformazioni
reversibili ed irreversibili, il teorema di Carnot, il ciclo di Carnot, il rendimento della macchina
di Carnot.
• La carica elettrica e la legge di Coulomb: L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli
isolanti, la definizione operativa della carica elettrica, la legge di Coulomb, le forza di
Coulomb nella materia, l’elettrizzazione per induzione.
• Il campo elettrico: il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, le
linee di campo elettrico, il flusso di campo elettrico, il flusso del campo vettoriale attraverso
una superficie, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; il campo elettricogenerato da una distribuzione piana infinita di carica; campi elettrici con particolari
simmetrie: distribuzione lineare e sferica.
Metodi di insegnamento: la classe ha mostrato generalmente un adeguato interesse e allievi
ottenendo risultati più apprezzabili nella trattazione discorsiva degli argomenti che nell’aspetto
tecnico-matematico di questi.. Molto tempo e’ stato dedicato allo svolgimento di esercizi
dettagliando tutti i passaggi algebrici con l’obiettivo di chiarire e consolidare le conoscenze di base.
Strumenti di verifica: Sono state svolte esercitazioni scritte contenenti semplici esercizi di
applicazione immediata delle formule ed interrogazioni orali per verificare l’apprendimento dei
singoli allievi. Le valutazioni sono scaturite oltre che dalla partecipazione in classe, dalla capacita di
deduzione e dalla padronanza di un linguaggio tecnico appropriato ed, ovviamente dalla
conoscenza delle questioni poste.
Liceo Classico “D.A. AZUNI”
Sassari
PROGRAMMA DI STORIA
Classe III F (v.o.): Liceo Classico
Docente: Giovanni Bernardini
Anno scolastico: 2013/14
TESTO DI RIFERIMENTO:
M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette “Passato Presente” Bruno Mondadori
CONTENUTI:
- La situazione dell’Italia post unitaria:
- la situazione politica, militare, economica, culturale e sociale
- il fenomeno del brigantaggio.
- La Destra e la Sinistra italiana:
- iniziative delle Destra nel settore agricolo, industriale, urbano e sociale;
- il governo di Depretis;
- la composizione della Sinistra;
- la politica interna ed estera della Sinistra;
- Crispi e il fallimento della politica coloniale.
- L’unità tedesca e il crollo della Francia di Napoleone III:
- il conflitto austro – prussiano;
- Bismarck.
- La seconda rivoluzione industriale: caratteri generali e conseguenze- L’età giolittiana:
- il decollo industriale dell’Italia;
- il doppio volto di Giolitti;
- la riforma elettorale;
- il giudizio di Salvemini e Croce sull’operato di Giolitti;
- la situazione degli emigranti e la conquista della Libia.
- La situazione dell’Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale: caratteri generali.
- La Belle époque: caratteri generali
- La Prima guerra mondiale:
- Lo scoppio del conflitto
- I piani di guerra
- L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra
- La situazione dell’Italia dalla neutralità all’intervento
- La guerra di trincea
- Il 1917 come anno della “svolta”
- L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali
- Il dopoguerra: costi sociali e politici e il problema dei reduci
- Il biennio rosso in Italia e la crisi del sistema liberale
- Il Partito popolare italiano: Luigi Sturzo
- Le “serrate e le lotte operaie
- L’occupazione di Fiume
- La Società delle Nazioni
- La pace:
- il trattato di Versailles e la nuova situazione internazionale
- I 14 punti di Wilson
- La rivoluzione russa e lo Stato sovietico:
- le rivoluzioni del 1917;
- la guerra civile;
- la morte di Lenin,
- la dittatura di Stalin e il rafforzamento della Russia.
- La crisi dello Stato liberale italiano: linee essenziali.
- Francia, Inghilterra, Germania e USA nel dopoguerra:
- gli Stati Uniti e il crollo dell’economia mondiale;
- Gli “Anni Ruggenti”: Isolazionismo, xenofobia e proibizionismo
- la ripresa degli Stati Uniti
- Roosevelt e il New Deal.
- Fascismo, Nazismo:
- la situazione dell’Italia e della Germania.
- L’ascesa di Mussolini e la marcia su Roma
- Le leggi fascistissime
- I patti lateranensi
- La conquista dell’Etiopia
- L’antifascismo: il delitto Matteotti
- Approfondimenti storiografici: Giovanni Gentile, filosofo del fascismo; la figura di Antonio
Gramsci narrata da L. Salvatori, “L’umanità del comunista Gramsci”
- La crisi economico sociale della Germania
- Il governo Stresemann
- La fine della Repubblica di Weimar- L’ascesa al potere di Adolf Hitler
- Il concetto di purezza della razza
- Hitler e la fuhrerprinzip: il successo del partito nazista
- Il Terzo Reich: l’edificazione dello Stato totalitario
- L’antisemitismo
- La soluzione finale e l’”operazione eutanasia”
- Approfondimenti storiografici: “Vivere nel Terzo Reich” di Annah Arendt; l’educazione dei
giovani nazisti; i mezzi d’informazione; le olimpiadi di Jesse Owens
- “Gli inizi di Mussolini” di A. Lepre, “Claretta, l’unico vero grande amore?” di A. Spinosa;
- Su Hitler: “Una vita vuota”, di S. Haffner; “Euforia e pessimismo: aspetti della personalità di
Hitler”, di W. Carr
- Su Stalin: “Stalin, l’uomo d’acciaio” e “La violenza di Stalin” di D. Volkogonov; “La moglie e i
figli di Stalin”, di M. Amis
- L’Europa e il mondo alla vigilia della Seconda Guerra mondiale: caratteri generali
- La Seconda guerra mondiale:
- 1939: la disfatta della Polonia; la dichiarazione di non belligeranza da parte dell’Italia
- 1940: La caduta della Francia; l’ingresso in guerra dell’Italia; la resistenza inglese; l’attacco
dell’Italia alla Grecia
- 1941: L’intervento in guerra di USA e URSS; l’”operazione Barbarossa”; la Carta Atlantica;
l’attacco giapponese nei confronti degli USA a Pearl Harbor
- 1942: l’anno della svolta; il progetto nazista dell’edificazione della “Nuova Europa”; la battaglia
delle Midway; la battaglia dell’Atlantico; la battaglia di El Alamein; la battaglia di Stalingrado.
- 1943: Il crollo dell’Italia; lo sbarco in Sicilia degli Alleati; la crisi del fascismo, le dimissioni e
l’arresto di Mussolini; la Repubblica di Salò; la conferenza di Teheran;
- 1944: Lo sbarco in Normandia e la liberazione dell’Europa; l’”operazione Overlord”
- 1945: La resa della Germania e la fine della guerra; la liberazione dell’Italia; la fucilazione di
Mussolini e il suicidio di Hitler; il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki
- le conseguenze della Seconda guerra mondiale;
- approfondimenti storiografici.
METODI
• lezione frontale espositiva
• lavoro di gruppo
• attività di ricerca
• dialogo e confronto
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
• tutti i materiali offerti dal manuale di storia
• fonti e documenti storiografici
• dispense
Il Docente
Gli alunni Giovanni BernardiniLiceo Classico “D.A. Azuni”
Sassari
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Classe III F (V.O): Liceo Classico
Docente: Giovanni Bernardini
Anno scolastico: 2013/14
LIBRO DI TESTO: Protagonisti e testi della Filosofia
Autore: N. Abbagnano – G. Fornero
Ed. Paravia
Kant: il criticismo
• Biografia e opere
• La proposta filosofica kantiana come filosofia del limite
• Scritti pre-critici e critici
• La Dissertazione del 1770
• Il retaggio illuministico nella filosofia di Kant
• I giudizi su cui si fonda la conoscenza umana: giudizi analitici e sintetici
• La Critica della ragion pura e il suo carattere gnoseologico
• L’Estetica trascendentale: la sensibilità e le sue forme a priori
• La distinzione tra fenomeno e noumeno
• L’Analitica trascendentale: l’intelletto e le categorie, l’Io penso
• La Dialettica trascendentale: lo smascheramento dei ragionamenti fallaci della metafisica
• Le Idee della ragione e la loro funzione regolativa
• La Critica della Ragion Pratica
• Massime e Imperativi
• Il formalismo etico kantiano
• I postulati della ragion pratica
• La Critica del Giudizio
• Giudizio determinante e riflettente: l’ordine finalistico della natura
• Il bello e il sublime
Il Romanticismo: caratteri generali
• La cultura tedesca dello Sturm und drang
• Il tema dell’infinito
• La nuova visione della natura
• Il concetto di nazione
Caratteri generali dell’Idealismo tedesco (cenni)Fichte: • Biografia e opere • Esplicitazione dei concetti dei concetti di Io e Non-Io • La “dottrina della scienza” e i suoi principi • La missione del dotto • La funzione del diritto e dello Stato • I “discorsi alla nazione tedesca” • Approfondimenti testuali tratti da “La dottrina della scienza” e dai “Discorsi alla nazione tedesca” Schelling: • Biografia e opere • L’Idealismo estetico-oggettivo di Schelling • L’Assoluto come identità di Natura e Spirito • La filosofia della natura • La filosofia dello Spirito • La concezione dell’arte • Approfondimenti testuali tratti da “Idee per una filosofia della natura” L’Idealismo assoluto: Hegel • Biografia e opere • Rigenerazione politica e rigenerazione religiosa • Il sistema hegeliano: la risoluzione del finito nell’infinito • La razionalità del reale: il panlogismo hegeliano • La funzione della filosofia • I tre momenti dell’Assoluto:Idea, Natura, Spirito • La Dialettica • La filosofia della storia: il giustificazionismo storico • La struttura della Fenomenologia dello Spirito Schopenhauer: • Biografia e opere • Il mondo come rappresentazione • Il mondo come volontà • La volontà come essenza del nostro essere • Il pessimismo schopenhaueriano • La critica delle varie forme di ottimismo: rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico • L’illusione dell’amore • Le vie di liberazione dal dolore: arte,ascesi e redenzione • Approfondimenti testuali: letture tratte da “ Il mondo come volontà e rappresentazione”
Kierkegaard:
• Biografia e opere
• La centralità del Singolo
• La dissoluzione del sistema hegeliano
• L’esistenza come possibilità e fede
• Gli stadi dell’esistenza
• Esistenza, possibilità e angoscia
• Approfondimenti testuali: Vita estetica e vita etica, da Aut-Aut
Marx:
• Biografia e opere
• Caratteristiche del marxismo
• La critica al sistema hegeliano
• La critica agli economisti classici
• La critica alla religione
• Il concetto di alienazione
• Materialismo storico
• Materialismo dialettico
• Valore d’uso e valore di scambio delle merci
• Il concetto di plus valore
• L’avvento del comunismo e la dittatura del proletariato
• Approfondimenti testuali: “ Il concetto di alienazione” da Manoscritti economico-filosofici; “classi e lotta
di classi” da Il manifesto del partito comunista
Nietzsche:
• Biografia e opere
• Filosofia e malattia
• Le fasi della riflessione filosofica nietzcheana
• L’interpretazione della grecità e la decadenza della civiltà occidentale
• L’apollineo e il dionisiaco
• La crisi della morale e del Cristianesimo
• La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche
• La “volontà di potenza”, il “superuomo” e l’ “eterno ritorno”
• Approfondimenti testuali: “Apollineo e dionisiaco”, tratto da La nascita della tragedia
Freud:
• Biografia e opere
• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
• La realtà dell’inconscio e i modi per accedervi
• La scomposizione psicoanalitica della personalità
• Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici
La teoria della sessualità: il complesso di Edicola religione e la civiltàMETODI
• lezione frontale espositiva
• lavoro di gruppo
• attività di ricerca
• dialogo e confrontoMEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
• tutti i materiali offerti dal manuale di storia
• fonti e documenti storiografici
• dispense
VALUTAZIONE:
• Verifiche orali
• Verifiche scritte con valore di prova orale
CONOSCENZE:
• Concetti fondamentali della disciplina
• Tematiche relative agli autori presi in esame
• Contestualizzazione cronologica delle teorie
• Terminologia specifica
COMPETENZE.
• Comprendere un testo filosofico
• Proprietà concettuali e logico-linguistiche
• Argomentare sia oralmente che per iscritto
CAPACITA’:
• Rielaborare criticamente le tematiche proposte
• Saper analizzare e operare sintesi
• Effettuare collegamenti interdisciplinari
• Esprimere giudizi personali e interpretazioni pertinenti
Gli alunni Il docente
Giovanni BernardiniAnno scolastico 2013/2014 STORIA DELL’ARTE 1) Situazione della classe: Al termine dell’anno scolastico, il livello della classe, relativamente alla disciplina, si puo definire senz’altro molto buono. Infatti quattordici alunni hanno riportato un profitto eccellente, sette un profitto ottimo, sette un profitto discreto. 2) Valenze formative della disciplina: Ruolo della disciplina nel curricolo: Formazione della personalità dell’alunno in riferimento al rapporto con l’altro Motivazione a produrre (progettare, realizzare) Capacità di usare sussidi e strumenti in modo autonomo Nuclei fondanti della disciplina: Arte Preistorica Arte Egea Arte Greca Arte Romana Arte tardo-‐antica e paleocristiana Arte bizantina
Puoi anche leggere