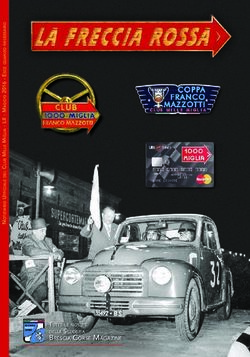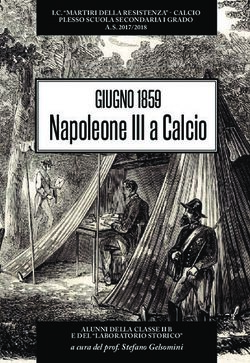GHIDONI 1920|2020 nel centenario della morte - Comune di Ospitaletto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
V iv er e
Ospitaletto
NUMERO SPECIALE OTTOBRE 2020 | NUMERO 35
SUPPLEMENTO AL N. 35,
OTTOBRE 2020
www.comune.ospitaletto.bs.it
IL PERIODICO TRIMESTRALE DEL TUO COMUNE
Seguici su:
PERIODICO TRIMESTRALE facebook.com/comuneospitaletto
DISTRIBUITO GRATUITAMENTE A TUTTE LE FAMIGLIE
Instangram.com/comunediospitaletto
STAMPATO IN 6.700 COPIE | NUMERO 35, OTTOBRE 2020
EDITORE: COMUNE DI OSPITALETTO (BS) Twitter @COspitaletto
DIRETTORE EDITORIALE: FABIO GIOVANNI PERLETTI
Leggici su:
DIRETTORE RESPONSABILE: GIOVANNI BATTISTA SARNICO issuu.com/vivereospitalettoVIVERE OSPITALETTO
PRESENTAZIONE
Domenico Ghidoni, artista.
Un uomo di Ospitaletto
I
l nostro concittadino Domenico Ghidoni nasce a Ospitaletto nel 1857 e
muore nel 1920: per questo erano state previste, nel 2020 , le celebrazioni
per ricordarlo nel centenario della morte. Purtroppo la pandemia del
COVID 19 ha fermato ogni progetto proprio nel momento in cui avrebbe
dovuto dispiegarsi (il primo appuntamento era previsto per il 21 marzo).
Tuttavia non volevamo far passare sotto silenzio il ricordo di questo
ospitalettese figlio di contadini - e fino ai 17 anni contadino anch’esso -
divenuto successivamente un importante scultore di fama nazionale e non
solo. Per questo motivo abbiamo realizzato questa edizione speciale del
Notiziario comunale nella quale si potranno trovare molte informazioni sulla
sua vita, la sua arte, le sue sculture e monumenti.
In questo breve saluto introduttivo vorrei però soffermarmi sulla sua figura
di uomo.
Domenico Ghidoni è stato per prima cosa un uomo figlio della nostra terra,
un uomo che nella seconda metà dell�Ottocento lasciò Ospitaletto per andare
a studiare a Milano, all�Accademia di Brera: una scelta di grande modernità,
coraggio e apertura non solo sua, ma anche della sua famiglia.
Trovo che quella scelta rappresenti perfettamente la natura della nostra
gente: laboriosa, seria, orgogliosa, con la voglia di imparare e di affermarsi,
rispettosa dei principi altrui, ma ferma nei propri. Ghidoni pagò cara la sua
natura, poiché volendo raccontare la società del tempo attraverso opere
dedicate ai più deboli e agli emarginati -“I Migranti” e “Le nostre Schiave”
(le prostitute) - venne censurato e isolato, addirittura la scultura “Le nostre
Schiave” venne distrutta.
A cento anni dalla morte ricordare un nostro concittadino, un uomo, che
ha fatto dell’arte la sua vita, trasformando l�arte in qualcosa che potesse
avvicinare e riconoscere chi spesso dall�arte viene ignorato, non può che
inorgoglirci. Ci aiuta a ricordare, infatti, che la memoria, le nostre radici,
la nostra cultura lasciano e devono lasciare una traccia che ci consenta di
guardare al futuro con maggiore consapevolezza e forza. Concludo con un
sentito ringraziamento all’Assessore alla Cultura Chiara Raza che insieme al
“Comitato promotore del Museo Domenico Ghidoni”, presieduto da Roberto
Bianchi ha collaborato per elaborare le iniziative celebrative poi compromesse
dal lockdown. Augurando quindi, innanzi tutto ai cittadini di Ospitaletto, una
buona lettura di questa fascicolo - che sotto molti aspetti, potrebbe essere
definito una “mostra a domicilio” - voglio assicurare che quando le condizioni
e le disposizioni consentiranno il ritorno alla consuetudine, l’Amministrazione
realizzerà senz�altro nuove iniziative pubbliche per valorizzare la figura
dell’artista ospitalettese. il Sindaco
Giovanni Battista Sarnico
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 1Comune di OSPITALETTO
STORIA DI UNA DONAZIONE
(Particolare)
Anni fa venne comunicato al Sin-
daco che quest�opera era stata
presentata ad un’asta benefica
della San Vincenzo, il cui ricavato
sarebbe stato destinato ad aiuti ai
più bisognosi.
Il Sindaco ne parlò al dott. Renato
Gnutti (grande estimatore di ope-
re d’arte moderna e contempora-
nea) che si offerse di acquistarla e
di farne dono al Comune, in vista
anche della creazione di un mu-
seo dedicato allo scultore.
Riteniamo che non esista occasio-
ne migliore della realizzazione di
uno speciale dedicato all’Artista
per rivolgere i nostri più sentiti
ringraziamenti al dottor Renato
Gnutti.
Primi passi (Mammina), 1908, bronzo
2 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
LA STORIA
DOMENICO GHIDONI
E L’AMBIENTE BRESCIANO Francesco De Leonardis
“Fino a vent’anni l’aveva tenuto quale aveva collaborato alla co- e intelligente riesce a distin-
la cura dei campi, non sen- struzione del monumento che guere l’opera moderna da quel-
za però che qualche capriccio la regina Vittoria aveva dedicato la realmente lavorata da scul-
dell’arte lo vincesse (...). E nello al consorte principe Alberto. tore del Cinquecento”. Nella
studio del Faitini si limitò pri- Pietro Faitini era scultore or- bottega di Pietro Faitini, da cui
ma al maneggio ed al trasporto natista dotato di grande tecnica passeranno anche Luigi Con-
delle pietre, poi cominciò a mo- ed abile nel riprodurre sculture tratti e successivamente Angelo
dellare la creta, che lo trasse antiche di ogni stile secondo Zanelli, Ghidoni ha certamente
alle manifestazioni più belle, più le richieste degli antiquari (in modo di farsi un bagaglio di co-
nobili e più magnanime dello particolare di quelli inglesi, con noscenze pratiche che gli servi-
spirito.” Così scrive Fabio Glis- cui manteneva stretti rapporti ranno a maturare rapidamente
senti nel 1920 nel necrologio di commerciali), conosceva inoltre come scultore, una volta avviato
Domenico Ghidoni, pubblicato il “mezzo di colorire con arte verso lo studio dell’arte.
sui “Commentari” dell’Ateneo, segreta l’opera de lo scalpello In questi anni si iscrive però an-
del quale lo scultore era socio onde paia che i secoli vi abbian che ai corsi serali della Scuola
fin dal 1901. deposto la patina antica. E la di Disegno annessa alla Pinaco-
La vocazione artistica di Ghidoni imitazione raggiunge sovente teca comunale Tosio, che a par-
si manifesta -ne parlano con- tal grado di perfezione che sol tire dal 1887 verrà, per delibera
cordi tutti i suoi primi biogra- l’occhio di un tecnico esercitato del Consiglio comunale, intito-
fi- ancora ad Ospitaletto nella
prima giovinezza, quando, im-
pegnato nel lavoro dei campi
insieme al padre ed ai fratelli,
Domenico si diverte ad inta-
gliare nel legno piccoli oggetti
che riempie di ornamenti fitti e
di decorazioni simboliche, ese-
guiti con estro fantastico e abi-
lità manuale, un’abilità che lo
spinge a lasciare la famiglia ed
a recarsi a Brescia per seguire
la sua vocazione. Ma intanto
deve cercare lavoro e lo trova
nella bottega che Pietro Faitini
ha aperto a Brescia intorno al
1877, dopo essere ritornato in
patria al termine di un lungo Domenico Ghidoni (l’ottavo da sinistra) in un laboratorio di scultura; è possibile
soggiorno londinese durante il che si tratti della bottega di Pietro Faitini
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 3Comune di OSPITALETTO
lata al Moretto; e come Scuola
“Moretto” è rimasta nella me-
moria storica della città. A Bre-
scia non esisteva un’accademia.
L’istruzione in campo artistico
era impartita da quest’istituzio-
ne, nata per iniziativa del pittore
Gabriele Rottini come scuola
privata di disegno rivolta in par-
ticolare ai fanciulli poveri; nel
1841 l’Amministrazione austria-
ca aveva concesso la necessa-
ria autorizzazione e la scuola
aveva funzionato con la deno-
minazione di Istituto Rottini fino
al 1851, quando un gruppo di
padri di alunni ne aveva chiesto
la pubblicizzazione, perché con
i soli mezzi privati non riusciva
a sussistere: nel novembre di
quell’anno l’Istituto Rottini era Domenico Ghidoni con il cane Paris in un travestimento leonino
divenuto Scuola di Arte e Pittu-
ra comunale e la sede era stata superiore), Luigi Arcioni (Archi- to presidente ed aveva rivolto
fissata in un locale dell’ex con- tettura), Luigi Campini (Figura) tutto il suo impegno a rinno-
vento di Santa Maria di Pace in e Virgilio Bianchi (assistente Or- vare metodi, attività didattica e
via Tosio. Nel 1865, dopo l’unifi- nato). Alla Scuola Ghidoni entra finalità di quest’istituzione, al-
cazione nazionale, all’indirizzo in contatto per la prima volta la quale rimase legato fino al
propriamente artistico di pre- con l’architetto Antonio Taglia- 1908, quando dovette ritirarsi
parazione alle scuole superiori ferri, ed è un incontro decisivo. per l’età e per l’aggravarsi delle
di Belle Arti si era affiancato un Tagliaferri, che era nato nel sue condizioni di salute.
corso di disegno applicato alle 1835, si era inizialmente avviato Nella seconda metà degli anni
arti meccaniche ed ai mestieri alla pittura frequentando lo stu- Settanta Antonio Tagliaferri è
e da quel momento nell’attività dio di Giovanni Renica, a Monti- ancora all’inizio di una carriera
didattica si era verificata una rone, e dal 1856 si era trasferito che sarà piena di incarichi e di
svolta verso l’indirizzo tecno- a Milano per iscriversi ai corsi soddisfazioni. I primi progetti
logico, che diverrà in seguito di architettura dell’Accademia importanti riguardano la siste-
preponderante. di Belle Arti di Brera. Nel 1859 mazione della facciata del Te-
Nel periodo in cui Ghidoni fre- aveva ottenuto il titolo di pro- atro Grande (1867-68, non ese-
quenta i corsi il Consiglio diret- fessore di architettura ed era guita), l’ampliamento di Palazzo
tivo della scuola è presieduto ritornato a Brescia, dove aveva Loggia (1873, non eseguito), il
dall’architetto Antonio Taglia- subito messo, gratuitamente, la rifacimento del Santuario della
ferri e composto da Stefano sua competenza a disposizione, Madonna delle Grazie (1875).
Fenaroli, Pietro Da Ponte, Lu- della Scuola comunale di Di- Questo fervore di iniziative, a cui
igi Cicogna e Giovanni Renica, segno; nel 1865 era entrato a l’architetto porta una forte spin-
mentre nel corpo insegnante fi- far parte del Consiglio direttivo ta innovativa sul piano dello sti-
gurano Luigi Trebeschi (Ornato della scuola, ne era stato elet- le attraverso il recupero ecletti-
4 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
co di forme neomedievali e ne- potuto respirare un’aria diversa nenti del tardo romanticismo
orinascimentali che vengono a e più aggiornata rispetto alla sentimentale e di un attardato
sostituire le stanche ridondanze realtà bresciana, che, per quan- purismo formale. In ambito lo-
del Secondo Impero, si inseri- to riguarda la scultura, si trova- cale non si era ancora formata
sce in un momento di profondo va in una situazione di stallo e di la nuova generazione di scultori
cambiamento della realtà bre- stanca attesa. (quella di Ghidoni, di France-
sciana, che viene generalmente Gli anni Settanta si erano chiusi sco Gusmeri, di Emilio Mago-
indicato come età zanardellia- a Brescia con la scomparsa di ni), tanto che le più importanti
na. Dopo il compimento dell’u- Giambattista Lombardi (1822- committenze pubbliche e priva-
nità nazionale, infatti, a Brescia 1880) e di Giovita Lombardi te dovevano rivolgersi ad arti-
si registra una forte crescita (1835-1879), che erano stati sti “forestieri”: il Monumento ai
delle attività imprenditoriali e -soprattutto il primo, vissuto Caduti per la Patria, inaugurato
mercantili; la borghesia postri- per diversi anni a Roma- espo- al Cimitero Vantiniano nel 1879
sorgimentale esprime una clas-
se politica che, sotto la guida
autorevole di Zanardelli, inten-
de dare una immagine forte di
sé che si rispecchi nella città,
nei suoi edifici, nei monumenti,
nei grandi cicli pittorici che van-
no a decorare banche, palazzi
pubblici, chiese... Tagliaferri è
l’architetto che meglio risponde
a questa esigenza sia sul piano
stilistico con il recupero sto-
ricistico di un’architettura che
rimanda all’Italia dei Comuni e
del Rinascimento, sia sul piano
costruttivo con la capacità di
soddisfare le richieste e i tempi
dell’edilizia moderna.
Quando arriva a Brescia il gio-
vane Ghidoni non è certo in
grado di percepire questo cam-
biamento, urgono per lui le esi-
genze “primarie” di lavorare e
mantenersi dopo che si è stac-
cato dalla famiglia. È però Anto-
nio Tagliaferri a capire le qualità
di questo suo allievo ed a spin-
gerlo a fare il grande passo, a
lasciare la bottega di Faitini ed
a trasferirsi a Milano per fre-
quentare i corsi dell’Accademia
di Brera, dove, a contatto con
l’ambiente milanese, avrebbe Antonio Tagliaferri
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 5Comune di OSPITALETTO
dopo il concorso del 1877, era “Arte in famiglia” e, ancora, nel
stato eseguito da Luigi Paga- vecchio Ateneo; le persone che
ni, bergamasco di nascita ma si ritrovavano nelle diverse isti-
attivo in ambiente milanese; il tuzioni erano sempre le stesse e
piemontese Odoardo Tabacchi, si stabiliva così una realtà, mol-
a cui si deve nel 1882 il Mo- to omogenea per finalità d’in-
numento ad Arnaldo, realizza, tenti e per visione dei problemi,
facendo conoscere la novità di attraverso la quale passavano
uno stile profondamente im- l’organizzazione delle mostre,
prontato al realismo, i due mo- la distribuzione delle pubbliche
numenti funebri del Vantiniano committenze, la gestione dei
della famiglia Cuzzetti-Bonardi concorsi.
(1876) e della famiglia Sedabo- Ghidoni che, dopo gli studi a
ni-Cavadini (1877); il Monumen- Brera, avrebbe aperto lo stu-
to a Giuseppe Garibaldi (1883) dio a Milano senza più ritorna-
ad Iseo viene affidato al verone- re stabilmente a Brescia, non
se Pietro Bordini. taglia i ponti con la sua città
Diversa la situazione della pit- e mantiene sempre uno stret-
La prima immagine ufficiale dell’arti-
tura. La volontà di elaborare sta pubblicata nel 1891 to legame con Tagliaferri, con
un linguaggio nuovo, molto vivo Carlo Manziana, con Gaetano
nella generazione degli artisti rappresentanti del gentil ses- Fornasini, con Francesco Ro-
pronti a recepire gli stimoli sca- so), ma l’iscrizione era aper- vetta, ma anche con l’Ateneo. Su
pigliati dell’ambiente milanese, ta anche ai semplici amatori questa rete di rapporti si svilup-
si accompagnava all’esigenza dell’arte purché versassero la pa la sua carriera nell’ambiente
di rinnovare anche il sistema quota di adesione annuale. La bresciano. Su tutti, è però An-
dell’arte in città che, per tut- Società voleva essere molto in- tonio Tagliaferri ad assumere
to l’Ottocento, aveva fatto capo formale, nello statuto le regole un ruolo paterno ed a seguire
all’Ateneo ed alle sue annuali erano ridotte al minimo, le ca- il giovane nei suoi primi passi,
mostre dei soci. Serviva, nella riche avevano funzione di rap- ad aiutarlo concretamente nel-
mutata situazione sociale in cui presentanza all’esterno e non le difficoltà, ad indirizzarlo e
si trovava ad operare l’artista, di autorità sui soci. Il Municipio a procurargli lavoro, ogni volta
uno strumento più libero e dut- aveva accordato un sostegno che è possibile, nei suoi progetti
tile, meno ufficiale dell’ambien- all’associazione concedendole edilizi.
te accademico che si riconosce- una sede, prima nella caserma Anche il trasferimento a Brera
va nell’Ateneo. Nasce allora, dei Pompieri in via del Portone non avviene senza la vigile at-
nel novembre 1876, la Società (ora via Felice Cavallotti) poi tenzione di Tagliaferri. È signi-
“Arte in famiglia”, che già nel in palazzo Bonoris; in cambio, ficativa in proposito una lettera
nome si richiama alla milanese “Arte in famiglia” offriva la sua che lo scultore Emilio Bisi in-
“Famiglia Artistica”. Carlo Man- collaborazione alla Scuola co- dirizza da Milano all’architetto
ziana, Gaetano Fornasini, Cesa- munale di Disegno consentendo il 31 agosto 1880. Bisi, che era
re Bertolotti, Francesco Rovetta agli allievi migliori di frequen- figlio di Luigi Bisi presidente
ne sono i promotori. L’adesione tarne l’attività. dell’Accademia di Belle Arti di
al gruppo è molto libera: po- Gli artisti bresciani venivano Brera, scrive: “Non so se ella
tevano farne parte tanto i pro- così ad avere i propri punti di abbia ancora visto Ghidoni, e
fessionisti quanto i dilettanti (e riferimento nella Scuola comu- saputo da lui come è andato nel
tra questi erano anche alcune nale di Disegno, nella Società concorso del gesso. Quantun-
6 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
que l’esito non sia stato favore-
vole torna però a tutta lode del
Ghidoni l’essere stato ammesso
al concorso dopo solo due me-
si ch’era entrato all’Accademia
(...). Nel mio studio ha eseguito
vari saggi di plastica che tor-
nano a sua lode, e che così a
Brescia potrebbero fargli onore.
Io credo che lei farebbe ottima
cosa nel potergli ottenere qual-
che sussidio per l’anno venturo,
e son certo che Ghidoni dareb-
be frutti se non brillantissimi
certo più serii e sicuri di ogni
altro (...). Anche per quello che
riguarda la prospettiva, mio pa-
dre ne è abbastanza soddisfat-
to, non esigendosi troppo prin-
cipalmente da uno scultore. Per
l’anno venturo, trovandomi in
uno studio più ampio, il Ghidoni
potrà accingersi a qualche più
serio lavoro. Insomma io glie
lo raccomando come lei l’aveva
raccomandato a me, avendolo
in quest’anno valutato comple-
tamente”.
Dalla lettera si ricava che le
qualità di Ghidoni sono emerse
subito anche a Milano, che il Pagine da uno dei taccuini dell’artista; collezione privata
giovane è apprezzato dai pro-
fessori, ma che le sue condizio- nista di opere d’arte che aveva insieme a Francesco Gusmeri,
ni economiche sono abbastanza raccolto in una villa costruita Faustino Pezzoli, Angelo Colo-
precarie, tanto che gli servireb- per lui da Rodolfo Vantini, po- sio, Pietro Calzavacca e Luigi
be un sussidio per potersi appli- co oltre Porta San Nazaro a Lombardi, che risulta vincito-
care all’arte con la tranquillità Brescia; alla sua morte aveva re; in quello stesso anno, in
necessaria. Una tranquillità che disposto che tutti i suoi beni, la occasione dell’inaugurazione
potrebbe venirgli da una vittoria villa e le collezioni andassero al del Monumento ad Arnaldo da
al concorso per la pensione del Comune e che, a suo nome, fos- Brescia di Odoardo Tabacchi,
Legato Brozzoni, che assegnava se istituita appunto una pensio- presenta per la prima volta sue
un sussidio biennale agli artisti ne, della quale hanno usufruito, opere a Brescia nell’ambito
bresciani meritevoli che voles- per parecchi decenni, tutti gli della “Esposizione di belle arti
sero approfondire i propri studi. artisti bresciani. e industrie affini”, organizzata
Camillo Brozzoni (1802-1863) Ghidoni concorre una prima in palazzo Bargnani dall’Asso-
era stato un grande collezio- volta nel 1882, senza successo, ciazione “Arte in famiglia”. Al
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 7Comune di OSPITALETTO
Monumento a Tito Speri, 1888, marmo di Botticino, Brescia, piazza Tito Speri
8 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
concorso si ripresenta nel 1884, presenza di Antonio Tagliaferri, moli, Costantino Quaranta, An-
ancora senza successo, in gara che è incaricato dal Comune di tonio Salvetti, Giovanni Savoldi,
con Pietro Calzavacca, France- sistemare la piazza dove l’opera Bartolomeo Schermini, Arnaldo
sco Gusmeri e Faustino Pezzoli. deve essere collocata e sugge- Soldini, Giuseppe Soncini, Gio-
Intanto però, e dobbiamo pen- risce idee per il basamento-, vanni Tebaldini, Agostino Za-
sare che ci sia sempre la regia Ghidoni figura tra i promoto- nelli, Camillo Zuccoli. Musicisti,
discreta di Tagliaferri, decide ri del “Circolo Artistico”, una pittori, scultori, poeti. L’associa-
di partecipare ai primi concorsi nuova associazione che si pre- zione non ha tuttavia la capacità
pubblici: nel 1883 manda un senta alla città con un articolo di realizzare compiutamente il
bozzetto ad Urbino per il con- pubblicato su “La Provincia di suo progetto e, dopo alcuni con-
corso per il Monumento a Raf- Brescia”. certi ed esposizioni organizza-
faello, che era stato promosso Dopo aver analizzato la situa- te autonomamente, finisce per
dall’Accademia “Raffaello San- zione presente, che appare gra- stabilire una collaborazione con
zio” di cui Tagliaferri era so- vata da un deplorevole torpore, “Arte in famiglia”.
cio: l’opera viene apprezzata, perché mancano “le condizioni Nell’estate dello stesso anno
ma l’esecuzione viene affidata a necessarie a produrre l’am- Ghidoni vince finalmente la pen-
Luigi Belli, che gode di maggior biente in cui possano sviluppar-
fama. Nel 1884 si offre di ese- si queste artistiche attività” in
guire il Monumento a Tito Speri un clima “troppo positivo e bor-
a Brescia, la cui realizzazione ghese”, i soci affermano il pro-
era stata promossa, attraver- posito di voler accogliere cultori
so una pubblica sottoscrizione, e amatori di ogni forma d’arte
dalla Società Reduci delle Pa- per dar vita, senza alcun lega-
trie Battaglie e Sezione Armata me con la politica, ad un vero
Nazionale, che voleva ricordare e proprio laboratorio culturale
l’eroe delle Dieci Giornate con in cui sia possibile fare musica,
una lapide. Quando ci si accorge recitare poesie, disegnare, leg-
però che il denaro affluisce in gere riviste e libri d’arte, espor-
maniera superiore al previsto re in maniera permanente le
e che sarebbe stato possibile proprie opere, e manifestano
realizzare qualcosa di più im- l’intento di volersi impegnare
pegnativo, Ghidoni propone di nella costruzione di un pubbli-
eseguire una statua accettando co, che ha bisogno di essere
un compenso di lire 4.000, a guidato alla scoperta del nuovo.
semplice copertura delle spe- Il nome di Ghidoni figura accan-
se. L’offerta viene dal carattere to a quelli di Battista Barbieri,
di Ghidoni, uomo estremamen- Carlo Baresani, Emilio Berto-
te generoso, ma si rivela poi loni, Eugenio Bertoloni, Cesa-
molto utile perché lo scultore re Bertolotti, Angelo Canossi,
ha modo di farsi conoscere e Paolo Chimeri, Vittorio Duina,
apprezzare e di acquistare una Guglielmo Forbek, Gaetano
pubblica “benemerenza”. Franchi, Arnaldo Ghio, France-
Nell’aprile 1887, quando la rea- sco Gusmeri, Luigi Lombardi,
lizzazione del monumento pro- Enrico Madoni, Giuseppe Nervi, Venditore d’acqua (Un portatore d’acqua o
Fellah o L’acquaiolo), 1884, bronzo
cede speditamente -è impor- Girolamo Orefici, Francesco Pa- Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia
tante anche qui registrare la sini, Luigi Pezzoli, Giovanni Pre- (G.A.M., inv. n.16)
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 9Comune di OSPITALETTO
sione del Legato Brozzoni. Con mune. Il verdetto è favorevole figure femminili a tutto tondo,
lui concorrono lo scultore Fran- all’elaborato di Ghidoni. Subito che raffigura Cristo tra i fan-
cesco Gusmeri, i pittori Arnaldo un’altra soddisfazione gli viene ciulli.
Soldini, Pietro Calzavacca, Gio- dall’acquisto da parte del Co- L’inaugurazione del monumen-
vanni Vender, l’architetto Giu- mune del bronzo Un portatore to a Tito Speri, pronto nel 1888,
seppe Faini e l’ornatista Giovan d’acqua, che era stato presen- viene a coronare un momento
Maria Berti. La prova si svolge il tato all’esposizione del “Circolo felice per Ghidoni, che racco-
5 agosto nei locali della Pinaco- Artistico”. glie apprezzamenti e finisce per
teca in palazzo Martinengo alla In questo stesso periodo è im- essere considerato il giovane
presenza del Consiglio direttivo, pegnato in quella che resterà artista capace di portare anche
che è formato da Antonio Ta- l’unica commissione venutagli a Brescia il verbo innovativo
gliaferri, Pietro Da Ponte, Pietro da Ospitaletto, suo paese nata- appreso a Milano. Arrivano inol-
Morelli, Luigi Cicogna e Giusep- le. Nel 1886 infatti un incendio tre per lui significative com-
pe Ariassi, direttore della Pina- aveva distrutto nella parroc- missioni: nel 1889 il “Circolo
coteca; per i pittori e gli scultori chiale l’altare ligneo del Santo Artistico” vuole una lapide com-
viene estratto il tema “Gli emi- Rosario; al momento della ri- memorativa del musicista Co-
granti”; a giudicare i lavori è costruzione, che non è esatta- stantino Quaranta (1813-1887)
una commissione composta da mente precisabile perché l’ar- da collocare a fianco del por-
Cesare Tallone, Ernesto Baz- chivio è in fase di riordino e non tale del Duomo Vecchio e se ne
zaro, Giuseppe Locati, Battista è stato possibile rintracciare la fanno promotori i pittori Carlo
Barbieri, Francesco Rovetta e relativa documentazione, Ghi- Manziana, Francesco Rovetta e
dagli ingegneri Luigi Marelli e doni fu contattato per esegui- Battista Barbieri; l’Ateneo nello
Ciro Barbieri, nominati dal Co- re la lunetta, affiancata da due stesso anno gli chiede un bu-
Gesù tra i fanciulli, 1887 circa, scagliola, Ospitaletto, chiesa parrocchiale di San Giacomo, altare del Santo Rosario
10 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
sto di Giuseppe Gallia; Antonio di Ghidoni lo spingono a pre-
Tagliaferri, nel 1890, paga di sentare un bozzetto per inizia-
tasca sua i due grandi Leoni di tiva autonoma dell’artista che
marmo che intende collocare intende offrirsi in libertà, come
sui pilastri che reggono i can- era avvenuto per il monumen-
celli della ristrutturata Porta to a Tito Speri. Nel 1893 dun-
San Nazaro. que arriva all’Ateneo (in quel
Nel 1891, infine, sempre l’archi- momento il presidente è l’o-
tetto fa da tramite tra Ghidoni e norevole Giuseppe Zanardelli)
il conte Gaetano Bonoris per il un bozzetto, alquanto innova-
quale sta lavorando al progetto tivo per l’ambiente bresciano,
di trasformazione del castel- che ha un carattere allegorico
lo di Montichiari, procurando e si ispira al monumento mi-
la commissione di un gruppo lanese alle Cinque Giornate di
marmoreo da collocare sulla Giuseppe Grandi, non ancora
tomba di famiglia al Cimitero Ninì Manziana Tagliaferri al pianoforte inaugurato ma già noto a Mi-
Vantiniano. lano. All’Ateneo, o perlomeno
È probabile che in questi anni per il monumento al Moretto. alla parte più “conservatrice”
Ghidoni abbia conosciuto Ninì L’idea dell’omaggio al pittore dei suoi soci, quest’offerta non
Manziana, la bella e colta figlia bresciano parte ancora una vol- piace e viene indetto regolare
del pittore Carlo Manziana; tra ta dall’Ateneo, che disponeva concorso nazionale con una se-
i due c’è una profonda distan- per questo tipo di iniziative dei rie di clausole che vanno contro
za sociale, ma Domenico resta cospicui fondi del Legato Gi- l’idea presente nel bozzetto di
senza dubbio affascinato dalla gola. Prima ancora che fosse Ghidoni e chiedono una rea-
giovane, le chiede di posare per bandito un concorso, gli amici lizzazione più tradizionale con
una lunga serie di ritratti e la
idealizza in un tipo femminile
che ritornerà spesso in tante
figure di donna presenti nelle
sue opere. La loro sarà un’ami-
cizia duratura che andrà oltre il
matrimonio di Ninì con Giovanni
Tagliaferri, nipote di Antonio,
avvenuto nel 1895.
Pieno di meriti e gloria dopo il
successo ottenuto con il grup-
po Emigranti all’Esposizione di
Brera, Ghidoni continua, negli
anni Novanta, a fare la spola tra
Milano e Brescia. In città il suo
fidato gruppo di amici continua
a sostenerlo con forza e a cer-
care di imporre il suo nome nel-
le commissioni più importanti.
Emblematica, a questo propo-
sito, la vicenda del concorso Giovanni Tagliaferri e Ninì Manziana a Vilminore davanti alla tomba del cane Jack
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 11Comune di OSPITALETTO
Emigranti, 1891, bronzo (fusione del 1921) Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (G.A.M., inv. n. 45)
la presenza di una statua con di un incidente che ha rapporti mandò uno di forma simbolica
l’immagine dell’artista. Subito colla Presidenza dell’Ateneo, -consistente in un obelisco dal
si levano diverse proteste da chiedendole in pari tempo ciò quale si stacca sulla fronte la
parte di Vittore Grubicy, della che ne pensi, e il modo con figura che deve rappresentare
“Famiglia Artistica” milanese, cui Ella crede che dobbiamo la pittura sacra; e sui fianchi un
di “Arte in famiglia”, che, com- condurci in proposito. Fino da altro che rappresenta la pittura
patta, deplora il concorso con quando l’Ateneo pensò ad eri- profana ed un genio- e allora
una lettera al presidente dell’A- gere un monumento al Moretto, pretesero che questo bozzet-
teneo sottoscritta da tutti gli alcuni amici dello scultore Ghi- to fosse dall’Ateneo prescelto
artisti bresciani. doni (l’autore del monumento senz’altro, e perché saggio di
Nell’Archivio storico dell’Ate- a Speri, dell’erma a Gallia, dei un autore concittadino e perché
neo è conservata, a proposito due leoni a porta stazione, e di meglio corrisponde, secondo
di questa polemica, la minuta un recente monumento funera- essi, al concetto d’onorarsi il
di una lettera (non datata e non rio al Cimitero) immaginarono grande pittore di cui, dicono,
firmata ma riferibile al vice pre- che si dovesse a lui, come bre- non si sa il ritratto conservato;
sidente professor Teodoro Per- sciano, affidare l’opera divisata il che da indagini fatte in questi
tusati) indirizzata al presidente, senza porre concorso tra gli giorni dal cav. Pietro Morelli
in cui si chiede un suo autore- altri scultori italiani. Essi, a tale risulterebbe inesatto. Quando
vole intervento: “Illustre Presi- scopo, lo eccitarono a presenta- poi avvenne che la Presidenza
dente, mi affretto a darle notizia re un bozzetto, ed egli in fatti ne dell’Ateneo in unione al Consi-
12 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
glio d’amministrazione decise
all’unanimità di aprire un con-
corso italiano, e nel programma
del concorso appose l’obbligo
della statua non sembrando né
a lei, come Presidente, né a
noi tutti il bozzetto suaccenna-
to simbolico adatto allo scopo,
perché troppo arduo a spiegarsi
al popolo, gli amici del Ghidoni
si agitarono e raccolsero ade-
sioni di altri dilettanti di bel-
le arti, mandarono all’Ateneo
la seguente protesta”. L’autore
prosegue chiedendo un auto-
revole intervento dell’onore-
vole Zanardelli, per troncare
ogni pettegolezzo. Il presidente
dell’Ateneo agisce però con ac-
cortezza e prudenza. Il concor-
so fa il suo iter e Ghidoni pre-
senta un secondo bozzetto, che
viene esposto insieme a quelli
degli altri 33 concorrenti nel
dicembre 1893 alla Crociera di
San Luca. La stampa cittadina
dà un buon risalto all’esposizio-
ne, il cronista di “La Provincia di
Brescia” indica anche i bozzet-
ti su cui si sofferma maggior-
mente l’attenzione dei visitatori,
contrassegnati dalle scritte Ar-
naldo, Ars, Ebbe fama..., Fidei,
Arte, Brescia Gloriosa, Veritas,
Brixia Fidelis, Il Moretto e la
Vergine e considera invece i ri-
manenti, compreso Ideale che è
di Ghidoni, “deficienti nel com-
plesso così da non meritare di
essere accolti per la considera-
zione della scelta”.
Diverso parere manifesta in-
vece la giuria, che è formata
dall’onorevole Giuseppe Zanar-
delli, dagli scultori Ettore Fer- Monumento a Alessandro Bonvicino detto Il Moretto, particolare, 1898, bronzo
rari e Gaetano Villa, dall’archi- Brescia, piazza Moretto
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 13Comune di OSPITALETTO
tetto Gaetano Moretti, delegato 26 agosto, al contratto. Nel frat- Ghidoni, al quale l’ambiente in-
dall’Accademia di Brera (assen- tempo però era scoppiato il caso tellettuale e politico bresciano
te Odoardo Tabacchi, trattenuto di Le nostre schiave e non è im- riconosce un merito che non ha
a Torino da un attacco di gotta) probabile che proprio la reazio- nessun altro scultore locale: è
e che assegna il primo premio ne all’esclusione dell’opera di stato Ghidoni che dal suo sog-
di lire 1000 proprio all’Ideale Ghidoni dalla mostra milanese, giorno milanese ha importato
di Ghidoni. Ma le “resistenze” inaugurata ai primi di maggio a Brescia i nuovi indirizzi della
all’interno dell’Ateneo nei con- del 1894, di cui si era fatta inter- scultura milanese per soddi-
fronti dello scultore sono an- prete tutta la stampa bresciana, sfare la voglia di cambiamento
cora molte, tanto che non gli si abbia suscitato nell’opinione e modernità che attraversava
assegna l’incarico di realizzare pubblica bresciana un moto di tutta l’età zanardelliana.
l’opera e si ventila l’ipotesi di “simpatia” nei confronti del no- Il monumento al Moretto è
indire un nuovo concorso limi- stro che consente di superare pronto e inaugurato nel 1898
tato agli autori dei primi sette le resistenze dei suoi avversari ed è proprio in questi anni che
bozzetti selezionati. La questio- dentro l’Ateneo, in particolare si registrano commissioni nu-
ne si trascina per alcuni mesi; del vice presidente, il professor merose e significative. Nel 1897
è soprattutto il basamento che Teodoro Pertusati. Pietro Da Ponte, studioso di sto-
non convince e interviene an- Se l’esecuzione del monumento ria e di arte bresciane, che ap-
cora Antonio Tagliaferri a fare a Tito Speri era stato l’accorto partiene ad una delle famiglia
da mediatore tra l’artista e i omaggio di un giovane artista più in vista della città ed è so-
committenti, suggerendo al- che voleva farsi conoscere dalla cio dell’Ateneo dal 1868, mem-
cune modifiche, che vengono sua città, la commissione per il bro del Consiglio direttivo della
accolte e che consentono il via monumento al Moretto rappre- Scuola comunale di Disegno
libera, dopo la deliberazione del senta l’affermazione ufficiale di “Moretto”, vice presidente della
Le nostre schiave, da una stampa fotografica di Achille Ferrario, 1894, Milano, Civico Archivio Fotografico
14 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
Le nostre schiave, frammento, 1894, gesso patinato, Ospitaletto, collezione Franca Stefanini
Commissione amministratrice na la tomba della sua famiglia. pittura. Ha partecipato a diver-
della Biblioteca Queriniana, re- Pietro Morelli (Pralboino 1841- se esposizioni di “Arte in fami-
gio ispettore degli scavi e dei 1923) è stato volontario garibal- glia” e del “Circolo Artistico”
monumenti, chiede a Ghidoni dino nel 1866, ha studiato legge con quadri di genere e di sog-
di eseguire la tomba della sua ed esercitato l’avvocatura, ma getto patriottico e ritratti. Nel
famiglia al Cimitero Vantiniano. ha dedicato il suo tempo anche 1885 è entrato a far parte del
Nel 1898 è invece l’avvocato An- agli interessi artistici che, fin Consiglio amministrativo della
tonio Pietro Morelli a commis- da giovane, lo hanno spinto a Scuola comunale di Disegno,
sionare la Donna velata che or- coltivare con buoni risultati la divenendone successivamente
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 15Comune di OSPITALETTO
il primo direttore, e proprio co- Nel 1899, per il tramite dei pit- occasione delle celebrazioni per
me membro del consiglio del- tori Carlo Manziana e France- il centenario dell’Ateneo, per
la Scuola gli era toccato nel sco Rovetta, arriva a Ghidoni la l’erezione di un monumento al
1887 di prestare assistenza alla richiesta di eseguire le statue matematico Nicolò Tartaglia; e
prova del concorso per il Le- per la parrocchiale di Gussago; nel 1904, quando dopo la morte
gato Brozzoni, a cui concorre- intorno al 1900 l’avvocato Gae- di Giuseppe Zanardelli si decide
va Ghidoni. In quell’occasione, tano Fornasini, pittore mancato di costruire subito un monu-
come è noto, era stato proposto per l’opposizione della famiglia mento allo statista bresciano,
il tema degli “Emigranti”, che alla sua vocazione artistica, ma il nome di Ghidoni è inserito tra
doveva essere particolarmente socio fondatore di “Arte in fami- i sei artisti invitati a presenta-
caro al Morelli visto che com- glia” oltre che studioso e appas- re dei bozzetti. Nella rosa dei
pare anche in un suo dipinto di sionato bibliofilo, gli chiede di selezionati gli artisti bresciani
quegli stessi anni, poi donato ai ricavare dal gruppo di Le nostre sono rappresentati solo da Luigi
Civici Musei d’Arte e Storia di schiave il busto in marmo del- Contratti e da Ghidoni, segno
Brescia. Consigliere comunale la figura femminile centrale. E, anche questo della stima e della
zanardelliano dal 1899 al 1904, ancora, sono da ricordare nel considerazione in cui lo si tiene
l’avvocato era socio dell’Ateneo 1901 i monumenti Richiedei e nella sua città.
dal 1893 ed aveva fornito con i Feltrinelli, la tomba di famiglia In seguito le commissioni a Bre-
suoi studi sul Moretto le notizie Ettori e il busto di Verdi al Teatro scia, almeno a livello pubblico,
storiche che dovevano servire, Grande; nel 1903 la lapide di Ce- si fanno più rade, ma amici e
anche a norma del bando, agli sare Correnti. Ghidoni partecipa collezionisti privati continuano
aspiranti al concorso per l’ere- anche, senza fortuna, al concor- ad acquistare piccoli bronzi e
zione del monumento al pittore. so che viene indetto nel 1902, in marmi che caratterizzano la
Sulla buona vita, gesso, 80x60x23,5, 1894, ubicazione sconosciuta, già Torino collezione De Amicis
16 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
Busto di Ninì Manziana Tagliaferri, 1899, bronzo, Brescia, collezione avvocato Francesco Capretti
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 17Comune di OSPITALETTO
sua ultima stagione artistica. lievo che Ninì terrà poi sempre funebre ed una serie di busti e
Resta saldissimo il legame con appeso nella sua camera. Non statuette che vanno alla fami-
i Tagliaferri, con Ninì e Giovanni, si allenta neppure il rapporto glia, all’Ateneo, al Cimitero Van-
ai quali l’artista è vicino nei mo- con il vecchio Antonio, che fino tiniano. Un busto viene regalato
menti di gioia e di dolore: alla all’ultimo suo lavoro -l’altare nel 1915 alla Scuola comunale
nascita nel 1898 di Carlo, il pri- maggiore della parrocchiale di di Disegno “Moretto” dallo stes-
mo figlio maschio, lo scultore Montichiari (1909)- vuole che so Ghidoni, che nell’occasione
dona loro un ritratto del bimbo sia Ghidoni ad eseguire le sta- scrive: “memore della Scuola
entro una conchiglia e, quando tue e i bronzi decorativi. Dopo la nella quale ho avuto le prime
nel 1907 muore la piccola Te- morte del suo maestro e amico, ed indimenticabili norme per
resa, utilizzando una fotografia che lo aveva “scoperto” e gui- l’Arte alla quale mi sono dedi-
che il padre aveva scattato alla dato nel corso della carriera, cato, offro alla stessa il busto
bambina, esegue un intenso ri- lo scultore esegue la maschera da me eseguito con figliale ri-
conoscenza del benemerito ed
illustre architetto cav. Antonio
Tagliaferri che fu della Scuola
Moretto anima e vita”.
Si sbaglierebbe però a pensa-
re a Ghidoni come ad un arti-
sta che sparisce dalla scena
bresciana, viene superato dai
tempi e ricompare, come da un
esilio, negli estremi momenti
in cui la malattia lo colpisce. I
legami con la città non si sono
mai allentati. Lo studio di Mila-
no è stato sempre frequentato
dai giovani artisti bresciani che
seguono i corsi di Brera, da
Claudio Botta e Timo Bortolotti
tra gli altri. Della stima che ha
circondato il suo nome sono
infine testimonianza anche i so-
netti che il poeta Angelo Canos-
si inserisce, a due riprese, in
La passeggiata di Maccheronica
Gambara nella Melodia e la im-
mediata decisione della città,
subito dopo la morte dello scul-
tore, di commemorarlo con un
monumento, con una delibera
dell’Amministrazione comunale
che non era mai stata presa (e
non lo sarà nemmeno in se-
Ritratto di Teresa Tagliaferri, 1907 circa, stiacciato e bassorilievo in gesso, guito) per nessun altro artista
Brescia, collezione privata bresciano.
18 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
LA CRITICA
DOMENICO GHIDONI Giovanna Ginex
La formazione d’ambito milanese italiane e storia generale e patria, Anatomia.
Domenico Ghidoni esordisce sulla scena artistica A questo anno di corso fa riferimento una lettera
nazionale presentandosi alla Esposizione di Belle dello scultore Emilio Bisi indirizzata da Milano
Arti dell’Accademia di Brera nel 1883. Ha ventisei all’architetto Antonio Tagliaferri che da Brescia
anni e da almeno quattro ha lasciato Ospitaletto seguiva fattivamente, con affetto e competenza, i
e Brescia per trasferirsi stabilmente a Milano, passi del giovane amico. Emilio Bisi, di sette anni
città dove salvo brevi parentesi risiederà fino alla più anziano del nostro scultore (era nato a Milano
morte. nel 1850), era per nascita molto bene introdotto
Le ricerche ora condotte per la prima volta nell’ambiente artistico, non solo milanese. Fi-
presso l’Archivio dell’Accademia di Belle Arti di glio del pittore e architetto Luigi Bisi, all’epoca
Brera hanno finalmente permesso di ricostruire docente e presidente dell’Accademia di Brera,
con precisione il corso di studi milanese dello poteva già vantare prestigiose commissioni per
scultore, che arriva al suo primo appuntamento la Veneranda Fabbrica del Duomo e in ambito
espositivo braidense con una non trascurabile cimiteriale (il padre Luigi era anche direttore
esperienza, una già consolidata perizia tecnica, della commissione artistica che vigilava sulle
un buon curriculum e, come vedremo, anche con opere funerarie da accogliere al Monumentale
qualche autorevole relazione in città. di Milano). Nella lettera Bisi informa Tagliaferri
Dal registro delle scuole (“Rubrica Allievi”) risul- dell’ammissione di Ghidoni al concorso annuale
ta che Ghidoni nell’anno accademico 1879-1880 braidense “dopo solo due mesi ch’era entrato
abbia frequentato i corsi di Ornato tenuti da all’Accademia”: un ottimo risultato, sottolinea lo
Lorenzo Vela, fratello di Vincenzo, Prospettiva scultore, anche se non coronato dall’assegnazio-
e Disegno di figura. Nello stesso anno stringe ne del premio, pur proposta dall’influente Raffae-
amicizie durature con alcuni compagni, tra cui il le Casnedi. “Nel mio studio ha eseguito vari saggi
pittore Emilio Longoni che era alla fine dei suoi di plastica che tornano a sua lode, e che costì a
studi. A Brera studiano in quegli anni gran parte
degli artisti d’area lombarda che porteranno a
termine nella maturità la rivoluzione pittorica e
plastica naturalista di tradizione scapigliata; è un
I curatori
ambiente culturalmente vivacissimo nel quale si
di questa pubblicazione
è già avviato il primo cambio generazionale tra gli Francesco De Leonardis, giornalista e critico
d’arte bresciano ha all’attivo svariate pubblicazioni
insegnanti, tra cui spiccano per l’influenza avuta e la curatela di numerose esposizioni.
sugli allievi Giuseppe Bertini e Raffaele Casnedi Giovanna Ginex è una storica dell�Arte e curatrice
per i corsi di Figura e Pittura, Francesco Barza- indipendente di mostre ed eventi artistici. È
specializzata in aspetti differenti dell�arte del
ghi per la Scultura.
XIX e XX secolo, dalla pittura alla scultura, dalla
Nell’anno accademico 1880-1881 Ghidoni (regi- fotografia al design. Ha collaborato con svariate
strato con il numero 18) segue i corsi di Ornato, istituzioni in Italia e all�estero. Ha curato la parte
critica della ricerca su Domenico Ghidoni.
Prospettiva sotto la guida di Luigi Bisi, Disegno di
figura elementare con Raffaele Casnedi, Lettere
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 19Comune di OSPITALETTO
Brescia potrebbero fargli onore”, continua Bisi, 1880 professore di Modellatura a Brera, Enrico
suggerendo a Tagliaferri di fare ottenere al gio- Butti, Francesco Crespi, Primo Giudici, Romolo
vane artista di Ospitaletto un sussidio per l’anno Leoni, Raimondo Pereda.
a venire, ricordando anche quanto ne fosse sod- Per l’anno accademico 1882-1883 Ghidoni è re-
disfatto il padre per i progressi fatti nello studio gistrato (con il numero 24) alla scuola di Nudo
della prospettiva. “Per l’anno venturo, trovando- e di Plastica; durante quest’anno è compagno di
mi in uno studio più ampio il Ghidoni potrà accin- corso di Medardo Rosso. Iscritto all’Accademia
gersi a qualche più serio lavoro”, assicura infine dal maggio 1882, Rosso ne verrà espulso nel
Bisi, che infatti traslocherà in via Montebello al marzo del 1883, anche per avere colpito due
numero 3. A questo stesso indirizzo, nei pressi studenti che si rifiutavano di firmare una sua
dell’Accademia di Brera e già storico atelier del- petizione nella quale si reclamavano “modifiche
lo scultore Antonio Tantardini, morto nel 1879, nell’insegnamento” per altro già in vigore in altre
Ghidoni potrà incontrare e confrontarsi con altri accademie italiane, in particolare riguardo alla
scultori che vi tenevano studio negli stessi anni, scuola di Nudo, ai suoi orari considerati troppo
tra cui ricordiamo almeno Ambrogio Borghi, dal ristretti e alla mancanza “di modello muliebre”.
Gli argomenti della petizione toccavano anche la
scuola di Anatomia, della quale si lamentava
l’uso di manichini in cartone al posto di
parti anatomiche tratte da cadaveri. Tra
i settantanove firmatari, anche il no-
stro Ghidoni, preceduto tra gli altri
da Giovanni Segantini. Il giovane
bresciano non esita dunque a fir-
mare la coraggiosa petizione che
avrebbe potuto almeno in parte
guastare i rapporti con i Bisi
padre e figlio, considerando che
proprio Luigi Bisi firmerà il de-
creto di espulsione di Rosso.
Al termine di questo intenso
anno accademico Ghidoni,
come già ricordato, espone
per la prima volta a Brera. Il
catalogo ufficiale della mo-
stra ci fornisce il primo reca-
pito milanese dello scultore:
via Rossini 3. Allo stesso in-
dirizzo abitavano anche il
pittore Ernesto Fontana e
lo scultore Giuseppe
Krieger. A pochi passi,
in via Rossini 5, abi-
terà per qualche tempo e negli
stessi anni anche l’amico pittore Emilio
Dolore, 1887, bronzo Longoni.
Brescia, Ateneo di Brescia Via Rossini era allora al centro di quelle “ortaglie”
20 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
descritte e riconosciute dai protagonisti della il gruppo di artisti -Vincenzo Vela, Pietro Magni,
Scapigliatura milanese come il luogo dove si svol- Giovanni Strazza, Antonio Tantardini, Giosuè Ar-
gevano la vita e l’opera dei suoi primi protagonisti. genti, Francesco Barzaghi, Odoardo Tabacchi,
Tra l’allora via Monforte (ora corso Monforte), via per non citare che i maggiori- che tra gli anni
Vivaio (che, come vedremo, sarà l’ultimo indirizzo Cinquanta e Settanta del secolo impressero la
milanese del nostro scultore) e via Conservatorio decisiva svolta in senso naturalista alla scultura
-adiacente a via Rossini- si concentravano negli accademica lombarda. Attorno agli anni Ottanta
anni Sessanta e Settanta del secolo gli studi degli appunto, con la svolta generazionale che modifi-
artisti, dei poeti e degli scrittori che inventarono cò anche i vertici dell’insegnamento accademico
la Scapigliatura. Una zona che ancora negli an- braidense, la “scuola di Milano” aveva esaurito la
ni Ottanta non era stata privata del suo fascino, sua forza innovatrice, ora
benché la morte di Tranquillo Cremona, nel patrimonio del-
1878, avesse minato alla base la vita del gruppo. la rivoluzione
Un’area all’epoca non completamente edificata,
caratterizzata da giardini, orti e case modeste
dai grandi cortili, adatte ad accogliere gli
studi degli artisti. Eco estrema del legame
di Ghidoni con l’ultima Scapigliatura mila-
nese sarà il delicato monumento funebre
eseguito per Carlotta Cagnoli, la vedova di
Tranquillo Cremona, morta nel febbraio
del 1913.
Non resta una documentazione certa di
Una bella presa, il “grazioso gruppetto in
bronzo” descritto da De Gubernatis nel
1906 e il cui soggetto identifichiamo ora
con il gesso raffigurante un’allegra coppia
di bevitori, della quale rimane una foto-
grafia d’epoca. Esposta con successo la
prima fusione a Brera nel 1883 e subito
venduta, Ghidoni ne ricavò una seconda
per ripresentare l’opera a Torino l’anno
seguente. Si tratta di una piccola scena
di genere di gusto ironico che non si
discosta dalle altre e molte sculture di
piccole dimensioni e di soggetto aned-
dotico esposte a Brera in quell’anno,
gradite all’epoca dal pubblico borghese
delle esposizioni e dunque particolar-
mente adatte alla vendita. Anche nel
modellato mosso della superficie, per
quanto sia concesso osservare dalla
fotografia, l’opera si allinea con gli
ultimi esiti generistici della plastica
lombarda riferibile alla “scuola di Mi- Testa femminile, 1910 circa, marmo di Candoglia
lano”; così la critica coeva usava definire Comune di Ospitaletto
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 21Comune di OSPITALETTO
plastica scapigliata che in Giuseppe Grandi aveva
il suo massimo esponente. In questo panorama
si colloca anche il Venditore d’acqua di Ghidoni,
datato 1884, in cui l’artista, concluso il suo ciclo
braidense, rivela forse per la prima volta, oltre
alla già comprovata perizia tecnica, una forte
personalità artistica in via di definizione.
L’opera fu esposta a Torino, non a Milano, e pri-
ma di questa data va con ogni probabilità collo-
cata la conclusione del breve soggiorno torinese
di Ghidoni, che vi frequentò l’Accademia Alberti-
na e lo studio di Odoardo Tabacchi; circostanza
della quale è difficile dubitare essendo ricor-
data da una nota autografa dello scultore (cfr.
il Regesto biografico, p. 177) e ripresa fin nelle
prime biografie apparse negli anni Novanta del
secolo. Tabacchi, che nel 1883 espone a Brera
alcuni ritratti, era all’epoca al culmine della
fama: nato a Valganna e formatosi a Milano, dal
1867 aveva sostituito Vincenzo Vela alla catte-
dra di Scultura presso l’Accademia Albertina di
Torino, divenendo uno degli artisti più richiesti
del tempo. Di lui Filippo Filippi, autorevole pub-
blicista, critico musicale del quotidiano milane-
se “La Perseveranza” e personaggio di punta
della Scapigliatura lombarda, scrive nel 1880:
“A Torino, il Tabacchi, professore di scultura, è
artista serio, proveniente da quella scuola mila- Testa di fanciullo, 1891 circa, gesso, Ospitaletto, collezione
nese che alcuni anni fa rappresentava il primato Angela Aiardi Cavallin
della scultura italiana (...). Il Tabacchi è autore
di statue pregevolissime, il cui senso della mo- importanti commissioni per il Vantiniano e alla
dernità si accoppia felicemente a qualità ideali IV Esposizione Nazionale di Belle Arti tenutasi
di stile”. Tabacchi anche negli anni torinesi non nel 1880 a Torino espone il colossale gesso per
interruppe mai i rapporti con Brera e con la il monumento ad Arnaldo da Brescia destinato
città, aprendo in altri casi documentati il suo appunto alla città. Un’opera che colpì la critica
studio torinese a giovani artisti lombardi, se- per la non convenzionalità e il realismo della
guendo per altro una consuetudine di scambio figurazione prescelta dallo scultore per raffigu-
e apprendistato tra artisti di diverse generazioni rare il “grande riformatore” e che nel 1882 viene
e operanti in città differenti molto comune all’e- inaugurata a Porta Torrelunga, proprio un anno
poca; penso ad Ambrogio Borghi che da Brera si prima del soggiorno torinese di Ghidoni. Le
spostò per qualche tempo nell’atelier torinese gravi lacune dell’archivio dell’Accademia tori-
di Tabacchi attorno al 1871, o a Luigi Contratti nese relative proprio agli anni che ci interessa-
che si trasferì definitivamente dalla provincia no non permettono un riscontro documentario
di Brescia a Torino. Tabacchi, inoltre, da qual- all’iscrizione ai corsi; in ogni caso era prassi
che anno era una presenza forte sul territorio normale che gli artisti frequentassero le aule
bresciano; dalla metà degli anni Settanta riceve di più di un’accademia, anche senza iscrizione
22 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020VIVERE OSPITALETTO
ufficiale, specie se introdotti da artisti locali, in
questo caso addirittura dal titolare della cat-
tedra. Inoltre l’Albertina, a differenza di Brera,
era all’avanguardia nei corsi “liberi”, tra i quali
gli scultori apprezzavano soprattutto quello di
Nudo, ricordato tra l’altro come esempio di di-
dattica avanzata anche nella petizione di Rosso
del 1883, firmata da Ghidoni, di cui ho già detto.
Il rapporto con Tabacchi con ogni probabilità non
si esaurì agli anni della formazione del nostro
scultore; ricordiamo almeno la presenza nel 1893
dell’anziano maestro nella commissione giudica-
trice del secondo bozzetto presentato da Ghidoni
al concorso per il monumento al Moretto.
L’affermazione come scultore “sociale”
Nel Venditore d’acqua abbiamo riconosciuto la
testimonianza dell’abilità plastica di Ghido-
ni ventisettenne, assorto nell’omaggio alla
scultura mossa, dai volumi spezzati, che a
Milano faceva riferimento all’opera di Grandi.
Il tema era ancora generico, in sintonia con l’o-
rientalismo in gran voga e forse da riferirsi anche
a un viaggio, compiuto da Ghidoni o da persone a
lui molto vicine, documentato dal gruppo di una
ventina di fotografie databili agli anni Ottanta
scattate in Africa del Nord, in particolare
in Egitto e Tunisia, ora ritrovate tra le
carte dello scultore.
Questa fase tanto vicina al-
la lezione di Grandi darà
i migliori risultati
qualche anno
L’Ideale (Ascensione o Monumento a Maddalena Monge Grün), 1910, marmo e Sarizzo Ghiandone, Milano, Cimitero
Monumentale
NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020 23Comune di OSPITALETTO
dopo, quando Ghidoni -abbandonati i più fa- chiudono la lunetta di Gesù tra i fanciulli per la
cili temi di genere in costume- si cimenterà parrocchiale di Ospitaletto: quella particolare
con le figure femminili, come nel Monumento resa “ribelle” dei capelli nelle sue giovani figure
Garbagnati del 1885 e nell’intenso femminili, assonante ancora all’opera di Grandi
Dolore presentato alla Perma- ma tradotta in modi personali, quei volumi che
nente milanese del 1887. La già si geometrizzano attorno ai corpi e lasciano
stessa matrice rivelano infi- intuire una prossima, autonoma traduzione pla-
ne le splendide fanciulle stica della mai rinnegata necessità di aderenza
angeliche che al “vero”. In queste opere già riconosciamo al-
cuni dei tratti iconografici e plastici propri dello
scultore maturo e riproposti da Ghidoni almeno
fino agli ultimi anni dell’Ottocento, quando una
breve stagione liberty gli farà sperimentare al-
tre soluzioni formali.
Entro la primavera del 1889 Ghidoni si trasferisce
in via Giuseppe Sirtori al numero 4, a ridosso dei
bastioni di Porta Venezia. Una zona ancora popo-
lare e una casa modesta, tuttora esistente, nel
cui cortile è ancora visibile una struttura che con
ogni probabilità ospitava lo studio dello scultore,
luminoso e abbastanza ampio da permettergli
di realizzare opere di grande dimensione. Qui si
compie la svolta centrale della carriera artistica
di Ghidoni verso un’intensa fase in cui i contenuti
delle sue creazioni assumono una valenza pro-
grammatica; qui Ghidoni elabora alcuni dei suoi
massimi capolavori.
Nella primavera del 1891 si inaugura la Prima
Esposizione Triennale dell’Accademia di Belle
Arti di Brera, che con la nuova scadenza sostitui-
sce le tradizionali mostre annuali; nel 1889 e nel
1890 le sale di Brera non avevano infatti ospitato
l’annuale esposizione d’arte, ormai sorpassata
nella formula da altre iniziative. Si riaprono nel
’91 in occasione dell’attesissima mostra nella
quale gli organizzatori e anche gli artisti ripone-
vano molte speranze: i primi tesi a favorire la
ripresa dello stagnante mercato arti-
stico, i secondi lo svecchiamen-
to della produzione figurativa
nazionale. Un evento molto
atteso anche dal pubblico e
dalla critica, che per la pittu-
ra italiana segnerà la prima uscita
ufficiale dei divisionisti, e per la scultura il de-
Maternità, 1915, gesso, Brescia, collezione privata finitivo tramonto dei soggetti non legati al “vero”.
24 NUMERO SPECIALE - OTTOBRE 2020Puoi anche leggere