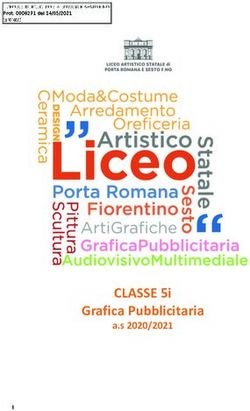ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DOCUMENTO DEL
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"
Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)
tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487
e-mail: POPS02000G@istruzione.it
posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCUMENTO
DEL
CONSIGLIO DI CLASSE della 5 A scientifico
. Il coordinatore di classe
Prof.ssa Tatiana Lucia Magnaterra
1PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO
Il Liceo “Niccolò Copernico” forma i giovani dell’area pratese e dei comuni limitrofi da quasi un
cinquantennio. Nato come liceo scientifico nel 1969 in seno al Convitto “Cicognini”, nella storica
sede in piazza del Collegio, fu trasferito dopo poco tempo in un nuovo edificio in Via Bicchierai. A
seguito del rapido aumento del numero degli iscritti, agli inizi degli anni ’70 vi fu un nuovo
spostamento, in un ex-complesso industriale di Via Costantini. Nel 1975 alcune classi del
“Copernico” furono trasferite in Via Reggiana, formando il primo nucleo di quello che più tardi
divenne una nuova istituzione scolastica autonoma, il LS “Carlo Livi”. La scuola rimase in Via
Costantini fino al 1999, quando fu resa disponibile, opportunamente ristrutturata, la sede attuale. La
posizione del Liceo, prossima alla stazione centrale, offriva facilità di collegamenti urbani ed extra-
urbani con i mezzi pubblici. Ciò ha contribuito nel tempo ad ulteriori incrementi della popolazione
scolastica. Già nei primi anni ’70 al “Copernico” prese il via una mini-sperimentazione dell’area
scientifica. L’indirizzo linguistico fu introdotto, in forma di maxi-sperimentazione, nell’anno
scolastico 1985. Gli anni successivi videro un rapidissimo incremento della popolazione scolastica,
attratta anche dall’introduzione di tre nuove mini-sperimentazioni nelle sezioni del liceo scientifico
(PNI, sperimentazione di scienze, sperimentazione bilingue). Negli anni ’90 anche l’indirizzo
linguistico fu oggetto di ulteriori modifiche, che sono rimaste in vigore fino alla riforma liceale del
2010. Negli ultimi decenni, vista la considerevole affluenza di alunni, il “Copernico” è stato oggetto
di diversi dimensionamenti, con scorporo di alcune classi a favore di altri licei del territorio. Al
contempo è stato deciso di utilizzare come succursale un edificio limitrofo, comunicante attraverso
il giardino con la sede centrale.
L’OFFERTA FORMATIVA
L’Offerta formativa della nostra scuola insiste da un lato su una solida base culturale in linea con
uno studio di tipo liceale, dall’altro si apre alle nuove esigenze della contemporaneità con un ampio
raggio di attività per rendere sempre più attuale, completa e flessibile la preparazione degli studenti.
I corsi di studio del Liceo Niccolò Copernico sono, per scelta e tradizione consolidata, il Liceo
Scientifico e il Liceo Linguistico, secondo i quadri orari indicati dalla riforma. Il Liceo Copernico si
connota prevalentemente come scuola preparatoria al percorso universitario. Anche per questo
motivo la didattica curriculare è integrata da numerosi progetti e iniziative di respiro locale,
nazionale, europeo, spesso in rete sinergica con altre Scuole Superiori Statali, con l’Università degli
Studi o gli Enti Pubblici territoriali.
Il Liceo Scientifico forma gli alunni con una solida preparazione di base e apre un ampio orizzonte
culturale, sviluppando un metodo di studio rigoroso e un’attitudine critica secondo un progetto
2collaudato, che bene integra le scienze e la tradizione umanistica del sapere per adeguarsi ad una
società in rapida evoluzione. I buoni risultati sono attestati dalle rilevazioni della Fondazione
Agnelli (progetto Eduscopio), da cui risulta uno dei migliori licei scientifici nel raggio di 30 km. Il
Liceo intrattiene, inoltre, rapporti con l’Unione Europea mediante la partecipazione a bandi per la
realizzazione di progetti rivolti a studenti e docenti ed è una delle poche scuole italiane ammesse a
Progetti Erasmus+ KA1 e KA2. Da alcuni anni ha stretto un rapporto di collaborazione con la sede
pratese dell’Università Monash e con la sede madre della University of Melbourne. Da qualche
anno è stata stipulata una convenzione anche con il campus pratese dell’Università americana New
Haven.
Nel corso dell’anno scolastico 2004-2005 il Liceo Copernico ha ottenuto la Certificazione di
Qualità ISO 9001:2000, modificata successivamente in ISO 9001:2008. Nell’anno scolastico 2016-
2017 ha ricevuto una nuova Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2015. Il Liceo
Copernico è inoltre accreditato sia come test center ECDL e Certificazioni linguistiche (inglese,
francese e tedesco) sia come Agenzia formativa presso la Regione Toscana.
1. PROFILO DELLA CLASSE
1. Quadro Orario Settimanale delle Discipline curriculari
QUADRO ORARIO CORSO SCIENTIFICO
Monoennio
Primo biennio Secondo biennio
Materie curriculari
Quinta
Prima Seconda Terza Quarta
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica (informatica al 1°biennio)
5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività
alternative 1 1 1 1 1
Totale Ore 27 27 30 30 30
32. Elenco docenti
Prof.ssa Nicoletta Ceccatelli (Lingua e Letteratura Italiana/Lingua e Cultura Latina)
Prof. Rocco Meoli (Matematica/Fisica)
Prof.ssa Jessica Donnini (Lingua e Civiltà Straniera/Inglese)
Prof. Lorenzo Monticelli (Storia/Filosofia)
Prof.ssa Tatiana Lucia Magnaterra (Scienze Naturali)
Prof. Claudio Puccetti (Disegno e Storia dell’Arte)
Prof. Angelo Bellanova (Scienze Motorie E Sportive)
Prof.ssa Daniela Manetti (Religione Cattolica)
3. Storia della classe
All’inizio del percorso liceale la classe I As era formata da 22 alunni così come l’attuale 5 As .
Tuttavia, nonostante il numero sia rimasto lo stesso, la composizione della classe è cambiata negli
anni a causa di non ammissioni, trasferimenti e nuovi inserimenti avvenuti durante il corso di studi.
IL primo anno era presente in classe un alunno certificato L. 104 che ha, poi, cambiato scuola in
seconda. Dal quarto anno nella classe sono presenti due casi con diagnosi di DSA, uno proveniente
da altra classe e uno già facente parte del gruppo classe, per il quali sono stati attivati i Piani
Didattici Personalizzati. Per la conoscenza delle problematiche relative ai due casi si rimanda ai
singoli PDP e agli allegati riservati del presente documento. L’avvicendamento del corpo insegnante
è riportato nella sottostante tabella insegnanti
4Materia 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Rosati Pagli Ceccatelli Ceccatelli
Italiano Rosati Gabriella
Gabriella Alessandro Nicoletta Nicoletta
Andolina
Ceccatelli Ceccatelli Ceccatelli
Latino Nadia Andolina Nadia
Nicoletta Nicoletta Nicoletta
Storia e Rosati
Rosati Gabriella
geogr. Gabriella
Donnini Donnini Donnini Donnini
Inglese Donnini Jessica
Jessica Jessica Jessica Jessica
Disegno e
Puccetti Puccetti Puccetti Puccetti Puccetti
Storia
Claudio Claudio Claudio Claudio Claudio
dell’arte
Storia e Monticelli Monticelli Monticelli
Filosofia Lorenzo Lorenzo Lorenzo
Magnolfi Magnolfi
Matematica Meoli Rocco Meoli Rocco Meoli Rocco
Rossella Rossella
Nesi
Nesi
Fisica Massimilian Meoli Rocco Meoli Rocco Meoli Rocco
Massimiliano
o
Magnaterra
Scienze Magnaterra Magnaterra Magnaterra Magnaterra
Tatiana
Naturali Tatiana Lucia Tatiana Lucia Tatiana Lucia Tatiana Lucia
Lucia
Scienze Bellanova Bellanova Bellanova Bellanova Bellanova
motorie Angelo Angelo Angelo Angelo Angelo
Manetti
Manetti Manetti Manetti
Religione Manetti Daniela Daniela
Daniela Daniela Daniela
54. Situazione didattico-disciplinare della classe
Il gruppo classe della 5As è attualmente composto da 22 studenti (9 femmine e 13 maschi), 20
provenienti dalla 4 As dello scorso anno, un’alunna proveniente da un’altra classe quarta e un
alunno ripetente di quinta. Sono presenti nella classe due alunni certificati DSA per i quali è stato
redatto e attuato il relativo PDP. In classe è presente anche un’alunna con problemi di salute
certificati che non le hanno consentito una frequenza regolare. La classe, mediamente eterogenea
sia per efficacia del metodo di studio che per capacità rielaborative e strategie di apprendimento, ha
mantenuto nel quinquennio una fisionomia sostanzialmente costante. Il comportamento della
maggioranza degli alunni è stato corretto e rispettoso nei confronti degli insegnanti e, solo in alcune
occasioni e in alcune discipline, si è reso talvolta necessario richiedere a qualche componente del
gruppo maschile un atteggiamento più responsabile e un più rigoroso rispetto delle regole. Altra
caratteristica costante che ha contraddistinto la fisionomia della classe e evidenziata nei verbali del
c.d.c., è stata la coesistenza di due gruppi con un diverso approccio allo studio. Un discreto numero
di alunni, comprendente la componente femminile e parte dei maschi, negli anni si è impegnato nel
lavoro scolastico con costanza e serietà senza tuttavia riuscire a far emergere elementi trainanti
positivi. Un gruppo meno numeroso ha lavorato in modo più superficiale e discontinuo nonostante
le continue sollecitazioni dei docenti. Alla conclusione del percorso liceale le competenze raggiunte
da ciascuno studente sono piuttosto diversificate sia nel complesso sia rispetto alle diverse
discipline e si possono evidenziare tre fasce di livello. La prima di livello buono e, in qualche caso,
molto buono è costituita da un esiguo numero di alunni che hanno lavorato con costanza,
frequentato assiduamente le lezioni, rispettato le consegne, possiedono un metodo di studio
organizzato ed efficace e capacità analitiche appropriate e apprezzabili competenze sia nelle
conoscenze che nel linguaggio delle singole discipline,. Una seconda fascia, più numerosa, presenta
un rendimento mediamente discreto, pur non omogeneo in tutte le discipline; tale profitto è ottenuto
con modalità differenti: alcuni studenti hanno lavorato con costanza ma non sempre in modo
adeguatamente orientato; altri, pur in possesso di buone capacità, hanno dimostrato impegno,
attenzione ed interesse discontinui. La terza fascia comprende studenti che hanno acquisito
competenze meno solide e che, pur mostrando di saper cogliere i contenuti essenziali delle singole
discipline, presentano ancora delle criticità in alcune materie. Queste fragilità sono dovute in parte
alla presenza di lacune pregresse, diverse capacità logiche e cognitive, metodo di studio meno
efficace e in parte, in alcuni casi, alla mancanza di un lavoro sistematico e costante e ad un interesse
selettivo e, in alcuni casi, contrassegnato anche da numerose assenze. Il programma è stato svolto
con regolarità fino al 04/03/2020 poi, a seguito della sospensione delle lezioni a causa del COVID-
19, è proseguito in modalità DAD e, risentendo di una modalità nuova e più problematica, ha subito
un leggero rallentamento e ridimensionamento rispetto a quanto programmato ad inizio d’anno.
65. Attività di recupero e/o di approfondimento
Gli interventi di recupero sono stati attuati come previsto dall’attuale PTOF del Liceo scientifico
Copernico, con attività in itinere di recupero e/o consolidamento svoltesi nel periodo stabilito dal
Collegio Docenti. A tali interventi si sono costantemente aggiunti, in orario curricolare, momenti di
recupero e collaborazione tra alunni con diversi livelli di competenze ed ordinarie attività di ripasso
dei programmi disciplinari svolti.
6. Percorsi nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”
Argomenti svolti nell’ambito del programma di Storia e Filosofia
· Il ruolo delle costituzioni
· Stato ed economia
· Stato e cultura
· Stato e informazione
· Lo Stato liberale e lo Stato organico
· Il rapporto tra Stato e Chiesa.
· Democrazia versus Dittatura.
· Il ruolo delle donne nella vita politica.
· Le caratteristiche della democrazia
Argomenti svolti solo dagli avvalentisi IRC:
Cittadinanza: la libertà e l’uguaglianza nell’assenza della fraternità.
L’emergenza sanitario-economico-ambientale nel panorama contemporaneo e urgenti istanze poste
a una politica “malata” di populismi e liberismi: (Analisi di alcuni stralci dalla Laudato sii; articoli
da Città Nuova; https://www.cittanuova.it/).
Dal condizionamento del panico a scelte etiche socialmente costruttive (CNOP)
7Costituzione: radici culturali e persona nei primi articoli; Giordani, La Pira, Dossetti Moro:
l’apporto di una visione cristiana di figure capaci di dialogo con altre prospettive.
7. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
La classe ha seguito un percorso progettato, attuato, verificato e valutato dall’Istituto scolastico.
Esso si è svolto nel triennio per oltre le 90 ore previste dalla normativa, articolandosi nelle attività
di seguito illustrate, che sono comuni alle altre classi quinte.
Pertanto tutti i ragazzi hanno seguito:
un corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
per un totale di 12 ore (4 ore “Formazione generale” + 4 ore “Formazione Specifica per il
rischio basso + 4 ore “Formazione Specifica per il rischio medio”) secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
un corso di Diritto del lavoro (per complessive 6 ore) attuato e valutato dagli insegnanti
dell’Istituto con titolo all’insegnamento di tale disciplina. Il corso ha avuto come obiettivi la
riflessione sulla funzione del lavoro nella società odierna, la comprensione della differenza
tra lavoro autonomo e subordinato, l’approccio alla cultura del lavoro e alle sue
problematiche.
una formazione relativa all’area di interesse scelta fra i percorsi offerti dalla scuola e
trasversali alle classi, per un totale di 26 ore ( 6 ore di presentazione e 20 ore di formazione).
uno stage aziendale (per complessive 30 ore) nell’ambito professionale relativo all’area di
interesse. L’esperienza di stage ha avuto diversi obiettivi: prendere contatto con il territorio,
uscire dall'autoreferenzialità del mondo scolastico, innovare strategie, metodologie e
strumenti, aggiornare i propri modelli organizzativi all'interno di ciascun ambito
disciplinare, sperimentare attitudini in contesto lavorativo.
un corso di autoimprenditorialità di 10 ore, volto a far scoprire a ciascuno studente le
proprie attitudini, i propri punti di forza e il ruolo che ognuno sente di poter rivestire
all'interno di gruppi di lavoro. Nell’attività si è ricorsi a simulazioni di situazioni relazionali
lavorative con cui ragazzi facilmente potranno confrontarsi al termine dei loro studi.
due brevi corsi progettati dal C.d.C. per l'acquisizione delle competenze necessarie alla
stesura di un efficace Curriculum Vitae e per la corretta stesura della relazione finale (per 14
ore )
un progetto di orientamento (per complessive 10 ore) denominato “Orientando” promosso
dall’Università degli Studi di Firenze e finalizzato a far conoscere agli studenti le diverse
scuole universitarie, sviluppare in loro autonomia nella ricerca delle informazioni sulle
offerte formative, portarli ad una maggiore consapevolezza delle proprie preferenze e abilità.
8 tre giornate di Orientamento, per complessive 14 ore, nelle quali gli studenti hanno potuto
assistere alle presentazioni di diversi Atenei ed Istituti di Istruzione post secondaria,
partecipare a lezioni universitarie e confrontarsi direttamente con laureandi di vari corsi di
studio.
La tabella riassuntiva delle ore effettivamente svolte da ciascun ragazzo si trova nel fascicolo
PCTO della classe.
8. CLIL
Gli studenti, nel mese di gennaio 2020, hanno seguito un corso di 12 ore sulla relatività ristretta
in inglese, tenuto da uno studente del MIT di Boston.
9. Iniziative complementari e integrative
Il Consiglio di Classe nel corso degli anni ha promosso la partecipazione a:
mostre, visite guidate, conferenze e spettacoli teatrali
iniziative varie nell’ambito di diversi progetti ( “Res publica”, Fiocco giallo”,” Legalità”,
“Quotidiano in classe”)
corso di Educazione stradale a cura dell’ACI
corso Coop “ I semi della discordia”
lezioni in lingua tenute da tirocinanti dell’università australiana Monash e incontri di
Conversation Exchange presso la sede pratese dell’università statunitense New Haven
Nel corso di questo anno scolastico, gli studenti hanno partecipato allo spettacolo “Operette morali”
di Leopardi tenuto da Galigani, altre iniziative programmate non sono state attuate a causa
dell’emergenza covid 19. Per lo stesso motivo non è stata effettuato il viaggio di istruzione in
Provenza.
Alcuni allievi, nel corso degli anni, hanno sostenuto e superato gli esami delle certificazioni PET,
FCE e CAE.
L’alunna Pecchioli Beatrice ha fatto parte nel triennio della squadra femminile di matematica del
Copernico che ha sempre ottenuto ottimi risultati qualificandosi per le finali nazionali
92. TRAGUARDI DI COMPETENZE TRASVERSALI
Area metodologica
❖ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari edessere
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
❖ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di continuare in
modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.
❖ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
Area logico-argomentativa
❖ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare criticamente le argomentazioni altrui
❖ Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a individuare
possibili soluzioni
❖ Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione Area
linguistica e comunicativa
❖ Avere la padronanza della lingua italiana attraverso: la scrittura in tutti i suoi aspetti; la lettura e
la comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni di significato proprie
di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
l’esposizione orale, sapendola adeguare ai diversi contesti.
❖ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
❖ Saper utilizzare le tecnologie dell’informatica per studiare, fare ricerca, comunicare
Area storico umanistica
❖ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,giuridiche,sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
❖ Conoscere, in riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai
giorni nostri.
10❖ Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici.
❖ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre culture.
❖ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio artistico italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della conservazione.
❖ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
❖ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica
❖ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà.
❖ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, conoscere
le procedure e i metodi di indagine propri.
❖ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti multimediali nelle attività di studio e di
approfondimento.
Risultati di apprendimento in uscita
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno:
❖ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico
e scientifico, anche attraverso i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica
❖ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale
❖ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi
❖ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali e una padronanza dei loro linguaggi specifici e dei loro metodi di indagine
❖ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, con attenzione critica alle loro dimensioni tecnico-applicative ed etiche
11❖ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
3. CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARI
Profilo della classe (interesse, partecipazione, frequenza, livello di preparazione raggiunto,
nonché ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento dell’esame)
Raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, competenze, abilità)
Metodologie didattiche (eventuali raccordi interdisciplinari)
Materiali didattici e spazi utilizzati
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione
Contenuti
12Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: prof.ssa Nicoletta Ceccatelli
PROFILO DELLA CLASSE
La classe, composta da 22 alunni, è stata da me seguita, per lo studio della lingua e della letteratura
italiana, nel corso del quarto e quinto anno, ma già conoscevo gli alunni dal terzo anno per
l’insegnamento di latino. Nel corso di questi anni si sono inseriti 4 nuovi alunni: due alunni che
ripetevano la classe, uno in quarta e uno in quinta e altri due provenienti dalla scuola che hanno
chiesto di cambiare sezione (un ragazzo in quarta e una ragazza in quinta). Due alunni hanno
seguito, come lo scorso anno, un PDP. Il comportamento degli studenti è stato nel corso di questi
anni abbastanza corretto ma non è stata uniforme la partecipazione al dialogo educativo. Una parte
degli alunni, costituita per la maggior parte dalle ragazze e alcuni maschi, è apparsa generalmente
disposta all'apprendimento e all'applicazione, partecipe e collaborativa nei confronti delle proposte
educative, ha dimostrato interesse verso la materia e si è dedicata con impegno ad attività di
approfondimento e di rielaborazione personale. Un gruppo di studenti, costituito prevalentemente
da maschi, nonostante le continue sollecitazioni verso un atteggiamento più attivo e responsabile, ha
dimostrato invece una certa facilità a distrarsi, poco costanza nel lavoro domestico, scarso impegno
nell’approfondimento personale e si è accontentata di uno studio superficiale, più mnemonico che
criticamente rielaborato.
Al momento della stesura di questo documento, tenendo conto delle attività svolte a scuola e delle
attività svolte in questo periodo di didattica a distanza, la classe presenta varie fasce di profitto. Un
gruppo di alunni ha sviluppato capacità comunicative discrete, in alcuni casi buone, questi studenti
si sanno esprimere con efficacia ed evidenziano una soddisfacente competenza espositiva; fra
questi, alcuni in particolare, hanno lavorato con costanza, mostrando di possedere anche una certa
autonomia nel metodo di studio, competenze critiche adeguate e capacità di operare anche confronti
interdisciplinari. Un gruppo più numeroso ha raggiunto competenze espositive e compositive
globalmente sufficienti / più che sufficienti, riuscendo ad esprimersi in modo abbastanza corretto: si
tratta di studenti capaci di comprendere ed analizzare il testo letterario dimostrando di saper
cogliere, in particolare, i nuclei essenziali; la competenza espositiva è accettabile anche se, talvolta,
è stata rilevata qualche incertezza sia nella conoscenza dei contenuti, sia nella capacità di operare
collegamenti fra testi, autori e materie. Il terzo gruppo, composto da un esiguo numero di alunni
mostra una preparazione complessivamente sufficiente, ma presenta, a causa di un impegno talvolta
discontinuo e di qualche carenza nell’approfondimento delle tematiche proposte, ancora difficoltà
ad organizzare le conoscenze secondo una rete di collegamenti efficaci, e ciò si riscontra
soprattutto nella produzione scritta.
13RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ)
Le competenze proposte in fase di programmazione per la classe 5 AS sono state mediamente
conseguite sia per quanto riguarda la produzione scritta sia in relazione all'esposizione orale.
Il lavoro di quest’anno è stato mirato in particolare a far raggiungere agli alunni una adeguata
capacità di analisi autonoma dei testi e di rielaborazione personale dei contenuti; ampio spazio è
stato dedicato alle esercitazioni sulle varie tipologie previste per la prima prova scritta. In
particolare sono state raggiunte, seppur in modo differenziato dai singoli studenti, le seguenti
competenze e abilità operative: conoscenza di testi, autori, generi relativi alla storia letteraria
dell’Ottocento e del Novecento che è stata presa in esame; il Paradiso dantesco nelle sue strutture
generali (con parafrasi e commento dei canti letti); le caratteristiche di varie tipologie testuali
(analisi di un testo letterario, testo argomentativo, testo espositivo- argomentativo). Buona parte
degli studenti nel complesso comprende il messaggio complessivo di un testo, ne individua i temi
principali e le componenti tecniche e formali; sa analizzare il testo, collocarlo nell’ambito storico-
letterario, e organizzare in modo adeguato informazioni e concetti; gli alunni sono stati sollecitati a
cogliere nessi significativi fra autori, temi, problemi studiati e a ricostruire, a partire dai testi e
autori conosciuti, i quadri di riferimento nelle linee essenziali. Oltre alla lettura, comprensione e
interpretazione di un testo, anche in un’ottica interdisciplinare, fra le competenze ritenute essenziali
per gli alunni al compimento del quinto anno, fondamentale è anche la produzione di elaborati con
particolare attenzione alla dimensione testuale, ideativa e linguistica. In particolare gli alunni si
sono esercitati sul testo argomentativo (individuazione di tesi e argomenti; composizione di un testo
argomentativo o espositivo-argomentativo valutabile in base alla capacità di ideare, pianificare ed
organizzare le proprie idee con coesione e coerenza; esprimersi con correttezza ortografica e
sintattica, e con padronanza lessicale; impiegare in maniera pertinente informazioni e conoscenze
culturali in relazione all'argomento proposto; esprimere giudizi critici e valutazioni personali).
METODOLOGIE DIDATTICHE
Oltre alla lezione frontale, necessaria per offrire un inquadramento sugli autori e sui contesti sociali,
politici e culturali delle varie epoche oggetto di studio e per l’esegesi testuale, per promuovere la
partecipazione attiva della classe è stata proposta la lezione interattiva, sollecitando la discussione e
il confronto su alcuni argomenti e tematiche e stimolando la ricerca di rapporti interdisciplinari. Si è
cercato inoltre di sollecitare la riflessione degli studenti anche attraverso la tecnica del problem
solving. Per lo studio della storia letteraria si è partiti dal contesto, inquadrando storicamente i
movimenti letterari e gli scenari culturali di riferimento e cercando di evidenziare il rapporto che la
letteratura ha con la storia, la filosofia, le letterature straniere e con le altre arti. E’ stata privilegiata
la lettura del testo, con l’analisi e il commento critico, guidato, ma aperto all’interpretazione
autonoma degli studenti spesso dopo la spiegazione sono stati sollecitati allo svolgimento di
esercizi per verificare il grado di comprensione e alla discussione. Si è curato il lavoro individuale,
14rivolto non solo al consolidamento del metodo di analisi, ma anche alla correzione di errori di
contenuto o di forma. Per quanto riguarda la produzione scritta, è stata curata la scrittura nei diversi
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), in modo tale che gli alunni
imparassero a modulare tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi
MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI
Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati i manuali in adozione, talvolta anche testi integrativi e
materiali utili per lo studio della produzione di un autore (forniti agli studenti in fotocopia o
attraverso la posta elettronica) e libri (romanzi) da leggere individualmente. Talvolta sono stati usati
strumenti didattici audiovisivi (per esempio, visione del film Il giovane favoloso; sono state
visionati alcuni filmati su D’Annunzio, episodi storici degli anni Trenta, interviste effettuate negli
anni sessanta a Ungaretti). Gli alunni hanno assistito a scuola a una rappresentazione teatrale, la
lezione -spettacolo di Galigani sulle Operette morali di Leopardi.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche orali: si sono utilizzate domande circoscritte o colloqui più ampi incentrati sulla lettura di
un testo, con parafrasi, commento e inquadramento storico-letterario, oppure sulla proposta di una
tematica da sviluppare e argomentare con riferimenti puntuali ai testi. Per le valutazioni dell’orale,
oltre alle interrogazioni, si sono utilizzate anche verifiche scritte
Verifiche scritte: si sono impiegati testi rispondenti a varie tipologie, analisi testuale, commento,
testo argomentativo, espositivo- argomentativo. Per quanto riguarda l’analisi del testo agli studenti è
stata lasciata la facoltà di utilizzare in modo non vincolante il questionario sia per quanto riguarda
l’ordine in cui si susseguono le domande sia per quanto concerne la possibile integrazione con
ulteriori apporti da parte degli studenti.
Criteri di valutazione:
Per la prova scritta (vedi griglia allegata), sono stati seguiti i seguenti criteri per la
determinazione dei livelli di profitto:
Livello di sufficienza: pertinenza alla traccia e presenza di conoscenze adeguate,
espresse in forma corretta.
Elementi per una valutazione superiore: sicurezza di argomentazioni in una struttura
molto pertinente alla traccia, capacità di elaborazione personale, sulla base di
conoscenze approfondite e documentate, capacità di giudizio critico e autonomo,
possesso di mezzi espressivi adeguati, lessico preciso e pertinente, rispetto del registro,
stile consapevole delle scelte adottate e personale.
15 Per la prova orale, sono stati seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei livelli di
profitto:
Livello di sufficienza: comprensione delle problematiche, conoscenza adeguata
dell’argomento, accettabili competenze di lettura, spiegazione e commento del testo,
correttezza espositiva.
Elementi per una valutazione superiore: conoscenze approfondite dell’argomento, sicure
competenze nella lettura e comprensione del testo, capacità di formulare giudizi,
correttezza espositiva e possesso di un lessico appropriato, elaborazione critica e
personale.
Nella valutazione, oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina, si è tenuto conto
del miglioramento delle competenze acquisite da parte dell’alunno rispetto alla situazione di
partenza, dell’impegno nel lavoro svolto, dell’interesse dimostrato. Sono stati attivati interventi di
recupero in itinere.
Nel trimestre sono state effettuate due prove scritte in classe, secondo la tipologia d’esame e due-
tre prove orali.
Nel pentamestre è stata effettuata una verifica scritta nel mese di gennaio (Tip. A -Analisi del testo ;
Tip.B - Testo argomentativo ). Dopo l’interruzione delle attività didattiche sono state assegnate agli
alunni alcune verifiche scritte con valore formativo su argomenti trattati in modalità didattica a
distanza (DaD). Prima della fine dell’anno scolastico verrà somministrata una verifica sommativa
che sarà considerata valida per lo scritto. Per quanto riguarda l’orale, erano state effettuate una
verifica scritta valida per l’orale e valutazioni orali per alcuni studenti fra gennaio e febbraio; una,
due verifiche orali sono state effettuate durante la modalità Dad.
Per i criteri di valutazione della prima prova si rimanda alla griglia in allegato.
Per quanto riguarda i tempi dello svolgimento del programma, non si è potuto del tutto rispettare la
scansione prevista a causa dell’interruzione dell’attività didattica e, anche se nel complesso è stato
rispettato il percorso programmato, è stato ridotto in alcuni casi il numero dei testi da analizzare.
CONTENUTI
GIACOMO LEOPARDI
La vita e le opere. Il pensiero. La poetica. I Canti. Le Operette morali. Lo Zibaldone.
Da Zibaldone di pensieri:
La teoria del piacere
La doppia visione
La rimembranza
Da Canti:
L’Infinito
16 La sera del dì di festa
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il passero solitario
A se stesso
La ginestra o il fiore del deserto
Da Operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere
Dialogo di Tristano e di un amico
L’età postunitaria
La Scapigliatura: modernità e ribellismo; riferimenti ai temi dei seguenti testi tratti da I fiori
del male di Charles Baudelaire: Corrispondenze, L’albatro.
Arrigo Boito, Dualismo vv.1-28
Iginio Ugo Tarchetti, da Fosca, “L’attrazione della morte”
Naturalismo e verismo
Il Naturalismo francese. La poetica di Zola. Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo
italiano.
Il Verismo in Italia
GIOVANNI VERGA
La vita e le opere. Il pensiero. La svolta verista.
“Impersonalità e “regressione” (L’amante di Gramigna, prefazione)
Da “Tutte le novelle”:
Vita dei campi:
Rosso Malpelo
Fantasticheria
Novelle rusticane:
La roba
Libertà
Drammi intimi
17Tentazione!
Per le vie:
L’ultima giornata
Da I Malavoglia
La prefazione ai Malavoglia
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I)
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico
(cap.IV)
I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII)
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV)
Da Mastro don Gesualdo: (l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità /la critica alla
religione della roba)
La morte di Gesualdo
Il Decadentismo
La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della
letteratura decadente
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita. Il pensiero e la poetica. D’Annunzio prosatore. Il piacere. Le vergini delle rocce. La
prosa “notturna”. D’Annunzio poeta: le Laudi.
Da Il piacere:
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (III,
2)
Una fantasia “in bianco maggiore” (III, 3)
Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”
Dalle Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto
Da Il Notturno: La prosa notturna
GIOVANNI PASCOLI
La vita. Il pensiero e la poetica. Le scelte stilistiche e formali. Il fanciullino. Myricae.
Poemetti. Canti di Castelvecchio.
18 Da Il Fanciullino:
Una poetica decadente
Il “fanciullino e il superuomo: due miti complementari – Microsaggio p. 539 ss.
Da Myricae:
Lavandare
X agosto
L’assiuolo
Temporale
Novembre
Il lampo
Da Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
Da Poemetti
Italy
Il primo Novecento.
La situazione storica e sociale in Italia. Ideologie e nuova mentalità. Le istituzioni culturali
Le idee e la cultura. Il Futurismo e le avanguardie.
FILIPPO TOMMASO MARINETTI:
Il manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
I CREPUSCOLARI
La corrente crepuscolare. Guido Gozzano
Guido Gozzano, La signorina Felicita I, III, VI (da I colloqui)
LUIGI PIRANDELLO
La vita. Il pensiero e la poetica. L’umorismo. Le Novelle. Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e
centomila. Il teatro pirandelliano: i caratteri principali
19 Da L’umorismo:
Un’ arte che scompone il reale. La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia
imbellettata
Da Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato
La carriola
Da Il fu Mattia Pascal:
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (cap. XII- XIII)
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII)
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (conclusione del romanzo)
Da Sei personaggi in cerca di autore: La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio
(*) ITALO SVEVO
La vita e le opere. Il pensiero. La poetica, i modelli e lo stile.
La coscienza di Zeno:
La morte del padre (cap. IV)
La “salute malata” di Augusta (cap. VI)
La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII)
Tra le due guerre
(*) UMBERTO SABA - La “poesia “onesta”
Da Il canzoniere:
Città vecchia
Amai
Ulisse
GIUSEPPE UNGARETTI
La vita e le opere. La poetica. L’Allegria. Sentimento del tempo. Il Dolore.
Da L’Allegria:
20In memoria
Il porto sepolto
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia
Mattina
Commiato
Da Sentimento del tempo: Di luglio
Da Il dolore: Non gridate più
EUGENIO MONTALE -
La vita e le opere. Il «male di vivere» e la ricerca del «varco». I modelli, la poetica e lo stile.
Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura.
Da Ossi di seppia:
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere
Forse un mattino andando
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri
Da La bufera e altro: Primavera hitleriana
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia- Letture individuali:
Letteratura e società: B. Fenoglio, Una questione privata
Letteratura e Tecnologia: P. Levi, Cerio (da Il sistema periodico)
Letteratura e politica: L. Sciascia, Una storia semplice
Dante, La Divina Commedia:
Paradiso: canti I , III , VI , XI ,XII, XV, XVII, XXXIII.
21 Lettura di due articoli di giornale:
Coronavirus: la matematica del contagio che ci aiuta a ragionare in mezzo al caos, P.
Giordano, “Corriere della sera”, 25 febbraio 2020
L’animale sociale rivuole la sua vita, A. Polito, “Corriere della sera”, 26 febbraio 2020
Nota: Degli argomenti contrassegnati con * si prevede lo svolgimento nel mese di maggio.
LIBRO DI TESTO: Baldi – Giusso – Rasetti – Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Giacomo
Leopardi. Dall’età postunitaria al primo Novecento (vol. 5.2). Dal periodo tra le due guerre ai nostri
giorni (vol. 6). Paravia editore
22Disciplina: LINGUA E LETTERATURA LATINA
Docente: prof.ssa Nicoletta Ceccatelli
PROFILO DELLA CLASSE
Ho seguito la classe per questa disciplina nel corso del triennio. Fin dall’inizio gli alunni hanno
rivelato competenze diversificate: a fronte di un gruppo che possedeva accettabili conoscenze
grammaticali e sintattiche e si impegnava con costanza a seguire le attività proposte, altri studenti
evidenziavano fragilità e insicurezze nell’analisi del testo e nella capacità di traduzione e
interpretazione, debolezze determinate da carenze nelle conoscenze morfo-sintattiche della lingua e
da una applicazione poco assidua all’esercizio sui testi. E’ stato perciò necessario per tutta la prima
parte del terzo anno procedere al ripasso del programma svolto nel biennio e diverse ore di lezione
sono state dedicate alla ripresa delle norme grammaticali e al laboratorio di traduzione. Non tutti gli
studenti tuttavia sono riusciti ad ottenere, per difficoltà nell’ambito linguistico, lacune pregresse o
impegno discontinuo, una sufficiente padronanza delle strutture della lingua, tale da poter
affrontare in modo adeguato la lettura degli autori, attività più complessa che allarga l’analisi del
testo anche alla comprensione degli aspetti peculiari dello stile (uso delle strutture sintattiche,
prevalenza di paratassi o ipotassi, uso del lessico, delle figure retoriche). Più positivo è stato nel
complesso l’approccio allo studio delle tematiche letterarie e della lettura di testi d’autore, proposti
anche in traduzione, seguito dagli alunni con maggior interesse, anche per la possibilità di
collegamenti con problematiche e tematiche della nostra contemporaneità e per i confronti con la
letteratura italiana e europea (per esempio il realismo di Petronio è stato confrontato con il realismo
moderno e il ritratto di questo autore con la figura dell’esteta nella letteratura del secondo
Ottocento). Per un gruppo di alunni l’interesse suscitato dalla lettura dei testi è stato sostenuto da un
impegno di studio abbastanza costante: questi studenti hanno acquisito una adeguata
preparazione su tematiche storico-letterarie anche se talvolta presentano qualche lieve incertezza
nella corretta interpretazione dei testi. Un’altra parte invece, sia a motivo di carenze pregresse, sia a
motivo di un impegno frammentario, presenta carenze nella preparazione e difficoltà nella corretta
traduzione e interpretazione dei testi. In questo ultimo anno è stato affrontato da un punto di vista
letterario lo studio degli autori dell’età imperiale, e in particolare, per l’esame della lingua e dello
stile, è stata proposta la lettura di alcuni passi delle opere filosofiche di Seneca, un autore
particolarmente significativo anche in un’ottica interdisciplinare. A causa dell’interruzione
dell’attività didattica, non è stato possibile affrontare in modo adeguato la lettura e l’analisi di
alcuni passi di Tacito, autore generalmente proposto per l’esame della lingua e dello stile, al quinto
anno.
23RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Le competenze proposte in fase di programmazione sono state mediamente raggiunte, anche se per alcuni
studenti, con minore sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la traduzione dei testi.
In particolare sono state raggiunte, seppur in modo differenziato dai singoli studenti, le seguenti
competenze e abilità operative:
Conoscere lo svolgimento della letteratura latina e dei suoi principali autori
Saper riconoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua latina
Saper tradurre testi d'autore
Saper contestualizzare un testo o un autore
Individuare la tipologia e il contenuto di un testo
Confrontare temi e motivi presenti nella letteratura latina con quelli affrontati nella
letteratura italiana
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali
lavori di coppia e di gruppo monitorati dal docente
lavoro individuale a casa e a scuola
ricerca individuale e/o di gruppo
utilizzo di strumenti didattici audiovisivi
biblioteca.
MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI
Libro di testo
materiali multimediali
fotocopie fornite dall’insegnante.
E’ stata inoltre proposta la visione di alcune parti del film Il Satyricon di Fellini.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata effettuata nel trimestre attraverso almeno due prove orali (verifica delle
conoscenze e delle competenze morfosintattiche, lettura, traduzione e commento dei testi antologici,
esposizione dei contenuti inerenti allo svolgimento della letteratura) e due prove scritte di vario
tipo: traduzioni di testi con analisi morfo-sintattica e retorica; questionari su argomenti di storia
della letteratura, commenti a testi di autori.
24Nel pentamestre sono state effettuate una prova scritta e alcune verifiche orali prima
dell’interruzione dell’attività didattica. Durante la didattica a distanza sono state effettuate alcune
verifiche scritte con valore formativo che hanno contribuito alla valutazione orale.
Nella valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che del raggiungimento delle competenze
specifiche della disciplina, dell'interesse, della partecipazione, della continuità, dell'impegno, sia in
classe che a casa, e dell'evoluzione rispetto al punto di partenza.
Per la prova sia scritta che orale, sono stati seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei livelli
di profitto:
Livello di sufficienza: adeguata comprensione del testo e traduzione sostanzialmente
corretta; conoscenze storico-letterarie essenziali, ma corrette.
Elementi per una valutazione superiore: comprensione piena del testo con scelte
comunicative efficaci, traduzione corretta, appropriata ed efficace nella forma e nel lessico,
conoscenze letterarie complete, articolate ed approfondite.
CONTENUTI
Lo svolgimento del programma è stato rallentato durante il pentamestre a causa dell’interruzione
dell’attività didattica. Durante questo periodo, con la modalità della didattica a distanza, c’è stata
una riduzione delle ore di lezione e non è stato possibile dedicare molto tempo e attenzione alla
traduzione ed all’analisi dei testi, attività in cui diversi studenti sono ancora poco autonomi,
pertanto è stato necessario operare dei tagli rispetto alla programmazione iniziale e ricorrere a testi
in traduzione.
L’ETA’ GIULIO CLAUDIA - Il contesto storico e culturale.
FEDRO– La favola (il modello, il genere, i contenuti)
Dalle FABULAE:
- Il lupo e l'agnello (I,1)
- La novella della vedova e del soldato (I,5)
SENECA (la vita e il pensiero; i Dialogi, i trattati, le Epistole a Lucilio; lo stile).
Il valore del tempo e il significato dell’esistenza:
E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4)
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1)
La morte come esperienza quotidiana (Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21)
L’esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-4)
25Il sapiente e gli altri uomini:
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilum, 47, 1-4 ; 5-13)
Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium 7, 1-3)
Il rapporto con il potere
La clemenza (De clementia, I, 1-4)
De tranquillitate animi, 2, 6-15: La casistica del male di vivere (2, 6-15); La partecipazione
alla vita politica: resistere o cedere alle armi? (4)
PETRONIO - La questione dell’autore del Satyricon – Il ritratto di Tacito
Il Satyricon (contenuto, genere letterario; il realismo petroniano):
Letture:
L’ingresso di Trimalchione
Presentazione dei padroni di casa
Da schiavo a ricco imprenditore
La matrona di Efeso
Approfondimento: E. Auerbach, Limiti del realismo petroniano p. 250
LUCANO: l’epica, il Bellum civile (fonti, caratteristiche dell’epos di lucano, rapporti con l’epos
virgiliano, personaggi, linguaggio poetico)
Bellum civile, I, vv. 1-32 (argomento del poema); VI vv. 719 ss. (scena di necromanzia)
PERSIO : la satira (poetica, contenuti, stile)
Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114-125 – Un genere contro corente
L'ETA’ DEI FLAVI – Il contesto storico e culturale
MARZIALE – L’epigramma (poetica, tecnica compositiva, temi) .
Obiettivo primario: piacere al lettore! (Ep., IX, 81)
La scelta dell’epigramma (Ep.,X,4)
Matrimonio di interesse (Ep., I, 10
Fabulla (Ep., VIII, 79)
QUINTILIANO (l’Institutio oratoria; la decadenza dell’oratoria: confronto con Tacito)
Dalla Institutio oratoria:
26 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (proemium, 9-12)
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2, 11-13; 18-20)
L’intervallo e il gioco (I, 3, 8-12)
Il maestro come “secondo padre” (II, 2, 4-8)
L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO - Il contesto storico e culturale
GIOVENALE: La satira (la poetica dell’indignatio, contenuti, l’espressionismo dello stile)
L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231 ss.).
PLINIO IL GIOVANE (il Panegirico di Traiano, l’epistolario)
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Ep. VI, 16)
Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Ep. X, 96-97)
TACITO: carriera politica; attività letteraria: Dialogus de oratoribus (decadenza dell’oratoria),
Agricola (biografia), Germania (etnografia), Annales, Historiae (storiografia).
Dalla Germania
I confini della Germania (1)
Caratteri fisici e morali dei Germani (49)
Vizi dei romani e virtù dei barbari (18-19)
Dagli Annales: Proemio (I, 1)
L’incendio di Roma (XV, 38)
La persecuzione contro i cristiani (XV, 44)
L’ETA’ DEGLI ANTONINI
APULEIO: Le Metamorfosi (titolo e trama del romanzo, intenti dell’opera, stile)
Lettura: La favola di Amore e Psiche: (Metamorphoseon libri IV,28 –VI, 24).
LIBRO DI TESTO: G. Garbarino, Luminis orae, vol 3, ed. Paravia
27Disciplina: INGLESE
Insegnante: Jessica Donnini
PROFILO DELLA CLASSE
Ho insegnato in questa classe per tutto il quinquennio ed ho potuto quindi seguire la sua
evoluzione e i suoi cambiamenti sia dal punto di vista dei rapporti interpersonali sia delle
competenze. Il gruppo di allievi nella sua generalità è formato da ragazzi positivi da un punto di
vista umano, che hanno instaurato un rapporto proficuo con l’insegnante, all’insegna del rispetto e
della correttezza. Per tutto il quinquennio la classe, pur mostrando crescita intellettuale e personale,
non si è mostrata molto vivace nella partecipazione al dialogo educativo, soprattutto negli allievi
dotati di minori predisposizioni verso la disciplina e con interesse non sempre adeguato e costante.
Solo gli allievi con migliore fluenza e maggior interesse verso la disciplina hanno apportato in
maniera pressoché costante il proprio contributo durante le lezioni, mentre la parte più fragile ha
costantemente richiesto la sollecitazione da parte dell’insegnante. Al fine di stimolare soprattutto la
parte meno attiva ad una più fattiva collaborazione e partecipazione, si è cercato spesso di
cambiare e/o adattare al caso specifico molteplici strategie didattiche, usando sempre la lingua
straniera durante le lezioni, stimolandone il più possibile l’uso, cercando di creare un clima
coinvolgente , privilegiando, laddove era possibile, il lavoro di gruppo e/o di coppia. La maggior
parte degli allievi ha comunque acquisito un metodo di studio personale e accettabilmente proficuo,
mentre ancora alcuni non sono del tutto autonomi nella rielaborazione delle conoscenze .
Lo svolgimento del programma in questo ultimo anno ha subito rallentamenti ed alcune
sfrondature rispetto a quanto preventivato in sede di programmazione annuale. Ciò è da imputarsi a
cause di varia natura: oltre all’esiguo numero di ore settimanali (3) che sono insufficienti per
affrontare la quantità di programma che la classe quinta richiederebbe, anche le assenze degli
allievi dovute a ragioni di vario genere (Agorà, assemblee di istituto, uscite, conferenze, giornate di
orientamento) non hanno permesso lo svolgimento di tutti gli argomenti programmati. Inoltre, dal
mese di marzo alla data attuale, data l’emergenza sanitaria presente nel paese a tutt’oggi, le lezioni
si sono svolte a distanza. Lo svolgimento del programma ha quindi subito ulteriori inevitabili
rallentamenti e l’aspetto che ha sofferto di più è stato quello relativo alla partecipazione al dialogo
educativo. La scarsa vivacità della classe non è stata sicuramente stimolata o favorita dalla modalità
in cui necessariamente le lezioni sono state svolte. Sia prima dell’interruzione dell’attività didattica
tradizionale sia dopo, gli allievi hanno mostrato scarsa autonomia nello studio della letteratura
in lingua straniera, soprattutto per quanto riguarda l’analisi del testo. Si è quindi preferito
soffermarci più a lungo su quelle parti che risultavano più ostiche piuttosto che presentare un nuovo
argomento. Alla fine del quinto anno, sia per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti sia
28l’elaborazione delle conoscenze, la classe ha mantenuto la configurazione diversificata che l’ ha
caratterizzata durante tutto l'anno scolastico e anche in quelli precedenti.
Ad oggi, nella classe si distingue un esiguo gruppo dotato di migliori prerequisiti e di maggiore
costanza nello studio che dimostra di conoscere gli argomenti di studio in maniera adeguata, si
esprime con discreta e talvolta buona fluenza, possiede un discreto vocabolario e mostra livelli di
competenza globalmente buoni. Tra questi, un paio di allievi hanno raggiunto un livello di
preparazione e una autonomia critica notevoli, sia per migliore predisposizione alla disciplina sia
per avere acquisito un metodo di studio sicuro e autonomo . Un buon numero di allievi, soprattutto
a causa di una minore, anche se accettabile, autonomia critica e qualche incertezza nella
produzione, soprattutto scritta, e, in alcuni casi, minore costanza nell’applicazione allo studio,
raggiunge un profitto che si attesta dal mediamente discreto al sufficiente. In alcuni allievi,
invece, a causa di fragilità espressive e non del tutto adeguata autonomia critica, nonché, nel caso
di alcuni, di un non sempre adeguato impegno profuso, il profilo delle competenze coincide con o
è inferiore a quello degli obiettivi minimi stabiliti. Questi ultimi allievi sono comunque capaci di
cogliere gli aspetti più significativi di un testo letterario e di esprimere, in modo semplice e con un
vocabolario limitato, il loro giudizio.
In generale, la competenza più carente risulta essere l’autonomia critica, in quanto essa è
necessariamente influenzata dalla padronanza della lingua: negli allievi in cui gli strumenti
espressivi sono maggiormente consolidati, emerge una capacità analitica e una riflessione critica
soddisfacente anche nell'ambito della comunicazione letteraria; in coloro , invece, nei quali
permangono maggiori incertezze linguistiche, essa deve essere necessariamente guidata.
In alcuni allievi le competenze riguardanti la lingua scritta presentano ancora incertezze, sia da un
punto di vista morfosintattico che di organizzazione dei contenuti.
Nel corso del quarto anno di studio e nella prima parte di questo ultimo anno scolastico, alcuni
allievi hanno partecipato agli incontri di Conversation Exchange presso la sede pratese
dell’università statunitense New Haven. Purtroppo, il progetto ha visto una brusca interruzione
all’inizio del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.
In prima, in seconda e in terza alcuni tirocinanti dell’università australiana Monash hanno tenuto
lezioni a tutta la classe su vari argomenti (aspetti della cultura australiana, flora e fauna., debating
skills)
Alcuni allievi, nel corso degli anni, hanno sostenuto e superato gli esami delle certificazioni PET,
FCE e CAE.
29Puoi anche leggere