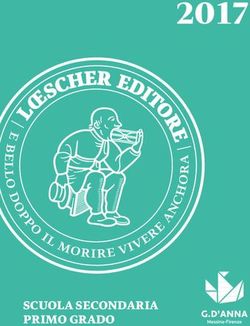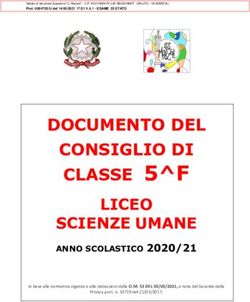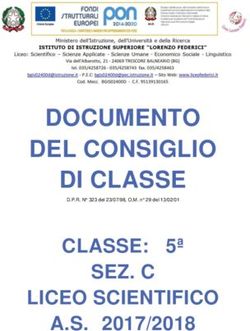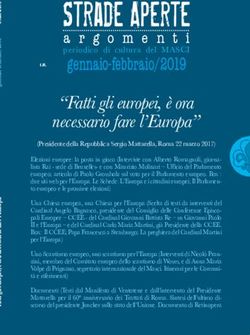ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DOCUMENTO DEL 15 maggio 2018 CONSIGLIO DI CLASSE della 5 B linguistico
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"
Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)
tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487
e-mail: POPS02000G@istruzione.it
posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
DOCUMENTO DEL 15 maggio 2018
CONSIGLIO DI CLASSE della 5 B linguistico
. Il coordinatore di classe
Prof. Elisabetta Bologni
1PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il Liceo “Niccolò Copernico” forma i giovani dell’area pratese e dei comuni limitrofi da quasi un
cinquantennio. Nato come liceo scientifico nel 1969 in seno al Convitto “Cicognini”, nella storica
sede in piazza del Collegio, fu trasferito dopo poco tempo in un nuovo edificio in Via Bicchierai. A
seguito del rapido aumento del numero degli iscritti, agli inizi degli anni ’70 vi fu un nuovo
spostamento, in un ex-complesso industriale di Via Costantini. Nel 1975 alcune classi del
“Copernico” furono trasferite in Via Reggiana, formando il primo nucleo di quello che più tardi
divenne una nuova istituzione scolastica autonoma, il LS “Carlo Livi”. La scuola rimase in Via
Costantini fino al 1999, quando fu resa disponibile, opportunamente ristrutturata, la sede attuale. La
posizione del Liceo, prossima alla stazione centrale, offriva facilità di collegamenti urbani ed extra-
urbani con i mezzi pubblici. Ciò ha contribuito nel tempo ad ulteriori incrementi della popolazione
scolastica. Già nei primi anni ’70 al “Copernico” prese il via una mini-sperimentazione dell’area
scientifica. L’indirizzo linguistico fu introdotto, in forma di maxi-sperimentazione, nell’anno
scolastico 1985. Gli anni successivi videro un rapidissimo incremento della popolazione scolastica,
attratta anche dall’introduzione di tre nuove mini-sperimentazioni nelle sezioni del liceo scientifico
(PNI, sperimentazione di scienze, sperimentazione bilingue). Negli anni ’90 anche l’indirizzo
linguistico fu oggetto di ulteriori modifiche, che sono rimaste in vigore fino alla riforma liceale del
2010. Negli ultimi decenni, vista la considerevole affluenza di alunni, il “Copernico” è stato oggetto
di diversi dimensionamenti, con scorporo di alcune classi a favore di altri licei del territorio. Al
contempo è stato deciso di utilizzare come succursale un edificio limitrofo, comunicante attraverso
il giardino con la sede centrale.
L’OFFERTA FORMATIVA
L’Offerta formativa della nostra scuola insiste da un lato su una solida base culturale in linea con
uno studio di tipo liceale, dall’altro si apre alle nuove esigenze della contemporaneità con un ampio
raggio di attività per rendere sempre più attuale, completa e flessibile la preparazione degli studenti.
I corsi di studio del Liceo Niccolò Copernico sono, per scelta e tradizione consolidata, il Liceo
Scientifico e il Liceo Linguistico, secondo i quadri orari indicati dalla riforma. Il Liceo Copernico si
connota prevalentemente come scuola preparatoria al percorso universitario. Anche per questo
motivo la didattica curriculare è integrata da numerosi progetti e iniziative di respiro locale,
nazionale, europeo, spesso in rete sinergica con altre Scuole Superiori Statali, con l’Università degli
Studi o gli Enti Pubblici territoriali.
I buoni risultati del nostro Liceo Linguistico sono attestati dalle rilevazioni della Fondazione
Agnelli (progetto Eduscopio), da cui risulta ai primi posti nel raggio di 30 km, con una percentuale
di immatricolazione all’università dell’81% e con indice FGA (media dei voti e crediti ottenuti
normalizzati in scala da 1 a 100) pari a 70.61.
Il Liceo Linguistico garantisce una formazione culturale in una dimensione europea del sapere. Le
lingue studiate nel nostro Liceo sono il francese, l’inglese e il tedesco. Per quanto riguarda
l’apprendimento di questa lingua, il liceo è stato riconosciuto dall’Ufficio Centrale per le Scuole
all’Estero (ZfA) della Germania come scuola d’eccellenza, in cui si attua un programma avanzato di
tedesco per preparare gli alunni al conseguimento del Diploma di Lingua Tedesca (Deutsches
Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz) che permette l’iscrizione alle università tedesche.
Il Liceo intrattiene, inoltre, rapporti con l’Unione Europea mediante la partecipazione a bandi per la
realizzazione di progetti rivolti a studenti e docenti ed è una delle poche scuole italiane ammesse a
Progetti Erasmus+ KA1 e KA2. Da sempre favorisce scambi, partenariati, soggiorni-studio con
scuole dell’Unione Europea e non. Da alcuni anni ha stretto un rapporto di collaborazione con la
2sede pratese dell’Università Monash e con la sede madre della University of Melbourne. Da qualche
anno è stata stipulata una convenzione anche con il campus pratese dell’Università americana New
Haven.
Nel corso dell’anno scolastico 2004-2005 il Liceo Copernico ha ottenuto la Certificazione di
Qualità ISO 9001:2000, modificata successivamente in ISO 9001:2008. Nell’anno scolastico 2016-
2017 ha ricevuto una nuova Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2015. Il Liceo
Copernico è inoltre accreditato sia come test center ECDL e Certificazioni linguistiche (inglese,
francese e tedesco) sia come Agenzia formativa presso la Regione Toscana.
1. PROFILO DELLA CLASSE
1.1 Quadro Orario Settimanale delle Discipline curriculari
QUADRO ORARIO CORSO LINGUISTICO
Primo biennio Secondo biennio Monoennio
Materie curriculari Prima Seconda Terza Quarta Quinta
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 2 2 - - -
Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica (informatica al 1°biennio) 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale Ore 27 27 30 30 30
31.2 Elenco docenti
Susanna Rosi (lingua e letteratura italiana)
Stefania Zampiga (lingua e cultura inglese)
Don Brand (conversazione inglese)
Cristina Didò (lingua e cultura tedesca)
Ute Praschifka (conversazione tedesco)
Aurelie Paris (lingua e cultura francese)
Michèle Pouzaud (conversazione francese)
Martina Figna (storia e filosofia)
Luigi Zola (storia dell'arte)
Elisabetta Bologni (matematica e fisica)
Simone Belli (scienze)
Caltabiano Fabian (scienze motorie e sportive)
Lucrezia Mastropasqua (IRC)
Stefania Nucera (sostegno)
Diana Muenter (sostegno)
Matteo Vannini (sostegno)
41.3 Storia della classe
La classe è attualmente formata da 22 alunni, 18 femmine e 4 maschi di cui uno che usufruisce della
legge 104/92. Gli alunni del primo anno erano 25, ma nel corso del quinquennio alcuni non sono
stati ammessi alla classe successiva. Al nucleo originario si è aggiunta una nuova alunna in quarta e
due nuovi elementi in quinta, tutti provenienti da altre classi dell'Istituto, fino ad ottenere l'attuale
composizione.
Gli insegnanti di scienze, di conversazione di francese e di tedesco hanno seguito la classe per tutto
il corso di studio; le insegnanti di italiano, storia e filosofia, matematica e fisica per l'intero triennio.
Inoltre, per inglese e tedesco c'è stata continuità negli ultimi due anni mentre i docenti di francese,
di storia dell'arte, di conversazione di inglese e di IRC sono subentrati quest'anno; l'insegnante di
scienze motorie e sportive ha sostituito l'insegnante titolare all'inizio del pentamestre.
1.4 Situazione didattico-disciplinare della classe
Gli allievi si sono dimostrati disponibili all'ascolto, generalmente interessati alle varie discipline e
corretti nei confronti degli insegnanti. Tutto ciò ha portato ad un clima positivo e sereno in cui
operare. Un piccolo gruppo di studenti ha mantenuto nel suo percorso scolastico un
atteggiamento serio e responsabile, studiando con continuità e impegno e partecipando al dialogo
educativo con interventi costruttivi e personali che denotano buone, talora ottime, competenze e
conoscenze approfondite; un secondo gruppo, meno autonomo rispetto al precedente, ha mostrato
una discreta motivazione e un impegno pressoché continuo raggiungendo risultati positivi; i
restanti alunni invece, complice una motivazione allo studio altalenante, non sono stati
particolarmente costanti nel lavoro domestico, il che ha portato spesso a una mancanza di
rielaborazione degli argomenti trattati e a uno studio essenzialmente mnemonico. A ciò si
aggiunge una frequenza risultata spesso discontinua, col risultato di avere un livello di
preparazione globale complessivamente appena sufficiente.
1.5 Attività di recupero e/o di approfondimento
I docenti hanno effettuato gli interventi ritenuti necessari e finalizzati al recupero di quegli alunni
che, pur lavorando a scuola e a casa con adeguato impegno, non sempre hanno raggiunto gli
obiettivi secondo le previsioni. Nelle ore curricolari sono stati fatti riepiloghi del programma svolto
e ci sono stati momenti di collaborazione tra gli alunni con diversi livelli di conoscenza. Inoltre per
le discipline in cui gli alunni, al termine del trimestre, avevano riportato valutazioni non sufficienti,
i docenti hanno attuato recupero curricolare per un numero di ore stabilito dal Collegio dei Docenti
(tre ore per le discipline con un numero di ore settimanali non superiore a tre, cinque ore per quelle
con un numero di ore settimanali di almeno quattro). Al termine del periodo di recupero è stata
svolta una prova di verifica sull’attività effettuata.
5Durante questo anno scolastico la classe ha partecipato a varie iniziative proposte dai docenti, sia
all’interno della scuola e dell’orario scolastico (conferenze e lezioni) che all’esterno (visita Museo
Scienze Planetarie)
Nell'ambito dell' attività CLIL la classe, in quest’anno scolastico, ha usufruito delle seguenti
attività:
dodici ore di lezione in modalità CLIL Arte/Francese sull'Impressionismo, svolto con l'insegnante di
conversazione di francese;
dodici ore di lezione in modalità CLIL Storia/ Inglese “The nineteenth century”, svolto con
l'insegnante curriculare di storia.
Come attività di preparazione all’esame di Stato la classe ha svolto tre simulazioni di terza prova (la
prima di tipologia B, la seconda e la terza di tipologia A) in un tempo di due ore e mezzo
Nell’allegato sono riportate le discipline scelte nelle tre simulazioni sottoposte agli alunni nel
corso dell’anno. Il C.d.C. ha riscontrato risultati migliori nella tipologia A con quattro materie.
Inoltre gli alunni affronteranno nel mese di maggio anche la simulazione della prima e della
seconda prova scritta, che si terranno negli stessi giorni in tutto l’Istituto.
1.6 Attività di alternanza scuola-lavoro
La classe ha seguito un percorso di alternanza scuola-lavoro progettato, attuato, verificato e
valutato dall’istituto scolastico. Esso si è articolato nel triennio secondo attività comuni alle
altre classi quinte ed attività attinenti allo specifico progetto proposto dal Consiglio di
Classe. Pertanto tutti i ragazzi dell’Istituto hanno seguito:
un corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, per un totale di 8 ore (4 ore “Formazione generale” + 4 ore “Formazione Specifica”)
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni.
un corso di Diritto del lavoro ( per complessive 8 ore: 6+2 della FIL Federazione
Italiana Lavoro) finalizzato a riflettere sulla funzione del lavoro nella società odierna,
comprendere la differenza tra lavoro autonomo e subordinato, avviare un approccio alla
cultura del lavoro, riflettere sulle problematiche relative al mondo del lavoro.
uno stage aziendale ( per complessive 60 ore) nell’ambito lavorativo scelto da
ciascuno studente e finalizzato a prendere contatto con il territorio, uscire
dall'autoreferenzialità del mondo scolastico, innovare strategie, metodologie e strumenti,
aggiornare i propri modelli organizzativi all'interno di ciascun ambito disciplinare,
sperimentare attitudini in contesto lavorativo.
un progetto di orientamento (per complessive 26 ore) denominato “Orientando”
promosso dall’Università degli Studi di Firenze e finalizzato a far conoscere agli studenti le
offerte formative di diversi Atenei e facoltà, sviluppare in loro autonomia nella ricerca delle
informazioni sulle offerte formative degli Atenei, portarli ad una maggiore consapevolezza
delle proprie preferenze e abilità.
6 tre giornate di Orienteering (per complessive 17 ore) nelle quali gli studenti hanno
potuto assistere alle presentazioni di diversi Atenei, facoltà ed Istituti di Istruzione post
secondaria anche in un confronto diretto con laureandi di vari corsi di studio.
un progetto di classe denominato “ Prospettive lavorative nell'ambito dell’attività
teatrale ” ( per complessive 36 ore) finalizzato a comprendere il processo di costruzione di
un'opera teatrale e la complessità dello sviluppo che porta alla creazione di una
rappresentazione.
a completamento del percorso il CdC ha aderito ai seguenti progetti
a) Progetto biblioteca
b) Allenamento ai quiz a risposta multipla ( 10 ore)
c) Corso su defibrillatore (5 ore)
d) Stage in azienda per i due alunni inseriti quest'anno
L’Istituto ha inoltre stabilito di riconoscere come ore di alternanza scuola-lavoro le ore di
formazione specifica che ciascun ragazzo abbia eventualmente dedicato al conseguimento di una
certificazione linguistica o al superamento di un esame per l’ECDL.
La tabella riassuntiva delle ore effettivamente svolte da ciascun ragazzo si trova nel rispettivo
fascicolo personale.
1.7 Iniziative complementari e integrative
Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato alle seguenti iniziative:
classe prima: viaggio di istruzione in una località etrusca; progetto “Vela per tutti”, comprendente
un viaggio di istruzione ad Antignano; uscita presso l'Istituto Francese di Firenze; una lezione dal
titolo “Essere pronti aiuta il soccorso” nell'ambito dell'educazione alla salute.
classe seconda: viaggio di istruzione a Ravenna; partecipazione al progetto Educazione alla salute;
conferenza su Gesù storico.
classe terza: soggiorno studio di una settimana a Wangen finalizzato allo sviluppo delle competenze
linguistiche in lingua tedesca; uscita presso l'Istituto Francese di Firenze; rappresentazione teatrale
su Boccaccio; attività di Chimica del restauro presso l'Opera del Duomo di Prato; concerto presso
l'Opera di Firenze; certificazioni Cambridge.
classe quarta: viaggio di istruzione a Torino; conferenza sulla dieta mediterranea; conferenza sulla
donazione del sangue e del midollo; spettacolo di Offenbach al teatro Goldoni di Firenze; visita alla
7Galleria degli Uffizi; certificazioni Cambridge; visione di spettacoli al teatro Metastasio e incontri
con registi.
classe quinta: museo delle Scienze planetarie; trekking a Figline nell'ambito della Giornata della
Memoria; incontro di educazione alla salute sulla donazione degli organi; spettacolo sulle “Operet-
te morali” .
2 TRAGUARDI DI COMPETENZE TRASVERSALI
Competenze chiave di cittadinanza
In base alle ultime indicazioni ministeriali relative anche al progetto di alternanza Scuola/Lavoro e a
una sempre più urgente esigenza e consapevolezza di cittadinanza attiva allle competenze chiave di
cittadinanza previste per il biennio (Imparare ad imparare; Comunicare; Collaborare e partecipare;
Agire in modo autonomo e responsabile), sulle quali il C.d.c. continuerà ad insistere, si aggiungono :
- saper apprezzare la dimensione culturale del sapere e del saper fare;
- sviluppare lo spirito di iniziativa;
- apprezzare l’arricchimento derivato dallo sviluppo dello spirito imprenditoriale
- apprezzare l’arricchimento derivato dai prodotti culturali.
Competenze per assi culturali
-Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita;
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
-Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui;
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni;
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
-Area linguistica e comunicativa
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
8corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e, per la seconda e terza
lingua, aver raggiunto e consolidato un pieno livello B1 e, in alcuni casi, B2.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
-Area storico-umanistico-sociale
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano
le lingue.
-Area matematica e scientifica
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base
della descrizione matematica della realtà.
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
93 CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARI
LINGUA e LETTERATURA ITALIANA
Relazione finale
Prof.ssa Susanna Rosi
Presentazione della classe e svolgimento del programma
Gli studenti di questa classe, che ho seguito per l'intero triennio,si sono mostrati fin dall'inizio
disponibili all'ascolto e interessati alle diverse problematiche affrontate ed hanno partecipato alla
lezione attivamente, vivacizzandola con interventi talora fin troppo esuberanti. Questo
atteggiamento, unito ad un comportamento sempre rispettoso nei confronti dell'insegnante e
tollerante delle altrui esigenze, ha determinato un clima sereno e positivo.
Fin dall'inizio, tuttavia, gran parte di questi stessi alunni si è rivelata poco costante nel lavoro
domestico e quasi per nulla incline all'approfondimento personale e, nonostante le continue
sollecitazioni, si è accontentata di uno studio superficiale, più mnemonico che criticamente
rielaborato.
A ciò va aggiunta la frequenza alle lezioni che è stata discontinua sempre, ma particolarmente
nell'ultimo anno, con conseguente rallentamento del lavoro, necessità di ripetere gli argomenti,
difficoltà nell'imprimere un ritmo accettabile allo svolgimento del programma.
Tutto questo ha finito per danneggiare un gruppo, purtroppo minoritario, di studenti che ha
mantenuto, invece, un atteggiamento responsabile, ha studiato con continuità e impegno personale,
mostrando delle buone capacità e una voglia di apprendere che dispiace non aver potuto del tutto
soddisfare.
Il programma ha riguardato la Storia della Letteratura italiana dalla seconda metà dell'Ottocento –
con particolare riferimento al pensiero e all'opera di Giacomo Leopardi - alla metà del Novecento .
Limiti oggettivi di tempo hanno impedito uno studio più articolato della letteratura novecentesca
che, tuttavia, si è cercato di esemplificare nel modo più efficace a creare stimoli e curiosità per una
autonoma lettura futura. Ogni autore è stato inserito nel contesto storico-culturale coevo per
coglierne le influenze sulla produzione letteraria e operare opportuni collegamenti; sono stati letti e
analizzati di ognuno testi significativi, sia da un punto di vista formale che contenutistico.
Alla lettura del Paradiso dantesco è stata dedicata un'ora settimanale dell'orario curriculare.
Arrivati alla conclusione del lavoro si osserva che buona parte degli studenti di questa classe
possiede in Italiano una preparazione sufficiente, in linea con gli obiettivi prefissati; pochi
raggiungono un profitto più che discreto o buono; altri sono riusciti ad ottenere una preparazione
poco elaborata, appena sufficiente nei contenuti.
Per quanto riguarda la produzione scritta va sottolineata la presenza di alcuni alunni in grado di
esprimere in forma corretta e lessicalmente ricca contenuti più che discreti, talora anche buoni, sia
per ampiezza di argomentazioni, sia per capacità di approfondimento critico. Un certo numero di
studenti si è dimostrato capace di svolgere prove discrete nel contenuto, ma non sempre esemplari
da un punto di vista espressivo, altri, al contrario sanno scrivere in modo chiaro, ma difettano nei
contenuti; non manca infine qualche caso di criticità sia da un punto di vista formale che
argomentativo.
10Obiettivi disciplinari
Conoscenza sufficientemente articolata delle principali tendenze della storia letteraria dell'ultimo
Ottocento e del Novecento;conoscenza del pensiero e dell'opera degli autori più significativi, di cui
sono stati letti testi esemplari.
Conoscenza del Paradiso dantesco nelle sue strutture generali con parafrasi e commento di canti
scelti.
Saper riferire su fatti specifici e concetti inerenti gli argomenti di studio con un linguaggio
sufficientemente corretto e lessicalmente appropriato; saper parafrasare un testo, analizzarlo nelle
sue componenti tematiche e formali e inserirlo nel rispettivo contesto storico- culturale.
Saper ragionare in termini di analisi e sintesi su un testo; saper ordinare fatti e concetti in base a
rapporti logici e cronologici; rielaborare criticamente e in modo autonomo gli argomenti studiati.
Metodi e mezzi
Lezioni frontali, al fine di offrire quadri di riferimento esaurienti sugli autori e sul periodo studiato.
Letture del testo, sua analisi e commento critico adeguatamente guidato, ma sempre aperto al
confronto e alla riflessione personale
Strumenti di verifica
Scritti: Svolgimento di tracce di attualità di contenuto storico;
Analisi di un testo letterario o non letterario;
Svolgimento di tracce secondo la tipologia “Saggio breve”.Nella elaborazione del saggio è stata
richiesta la citazione di almeno la metà del materiale offerto.
Tema di attualità.
Per la valutazione delle prove scritte ci si è attenuti alle griglie d'Istituto.
Orali; Colloqui individuali che, partendo dalla lettura di un testo o di parti di esso, sua parafrasi e
commento critico, portino alla individuazione delle tematiche che sono tipiche dell'autore e lo
collocano in una data corrente letteraria.
Livello di sufficienza: comprensione delle problematiche, conoscenza adeguata dell'argomento,
accettabile competenza di lettura, spiegazione e commento del testo.
Elementi per una valutazione più alta: conoscenza approfondita dell'argomento, sicure competenze
nella lettura e spiegazione del testo;capacità di formulare giudizi, correttezza espositiva e uso di un
lessico adeguato.
Programma
Testo adottato: Luperini, Cataldi. Marchiani, Marchese : Perché la Letteratura, vv.4,5,6. Palumbo
Editore.
Di ognuno degli autori affrontati si sottintende la conoscenza della biografia, del corpus delle opere,
delle fasi del pensiero.
11GIACOMO LEOPARDI
Dallo “Zibaldone”:
– La teoria del piacere
– L'antico
– Indefinito e infinito
– Il vero è brutto
– Teoria della visione
– Parole poetiche
– Ricordanza e poesia
– Teoria del suono
– Indefinito e poesia
– Suoni indefiniti
– La doppia visione
Dalle “Operette morali”:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di Tristano e di un amico
– Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez
– Il suicidio e la solidarietà
– Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Dai “Canti”:
- L'Infinito
- La sera del di' di festa
- A Silvia
- La quiete dopo la tempesta
- Il sabato del villaggio
- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
- A se stesso
La ginestra, o il fiore del deserto.
L'ETA' POSTUNITARIA
La Scapigliatura
Emilio Praga,
da “Penombre”:
- Preludio
Igino Ugo Tarchetti,
Caratteri del romanzo scapigliato
GIOSUE CARDUCCI
Da “Rime nuove”:
- Pianto antico
- San Martino
Da “Odi Barbare”:
- Nevicata
NATURALISMO E VERISMO
Zola e il “Romanzo sperimentale”
12GIOVANNI VERGA
Dalla Prefazione all'amante di Gramigna,
- Dedicatoria a Salvatore Farina
Lettera a Salvatore Verdura sul ciclo della “Marea”
Da “Vita dei campi”:
- Fantasticheria
- Rosso Malpelo
- La lupa
Da “Novelle rusticane”:
- La roba
- Libertà
Il ciclo dei Vinti
Da “I Malavoglia”
– La prefazione ai Malavoglia
– L'inizio dei Malavoglia
– L'addio di 'Ntoni
– Mara, compare Alfio..
“ Mastro don Gesualdo”: lettura integrale
IL DECADENTISMO
Charles Baudelaire e il Simbolismo
GIOVANNI PASCOLI
Da “Il fanciullino”:
- Il fanciullino
Da “Myricae”:
- Novembre
– X Agosto
– L'assiuolo
– Temporale
– Il lampo
– Il tuono
Da “Poemetti”:
- Digitale purpurea
Da “Canti di Castelvecchio”:
- Il gelsomino notturno
Da “La grande proletaria si è mossa”:
- Il nazionalismo pascoliano.
13GABRIELE D'ANNUNZIO
Da” Alcyone”:
- La sera fiesolana
– La pioggia nel pineto
– I pastori
– Meriggio
“Il piacere” :Lettura integrale
ITALO SVEVO
“Una vita” : lettura integrale
Da “Senilità”:
- Inettitudine e senilità
- L'ultimo appuntamento di Angiolina
– La metamorfosi strana di Angiolina
–
Da “La coscienza di Zeno”:
- La prefazione del Dottor S.
- Lo schiaffo del padre
- La proposta di matrimonio
- L'addio a Carla
– La vita è una malattia
Da “L'uomo e la teoria darwiniana”
- L'elogio dell'abbozzo.
LUIGI PIRANDELLO
Da “Novelle per un anno”:
– Il treno ha fischiato
– C'è qualcuno che ride
– Tu ridi
“Il fu Mattia Pascal” (Lettura integrale)
Da“ Quaderni di Serafino Gubbio operatore “
– Le macchine e la modernità
– Il silenzio di cosa
Da “Uno, nessuno,centomila”:
- La vita non conclude.
Da “Sei personaggi in cerca d'autore”
- L'irruzione dei personaggi sul palcoscenico
Da “L'Umorismo”:
- La differenza fra umorismo e comicità
14LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE
I Poeti Crepuscolari
SERGIO CORAZZINI
Da “Piccolo libro inutile”:
- Desolazione del povero poeta sentimentale
GUIDO GOZZANO
Dai “Colloqui”:
- La signorina Felicita ovvero la felicità
I Futuristi
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
“Manifesto del Futurismo”
“Manifesto tecnico della letteratura futurista”
ALDO PALAZZESCHI
Da “L'incendiario”:
- E lasciatemi divertire!
LA NUOVA POESIA
UMBERTO SABA
Dal “Canzoniere”
- A mia moglie
- La capra
- Città vecchia
- Parole
- Teatro degli Artigianelli
– Goal
– Amai
–
GIUSEPPE UNGARETTI
Da “L'Allegria”
- Il porto sepolto
- Veglia
- S.Martino del Carso
- Commiato
- Mattina
- Soldati
- Girovago
Da “Il dolore”:
- Non gridate più
EUGENIO MONTALE
Da “Ossi di seppia”
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato
Da “La bufera ed altro”
- La primavera hitleriana
15Da “Satura”
- Ho sceso dandoti il braccio.
LA POESIA DEL '900 : Ermetismo e Antinovecentismo
SALVATORE QUASIMODO
Da “Ed è subito sera”
– Ed è subito sera
GIORGIO CAPRONI
Da “Il seme del piangere”
- La gente se l'additava
Da “Il muro della terra”
- Senza esclamativi
NARRATIVA
Il Neorealismo
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)
DANTE ALIGHIERI
Dal Paradiso:
canti:I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXI (v.105-142), XXII , XXVII (vv.1-66 e 120-148),
XXX, XXXI,XXXIII.
Prof.ssa Susanna Rosi
16PRIMA LINGUA STRANIERA: INGLESE Professoressa Stefania Zampiga
Profilo della classe
Sono stata l’insegnante della classe negli ultimi due anni di corso e ho potuto sviluppare con loro un
rapporto didattico sostanzialmente positivo. La classe nel suo insieme ha dimostrato interesse verso
la disciplina e partecipazione crescente durante le lezioni, con esiti differenziati in rapporto al
livello di ingresso e alla frequenza personali. In realtà una frequenza generale non costante - per
motivi diversi- ha inciso sul percorso comune rendendo solo possibile lo svolgimento di un
programma circoscritto. Ciò nonostante la classe, nel suo insieme, ha raggiunto un livello di
conoscenza e di competenza comunicativa soddisfacente e, in alcuni casi, eccellente. . Gli obiettivi
da me posti, rapportabili a un livello CEFR B2 sia nelle abilità ricettive che produttive, obiettivi
coerenti con quelli del PTOF di istituto e dunque con le indicazioni ministeriali e il profilo di uscita
dello studente liceale, sono stati mirati all’acquisizione dell’inglese come strumento di
comunicazione, riflessione e crescita personale nella cittadinanza europea. Il livello linguistico
raggiunto appare, pertanto, diversificato con qualche punta molto alta, una fascia medio-alta e
soprattutto media ma anche un piccolo gruppo che presenta un livello appena sufficiente. In
rapporto alle certificazioni Cambridge ci sono un C2, due C1 e 7 B2 certificati. Il resto, tranne pochi
casi, sembra attestarsi intorno al livello B2.
Lo studio della letteratura è stato inteso come sviluppo della competenza comunicativa,
arricchimento culturale oltre che linguistico e capacità di collegare testi ed eventi attraverso un
approccio tematico all'interno di un percorso sostanzialmente cronologico. Nell’ultimo anno di
corso mi sono concentrata sui nuclei essenziali dei contenuti selezionati lavorando di più sullo
sviluppo delle abilità di comprensione dei testi in programma, fatte di osservazione e riflessione,
sulla capacità di mettere in relazione le varie parti del programma e stabilire qualche collegamento
con i temi di attualità e di argomento non letterario affrontati nelle ore di conversazione con
l’insegnante madrelingua, cercando di promuovere uno sguardo consapevole e rispettoso della
diversità. L’esiguo numero di ore per la prima lingua straniera, effetto della Riforma Gelmini, mi ha
spinto, infatti, non solo a ridurre drasticamente i contenuti del tradizionale programma di letteratura,
ma soprattutto, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali, a privilegiare attività laboratoriali e
interattive basate sullo scambio e la condivisione anche di segmenti specifici del programma
assegnati a ciascuno e approfonditi con lo studio a casa.
Gli alunni sono, pertanto, in grado di identificare i temi e i messaggi presenti nei testi studiati e di
collocare il brano all’interno di un periodo storico; alcuni riescono anche a farlo con un buon uso
della meta-lingua letteraria.
Per quanto riguarda l’abilità di produrre testi orali e scritti coerenti e coesi per riferire fatti,
descrivere situazioni e sostenere le proprie opinioni con opportune argomentazioni, quasi tutti
riescono a farlo in modo per lo meno accettabile, alcuni con ottime capacità espressive e autonomia
di rielaborazione.
Competenze linguistiche e comunicative
Durante il quinto anno l’alunno/a consolida competenze linguistico-comunicative tendendo al
livello B2 del Quadro Comune Europeo sia per quanto riguarda le abilità ricettive sia per quanto
riguarda la produzione scritta o orale, migliorando l’articolazione testuale e la competenza
argomentativa.
Nello specifico l’alunno/a :
• analizza e confronta testi letterari appartenenti a epoche diversi
• comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie anche su temi di attualità (purtroppo,
per motivi succitati, sono stati appena toccati testi artistici e storici)
17• produce testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare con un accettabile livello di
padronanza linguistica
• consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una
disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali
• utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non
linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
Metodi, mezzi e tempi
Le attività svolte sono state prevalentemente di tipo comunicativo e strutturate in modo da favorire
la scoperta personale, la capacità di notare (noticing) e lo sviluppo del senso critico dell’alunno
attraverso la pratica della riflessione individuale e collettiva. Sono state usate tecniche e strategie
afferenti ai principi pedagogici del Costruttivismo partendo sempre, quindi, nella proposta di un
argomento dall’enciclopedia personale, attivando le conoscenze pregresse. Nella comprensione dei
testi scritti sono state usate strategie di predizione e anticipazione e tecniche di lettura quali
skimming / scanning e inferring con lo scopo di rendere l’alunno attivo e autonomo nella
comprensione e nell’analisi attraverso tasks predisposti dall’insegnante e/o dal libro di testo. Sono
stati usati strumenti didattici quali libri di testo con relativi audio, proiettore con accesso ad Internet,
fotocopie anche di materiali ministeriali. Alcuni moduli hanno richiesto tempi di presentazione e di
apprendimento più lunghi, soprattutto perchè sono state scelte modalità di apprendimento non
trasmissive e la presentazione dei risultati dello studio e della ricerca diversa dall’interrogazione
tradizionale; inoltre gli argomenti selezionati hanno tenuto conto di esigenze di approfondimento e
di interessi della classe, come ad esempio il tema dell’innocenza; il tema della gender parity
attraverso biografie di scrittrici dell’ 800 e relativi brani letterari; il “doppio”; l’interiorità e la sua
rappresentazione.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Come previsto nella programmazione generale del C.d.C., si è fatto ricorso ad un congruo numero
di verifiche, sia di tipo formativo che sommativo. Per quanto riguarda le prove orali esse sono state
essenzialmente resoconti su lavori personali o di gruppo, interventi in discussioni (correzione dei
compiti a casa o in classe), presentazioni individuali o di gruppo in varie forme concordate anche
con il docente madrelingua. Le prove scritte sono state somministrate sotto forma di saggi brevi
(generali/argomentativi), o risposta a domande anche per accertare la comprensione dei testi, e
simulazione della seconda prova di esame.
Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal C.d.C e dal Dipartimento Disciplinare (cfr.
Ptof). Per le prove scritte si è dato rilievo alla rispondenza dello svolgimento in relazione alla
consegna (e di conseguenza alla capacità di selezionare le conoscenze in base al quesito), alla
coerenza e coesione delle argomentazioni prodotte e infine all’appropriatezza e alla ricchezza
lessicale e alla correttezza morfo-sintattica. Nelle prove orali si è tenuto conto dei seguenti
parametri: della pertinenza degli argomenti, della coerenza e coesione dei punti comunicati, della
capacità di stabilire relazioni significative tra gli argomenti e di esprimere personali motivate, con
adeguate chiarezza e correttezza.
Nelle valutazioni periodali e finali, tali elementi sono stati integrati tenendo conto:
- della partecipazione attiva alle lezioni
- dell’assiduità nella frequenza
- dell’attenzione in classe
- degli apporti costruttivi alle lezioni
della regolarità dell’apprendimento e dello studio pomeridiano a casa
18In questo senso allego anche una griglia prodotta e discussa all’interno del dipartimento e impiegata
in via sperimentale per la correzione della simulazione della seconda prova di esame a maggio, in
quanto più vicina alle indicazioni nazionali attuali.
1. Comprensione e interpretazione Livello Punteggio
Competenza di lettura del testo: Ottimo 6
individua le informazioni rilevanti e comprende i Buono 5,5
contenuti e le intenzioni comunicative del testo. Sa Discreto 5
fare inferenze testuali. Più che sufficiente 4,5
Sufficiente 4
Insufficiente 3,5
Gravemente insufficiente 3-1
Rielaborazione formale e restituzione dei Ottimo 6
contenuti: Buono 5,5
sa esporre singole spiegazioni con i necessari elementi Discreto 5
di giustificazione. Fa uso di riformulazioni e parafrasi Più che sufficiente 4,5
(rephrasing e paraphrasing) e di sinonimi. Sufficiente 4
Insufficiente 3,5
Gravemente insufficiente 3-1
Ottimo 3
Struttura del discorso ed elementi relativi Buono/discreto 2,5
all’aspetto formale della lingua: sufficiente 2
mostra familiarità con il sistema generale della lingua insufficiente/mediocre 1,5
funzionale alla comunicazione di informazioni gravemente insufficiente 1
Ampiezza del repertorio lessicale e uso di strutture
morfosintantiche appropriate.
4 Produzione
Rispetto delle consegne e della richiesta di tipologia di Ottimo 6
testo Buono 5,5
Pertinenza, organizzazione e strutturazione degli Discreto 5
argomenti Più che sufficiente 4,5
Ricchezza e precisione di informazioni ed esempi e Sufficiente 4
presenza di commenti e valutazioni personali o di Insufficiente 3,5
collegamenti a esperienze e conoscenze personali. Gravemente insufficiente 3-1
Rielaborazione delle informazioni e coerenza e Ottimo 6
coesione nella struttura organizzativa del discorso e Buono 5,5
uso di connettivi logici appropriati e di elementi di Discreto 5
correlazione. Più che sufficiente 4,5
Sufficiente 4
Insufficiente 3,5
Gravemente insufficiente 3-1
Struttura del discorso ed elementi relativi all’aspetto Ottimo 3
formale della lingua: Buono/discreto 2,5
mostra familiarità con il sistema generale della lingua sufficiente 2
funzionale alla comunicazione di informazioni insufficiente/mediocre 1,5
Ampiezza del repertorio lessicale e uso di strutture gravemente insufficiente 1
morfosintantiche appropriate.
Totale: (A+B) /2= …./15
19Contenuti svolti
Textbook: Past & Present ( Culture, Language, Literature, Competences), Black Cat
Modulo 0:
Let’s start from the end, The Final Exam
Seconda Prova Scritta: Tracce Esame di Stato L104 Liceo Linguistico 2017
a. Strategie di approccio al testo letterario: Nadine Gordimer, excerpt from The Ultimate Safari,
Esame di Stato 2017; from textbook pp B 157-161; from YouTube, Nadine Gordimer reads
excerpts from The Ultimate Safari ( first 10 minutes)
(Introduzione all’analisi del testo: Narrator, Point of view, Characters, Setting, Themes)
Biographical notes B 156
The History Box B 117 The European Powers in Africa
b. Attualità, from Esame di Stato 2017, testo su povertà nelle scuole americane; sviluppo con
dibattito su povertà e istruzione in Italia.
c. Storico-sociale from Esame di Stato 2017, The case for gender parity; sviluppo con ricerche di
gruppo su 19th Century Women Writers- Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, Jane Austen, Emily
Bronte, Charlotte Bronte, Elizabeth Barret Browning, Emily Dickinson, sui temi di a.
Upbringing/education b. personality c. thought d. A detail of the biography especially connected
with gender e. An example of a relevant work f. Relevance today.
d. Artistico. Art criticism, from Encyclopedia Britannica.
Modulo 1
Innocence
William Blake, Infant Joy, DB expansions (photocopy)
Infant Sorrow, DB expansions (photocopy)
Bitesizes on Poetry (photocopy)
Mary Shelley, from Frankenstein, 1818, A284-9. a. The Creation b. Farewell
extensive viewing: Everything you need to know to read "Frankenstein" - Iseult Gillespie (ted-ed
Video)
Historical Coordinates: Voices from Within: Early Aesthetic Moves, The Nature of Poetry, The
Poetry of Nature, Developments of Romantic Poetry, The Novel in the Romantic Period, pp A227-
31
Modulo 2
Forms of Love
Emily Bronte, from Wuthering Heights, 1847 pp A 292-300
extensive viewing: TRAILER (2012) - Sundance Movie HD
Wuthering Heights - I'm Heathcliff (HD)1992
extensive listening: Kate Bush, Wuthering Heights Lyrics, (youtube)
Charlotte Bronte, from Jane Eyre, 1847 pp A 328-335
extensive viewing: equivalent film clip of the first passage
Emily Dickinson, Wild Nights 1861, pp A368-9
extensive viewing: Jane Eyre fairy tale and realism ( British Library video)
Extensive viewing, (Teachers tv) The Victorian workhouse.
20Modulo 3
Public and private selves
Robert Louis Stevenson, from The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde. 1886 , pp A372-8
Chapter 10, The Duality of Man
The transformation. (photocopy)
O. Wilde, from The Picture of Dorian Gray, A New Hedonism. 1891, pp A358-60
Historical Coordinates of the Victorian Age: pp a 315-22
Modulo 4
Inner lives
James Joyce, Eveline, from Dubliners 1914 , pp b41-47
Virginia Woolf, extracts from Mrs Dalloway 1925, pp b 31-40
from A Sketch from the Past, 1939 (photocopy)
From Three Guineas, 1938 (photocopy)
*Sigfrid Sassoon, They, 1966 pp b 65-6
*Samuel Beckett, Waiting for Godot, 1952, pp b 90-3
extensive viewing: Mrs Dalloway: exploring consciousness and the modern world
Clip from 1997 homonymous film: Septimus Warren Smith
Historical coordinates of the first half of the 20th Century, pp b 2-7
Modulo 5
Current political affairs
From Jacobin, David Broder, Italian Terrible Alternatives (photocopy)
https://jacobinmag.com/2018/01/italian-election-berlusconi-five-star-movement
from Gandhi’s Quit India Speech p b 170
from Martin Luther King’s I have a Dream
a) From The Never Again Movement speech
b) Historical Coordinates: Capitalism and Globalisation, b124
(Parti marcate da *: ipotizzate entro la fine dell’anno)
Letture Estive individuali (scelta)
Mary Shelley , Frankenstein – The Modern Prometheus
Emily Bronte, Wuthering Heights
Charlotte Bronte, Jane Eyre
R.L.Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyl and Mr Hyde
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
James Joyce, Dubliners
Virginia Woolf, Mrs Dalloway
E. M. Forster, A Passage to India
George Orwell, 1984
Samuel Beckett, Waiting for Godot
Jeanette Winterson, Why Be Happy when you can be Normal
21Relazione finale Docente
Prof.ssa : Aurélie Paris
Materia : Lingua e cultura francese
Classe : 5BL
A.S. 2017 – 2018
Profilo della classe
Ho iniziato a lavorare con questa classe solo dall’inizio di questo anno scolastico, riscontrando sin
da subito un livello di preparazione non adeguato ad una classe quinta tranne qualche eccezione. Mi
sono quindi attivata per proporre numerose attività miranti a colmare il più possibile le lacune
linguistiche (grammaticali e lessicali) diffuse, arricchire e potenziare la competenza linguistica e
culturale e migliorare il metodo di studio. Tuttavia l’interesse e la motivazione allo studio sono stati
altalenanti e non sempre adeguati per un buon numero di alunni e questo ha reso difficile lo
svolgimento del programma che in effetti è stato adattato al livello della classe. Al termine dell'anno
scolastico gli alunni si possono differenziare in tre gruppi: un primo gruppo, composto da poche
alunne molto motivate che possiedono un’ottima conoscenza della lingua; un secondo gruppo,
formato da alunni che hanno acquisito una discreta motivazione e conoscenza della lingua; un terzo
e più numeroso gruppo con una conoscenza della lingua fragile e poco interessato alla materia. La
maggior parte degli alunni, a causa delle fragili basi linguistiche, ha privilegiato lo studio
mnemonico, cosa che non sempre ha dato loro sicurezza, sia nell’esposizione orale che in quella
scritta. Le poche alunne con solide basi linguistiche hanno rinforzato le capacità di analizzare un
testo o un argomento proposto, sanno collegare testi e argomenti di autori e epoche diverse, sanno
affrontare una conversazione su questi senza studio mnemonico. Alla luce di quanto esposto si
evince che permangono in alcuni difficoltà più o meno evidenti per quanto concerne la correttezza
morfo-sintattica degli enunciati, ed anche il lessico non sempre risulta adeguato agli argomenti
proposti.
Durante il primo trimestre ho lavorato sulla lingua e su argomenti legati al mondo contemporaneo.
Il pentamestre invece è stato dedicato prevalentemente allo studio della letteratura. Diversi studenti
non hanno sempre seguito le lezioni con regolarità e le loro frequenti assenze hanno avuto
conseguenze negative sia sul proprio andamento scolastico che su quello della classe. Inoltre questi
alunni non hanno sempre avuto un comportamento adeguato alle diverse situazioni e risposto
positivamente agli stimoli ricevuti; anche questo ha rallentato notevolmente lo svolgimento del
programma.
Durante le ore di lavoro con la docente madrelingua gli studenti hanno svolto esercitazioni scritte e
orali relative a testi di vario genere, su cui hanno lavorato individualmente a casa e che sono stati
corretti in classe, offrendo numerosi spunti per l’approfondimento lessicale e grammaticale. E' stato
inoltre svolto un modulo CLIL di storia dell'arte in francese sull'Impressionismo.
Raggiungimento degli obiettivi
Per quanto concerne le competenze generali disciplinari, faccio riferimento a quanto enunciato nel
POF del liceo e al “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” (QCER); l’obiettivo
perseguito durante l’anno scolastico corrisponde al Livello B1+ del Quadro europeo, adattato al
livello della classe:
comprende argomenti familiari ed le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti del proprio settore di specializzazione. Sa interagire con relativa
scioltezza in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la
lingua. E’ in grado di produrre un testo relativo ad un’ampia gamma di argomenti e di
22esprimere la propria opinione motivata.
Le competenze minime sono le seguenti:
riesce a comprendere e utilizzare espressioni di tipo quotidiano e settoriale. Sa produrre testi orali
e scritti su argomenti personali e di settore, se formulati in maniera semplice.
Inoltre, sono stati perseguiti gli obiettivi stabiliti per la classe a livello interdisciplinare.
Metodologie didattiche
Ho usato un approccio metodologico il più possibile comunicativo, basato su una lingua funzionale
ai vari contesti, con spiegazioni e possibilità di interazione all’interno di un dialogo. Ciò nell’ottica
di favorire una sempre più ampia autonomia da parte degli allievi.
Sono stati necessari anche ripassi grammaticali o lessicali, ma sempre contestualizzati; ho fatto
ricorso anche alla proiezione di brevi video e alla distribuzione di fotocopie ad integrazione e
supporto di aspetti socio-culturali affrontati in letteratura.
L’analisi del testo letterario è stata affrontata con l’obiettivo di preparare gli studenti, tramite
esercitazioni orali e scritte, ad un’espressione consapevole, che tenga conto anche dell’aspetto
critico e dell’espressione di opinioni documentate.
Materiali didattici e spazi utilizzati
Per conseguire gli obiettivi si sono utilizzati:
- i testi in adozione
- fotocopie
- sussidi audiovisivi.
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione
Durante il processo di apprendimento, sono state svolte delle prove formative, sotto forma di
esercizi o di relazioni su argomenti affrontati al fine di ottenere indicazioni utili per verificare le
tappe del processo di apprendimento e l’efficacia del lavoro proposto.
Inoltre, sono state svolte numerose prove sommative, scritte e orali, per la verifica e la valutazione
delle competenze acquisite.
I criteri di valutazione sono da distinguersi per lo scritto e per l’orale:
Valutazione prova scritta: pertinenza (conoscenza e contenuti)
competenze linguistiche (correttezza formale e lessicale)
capacità di analisi del testo e sintesi concettuale
capacità di elaborazione e valutazione
Valutazione prova orale: pronuncia ed intonazione
scelta lessicale
correttezza lessicale e formale
capacità di comprensione
capacità di sostenere una conversazione a livello letterario.
La valutazione si è basata sulle griglie di valutazione previste nel POF.
23Contenuti disciplinari
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
Libro di testo: Marie Christine Jamet, Avenir 2, Anthologie culturelle de la langue française (du
XIXe siècle à nos jours), Valmartina DEA scuola 2014.
Programma svolto fino al giorno 4 maggio 2017 :
L'Union Européenne
– La Journée européenne des langues
– Les pays de l'UE, les symboles de l'UE
– La zone Euro
– Les institutions européennes et leur fonctionnement
– Programme Erasmus: analyse de l'affiche du film “L'auberge espagnole” di C. Klapisch
(2002)
Contexte historique de la fin du XVIIIè et de la première moitié du XIXè siècle
Le préromantisme français
- François-René de Chateaubriand, René, « L'étrange blessure », p. 26
- François-René de Chateaubriand, Le Génie du Christianisme, « Vague à l'âme », p. 27
- Madame de Staël, De l'Allemagne, « L'alliance de l'homme et de la nature », p. 33
- Comparaison entre romantisme et classicisme, p.41
Le Romantisme
- La poésie romantique
- Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques, « Le Lac », pp.44-45
- Victor Hugo, Les Orientales, « Clair de Lune » p. 67
- Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, « Une larme pour une goutte d'eau », p. 71
- Le roman durant la période romantique
- Le théâtre romantique (brève introduction, caractéristiques, Préface de Cromwell)
Entre Romantisme et Réalisme
- Honoré de Balzac, Le père Goriot, « L’odeur de la pension Vauquer », p. 83
- Honoré de Balzac : son œuvre, son style, ses influences
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, « Un père et un fils », p.91
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, « Combat sentimental », pp.92-93
- Visionnage de certaines scènes du film « Le Rouge et le Noir » de J.-D. Verhaeghe (1997)
et analyse de l'adaptation de l'oeuvre de Stendhal au cinéma
- Le Beylisme et le héros stendhalien
- Gustave Flaubert, Madame Bovary, « Lectures romantiques et romanesques » p. 143
- Gustave Flaubert, Madame Bovary, « J'ai un amant », pp. 148-149
- Le Bovarysme, le style de Flaubert
- Visionnage du film « Madame Bovary » de C. Chabrol (1991) – Analyse de l'adaptation
cinématographique des scènes étudiées en classe
24Puoi anche leggere