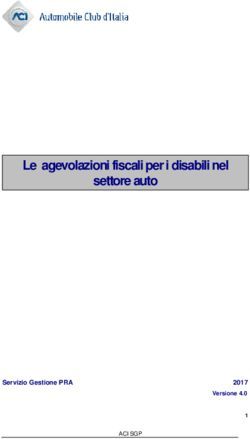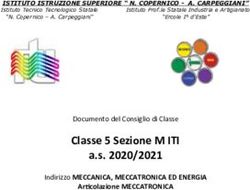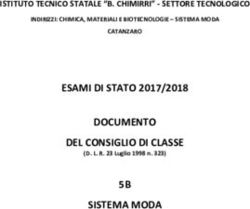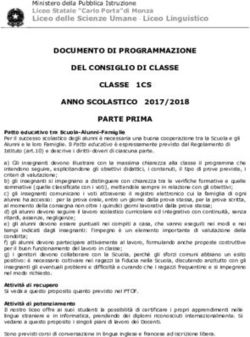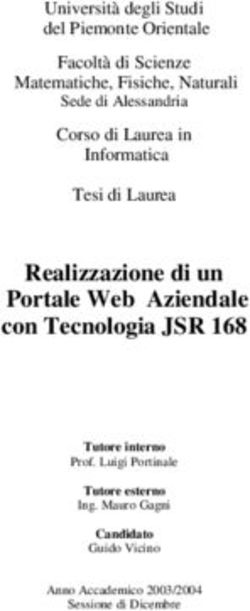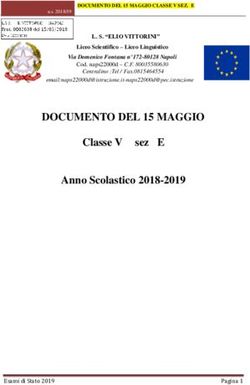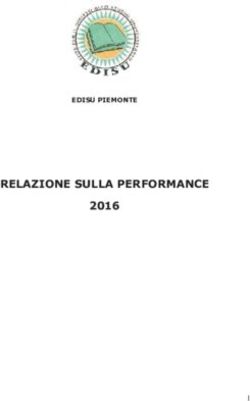DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE II A - Anno scolastico 2019/2020 - Roma, 12 Ottobre 2019 - Liceo Montale
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Anno scolastico 2019/2020
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
DEL CONSIGLIO DELLA
CLASSE II A
Roma, 12 Ottobre 2019A.S. 2019/2020
Documento Programmatico del Consiglio della classe II A Indirizzo Classico
a cura della Coordinatrice: Prof.ssa Maria Cristina Zerbino
1. Programmazione generale della classe
2. Programmazioni individuali
Composizione del Consiglio:
Barbarulo Maria Vittoria (Scienze naturali)
D’Angelo Flavia (Religione)
Ferrara Rita (inglese)
Giannini Marina (italiano e geostoria)
Pasquini Rita (Matematica)
Manganelli Manuela (Educazione fisica)
Zerbino Maria Cristina (Latino e Greco)Programmazione generale del Consiglio di Classe
Premessa
La presente programmazione fa riferimento al quadro delle competenze delineato nella
nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea (22 Maggio 2018) relativa alla
definizione delle “competenze-chiave per l’apprendimento permanente” in cui il concetto di
competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, e
l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone,
situazioni”.
Per quanto riguarda le competenze in uscita alla fine del primo biennio, si fa riferimento agli
assi culturali che raggruppano trasversalmente le varie discipline
(https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf)
sintetizzati nella seguente tabella::
COMPETENZE ALL’USCITA DEL BIENNIO
Asse dei linguaggi
N.1: Strumenti espressivi e argomentativi
“Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
Tutte le materie
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti”
N.2: Lettura, comprensione, interpretazione
Tutte le materie
“Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo”
N. 3: Produzione di testi
“Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi Tutte le materie
comunicativi”
N.4: Lingua straniera: inglese
Inglese e le altre discipline
“Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e
in CLIL
operativi”
N. 5: Arte e letteratura
St. Arte Latino Greco
“Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
Italiano Geostoria
consapevole del patrimonio artistico e letterario”
N. 6: Testi multimediali
Tutte le materie
“Utilizzare e produrre testi multimediali”
Asse matematico
N.7: Tecniche di calcolo
“Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e Matematica
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica”
N. 8: Figure geometriche
“Confrontare e analizzare figure geometriche individuando Matematica
invarianti e relazioni”
N. 9: Soluzioni di problemi Matematica, scienze, tutte
“Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi” le materie in problemsolving
N. 10: Analisi dei dati
“Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e Matematica, scienze, tutte
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni le materie nell’uso di dati
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le statistici
potenzialità offerte da strumenti specifici di tipo informatico”
Asse scientifico-tecnologico
N. 11: Fenomeni naturali e artificiali
“Osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla
Scienze
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità”
N. 12: Trasformazioni di energia
“Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati Scienze
alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza”
N. 13: Applicazione delle tecnologie
Scienze, geostoria e tutte le
“Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
discipline su questo tema
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate”
Asse storico-sociale
N. 14: Epoche storiche e aree geografiche
Latino Greco Arte Geostoria
“Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
e tutte le discipline nella
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
loro dimensione storico-
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche
culturale
e culturali”
N. 15: Individuo, società e ambiente
Geostoria e, sullo specifico
“Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
tema, italiano latino greco
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione,
st. Arte
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente”
N. 16: Sistema economico e produzione
“Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
Geostoria
socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio”
Il Consiglio di Classe opera quindi in vista dei seguenti Obiettivi
Conoscenze:
• Conoscenza dei dati fondamentali e dei concetti di base del processo storico, culturale,
scientifico
• Conoscenza specifica dei contenuti dei programmi delle singole discipline
• Conoscenza delle procedure necessarie all’impostazione e risoluzione dei problemi
• Conoscenza di criteri di priorità
• Conoscenza delle terminologie specifiche
Competenze
• Adoperare manuali e testi e capirne l’organizzazione logica
• Contestualizzare i fenomeni ed elaborare le conoscenze in forma organica e critica
• Documentare in forma scritta, grafica e/o pratica il lavoro svolto• Dimostrare la padronanza delle lingue italiana e straniera • Formalizzare i termini esatti di un problema, utilizzando il linguaggio specifico pertinente • Valutare gli elementi essenziali in una situazione problematica e utilizzarli per la costruzione di un modello risolutivo • Attualizzare le conoscenze • Utilizzare gli strumenti informatici Bisogni di competenza • Capacità di selezionare e classificare informazioni • Capacità di sintesi • Capacità linguistico-espressive • Capacità logico-interpretative • Capacità critiche e di rielaborazione • Capacità di inserirsi in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo contributo • Capacità di individuare gli elementi costitutivi di un evento, di un problema, di un testo, evidenziandone i rapporti Il Consiglio di Classe opera altresì in vista dei seguenti obiettivi comportamentali: • Sapersi integrare attivamente nel gruppo della classe • Saper entrare in relazione con l’insegnante • Rispettare le regole, l’ambiente e i beni comuni • Rispettare le diversità sociali, sessuali, ideologiche, intellettive etc. Contenuti Per i contenuti delle singole discipline si rimanda alle programmazioni individuali dei docenti. Metodi Per la didattica delle varie discipline saranno utilizzate le seguenti metodologie: • Lezione frontale • Lezione dialogata • Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione • Metodologie miranti a una Didattica inclusiva (Lavori di gruppo; apprendimento cooperativo, educazione tra pari) • Lettura diretta, analisi e contestualizzazione di testi (letterari, scientifici, iconografici) • Esercitazioni in classe e a casa • Esperienze di laboratorio • Pratica e avviamento all’attività sportiva Mezzi Nella didattica saranno utilizzati dai vari docenti i seguenti mezzi: - Libri di testo - Fotocopie di materiale didattico - Audiovisivi - Computer di classe, LIM e Tablet - Attrezzi e attrezzature sportive disponibili nella scuola
Spazi
Gli spazi di realizzazione della didattica sono i seguenti:
- Aule della sede centrale
- Aula 3.0
- Laboratorio di Informatica e multimediale
- Laboratorio Linguistico
- Sala Audiovisivi e Biblioteca
- Palestra
Tempi
Per il numero di ore utilizzate per lo svolgimento delle unità didattiche o dei moduli nelle
singole
discipline si rimanda alla programmazione dei docenti
Criteri di valutazione
Per la valutazione del rendimento generale degli alunni saranno utilizzati i seguenti criteri:
• Considerazione dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione, nonché della regolarità
nella frequenza e nell’applicazione
• Conoscenza dei temi e dei contenuti proposti
• Correttezza espositiva
• Padronanza delle categorie specifiche
• Capacità di comunicare in modo logico ed organico
• Capacità di rielaborazione autonome e personale
Per ulteriori criteri specifici si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti
Criteri di sufficienza (in relazione agli obiettivi minimi)
Per l’attribuzione agli alunni di una valutazione sufficiente saranno considerati i seguenti
livelli minimi:
• Considerazione dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione, nonché della regolarità
nella frequenza e nell’applicazione
• Conoscenza appropriata dei temi e dei contenuti proposti
• Esposizione lineare e generalmente corretta
• Capacità di formulare dei collegamenti, anche se guidati
Verifiche
Le tipologie di verifica utilizzate dai professori sono le seguenti:
- Verifiche orali
- Verifiche scritte
- Verifiche multimediali (con l’ausilio del tablet o dei computer della scuola)
- Lavori di gruppo
- Discussioni aperte all’intera classe
- Verifiche delle attività di palestra e sportive
Attività para ed extra-curriculari
· Progetti in collaborazione con il Bibliopoint “Il Girasole del Montale”, l’Ente
Biblioteche di ROma e il Centro per il Libro e la Lettura:(“Libriamoci” settimana di lettura ad alta voce nelle scuole Novembre 2019; “Il Maggio dei libri”) · “Il Montale per l’Africa” - Attività collaborazione con l’associazione Schola Mundi · Commemorazione 27 gennaio (giorno della memoria) · Viaggio di istruzione · Visite guidate a siti archeologici e museali · Partecipazione a rappresentazioni teatrali · Partecipazione a proiezioni cinematografiche anche nell’ambito della Mostra del Cinema di Roma · Progetto “Imparara a imparare” · Corso di lingue pomeridiano · Laboratorio teatrale · Concorsi letterari del liceo “Montale” · Olimpiadi sportive del liceo “Montale” e attività di Orienteering · Corso di pittura Seguno programmazioni delle singole discipline.
Programmazione didattica classi 1°A-2°A-1°M- 2°M
Docente Manuela Manganelli- AS 2019-2020
LINEE GENERALI E COMPETENZE
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, naturale proseguimento della scuola
secondaria di primo grado, costituisce un prezioso contributo alla formazione dello
studente, veicolando l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive,
emotive, sociali, patrimonio indispensabile per una crescita sana ed armonica della persona.
Superando la vecchia dicotomia corpo-mente le rinnovate Scienze Motorie e Sportive si
propongono come elemento essenziale per lo sviluppo integrale del giovane, attraverso
esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità nuove, che diventano patrimonio
personale dell’alunno.
L’insegnamento dell’Educazione Fisica sarà presente all’interno del curricolo liceale per un
monte ore complessivo di 330 ore nel quinquennio , corrispondente a 66 ore annuali,
ovvero 2 ore settimanali.
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà:
1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una
personalità equilibrata e stabile;
2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;
3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e
l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari;
4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra
valorizzando le attitudini personali;
5. Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.
6. Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in
ambito sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano
stile di vita.
7. Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei
diversi ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e
come momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali
corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro.OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
PRIMO BIENNIO
Nel primo biennio, dopo aver verificato i livelli di apprendimento conseguiti nel corso del
primo ciclo dell’istruzione, sarà dedicato un percorso didattico specifico atto a colmare
eventuali lacune, e a definire e ampliare negli studenti le capacità coordinative e
condizionali per permettere loro di realizzare schemi motori complessi che possano
permettergli di affrontare diverse attività motorie e sportive.
Sono stati identificati quattro nuclei fondanti nell’ambito dei quali sono state individuate le
competenze e le relative conoscenze e abilità da raggiungere.
CORPO, SUA LA PERCEZIONE GIOCO, GIOCO-SPORT SICUREZZA E SALUTE
ESPRESSIVITA’ E SENSORIALE, E SPORT
NUCLEI FONDANTI: CAPACITA’ MOVIMENTO, SPAZIO-
CONDIZIONALI TEMPO E CAPACITA’
COORDINATIVE
Svolgere attività Utilizzare gli stimoli Conoscere e Conoscere il proprio
motorie adeguandosi percettivi per praticare in modo corpo e la propria
ai diversi contesti ed realizzare in modo corretto ed condizione fisica, le
esprimere le azioni idoneo ed efficace essenziale i norme di
COMPETENZE: attraverso la l’azione motoria principali giochi comportamento per
gestualità richiesta sportivi e sport la prevenzione di
individuali infortuni e del primo
soccorso .
Conoscere i principi
fondamentali di
Conoscere il proprio Conoscere il sistema
prevenzione ed
corpo, la sua delle capacità motorie Conoscere gli aspetti attuazione della sicurezza
funzionalità e le capacità coordinative, che essenziali della personale in palestra e
CONOSCENZE condizionali; riconoscere sottendono la terminologia, negli spazi aperti.
la differenza tra prestazione motoria e regolamento e tecnica
movimento funzionale sportiva. degli sport; Conoscere gli elementi
ed espressivo. fondamentali del primo
soccorso e della
alimentazione.
Percezione, Consapevolezza di una
consapevolezza ed risposta motoria efficace
elaborazione di risposte ed economica. Praticare in modo
motorie efficaci e essenziale e corretto Adottare un sano stile di
ABILITA’ personali in situazioni Organizzare la fase di dei giochi sportivi e vita.
semplici. Assumere avviamento e di degli sport individuali.
posture corrette a carico allungamento muscolare
naturale. in situazioni semplici.
Applicare le norme di
un corretto Assumere
Saper riconoscere ed
Rispetto delle regole, comportamento comportamenti funzionali
esprimere in modo
COMPORTAMENTO delle persone e sportivo in ambito alla sicurezza in palestra,
corretto le proprie
dell’ambiente. scolastico (fair play). a scuola e negli spazi
tensioni emotive.
aperti.OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI DEL PRIMO BIENNIO
(Profilo in uscita)
Al termine del primo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di:
● Tollerare un lavoro per un tempo prolungato.
● Vincere resistenze a carico naturale.
● Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile.
● Sviluppare un controllo segmentario del proprio corpo.
● Svolgere compiti motori in situazioni anche inusuali, tali da richiedere la conquista, il
mantenimento ed il recupero dell’equilibrio.
● Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra ed uno
individuale.
● Acquisire una conoscenza progressiva del proprio corpo e la sua funzionalità.
● Essere in grado di realizzare un semplice avviamento e relativa fase di allungamento
muscolare di una lezione.
● Acquisire coscienza rispetto ai problemi legati all’ecologia ed adottare stili di vita che
contribuiscano alla salvaguardia dell’ambiente
● VERIFICHE E VALUTAZIONI
● Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto
tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via
appreso nel curricolo. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di
evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo, l’efficacia del processo
didattico attuato.
● Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta
un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata
esclusivamente per contenuti. Il passaggio da un modello formativo tradizionale a un
sistema basato su unità capitalizzabili (quindi su una formazione centrata sulle
competenze) implica il riferimento a modelli progettuali orientati alla flessibilità ed
alla modularità dell’offerta formativa.
ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRACURRICOLARE
● Per quanto riguarda le attività extracurricolari si proseguirà con l’attività del Centro
Sportivo Scolastico secondo le indicazioni del M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale.
● Il raggiungimento di rilevanti prestazioni e/o la partecipazione assidua alla suddetta
attività verrà tenuta in considerazione nella valutazione finale dell’alunno.Griglia di valutazioni
descrittori Gravemente insufficiente sufficiente discreto buono Ottimo- eccellente
insufficiente
1-4 4-5 6 7 8-9 9-10
Conoscenze Inesistenti o Imprecise e Sostanzialmente Organiche e Approfondite, Molto approfondite,
teoriche molto scorrette e frammentarie corrette, ma chiaramente esposte espresse con frutto di un percorso
( anche per lacunose superficiali, terminologia individuale di ricerca e
studenti terminologia non appropriata rielaborazione critica,
esonerati e con appropriata terminologia
disabilità appropriata
motorie), uso del
linguaggio tecnico
specifico.
In particolare per Si distrae e crea Si distrae e segue in Segue la lezione Segue la lezione senza Segue Collabora sempre con
gli studenti con disturbo, si rifiuta modo discontinuo la passivamente, parteciparvi costantemente la un contributo attivo e
disabilità motorie, di collaborare lezione. Non è in risponde alle richieste attivamente, risponde lezione, collabora propositivo;
esonerati, anche quando grado di collaborare senza convinzione , alle richieste senza con il docente nei interagisce con i
esonerati vengono affidate nei compiti di giuria non sempre collabora prendere iniziative, compiti di giuria compagni nella
temporanei e semplici mansioni ed arbitraggio nei compiti di giuria collabora comunque ed arbitraggio gestione delle
giustificati. ed arbitraggio nei compiti di giuria squadre in fase di
ed arbitraggio gioco utilizzando un
linguaggio tecnico e
tattico
Impegno e Scarso e progressi Saltuario e progressi Limitato, progressi Costante con Costante e Serio e costruttivo,
progressi nel insignificanti incostanti settoriali apprezzabili progressi collaborativi, notevoli progressi
rendimento evidenti progressi
( anche per
disabili ed
esonerati)
Capacità Scarsa Schemi motori poco Sufficienti capacità Livello adeguato sia Ben strutturati gli Capacità coordinative
coordinative coordinazione efficaci, le capacità coordinative e per quanto riguarda schemi motori, ottime. Applicazione
generale, schemi coordinative non raggiungimento gli schemi motori che efficaci e autonoma, versatile e
motori incompleti consentono il almeno in parte degli per le capacità autonome le creativa degli schemi
e inadeguati, non completo obiettivi minimi coordinative, pur con applicazioni nella motori di base
ha raggiunto gli raggiungimento qualche limite pratica motoria
obiettivi minimi degli obiettivi nell’efficacia
previsti minimi applicativa
Capacità Scarsa capacità di Limitata capacità di Sufficiente capacità di Discreto, anche se Buone-ottime Completa
condizionali sopportare sopportare carichi sopportare carichi di non omogeneo, prestazioni preparazione atletica
minimi carichi di di lavoro e non lavoro con sviluppo di tutte le atletiche pur con perfomance di
lavoro raggiungimento raggiungimento degli capacità condizionali limitatamente ad elevato livello
degli obiettivi obiettivi minimi alcune capacità
minimi previsti condizionali
Competenze di Estraneità, Mancanza di Partecipazione al Partecipazione attiva, Partecipazione Partecipazione
cittadinanza: disturbo, collaborazione, dialogo educativo ruolo aggregante, vivace e propositiva e
partecipazione, mancanza di passività, scarso discontinua e non rispetto diligente delle produttiva, ruolo costruttiva, ruolo
ruolo nella rispetto delle rispetto delle regole sempre adeguata, regole aggre- gante e trainante, rispetto
socializzazione, regole e dei e dei compagni. collaborazione responsabile, maturo e responsabile
rispetto delle compagni. occasiona le con i rispetto delle regole
regole e dei compagni, alter no consapevole delle
compagni rispetto delle regole regole
Partecipazione ai nullo nullo nullo apprezzabile determinante encomiabile
G.S.S. e attività
parascolastichePIANO DI LAVORO DI SCIENZE NATURALI
classe 2A
Prof.ssa Maria Vittoria Barbarulo
A. OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il primo biennio dei licei ex Riforma Gelmini 2008
prevedono:
«Lo studio della Chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni
semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi
tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni;
la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e
composte) e le relative definizioni operative; le leggi fondamentali e i modelli atomici, la
formula chimica e i suoi significati, il sistema periodico.
Per le Scienze della Terra il completamento e l’approfondimento dei contenuti già in
precedenza acquisiti, ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si
procede, successivamente, allo studio geomorfologico di strutture che costituiscono la
superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari eccetera).
Per la Biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi
viventi, con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse
forme con cui si manifestano (biodiversità). La varietà dei viventi e la complessità delle loro
strutture e funzioni introducono allo studio dell’evoluzione e della sistematica, della
genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente, nella prospettiva della
valorizzazione e mantenimento della biodiversità.»
Obiettivi minimi (elaborati dal Dip.to Scientifico del Liceo Montale per il secondo anno)
● Struttura atomica (modello quanto meccanico) configurazioni elettroniche, legami (con
ibridazione degli orbitali) e interazioni deboli (legami a H, tutte le interazioni deboli),
passaggi di stato, leggi dei gas (concetto di mole), stato solido (sistemi cristallini), stato
liquido (soluzioni, concentrazioni, proprietà colligative)
● Litosfera (minerali e rocce)
● Biomolecole - Viventi: classificazione e caratteri distintivi - La cellula,
procariote/eucariote, autotrofa / eterotrofa - Metabolismo: generalità su respirazione
(aerobia anaerobia) e fotosintesi - Divisione cellulare: mitosi e meiosi
A. COMPETENZE DI DISCIPLINA (anche in riferimento alla definizione degli assi culturali)
● riconoscere il linguaggio della disciplina scientifica ed utilizzarlo in modo corretto (unità
di misura, simbologia, convenzioni, rappresentazioni cartesiane di funzioni)
● definire la cellula dal punto di vista molecolare e descrivere il metabolismo cellulare
● individuare ed illustrare i processi evolutivi
● raccogliere dati attraverso la consultazione di testi cartacei ed elettronici, organizzarli e
utilizzarli
● interpretare un fenomeno naturale dal punto di vista degli scambi e delle trasformazioni
di energia
B1. COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA (elaborate dal Dip.to Scientifico del Liceo
Montale per il biennio)● saper riconoscere i fenomeni naturali mediante una loro osservazione, analisi e
descrizione
● riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
● individuare una risoluzione possibile di un problema
● distinguere tra opinioni e interpretazioni personali ed evidenze scientifiche
● padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbali nei contesti scientifici
● collaborare e partecipare in ambiente scientifico
● agire in modo autonomo e responsabile nell’organizzazione e pianificazione di un lavoro
B. STRUMENTI, METODI E STRATEGIE
Premessa - Lo studio viene presentato come fonte di crescita e sviluppo individuale, di
senso del dovere e di dignità, anche negli insuccessi, e di divertimento culturale. Si opera
con metodi costruttivisti e facendo ricorso, nei casi in cui sia possibile, ad una costante
sperimentazione, per consentire di raggiungere buoni livelli nell’acquisizione dei concetti
scientifici proposti.
● libri di testo
Atkins e Jones LA CHIMICA DI ATKINS - Zanichelli ed.
Sadawa et al. BIOLOGIA BLU - Zanichelli ed.,
● articoli tratti da quotidiani, riviste scientifiche di divulgazione e specialistiche
● materiali della biblioteca personale della prof. Barbarulo e della scuola
● diapositive, cassette audio e video, CD ROM, lavagna interattiva multimediale LIM e
risorse Internet
● reperti, campioni e modelli del gabinetto scientifico scolastico
● lezioni in aula, nei laboratori di Chimica e di Informatica
● lezioni secondo la metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning, con
argomenti scelti nella prospettiva Teaching Science through English, concordati con
l’intero Consiglio della classe IIA
D. PROVE PER LA VERIFICA DELL’APRENDIMENTO, VALUTAZIONI E RELATIVI CRITERI
Per verificare il processo di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti da
parte degli alunni saranno privilegiate le prove orali, in forma di interrogazioni brevi e
colloqui; talvolta, potranno essere predisposte dal docente prove scritte strutturate,
semistrutturate ed aperte, e potranno essere richieste relazioni di attività straordinarie, sia
individuali, sia realizzate in gruppo.
Gli alunni con disturbi specifici nell’apprendimento - DSA, in accordo con la Legge 8 ottobre
2010 n. 170, svolgeranno prove di verifica differenziate, caso per caso in base al PDP, per
tipologia e dimensione in base all’adozione di misure dispensative e potranno utilizzare
strumenti compensativi
La valutazione è formulata in base ai criteri della tabella 1:
● nel I quadrimestre sulle interrogazioni e sui compiti scritti svolti fino al 17 gennaio 2020
● nello scrutinio di fine anno, sull'insieme di tutte le prove effettuate nel corso dell'intero
anno scolastico, con particolare attenzione alla progressione (rispetto al livello iniziale di
conoscenze) ed ai risultati del II quadrimestre; dal 29 maggio 2020 avranno luogo prove
orali destinate all’accertamento di conoscenze e competenze attraverso l’intero
programma svolto.Ulteriori elementi utili per la valutazione potrebbero essere forniti dalla Prova d’Istituto per
classi parallele.
Rilievo particolare è attribuito alla serietà, alla responsabilità ed al rispetto mostrati
dall’alunno verso l’Istituzione scolastica, nei confronti del docente e inter pares.
TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI
livello valutazione indicatore principale
insufficientePiano di lavoro di Italiano - classe 2A
Anno Scolastico 2019/2020
Prof. Marina Giannini
FINALITA’
Fare acquisire agli alunni la padronanza della lingua italiana nella sua
varietà.
Favorire l’affinamento della capacità di usare la lingua in maniera corretta, chiara e
articolata
(sia orale che scritta), in relazione alle diverse funzioni comunicative, con conseguente
arricchimento del patrimonio lessicale anche attraverso il confronto con le altre
lingue.
OBIETTIVI
Abilità linguistiche:
COMUNICAZIONE ORALE
ASCOLTO: Sviluppo della consapevolezza dei processi comunicativi.
PARLATO: Potenziamento della competenza linguistica. Organizzare il proprio discorso, tenendo
conto delle caratteristiche del destinatario, delle diverse situazioni comunicative e delle diverse
finalità del messaggio.
LETTURA
a) Nella lettura silenziosa lo studente deve sapere:
Compiere letture diversificate, nel metodo e nei tempi, in rapporto a scopi diversi, quali la ricerca
di dati e informazioni, la sommaria esplorazione, la comprensione globale, l’uso del testo per lo
studio. Saper individuare le strutture e le convenzioni proprie dei diversi tipi di testo; integrare le
informazioni del testo con quelle fornite da altre fonti.
b) Nella lettura a voce lo studente deve
sapere:
Regolare gli aspetti fonici, prosodici e di direzione comunicativa.
SCRITTURA
Nella pratica della scrittura lo studente deve
raggiungere:
a) Una adeguata consapevolezza e capacità di controllo delle differenze tra formulazione orale e
formulazione scritta del pensiero con particolare riferimento ai rapporti tra fatti prosodici e
punteggiatura, tra sintassi ellittica e sintassi esplicita, tra lessico comune e lessico preciso o
tecnico.
b) La capacità di realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle
situazioni comunicative.
c) La consapevolezza della flessibilità del progetto di scrittura e la conseguente capacità di
modificarlo quando occorra.
Riflessione sulla linguaLo studente deve
sapere:
a) Analizzare con metodi di adeguato rigore scientifico la lingua, sapendo collegare i fenomeni dei
vari livelli del sistema e istituendo confronti tra alcuni elementi fondamentali della lingua italiana e
quelli di altre lingue studiate o note, compresi i dialetti.
b) Riconoscere la diversa utilizzazione che hanno le stesse strutture linguistiche in diversi tipi di
testo
.
c) Rilevare gli aspetti della storicità della lingua e delle varietà linguistiche nello spazio
geografico.
CONOSCENZE
Conoscenza degli argomenti specifici della disciplina in relazione ai contenuti
programmati. ABILITA’
Comprensione del significato delle conoscenze e del messaggio profondo di un testo; esposizione
in forma chiara, corretta e appropriata. Capacità di analisi, sintesi e valutazione autonoma.
COMPETENZE
Competenza linguistica e comunicativa. Padronanza di più codici linguistici. Saper riconoscere i vari
tipi di testo.
METODOLOGIA DIDATTICA
a) Lezione frontale intesa come introduzione e sollecitazione di interesse alla lettura. Lettura
autonoma di testi integrali con relativi esercizi di analisi e rielaborazione, individuazione di
tematiche interessanti da sviluppare nel corso dell’anno, discussioni, esercitazioni.
b) Per la produzione di testi: elaborazione guidata di paragrafi e testi espositivi, descrittivi e
argomentativi, attenzione e cura per l’uso consapevole degli elementi della coerenza e coesione.
c) Per la riflessione sulla lingua: analisi lessicale e morfo-sintattica.
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE O PLURIDISCIPLINARE
Le attività interdisciplinari coinvolgeranno la storia, la geografia, il latino e il greco.
LIBRI DI TESTO
Biglia- Manfredi- Terrile, Un incontro inatteso poesia e teatro vol. B
M. Sensini Con metodo
E. Cantarella Felici approdi - epica
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi (commento di Ciocca - Ferri)
N. Ginzburg La famiglia Manzoni
G. Boccaccio, Decameron a cura di S. Motta e A. Di StefanoContenuti delle Lezioni e delle Unita’ Didattiche o Moduli con l’indicazione delle ore previste.
TEMPI 132 ore
Nei tempi sono compresi anche il ripasso e le verifiche, le visite culturali ed eventuali viaggi di
istruzione.
GRAMMATICA
MODULO 0
Riflessione sulla lingua
Ripresa e approfondimento degli argomenti studiati l’anno precedente, con particolare attenzione
alla grammatica del verbo e all’analisi logica. 3 ORE
MODULO 1 Il periodo
U 1 Struttura e analisi del
periodo
U 2 Le proposizioni subordinate
U 3 I tempi verbali e i modi delle
subordinate
U 4 Uso del congiuntivo nelle dipendenti
U 5 Il discorso diretto e indiretto 6 ORE
ABILITA’ DI SCRITTURA
I testi argomentativi
Verranno effettuati lavori di esercitazione sull’elaborazione di vari testi di natura argomentativa, a
casa e in
classe.
4 ORE
ANTOLOGIA I testi letterari
MODULO 1
Elementi costitutivi e caratteristiche generali (Revisione e ripasso del programma dell’anno
precedente)
U 1 La costruzione del racconto
Divisione in sequenze
Fabula e
intreccio
U 2 Tempi e luoghi
U 3 I personaggi
U 4 Chi racconta e chi legge
Il
narratore
Il punto di vista
Il
lettore
Il contesto 1 ORA
MODULO 2
Il romanzoLettura integrale dell’opera di A. Manzoni “I Promessi Sposi “
Con analisi del testo, dei personaggi, della società del tempo, della lingua e dello stile. Particolare
attenzione verrà data alla genesi del romanzo e alla dettagliata analisi delle figure retoriche.
60 ORE
MODULO 3
Il testo poetico
U 1 Elementi costitutivi e caratteristiche fondamentali per la comprensione del testo
poetico.
U 2 Il suono: rime e schemi metrici; le figure di suono.
U 3 Il senso: le figure di significato e sintattiche
U 4 Il lessico e la sintassi
U 5 Significati, temi e contesti
U 6 Percorso poetico dal ‘200 al ‘900; una particolare attenzione verrà data alla poesia del
Duecento e del
Trecento.
U 7 Percorso d’autore: Giovanni Pascoli/ Giacomo Leopardi/ F. Petrarca.
28 ORE
MODULO 4
Il testo teatrale
U 1 Le origini. La tragedia. La commedia.
U 2 Il teatro greco: lettura integrale della trilogia Orestea di
Eschilo.
5 ORE
MODULO 5
Il poema epico a Roma: l’Eneide
La vita e il pensiero di Virgilio. L’età augustea. Genesi dell’opera.
Lettura, commento e analisi del testo di brani salienti
dell’opera.
15 ORE
MODULO 6
La narrazione realistica
Il realismo in Boccaccio
Analisi e lettura di alcune novelle atte a sottolineare il pensiero di G. Boccaccio, in rapporto alla
letteratura del Trecento, come prosecuzione dell’attività dell’anno
precedente.
7 ORE
5
Verranno letti, nel corso dell’anno, alcuni romanzi ed opere teatrali, su cui verrà effettuata l’analisi
del testo. In particolare si prevede un lavoro di approfondimento sul romanzo di formazione, sia
attraverso testi letti durante la scorsa estate, sia attraverso testi di nuova lettura. Si prevede la
visione di spettacoli teatrali e cinematografici corredati da adeguata
preparazione.
Si prevede l’eventualità di alcune ore di potenziamento in analisi del
periodo.Piano di lavoro di Storia e Geografia
Anno Scolastico 2019/2020 - classe 2A
Prof. Marina Giannini
Finalità e obiettivi
• Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi studiati.
• Usare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico e geografico.
• Interpretare, in casi semplici, le testimonianze utilizzate.
• Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato
problema storico studiato.
Conoscenze, abilità e competenze
• Conoscenza di informazioni, dati, definizioni, concetti relativi agli argomenti di studio.
• Capacità di esprimere e di esporre i concetti studiati con correttezza e con una terminologia
specifica.
• Capacità di analizzare e sintetizzare le tematiche affrontate cogliendone gli sviluppi diacronici e
sincronici.
Criteri di valutazione
• Capacità di ascoltare, capire, apprendere ed esporre in modo organico e critico e in forma
appropriata i contenuti.
• Capacità di collegare gli eventi storici e di analizzare le differenze e/o le analogie rilevabili tra
le civiltà studiate.
• Uso della terminologia geografica.
• Capacità di utilizzare strumenti cartografici e grafici.
• Capacità di analizzare e sintetizzare le tematiche affrontate cogliendo le connessioni e le
influenze degli eventi storici e dei problemi mondiali sullo assetto territoriale.
Criteri di sufficienza
• Conoscenza delle linee generali del programma.
• Correttezza espositiva.
Saranno inoltre oggetto di valutazione l’interesse, l’attenzione, il comportamento corretto
e il puntuale svolgimento dei compiti assegnati.
Metodologia didattica
Storia Il periodo storico preso in considerazione verrà esaminato alla luce di tre diversi itinerari di
analisi:
1. Un itinerario narrativo, che consente di soddisfare il bisogno della conoscenza del singolare
concreto, e offre il senso del divenire e del
mutamento.
2. Un itinerario interpretativo che, esigendo l’accostamento di esempi, propone modelli
di
approfondimento di eventi e fenomeni
storici.
3. Un itinerario iconico, che permette un contatto diretto con una significativa documentazione
e diviene stimolo alla realistica ricostruzione del passato.Geografia Il lavoro del secondo anno sarà finalizzato al consolidamento dei dati generali di carattere fisico e antropico che costituiranno la base conoscitiva per attuare successivi problemi di analisi del territorio. Saranno poste in esame particolari attività che permettano di cogliere appieno e nel modo più diretto possibile il rapporto di interdipendenza tra uomo e territorio. Sarà inoltre dato risalto alla lettura e all’interpretazione di carte varie. Come lavoro di connessione con la storia si prevede un modulo di lettura e identificazione delle carte dell’antica Grecia e dell’antica Roma. Libro di testo: Manfredi- Alfieri- Leone Itaca- Viaggio nella geostoria vol.1 e 2 Tipologia delle prove Verifiche orali; test scritti Contenuti delle lezioni divise in unità didattiche. Ore previste 99. Classe 2 A Prof. M. Giannini Storia U 1 Revisione e ripasso del programma dell’anno precedente, con particolare riferimento alla Roma repubblicana e all’organizzazione politica e magistratuale. Le guerre Puniche e la conquista dell’Oriente. U 2 Trasformazioni sociali ed economiche dopo la conquista dell’Oriente. I tentativi di riforma dei Gracchi. Il consolato di Mario. La guerra sociale. U 3 L’età delle guerre civili. La guerra tra Mario e Silla. Ascesa di Pompeo. La congiura di Catilina. Il primo triumvirato. Il consolato di Cesare. La guerra tra Cesare e Pompeo. La dittatura di Cesare. U 4 Augusto e la nascita dell’impero. U 5 La dinastia Giulio Claudia. I Flavi. U 6 Il consolidamento dell’impero. L’apogeo dell’impero. U 7 La vita culturale e religiosa dell’impero. Il Cristianesimo. U 8 L’impero nel caos: l’anarchia militare. U 9 L’impero cambia volto: Diocleziano. U 10 Costantino e l’alleanza tra impero e Chiesa U 11 Teodosio e l’impero cristiano. U 12 Agonia e fine dell’impero. U 13 I regni romano barbarici U 14 L‘impero d’Oriente. U 15 L’impero restaurato da Giustiniano. U 16 La Chiesa e il monachesimo in Occidente U 17 La civiltà islamica. U 18 L’Occidente nell’Alto Medioevo. I Longobardi. La Chiesa di Roma alleata dei Franchi. Economia e società nelle curtes.
U 19 L’età di Carlo Magno e l’impero carolingio. U 20 L’eredità carolingia e la frammentazione dell’impero U 21 La società feudale. Geografia U 1 Aspetti della globalizzazione U 2 Le risorse della Terra U 3 Le attività economiche U 5 Gli organismi internazionali Roma, 3 ottobre 2019
Indirizzo classico - classe II A a.s. 2019/2020
docente: Rita Pasquini
PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA
Finalità generali
o Lo sviluppo di capacità intuitive e logiche
o La maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti
o Lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche
o L’abitudine alla precisione del linguaggio
o La capacità di ragionamento coerente ed argomentato
o La consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici emergenti dei nuovi mezzi
informatici
Conoscenze
o conoscere i contenuti proposti
Capacità
o dimostrare proprietà di figure geometriche
o comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi matematici
o cogliere analogie strutturali ed individuare strutture fondamentali
Competenze
o utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo
o operare nel calcolo numerico
o operare nel calcolo letterale
o saper risolvere equazioni, disequazioni,di primo grado
o saper utilizzare gli strumenti di calcolo per risolvere semplici problemi di primo
grado
o possedere capacità di analisi
o possedere capacità di sintesi
Criteri di valutazione
o conoscenza dei contenuti
o capacità di collegamento tra argomenti correlati
o capacità di astrazione
o capacità di cogliere analogie e di sfruttare conoscenze pregresse e interdisciplinari
o la frequenza, la partecipazione e l’impegno alle attività proposte
o capacità di analisi e sintesi
(Gli indicatori di valutazione sono nella griglia al termine del documento)
Metodologia
o lezione frontale
o lezione dialogatao colloqui
o tradizionali prove scritte
o test ed esercizi
o recupero in orario curriculare
Contenuti
Algebra
o Statistica
I pittogrammi e i grafici a barre
I grafici a torta
Gli indici centrali : media, mediana, moda
Come usare moda, media e mediana.
o Le disequazioni lineari
Le disuguaglianze numeriche
Le disequazioni numeriche intere e fratte
I sistemi di disequazioni
Problemi e disequazioni lineari
o I sistemi lineari
I sistemi di due equazioni in due incognite
Il metodo grafico
Il metodo di sostituzione
Il metodo di Cramer
I sistemi lineari e problemi
o Il piano cartesiano e la retta:
Piano cartesiano: definizione e proprietà
Punto medio di un segmento, distanza tra due punti
Equazioni degli assi cartesiani, equazioni delle bisettrici dei quadranti
Equazione retta per l'origine, equazione retta in forma esplicita ed implicita
Fascio di rette proprio ed improprio
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra rette
Intersezione tra rette
Equazione retta per due punti
Distanza punto retta
o Radicali
La funzione potenza.
Radice: la funzione inversa della potenza
Definizione, proprietà, operazioni. Razionalizzazione del denominatore di una
frazione
o Scomposizione in fattori di un polinomioRaccoglimento totale, parziale Fattorizzazione tramite prodotti notevoli Trinomio particolare MCD, mcm di un polinomio Frazioni algebriche e relative operazioni o La statistica e gli indici di dispersione Rappresentare i dati in classi Interpretare i grafici Gli indici di dispersione o Introduzione alla probabilità Eventi certi e probabili La probabilità Il calcolo della probabilità su basi statistiche e di simmetria Assicurazioni e probabilità o Perimetri e aree- teorema di Pitagora Misure di lunghezza e di area Aree di parallelogramma, triangolo, trapezio, rombo Lunghezza di circonferenza ed area cerchio I poligoni in un reticolo e le aree approssimate Teorema di Pitagora, applicazioni. Libro di testo: C.Bertoni - J Yeo - Y. Ban Har - T. Keng, Pensaci! 2, ed. Zanichelli
Indicatori di valutazione globale
GIUDIZIO
VOTO/
10 Conoscenze Competenze Capacità
0–2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.
Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre distingue i dati, senza saperli
corretta dei contenuti che non riesce ad applicare a classificare né sintetizzare in maniera
3–4 contesti diversi da quelli appresi precisa
Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo.
distingue e collega i dati tra loro in
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale modo frammentario perdendosi, se
5 non guidato, nella loro applicazione.
Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo.
Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a li sa distinguere e raggruppare in
compiere semplici applicazioni degli stessi. modo elementare, ma corretto.
6
Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato.
Ha una conoscenza completa, ma non sempre
approfondita dei contenuti che collega tra loro e applica li sa analizzare e sintetizzare,
7 a diversi contesti con parziale autonomia
Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato.
Ha una conoscenza completa ed approfondita dei
li sa ordinare, classificare e
contenuti che collega tra loro e applica a diversi
sintetizzare,
8 contesti.
Linguaggio specifico della disciplina pertinente.
Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che
riconosce e collega in opposizione e in analogia compie analisi critiche personali e
(classificazione) con altre conoscenze, applicandoli, sintesi corrette e originali.
9 – 10
autonomamente e correttamente, a contesti diversi.
Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole.Piano di lavoro di Religione 2 A
A.s. 2019 -2020
Prof.ssa Flavia D’Angelo
FINALITA’
Contribuire allo sviluppo integrale della personalità dello studente.
Offrire elementi culturali per scelte più libere, consapevoli e responsabili.
Favorire la ricerca del senso della vita.
Contribuire allo sviluppo del senso civico, dell’attenzione all’altro e della dimensione
della solidarietà.
Offrire opportunità di dialogo che favoriscano le relazioni con se stessi e con gli altri
OBIETTIVI
Stimolare l’attenzione, la motivazione, la curiosità.
Comprendere la specificità dell’esperienza religiosa ebraica e cristiana.
Conoscere la personalità di Gesù di Nazareth ed il suo messaggio.
CONOSCENZE
Struttura essenziale del documento biblico.
Principali eventi storici della rivelazione ebraica e cristiana.
Caratteristiche dell’annuncio di Gesù Cristo.
Nucleo essenziale dell’insegnamento buddhista.
CAPACITA’
Capacità di ascolto, di interiorizzazione, di dialogo.
Saper attualizzare gli insegnamenti di Gesù e riferirli ad esperienze di vita.
Rispettare le possibili, diverse posizioni etiche e religiose di ogni persona.
COMPETENZE
Valutare l’importanza della comunicazione e del linguaggio nella vita dell’uomo.
Cogliere la specificità dell’esperienza cristiana e saperla confrontare con la ricerca
dell’Assoluto nelle tradizioni religiose dell’India.
OBIETTIVI MINIMI
Conoscenza del nucleo essenziale dell’annuncio di Gesù di Nazareth e gli episodi
principali della sua vita.
CONTENUTI
Il fenomeno religioso nella storia dell’uomo.
Lo Spirito e l’ego. Costruire sulla sabbia o sulla roccia.
L’esperienza del limite ed il problema del male.
Siddharta e la via del risveglio dal dolore.
Dio si rivela all’uomo: Gesù di Nazareth.
Proiezione film “Jesus” e “I giardini dell’Eden”.
Le Beatitudini, il messaggio del “Regno” e la nuova giustizia.
L’annuncio attraverso le parabole ed i gesti di liberazione.
Gesù ed il suo rapporto con il Padre e con lo Spirito.
Il mistero negli eventi della passione, morte e resurrezione.
La vita “oltre” la vita: l’esperienza di Colton Burpo.
Le origini della prima comunità cristiana.
Il mistero scientifico della Sindone.
VALUTAZIONESi terrà conto della motivazione, dell’interesse e della partecipazione al dialogo
formativo e culturale.
Piano di lavoro di Latino e Greco
Classe II A
a.s. 2019/2020
docente: Maria Cristina Zerbino
Premessa. Le finalità educative e formative generali, la formulazione degli obiettivi didattici,
compresi gli obiettivi minimi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, la
predisposizione della metodologia didattica e degli strumenti di lavoro di base, le griglie, i
criteri e le modalità di valutazione sono frutto di confronto tra i docenti di lettere del Liceo:
per la consultazione si rimanda alla verbalizzazioni delle riunioni del gruppo effettuate
dall’inizio del corrente anno scolastico.
Finalità
Riflessione sui fenomeni linguistici caratterizzanti l’evoluzione storica delle due lingue
classiche in raccordo con l’Italiano, per determinare un contatto diretto con civiltà che sono
alla radice del nostro presente.
Obiettivi Educativi
Sviluppo della percezione di sé come discente, nel contesto relazionale di un ambiente di
studio; consolidamento del valore del rispetto di sé e degli altri; sviluppo e consolidamento
della capacità critica di autovalutazione delle proprie conoscenze; sviluppo e
consolidamento del corretto metodo di studio.
Obiettivi di latino e greco nel biennio.
- Acquisizione delle strutture storico-linguistiche fondamentali, con particolare
attenzione alla morfosintassi di base.
- Acquisizione di abilità per la comprensione di testi di varia tipologia e per la loro
adeguata resa in italiano.
- Individuazione di elementi di continuità linguistici, storici e culturali.
Obiettivi minimi definiti nella riunione di area del 12 Settembre 2019
- Acquisizione delle strutture storico-linguistiche fondamentali, con particolare
attenzione alla morfosintassi di base.
- Acquisizione di abilità per la comprensione di testi di varia tipologia e per la
loro adeguata resa in italiano.
- Individuazione di elementi di continuità linguistici, storici e culturali.
LATINO:
- acquisizione della morfologia nominale e verbale (le cinque declinazioni, gli aggettivi e i
pronomi, il verbo sum e le quattro coniugazioni attive, passive e deponenti);
- acquisizione delle strutture sintattiche di base (complementi e principali proposizionisubordinate: cum narrativo, finale, infinitiva, causale, temporale);
- acquisizione del lessico fondamentale.
GRECO:
- acquisizione della morfologia nominale e verbale (le tre declinazioni, gli aggettivi, il
presente e l’imperfetto dei verbi);
- acquisizione delle strutture sintattiche di base (complementi e principali proposizioni
subordinate, ad es. dichiarativa, finale, infinitiva);
- acquisizione del lessico fondamentale.
Gli strumenti di lavoro: Metodologia didattica
In generale l’attenzione sarà quella a realizzare sempre di più una didattica inclusiva
basata sull’apprendimento e centrata sul discente. Le metodologie utilizzate saranno le
seguenti:
- lezioni frontali (anche con presentazioni prezi o ppt)
- lezioni interattive con l’utilizzo delle Tecnologie per l’informazione e la
Comunicazione (in particolare si utilizzeranno le seguenti piattaforme e strumenti
disponiblili sul web: Nearpod, E-maze, Genial.ly, Evernote, Socrative)
- lavori di gruppo, apprendimento collaborativo (tecnica jigsaw), educazione tra
pari;
- didattica laboratoriale: laboratorio di tra
- duzione e studio morfo-sintattico della lingua a partire dal testo, scelto in modo
da favorire la motivazione e la contestualizzazione; studio delle procedure e fasi
necessarie per giungere ad una buona traduzione con esercizi di analisi, di
memorizzazione del lessico e comprensione;
- classe virtuale (utilizzando la piattaforma Classroom di Gsuite for Education)
- Saranno pianificati momenti di rinforzo durante lo svolgimento di ciascun modulo e,
alla sua conclusione, recupero in classe.
Per quanto attiene specificamente alla didattica delle lingue classiche l’approccio
tradizionale sarà integrato con altri approcci, innanzitutto il Lexical Aproach che lavora sulla
memorizzazione delle collocazioni piuttosto che delle singole parole, ma anche, in modo
ancora sperimentale il metodo induttivo o methodus directa che sposta l’attenzione dalla
grammatica alla lingua come strumento di comunicazione.
Progetti e attività interdisciplinare
Costanti collegamenti e richiami a tematiche di Storia, Educazione Civica, Geografia, Storia
dell’Arte, Inglese, Religione. Eventuali Visite didattiche a musei e parchi archeologici.
Partecipazione all’iniziativa Libriamoci: letture ad alta voce nelle scuole proposta dal “Centro
per il libro e la lettura”.
Circolo di Lettura delle Biblioteche di Roma. Il Maggio dei Libri.
Verifiche e valutazione
La valutazione delle conoscenze, competenze e capacità acquisite si baserà su diversi tipi
di verifica: strutturate, semistrutturate, aperte, chiuse; orali, scritte; quotidiane, periodiche;
individuali, collettive; svolte in classe o a casa. Tutte le verifiche si intendono finalizzate sia
alla diagnosi dei livelli di apprendimento che al monitoraggio del percorso didattico.
Per le verifiche o le esercitazioni precedenti alle verifiche si utilizzerà, quando ritenuto
utile, la piattaforma Socrative.La valutazione degli scritti scaturirà di volta in volta dagli indicatori espressi nelle prove
semistrutturate, o dall’applicazione delle relative griglie di valutazione, sempre corredate da
un giudizio analitico e sintetico. Si prevedono almeno tre verifiche scritte e due orali a
quadrimestre. Le verifiche orali costituiranno un momento importante del processo
didattico e saranno valutate secondo apposite griglie di valutazione. In ogni quadrimestre
almeno un voto orale scaturirà da una prova scritta, per garantire, oltre che un monitoraggio
puntuale del percorso, maggiore equità (a tutti verranno chiesti almeno una volta gli stessi
argomenti), oggettività e trasparenza. La valutazione del profitto globale dell'alunno terrà
conto di tutte le prove fornite durante l'anno e dei seguenti elementi:
- delle conoscenze e competenze acquisite
- delle capacità espressive, di analisi, sintesi, interpretazione, valutazione critica.
- della frequenza, interesse, partecipazione, serietà ed impegno dimostrati.
- del livello di partenza e di arrivo.
Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte di latino e greco, verrà utilizzata la
seguente griglia (in accordo con quanto stabilito nella riunione di dipartimento del 12
Settembre 2019):
indicatori descrittori Punti
comprensione del testo completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2) ………/4
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0)
conoscenza delle regole e precisa e completa (4)
delle strutture morfo- esatta ma con qualche imprecisione (3)
sintattiche* elementare (2)
frammentaria (1) ………/4….
nulla (0)
capacità di interpretazione e linguaggio fluido e resa completa del testo (2)
resa in lingua italiana linguaggio sufficientemente fluido (1)
linguaggio confuso e poco aderente (0.5) ………/2….
nessuna resa in italiano (0)
votoxxx …../10
Attività di recupero
Progetto “Imparare a imparare”: corso di metodo di studio e potenziamento delle
competenze di base dell’italiano del latino e del greco con attività di tutoraggio e di studio
assistito.
Momenti di sospensione nello svolgimento del programma per creare pause di
approfondimento e di ripasso collettivi.Puoi anche leggere