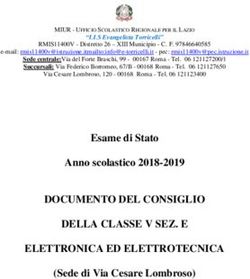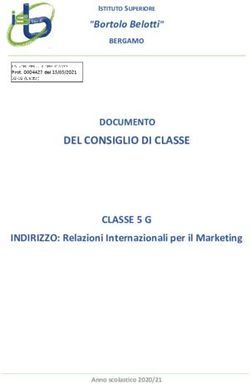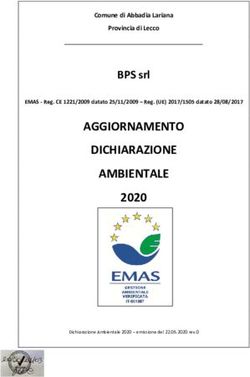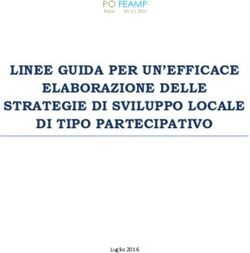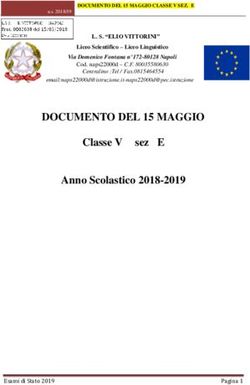DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2018/2019 - "Guglielmo Marconi"-Latina
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE
A.S. 2018/2019
Classe: 5a Sezione: F
Indirizzo ITT - Informatica e Telecomunicazioni
Articolazione: Informatica
I.I.S. "Guglielmo Marconi" via Reno, snc – 04100 LATINA tel. 0773 472005 - fax 0773 410393
www.iismarconilatina.edu.it
1PREMESSA
Il Consiglio di Classe nella seduta del 29 aprile 2019, sulla base della programmazione
didattico educativa annuale coordinata, redatta in attuazione degli obiettivi culturali e
formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali contenute nel Piano dell'Offerta
Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il presente documento destinato alla
Commissione d'Esame. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato
conclusivi del corso di studi, il documento esplicita i contenuti disciplinari, gli obiettivi, i
metodi, i mezzi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di
valutazione.
INDICE
Presentazione della scuola
Strutture e risorse
Profilo professionale
Docenti componenti del C. di C.
Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta
Presentazione della classe
Obiettivi
Strategie
Modalità d'intervento e strumenti
Attività di recupero /potenziamento e approfondimento
Verifiche e valutazione
Attività curricolari
Attività extracurricolari (di orientamento e stage aziendali)
Parametri e criteri di attribuzione dei crediti scolastico e formativo
Percorsi formativi delle singole discipline
Simulazione delle prove d'esame e griglie di valutazione
Percorsi per le competenze trasversali e l'’orientamento
Cittadinanza e costituzione
2PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
L'Istituto di Istruzione Superiore "G. Marconi" di Latina è nato principalmente per erogare
servizi ad un bacino d'utenza che si espande nell'intera zona nord della provincia.
Questo si compone dell'Istituto Tecnico settore Tecnologico - Indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni, Istituto Tecnico settore Economico - Indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. E' attento alle grandi
trasformazioni tecnologiche anche perché si propone una funzione importante non solo
per l'educazione culturale, sociale e umana, ma anche professionale ed operativa.
Riguardo al territorio della provincia di Latina, occorre considerare che il mondo del
lavoro presenta aziende piccole e medie, che solo dopo il 1983 hanno trovato le condizioni
attuali per la diffusione delle tecnologie informatiche. Dall'inizio degli anni '90 le aziende,
nel territorio pontino, per essere competitive in un mercato sempre più internazionale, si
sono orientate ad impiegare l'elaboratore nella produzione, nel marketing e in genere nel
supporto alle decisioni strategiche di aziende. A ciò si aggiunge il fatto che il progresso
tecnologico ha comportato uno spostamento della domanda di lavoro verso personale
qualificato, soprattutto in relazione allo sviluppo delle tecnologie informatiche.
In questo contesto quindi l'I.I.S. "G. Marconi" di Latina ritiene, nell'ambito del suo
piano dell'offerta formativa, che la formazione sia uno strumento di politica attiva nel
mercato del lavoro, tendente ad adeguare le qualifiche professionali alle necessità del
mercato, e divenendo, di conseguenza, un elemento chiave per dare maggiore
flessibilità a quest'ultimo.
Alla luce di quest'analisi, l'I.I.S. "G. Marconi" si propone di dare delle valide risposte
dal punto di vista educativo e professionale, pertanto l’identità dell’Istituto Tecnico, in
particolare, è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico-tecnologico, in
linea con le indicazioni della Comunità Europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e
specifico.
3STRUTTURE E RISORSE
L'Istituto "G. Marconi" di Latina presenta una ampia dotazione di laboratori.
Nel triennio gli studenti possono accedere ai laboratori di:
Informatica e Sistemi (personal computer con un'ampia gamma di software per
sistemi di sviluppo di linguaggi di programmazione e per lo studio dei
microprocessori)
Telecomunicazioni (personal computer e strumentazione e componentistica
elettronica con programmi di progettazione CAD elettronico, PLC)
linguistico multimediale
Fisica
Biologia
Chimica
Tutti i laboratori sono collegati fra loro tramite rete Intranet e sono forniti di lavagne
interattive multimediali.
Altri strumenti a disposizione dei docenti nello svolgimento in aula delle attività didattiche e
comunemente usati sono:
lavagna luminosa per la proiezione di lucidi con schermo
televisione con video registratore
registratore
lavagne interattive multimediali
display LCD per la proiezione su schermo di immagini provenienti da computer
4PROFILO DELL'INDIRIZZO ITT
(Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni)
Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei
segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni (“privacy”).
È in grado di:
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della
tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e
nell’organizzazione produttiva delle imprese;
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team,
un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo,
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;
- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale
caratterizzato da forte internazionalizzazione;
- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
5ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA Numero ore DOCENTE Continuità
settimanali
ITALIANO 4 VIVOLO Chiara Maria 1
STORIA 2 VIVOLO Chiara Maria 1
INGLESE 3 TOMASI Alessandra 3
MATEMATICA 3 LOFFREDI Lina 3
INFORMATICA 6 MATTACCHIONI Silvino 3
LAB. INFORMATICA 4 MELE Ciro 3
SISTEMI E RETI 4 DE BONIS Carlo 3
LAB. SISTEMI E RETI 3 TARANTINO Patrizia 1
TECNOLOGIE E PROG. 4 CIUFO Angelo 1
LAB. TECNOLOGIE E PROG. 2 DALLA SENTA Dennis 1
GESTIONE DI PROG. 3 COLISTRA Maria 1
(sost. da PICOZZA Laura)
LAB. GESTIONE DI PROG. 1 TARANTINO Patrizia 1
SCIENZE MOTORIE 2 MAZZUCCO Alessandra 3
RELIGIONE 1 ESPOSITO Antonietta 3
MATERIA ALTERNATIVA ALLA 1 ZANABONI Maria Enrica 1
RELIGIONE
6PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5a F è composta da 18 alunni, 16 maschi e 2 femmine, tutti provenienti dalla
classe quarta.
In riferimento alla continuità didattica, gli studenti della 5 a F ne hanno usufruito per gli
insegnamenti di Matematica, Inglese, Scienze Motorie, Informatica, Sistemi, Religione e
Laboratorio di Informatica mentre per le discipline Italiano, Storia, Tecnologie, Gestione di
Progetto, Laboratorio di Sistemi, Laboratorio di Tecnologie e Laboratorio di Gestione di
Progetto, si sono avvicendati diversi docenti nel corso del triennio.
Il profilo didattico della classe si presenta eterogeneo, buona parte degli alunni hanno
partecipato con vivo interesse ed attenzione all’attività didattica sia in aula che nelle attività
extracurriculari, manifestando interesse e partecipazione attiva verso tutte le discipline e
raggiungendo in modo più che soddisfacente gli obiettivi prefissati, mentre i rimanenti sono
arrivati con fatica ad acquisire in modo corretto le competenze richieste al termine del
triennio e la loro preparazione appare fragile in alcune materie, in particolare in quelle di
indirizzo.
Perciò la classe presenta un gruppo particolarmente motivato e capace che è riuscito a
raggiungere ottimi risultati di profitto, riuscendo a coinvolgere nel dialogo educativo tutta la
classe, ed un altro, invece, in cui permangono situazioni di debolezza, tanto che il risultato
raggiunto è appena sufficiente. In generale il rapporto alunno – docente è stato fondato
sulla stima e sul rispetto reciproco, buoni i rapporti con le famiglie.
Per quanto concerne l’alternanza scuola-lavoro la classe ha dimostrato autonomia
operativa nello svolgere i compiti e le procedure assegnate, alcuni discenti si sono distinti
per aver svolto un maggior numero di ore e per aver manifestato un buon rispetto delle
procedure relative alle azioni progettuali.
Per Cittadinanza e Costituzione la classe ha seguito con interesse i percorsi svolti,
partecipando ai dialoghi e ai dibattiti che via via nascevano durante la rielaborazione in
classe delle tematiche trattate.
7ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
(con riferimento al percorso evolutivo nel triennio)
Si fa riferimento all’allegato A del presente documento.
Composizione anni precedenti
Classe 3a :
n° 21 studenti a.s. 2016/2017
studenti promossi a giugno: 11
studenti con sospensione del giudizio: 9
studenti non promossi a giugno: 1
studenti promossi ad agosto: 9
Classe 4a :
n° 20 studenti a.s. 2017/2018
studenti promossi a giugno: 11
studenti con sospensione del giudizio: 7
studenti non promossi a giugno: 2
studenti promossi ad agosto: 7
8OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
A) COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE
Assiduità nei controlli dei compiti assegnati a casa
Trasparenza nella valutazione
Celerità nella riconsegna degli elaborati scritti
Esigere puntualità nell'ingresso alle lezioni e rispetto del Regolamento di Istituto
B) OBIETTIVI TRASVERSALI: (comportamentali e cognitivi)
B1 - COMPORTAMENTALI
Acquisire la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino in una società
democratica
Sviluppare la fiducia in sé e la motivazione alla crescita individuale e culturale
Interiorizzare norme etiche e comprendere il valore della legalità
Conoscere e rispettare le regole della vita scolastica contenute nel Regolamento
d’Istituto
Essere capaci di un confronto civile, rispettando il punto di vista degli altri
Imparare a formulare domande e risposte adeguate, ad assumersi responsabilità, a
sviluppare uno spirito cooperativo
Partecipare attivamente e con contributi personali alle attività didattiche svolte in
classe
Acquisire un metodo di studio adeguato al raggiungimento degli obiettivi della
programmazione
Prendere appunti, reperire informazioni, leggere selettivamente e criticamente i
materiali di studio, utilizzando sia sussidi cartacei che multimediali
Collaborare con gli insegnanti e con i compagni nell’esecuzione di un compito,
imparando a lavorare in gruppo
Sviluppare la capacità di valutazione e di autovalutazione, sia del lavoro scolastico
che dei rapporti sociali, al fine di riconoscere per tempo eventuali difficoltà/carenze
e avviare un percorso di recupero
B2 - COGNITIVI
Riconoscere e decodificare messaggi usando linguaggi verbali, non verbali e
simbolici
Comprendere testi di tipo diverso (giornalistico, scientifico, tecnico, storico,
letterario, ecc.), formulari diversi, leggere mappe e carte, interpretare grafici
Comunicare ad altri, in diverse forme parlate e scritte (relazioni, interventi in
discussioni, tabelle, commenti, questionari, articoli, ecc.), idee e dati, organizzando
in maniera adeguata le informazioni
Individuare percorsi e strumenti efficaci, utilizzare autonomamente metodi e
strategie originali
Rilevare, misurare, rappresentare fenomeni e risolvere con coerenza problemi,
usando tecniche di tipo matematico e scientifico, controllare dati, elaborare risultati
Padroneggiare le conoscenze informatiche di base ed i programmi applicativi più
utilizzati nello studio e nel lavoro
Acquisire il linguaggio specialistico delle discipline tecniche
Acquisire la capacità di impostare e sviluppare adeguatamente le diverse fasi di un
progetto tecnico
9 Acquisire le competenze professionali di base e una propensione culturale
all’aggiornamento
Partecipare operativamente alla costruzione di una nuova cultura della sicurezza
sui luoghi di lavoro
Sviluppare competenze progettuali nell’elaborazione di interventi di riqualificazione
e di sviluppo sostenibile del territorio
C) STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO
Accertamento dei pre-requisiti prima di ogni nuova fase di lavoro
Schematizzare quanto viene fatto in classe individuando gli aspetti più importanti e
guidare a tal scopo nei collegamenti e nelle elaborazioni
Lezioni di diversa natura: frontali, di gruppo, riassuntive, esercitazioni, dibattiti di
approfondimento. Verifiche orali di carattere individuale come lezione dialogata di
ripasso e approfondimento tali da incentivare la partecipazione attiva del resto della
classe
Correzione motivata degli elaborati per una migliore consapevolezza delle proprie
capacità, dei propri limiti e del processo formativo da parte degli studenti
Rendere familiari i linguaggi specifici, spiegare il lessico e correggere
sistematicamente i vocaboli usati impropriamente
Favorire la partecipazione responsabile e costruttiva alle opportunità di confronto,
conoscenza e analisi della realtà offerta dalla scuola per l'inserimento dell'individuo
nella società
D) STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Criteri generali
Il processo della valutazione dura per l’intero anno scolastico e verifica il raggiungimento
degli obiettivi formativi e delle competenze previste per ciascun indirizzo e per ciascun
allievo. Il sistema di valutazione parte dai seguenti obiettivi prioritari che lo studente deve
raggiungere:
a) la formazione integrata
b) il corretto rapporto con il territorio
c) la padronanza delle tecnologie
d) le competenze proprie dei diversi indirizzi presenti nell’istituto
Il Consiglio di Classe, che ha dato la valutazione finale dello studente, ha monitorizzato
costantemente:
a) la progressione nell’apprendimento
b) il grado di maturità raggiunto nella conoscenza delle discipline
c) l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo
d) lo sviluppo delle capacità di analisi, comprensione, applicazione in contesti diversi
e) elaborazione e senso critico
f) comportamento dello studente nel sistema scuola
La valutazione finale ha tenuto conto, inoltre, dei seguenti elementi:
a) la misurazione di parti di moduli
b) il collegamento con la programmazione individuale e di classe
c) le prove differenziate previste in sede di programmazione
d) l’autovalutazione cui lo studente è stato adeguatamente sottoposto
10E) STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Obiettivo Strategia Indicatore
Obiettivi comportamentali Discussioni in classe e Ruoli svolti nelle
simulazione di lavoro di gruppo dinamiche di gruppo,
partecipazione ed
interesse
Obiettivi cognitivi Lavori di gruppo, ricerche Rendimento rispetto alle
individuali, lezioni frontali e verifiche orali e scritte
partecipate, in laboratorio ...
OBIETTIVI RAGGIUNTI RELATIVAMENTE ALLE CONOSCENZE
La classe ha raggiunto un livello di conoscenze apprezzabili in quasi tutte le discipline,
sanno organizzare e articolare un pensiero logico e analitico, inoltre sanno riferire i
contenuti noti utilizzando, generalmente con correttezza il linguaggio specifico.
OBIETTIVI RAGGIUNTI RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE
Relativamente all’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi,
nell’effettuazione di compiti affidati e in generale nell’applicazione corretta di quanto
appreso, la classe ha raggiunto un livello sufficiente tutte le discipline. Alcuni alunni si
sono distinti ottimi livelli di competenza.
OBIETTIVI RAGGIUNTI RELATIVAMENTE ALLE CAPACITÀ
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al riconoscimento
delle priorità tra i concetti appresi, alla capacità di un loro autonomo e corretto utilizzo, la
classe ha raggiunto un livello sufficiente, fatta eccezione di una parte della classe che ha
raggiunto ottimi risultati.
11STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA
(CONTROLLO IN ITINERE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO)
Religione
Matemat.
Gest.Imp
Sc.Motor
Informat.
Tecnol.P
Sistemi
Italiano
Inglese
Storia
Strumento
Utilizzato
Interrog. lunga x x
Interrog. breve x x x x x x x x x x
Tema o
x x x
problema
Prove
x x x x x x x x
strutturate
Prove semi
x x
strutturate
Questionario x x x x x x
Relazione x
Esercizi x x x x x x x x x
Dialogo
x x x x x x
educativo
Lavori di
x x x
gruppo
Attività “tra
x x
pari”
Tesine x x x
Approfondim.
STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA SOMMATIVA
(CONTROLLO DEL PROFILO SCOLASTICO AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE)
Religione
Matemat.
Gest.Imp
Sc.Motor
Informat.
Tecnol.P
Sistemi
Italiano
Inglese
Storia
Strumento
Utilizzato
Interrog. lunga x x x
Interrog. breve x x x x x x x x x
Tema o
problema x x x
Prove
strutturate x x x x x x x x
Prove semi
strutturate x x
Questionario x x x x x
12Modalità di intervento
Strumenti:
tecnologie multimediali
software specifici
rete Internet
libri di testo e non
dispense
Attività di recupero / potenziamento e approfondimento
Intervento individualizzato
Recupero / approfondimento in itinere
Sportello dello studente
Simulazioni delle prove d'esame
13GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE, SCRITTE ORALI E GRAFICHE
Voto Conoscenze Competenze Capacità
Conoscenze ampie, Affronta autonomamente Comunica in modo proprio,
complete e approfondite compiti complessi, applicando efficace, articolato.
10 anche in modo autonomo le conoscenze in modo Sa collegare conoscenze
corretto, critico e autonomo attinte da ambiti
pluridisciplinari.
Analizza in modo critico e
documenta il proprio lavoro
Conoscenze ampie, com- Affronta autonomamente com- Comunica in modo proprio,
plete e organiche piti complessi, applicando le efficace.
9 conoscenze in modo Sa collegare conoscenze at-
corretto,critico e autonomo tinte
da ambiti pluridisciplinari.
Analizza in modo critico la
realtà di interesse.
8 Complete e organiche Affronta compiti anche Analizza in modo
complessi in modo accettabile complessivamente corretto,
compie alcuni collegamenti,
rielabora in modo
abbastanza autonomo
7 Conosce gli elementi Esegue correttamente compiti Comunica in modo
fondamentali essenziali semplici; affronta compiti più adeguato, è diligente nello
complessi svolgimento dei compiti;
coglie gli aspetti
fondamentali e analizza in
modo discreto
6 Essenziali con lacune non Esegue compiti semplici senza Comunica in modo
estese e/o profonde errori sostanziali; affronta accettabile. Coglie
compiti più complessi con gli aspetti fondamentali, le
incertezza sue analisi sono sufficienti
5 Incerte e incomplete Applica le conoscenze minime Comunica in modo non
con imprecisione sempre coerente, ha
difficoltà a cogliere nessi
logici e ad analizzare temi,
questioni, problemi
4 Carenti e lacunose Applica le conoscenze minime Effettua analisi parziali e non
solo se guidato commettendo corrette e comunica in modo
comunque gravi errori improprio
3 Frammentarie e Applica le conoscenze minime Non è in grado di cogliere
gravemente commettendo gravissimi errori concetti e relazioni essenziali
lacunose che legano fra loro anche i
fatti più elementari
2 Non applica le Non si orienta
Estremamente
conoscenze minime
frammentarie e
commettendo gravissimi
gravemente lacunose
errori
1 Nessuna Nessuna Non si orienta
14GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO
VOTO DESCRITTORI
10 a) Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle regole
b) Vivo interesse e partecipazione attiva all'attività didattica
c) Consapevolezza del proprio dovere e puntualità e completezza nello
svolgimento degli impegni scolastici
d) Apporti propositivi al dialogo educativo e collaborazione con docenti e compagni
e) Frequenza scolastica assidua, per i ritardi e le uscite anticipate rispetta il
Regolamento d’Istituto
f) non ci sono a suo carico segnalazioni negative, né verbali né scritte
9 a) Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle regole
b) Vivo interesse e partecipazione attiva all'attività didattica
c) Consapevolezza del proprio dovere e puntuale svolgimento degli impegni
scolastici
d) collabora al dialogo educativo, con i docenti e i compagni
e) Frequenza scolastica assidua, per i ritardi e le uscite anticipate rispetta il
Regolamento d’Istituto
f) non ci sono a suo carico segnalazioni negative, né verbali né scritte
8 a) Comportamento corretto e rispettoso delle regole
b) Interesse e partecipazione attenta alle lezioni
c) Puntualità nello svolgimento degli impegni scolastici
d) Collabora al dialogo educativo, con i docenti e con i compagni
e) Frequenza scolastica regolare, qualche volta entra in ritardo o esce in anticipo
f) non ci sono a suo carico segnalazioni negative, né verbali né scritte
7 a) Comportamento corretto
b) Discreto interesse e partecipazione generalmente attenta alle lezioni
c) Discreta puntualità nello svolgimento degli impegni scolastici
d) Partecipa se sollecitato al dialogo educativo, e collabora con i docenti e
compagni non ci sono a suo carico segnalazioni negative, né verbali né scritte
e) Frequenza normale (fa qualche assenza strategica; a volte entra o esce fuori
orario senza particolari necessità)
f) A suo carico si registra qualche sporadico richiamo verbale o scritto
6 a) Comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione
b) Episodi di disturbo all'attività didattica
c) Interesse incostante e partecipazione saltuaria e/o passiva al dialogo educativo
d) Discontinuità nello svolgimento degli impegni scolastici
e) Frequenza discontinua (numerose assenze, numerosi ritardi e uscite anticipate)
f) Cura non sempre costante nell'utilizzo di ambienti, strutture e materiali
g) A suo carico si registrano frequenti richiami verbali e/o provvedimenti disciplinari
scritti anche di più docenti
5 a) Comportamento scorretto e poco responsabile
b) Mancanza di rispetto delle regole con grave e frequente disturbo del lavoro
comune
c) Sanzioni disciplinari ripetute di fronte alle quali lo studente/studentessa non
evidenzia apprezzabili miglioramenti
d) Sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni (DM 16/01/2009, art. 4, comma 2)
e) Mancanza di ravvedimento da parte dello studente/studentessa
f) Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo
g) Impegno insufficiente nello svolgimento degli impegni scolastici
h) Frequenza estremamente discontinua con assenze e/o ritardi non giustificati
i) Mancanza di cura nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali
15ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI
Tipo di attività a.s. 2016/2017 Studenti partecipanti
Olimpiadi di Informatica p.c.
Tipo di attività a.s. 2017/2018 Studenti partecipanti
Maker Faire Rome i.c.
Rai Saxa Rubra i.c.
Olimpiadi di Informatica p.c.
Olimpiadi di Matematica p.c.
Viaggio di istruzione a Torino p.c.
Tipo di attività a.s. 2018/2019 Studenti partecipanti
Maker Faire Rome
i.c.
FabLab
i.c.
Corso “Fermi Masterclass 2019”
p.c.
Viaggio di istruzione a Praga (CZ)
p.c.
16ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI
Tipo di attività a.s. 2016/2017 Studenti partecipanti
Centro sportivo scolastico p.c.
Corso primo soccorso p.c.
Corso di lingua “Cambridge” p.c.
Corso “Arduino day” p.c.
Macchina di Turing p.c.
Tipo di attività a.s. 2017/2018 Studenti partecipanti
Centro sportivo scolastico p.c.
Corso di lingua spagnola p.c.
Corso di lingua “ANGLO” p.c.
Corso di lingua “Pearson” p.c.
Giornale “Parolimpici” p.c.
Corso “Riaccendiamo il saldatore” p.c.
Tipo di attività a.s. 2018/2019 Studenti partecipanti
Centro sportivo scolastico p.c.
Corso di lingua “Pearson” p.c.
ECDL p.c.
Corso "Un Anno per il tuo Futuro" p.c.
17PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
L’assiduità della frequenza scolastica pari almeno all’85% dell’orario
scolastico;
partecipazione con impegno ed interesse alle attività scolastiche
complementari ed integrative (almeno 2);
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
eventuali crediti formativi;
l’interesse e l’impegno nello svolgimento delle attività di percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (con valutazione
almeno discreta);
si avvale dell’insegnamento dell’IRC o ha frequentato un corso di
attività alternative (con voto di profitto almeno discreto).
CRITERI PER IL CREDITO FORMATIVO
Per quanto riguarda le modalità procedurali si richiama quanto precisato
dall’art. 3 del D.M. n. 49 e dall’art. 12 del Regolamento:
“la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a crediti formativi
deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli Enti,
associazioni, istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza
e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa”
“le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui
sono versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni e
la normativa che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo”.
18ALLEGATI
Programmi consuntivi
Materia Numero
allegato
Italiano 1
Storia 2
Lingua Inglese 3
Matematica 4
Informatica 5
Sistemi e reti 6
Tecnologie e prog. 7
Gestione d’impresa 8
Scienze Motorie 9
Religione Cattolica 10
Materia alternativa 11
Simulazioni prove d'esame
Tempi di
Prova Discipline coinvolte Tipologia
esecuzione
19 febbraio
Simulazione
(6 ore)
prima prova
Italiano A, B, C 26 marzo
scritta
(6 ore)
28 febbraio
Simulazione (6 ore)
seconda prova Sistemi e reti C 2 aprile
scritta (5 ore)
Allegati dal no 12 al no 16
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TABELLA PCTO
Latina, 29 aprile 2019
19ELENCO DOCENTI CLASSE 5a F
Prof.ssa VIVOLO Chiara Maria _____________________________
Prof.ssa LOFFREDI Lina _____________________________
Prof.ssa TOMASI Alessandra _____________________________
Prof. MATTACCHIONI Silvino _____________________________
Prof. MELE Ciro _____________________________
Prof. DE BONIS Carlo _____________________________
Prof.ssa TARANTINO Patrizia _____________________________
Prof. CIUFO Angelo _____________________________
Prof. DALLA SENTA Dennis _____________________________
Prof.ssa COLISTRA Maria (PICOZZA Laura) _____________________________
Prof.ssa MAZZUCCO Alessandra _____________________________
Prof.ssa ESPOSITO Antonietta _____________________________
Prof.ssa ZANABONI Maria Enrica _____________________________
Latina, 15 maggio 2019
Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico
(Prof. Angelo Ciufo) (Dott.ssa Ester Scarabello)
20ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: VIVOLO Chiara Maria
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
G. Bellini, T. Gargano, G. Mazzoni, Costellazioni, Dall’Unità d’Italia a oggi, vol. 3, Editori
Laterza, Bari, 2012
ARGOMENTI/
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
in cui si articola la (Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo )
disciplina
Tra Ottocento e
L’età del Positivismo e del Naturalismo: analisi del contesto
Novecento storico-sociale. Il contesto culturale e letterario:
materialismo, determinismo ed evoluzionismo. Il pensiero
positivo da Comte a Darwin.
Naturalismo francese e Verismo italiano: poetiche,
contenuti e generi letterari.
Il romanzo sperimentale di E. Zola. Lettura e analisi del
brano “Gervaise e Coupeau all’Assomoir”, tratto dal
romanzo “L’Assomoir”.
Giovanni Verga: la vita e le opere. Dagli esordi all’adesione
al Verismo. L’impersonalità e la rivoluzione stilistica: da
“Nedda” a “Vita dei campi”. Lettura e analisi dei testi “La
lupa” e “La dedica” a “L’amante di Gramigna”.
Il progetto di un “ciclo dei vinti”: lettura e analisi de “La
prefazione” a “I Malavoglia”. “I Malavoglia”: struttura,
personaggi, temi del romanzo; il progetto letterario, le
tecniche narrative e stilistiche. Lettura e analisi della prima
pagina del romanzo, de “Il coro dei Malavoglia” (estratto
del II capitolo) e delle pagine finali del romanzo “L’addio
di ‘Ntoni”.
L’evoluzione dell’ideologia verghiana: il tema della “roba”.
Lettura e analisi del testo “La roba” da “Novelle rusticane”.
Il “Mastro-don Gesualdo”: i temi, i personaggi, l’ideologia,
lo stile. Lettura e analisi della prima pagina del romanzo.
La lirica in L’età del Simbolismo e del Decadentismo: il quadro
Francia e in storico-culturale, i temi, la filosofia, le poetiche.
Italia Il Decadentismo in Europa: caratteri fondamentali della
21poetica decadente, i “poeti maledetti”. C. Baudelaire: lettura
e analisi dei testi “L’albatro” e “Corrispondenze”.
Caratteri del Decadentismo italiano: confronto tra
Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio.
Giovanni Pascoli: la vita, la formazione culturale, l’opera
maggiore (Myricae). Una poetica decadente: il Fanciullino
e il mito dell’infanzia. Lettura e analisi di alcune pagine de
“Il Fanciullino”: “La metafora del fanciullino” (capitolo I)
e “Il fanciullino si identifica col poeta” (capitolo III). Il
simbolismo pascoliano e la poesia delle piccole cose. Una
nuova lingua per la poesia. Lettura e analisi del testo da
“Myricae”: “Novembre”, “Lavandare”, “Il lampo”; da “I
canti di Castelvecchio”: “La mia sera”.
Gabriele D’Annunzio: la vita, la formazione culturale, le
idee. Il periodo romano: l’esteta, il dandy. Il mito del
superuomo, la lettura di Nietzsche e l’ideologia
superomista. Lettura e analisi del passo tratto da “Le vergini
delle rocce”: “Il manifesto ideologico del superuomo”. La
poesia delle Laudi: il panismo. Lettura e analisi di testi tratti
da “Alcyone”: “La sera fiesolana” e “I pastori”.
Il primo
Novecento: “età dell’ansia”. Il contesto storico-sociale. Il
Novecento quadro culturale e letterario: le avanguardie storiche. La
nozione di avanguardia.
Il futurismo italiano: F. T. Marinetti e la storia del
movimento. Il manifesto tecnico e la poetica delle parole in
libertà. Lettura e analisi dei testi: “Manifesto tecnico della
letteratura futurista” e di “Bombardamento di Adrianopoli
(parole in libertà)”.
L’esperienza crepuscolare: caratteri generali del
movimento attraverso l’analisi e il confronto dei testi di G.
Gozzano “La signorina Felicità ovvero la felicità” (strofe I
e III), e di S. Corazzini “Desolazione del povero poeta
sentimentale”.
La narrativa del Novecento: il grande romanzo europeo.
Le trasformazioni culturali, la crisi del soggetto, le nuove
tecniche narrative. Lettura e analisi dei testi: “L’incubo del
risveglio” tratto dal cap. I de “La metamorfosi” di F. Kafka;
“La madeleine”, tratto da “Alla ricerca del tempo perduto”
di M. Proust; “Il monologo di Molly Bloom”, tratto
dall’“Ulisse” di J. Joyce; “La passeggiata della signora
Dalloway”, tratto da “La signora Dalloway” di Virginia
Woolf.
La narrativa italiana: Pirandello e Svevo. Luigi
22Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica. La poetica
dell’umorismo: i personaggi e le maschere nude, il dissidio
tra forma e vita, avvertimento e sentimento del contrario.
Lettura e analisi dei testi: “L’umorismo secondo
Pirandello” e “L’arte umoristica” (dal cap. VI), tratti dal
saggio “L’Umorismo”. La sperimentazione novellistica “Le
novelle per un anno”: la composizione, la struttura, i temi.
Lettura e analisi dei testi: “Ciàula scopre la luna”, “Il treno
ha fischiato…”, “La carriola”, “Una giornata”. Esame dei
romanzi umoristici: la creazione di una nuova struttura
narrativa e la dissoluzione delle forme tradizionali, i temi,
l’intreccio, i personaggi. Lettura e analisi di testi tratti da
“Il fu Mattia Pascal”: prima e seconda “Premessa”,
“Cambio treno” (estratto del cap VII), “Un po’ di nebbia”
(estratto del cap IX), “Acquasantiera e portacenere”
(estratto del cap X), “Senza documenti non si può amare”
(estratto del cap XV) e “L’ombra d’un morto: ecco la mia
vita” (estratto del cap XV). Lettura e analisi di testi tratti da
“Uno, nessuno e centomila”: “Il mio naso” (cap I-II), “Non
conclude” (libro VIII, cap IV). Pirandello drammaturgo:
dalla fase del grottesco a quella del teatro nel teatro. “Sei
personaggi in cerca d’autore”: la trama e i temi dell’opera.
Lettura e analisi del testo: “I personaggi irrompono sul
palcoscenico” (atto I).
Italo Svevo: la vita, la formazione culturale, le opere. Il
pensiero e la poetica. Svevo narratore: i personaggi, la
figura dell’inetto, lo “scrivere seriamente”, lo stile. Vicende,
temi e soluzioni formali in “Una vita”. Lettura e analisi del
brano “Il gabbiano” (cap VIII), tratto da “Una vita”.
L’inettitudine e la senilità. Esame del romanzo “Senilità”: la
trama, i personaggi, i procedimenti narrativi. Il ritorno alla
letteratura e la composizione de “La coscienza di Zeno”. La
struttura e i contenuti del romanzo. La storia di una
malattia. La vicenda, i personaggi, scrittura e psico-analisi,
malattia e salute. Lettura e analisi di alcuni brani tratti dal
romanzo: “La prefazione” del dottor S., il “Preambolo” di
Zeno, “Il fumo” (capitolo intero), “La morte del padre”
(capitolo intero).
La lirica Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, la cronologia e i
italiana tratti salienti delle opere. Il legame tra vita e poesia, la
prima stagione poetica. La nascita della “nuova poesia
italiana” del Novecento: il frammentismo. “L’Allegria”: la
struttura, i temi, la lingua e lo stile. Lettura e analisi delle
23poesie: “Notte di maggio”, “Il Porto Sepolto”, “Veglia”, “I
fiumi”, “Mattina”, “Soldati”, “San Martino del Carso”.
Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica. La
poetica montaliana: il procedimento allegorico, il
correlativo oggettivo, le scelte stilistiche. “Ossi di seppia”:
la struttura, i temi, lo stile. Lettura e analisi delle poesie: “I
limoni”, “Non chiederci la parola…” e “Spesso il male di
vivere ho incontrato”. “Le occasioni”: temi, significati, stile
della raccolta. “Satura”: struttura, temi, elementi stilistici.
Lettura e analisi della poesia “Ho sceso, dandoti il braccio,
almeno un milione di scale”.
Salvatore Quasimodo: la vita, la poetica ed il rapporto
con l’Ermetismo. Le due fasi della produzione: influenze,
caratteristiche generali, temi. Lettura e analisi dei testi: “Ed
è subito sera” e “Alle fronde dei salici”.
LATINA, 15/05/2019 PROF.SSA CHIARA MARIA VIVOLO
24ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: VIVOLO Chiara Maria
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
M. Montanari, Vivere nella storia, voll. 2-3, Editori Laterza, Bari, 2012.
ARGOMENTI/
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
in cui si articola la (Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo )
disciplina
Dalle speranze La seconda rivoluzione industriale
del nuovo secolo La rivoluzione dei trasporti e dell’industria siderurgica, la
al cataclisma svolta delle telecomunicazioni, le nuove fonti
della Grande energetiche.
guerra L’affermazione della borghesia: liberalismo e liberismo.
La rivoluzione proletaria. Dal liberismo al protezionismo.
La nascita della società di massa, la trasformazione delle
città. La società europea alla fine del XIX secolo:
nazionalismo e socialismo.
L’unificazione della Germania
g) L’ascesa della Prussia, la guerra austro-prussiana, la
guerra franco-prussiana.
h) La nascita del Secondo Reich.
Le grandi potenze tra assolutismo e liberalismo
g) La fine dell’impero asburgico e la nascita dell’impero
austro-ungarico.
h) La crisi dell’impero ottomano e la “questione d’Oriente”.
i) L’impero russo degli Zar. La Gran Bretagna e la Francia
di fine secolo.
j) Gli Stati Uniti tra liberalismo e protezionismo. La guerra
di secessione americana.
L’Italia tra Ottocento e Novecento
1.Sviluppo e crisi: i governi della Sinistra. Da Depretis a Crispi.
La Triplice Alleanza e la colonizzazione dell’Etiopia.
2.L’età giolittiana: Giolitti e il riformismo liberale, le riforme, il
decollo industriale, il divario tra Nord e Sud. La politica estera
e l’occupazione della Libia.
La Prima guerra mondiale
251.Contrasti e alleanze tra le potenze europee. Le cause
scatenanti del conflitto. Lo scoppio della guerra. 1917: l’anno
della svolta. 1918: l’ultimo anno di guerra.
2.La guerra di trincea, una guerra con caratteristiche nuove, la
propaganda.
3.L’Italia in guerra.
4.La fine della guerra: l’Europa ridisegnata. I trattati di pace e
le loro conseguenze. La nascita della Società delle Nazioni.
I regimi g) La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS
totalitari g) Un Paese arretrato. Dalle proteste alle rivolte: la
europei rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre.
◦ Lenin e la nascita della Russia sovietica. La Nuova
Politica Economica.
h) Il declino europeo e il primato americano
◦ La crisi degli imperi coloniali: il risveglio dei
nazionalismi. Il declino della centralità europea.
◦ Gli anni ruggenti dell’America. Dall’isolazionismo
al piano Dawes: dollari americani per l’Europa.
i) I regimi totalitari in Europa
◦ Il mondo nel primo dopoguerra. La Germania e la
nascita della Repubblica di Weimar. La crisi del
’29 negli Stati Uniti e in Europa.
◦ L’avvento del fascismo in Italia: l’ascesa al potere
di Mussolini, la politica sociale ed economica, la
propaganda, il rapporto con la Chiesa.
◦ La Germania dalla crisi al nazismo: dalla
Repubblica di Weimar al governo di Hitler, la
costruzione di uno Stato totalitario, il mito della
razza ariana e l’ideologia nazista, l’alleanza con
Mussolini.
◦ L’URSS di Stalin: la collettivizzazione
dell’agricoltura, l’industrializzazione forzata, il
regime totalitario.
La Seconda La Seconda guerra mondiale
guerra ◦ L’aggressiva politica estera di Hitler. L’occupazione
mondiale e i della Polonia e lo scoppio del conflitto. Le fasi
nuovi equilibri principali della guerra. Una “guerra totale”.
mondiali ◦ L’Italia nella Seconda guerra mondiale. La
Resistenza. La liberazione dell’Italia.
◦ La fine del conflitto: la bomba atomica e la resa del
Giappone. La guerra “ai civili”.
◦ I trattati di pace. Il processo di Norimberga.
Il mondo bipolare
26◦ USA e URSS padroni del mondo. La nascita
dell’ONU.
◦ La guerra fredda. La politica di armamento nucleare e
la guerra di Corea.
◦ L’Europa divisa e le alleanze economiche e militari.
◦ Le due Germanie.
L’Italia nel dopoguerra
◦ La ricostruzione materiale e politica.
◦ La nascita della Repubblica e della Costituzione.
Latina, 15/05/2019 PROF.SSA CHIARA MARIA VIVOLO
27ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: TOMASI Alessandra
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
Working with New Technology, Kiaran O’Malley, Pearson / Longman, Milano-
Torino, 2017.
ARGOMENTI/
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
in cui si articola la (Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo )
disciplina
Introductory -PLCs
Module -Moore’s Law
(get started with
Electronics and IT)
UNIT 6 ELECTRONIC COMPONENTS
-Applications of electronics
-Semiconductors
-The transistor
-Basic electronic components
-Silicon Valley
UNIT 7 ELECTRONIC SYSTEMS
-Conventional and integrated circuits
-Amplifiers
-Oscillators
-MEMs (Microelectromechanical Systems)
-How an electronic system works
-Analogue and digital
UNIT 8 MICROPROCESSORS
-What is a microprocessor?
-How a microprocessor works
-Logic gates
-The man who invented the microprocessor
-How microchips are made
UNIT 9 AUTOMATION
-How automation works
-Advantages of automation
-Programmable logic controller
-How a robot works
-Varieties and uses of robots
-Robots and manufacturing
28UNIT 12 COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMMING
-Systems software
-An introduction to programming
-Computer languages
Programming languages most in demand
-Alan’s Turing ‘intelligent machines’
UNIT 13⃰ APPLICATIONS
-Where computers are used
-Types of application
-The spreadsheet
-The database
-Database Management System
UNIT 14⃰ COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET
-Linking computers
-How the Internet began
-Internet services
-How the Internet works
Literature Module O. WILDE: The Picture of Dorian Gray and
the Aesthetic Movement
G. ORWELL: Animal Farm
I. ASIMOV: “Alexander the God” from the
collection “Gold” (1995, published
posthumously).
INVALSI training Education
Religion
LATINA, 15/05/2019 PROF.SSA ALESSANDRA TOMASI
29ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: LOFFREDI Lina
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi
“Matematica.verde 4B” con tutor - Zanichelli
ARGOMENTI/
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
in cui si articola la (Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo )
disciplina
MODULO Integrale indefinito: definizione e proprietà.
DIDATTICO Teoremi del calcolo integrale.
N° 1 Integrali Regole e metodi di calcolo di integrazione.
indefiniti Integrali immediati, per scomposizione, di funzioni composte,
per sostituzione, per parti, integrali di funzioni razionali fratte
MODULO Integrale definito: definizione e proprietà.
DIDATTICO Calcolo dell’integrale definito.
N° 2 Integrali Teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema della media.
definiti Il calcolo delle aree.
Estensione del concetto di integrale definito:integrali impropri di primo e
secondo tipo.
Saper calcolare gli integrali impropri.
Concetto di integrale definito e improprio
MODULO Il concetto di calcolo combinatorio.
DIDATTICO Disposizioni semplici e con ripetizione
N° 3 Il calcolo Permutazioni semplici e con ripetizione
combinatorio Funzione fattoriale
Combinazioni semplici e con ripetizione
Coefficienti binomiali
Binomio di Newton
MODULO Concetto di probabilità. Gli eventi
DIDATTICO Concezione classica di probabilità
N° 4 La Probabilità e il calcolo combinatorio
probabilità Concezione statistica della probabilità
Concezione soggettiva della probabilità
LATINA, 15/05/2019 PROF.SSA LINA LOFFREDI
30ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: INFORMATICA
DOCENTI: MATTACCHIONI Silvino – MELE Ciro
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
Informatica per istituti tecnici tecnologici vol. C. Autori LORENZI AGOSTINO /
MORIGGIA VITTORIO / RIZZI ANDREA. Editore Atlas
ARGOMENTI/
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
in cui si articola la (Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo )
disciplina
1) • Gli archivi
Organizzazio • I supporti fisici
• Le memorie di massa
ne degli
• Le copie di sicurezza
archivi e basi • La gerarchia delle memorie
di dati • Il software per la gestione degli archivi
• Organizzazione degli archivi
• Operazioni sui file
• Le basi di dati
• Limiti dell’organizzazione degli archivi tradizionali
• Organizzazione degli archivi mediante basi di dati
• I modelli per il database
• La gestione del database
2) Lo sviluppo • Il progetto
del progetto • La qualità per i prodotti software
• La metodologia
informatico
• La conoscenza degli obiettivi
• L’intervista
• L’analisi
• Le funzioni
• Il flusso dei dati
• La progettazione
• La transizione
• La documentazione
• Le prove
• La formazione
• L’esercizio
3) Le base di • Introduzione alle base di dati
dati • Modellazione dei dati
• Entità ed associazioni
• Gli attributi
31• Le associazioni tra entità
• Regole di lettura
4) La • I concetti fondamentali del modello relazionale
progettazione • Le regole di derivazione
• Le operazioni relazionali
concettuale: il
• Interrogazioni con più operatori
modello E/R • La normalizzazione delle relazioni
• I vincoli di integrità
5) L’SQL • Identificatori e tipi di dati
• Istruzioni del DDL di SQL
• Vincoli di integrità
• Indici e modifica delle tabelle
• Istruzione del DML di SQL
• L’istruzione SELECT
• Le operazioni relazionali in SQL
• Operazioni di Join
• Altre operazione relazionali
• Le funzioni di aggregazione
• Query e subquery annidate
• I predicati ANY, ALL, IN e EXIST
• Le viste
6) PHP e • Ripasso dei principali tag HTML
database in • Ripasso delle modalità di realizzazione dei layout di un sito con i CSS
• Le variabili e gli operatori PHP
rete
• Le istruzioni di controllo
• Gli array
• Interazione con l’utente mediante un form HTML
• Connessione ai database Mysql tramite script PHP
• Manipolazione dei database in rete
• Interrogazione dei database in rete
• Query con parametri forniti tramite form HTML
LATINA, 15/05/2019 PROF. SILVINO MATTACCHIONI
P ROF. CIRO MELE
32ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: SISTEMI E RETI
DOCENTI: DE BONIS Carlo – TARANTINO Patrizia
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
Sistemi e reti. Nuova Edizione Openschool - Volume 3 – HOEPLI (Luigi Lo Russo,
Elena Bianchi)
ARGOMENTI/
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
in cui si articola la • (Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo )
disciplina
Ripasso sul • protocolli: ARP, Ethernet, ICMP, IP, TCP e UDP
Networking • configurazione base apparati Cisco con Packet Tracer
• Configurazione RAID
• Cablaggio strutturato
• Livello Applicativo
• HTTP, DNS, FTP, protocolli per la posta elettronica
• configurazione: DHCP, DNS
Virtual Local • Richiami sulle LAN, dominio di collisione
Area • Definizione e vantaggi delle vlan
• protocollo 801.1Q
Network
• vlan tagged e untagged,
• tipi di porta: access e trunc
• fasi di ingress, forwording ed egress
• inter-vlan routing
• configurazione vlan apparati Cisco
Realizzazione di una vlan con Packet Tracer
Crittografia • Principi di crittografia e crittoanalisi
• algoritmi monoalfabetici
• algoritmi polialfabetici
• il principio di Kerckhoffs
• crittografia simmetrica (chiave privata condivisa, 3-DES, AES,
IDEA, AES)
• asimmetrica (chiave pubblica e privata, RSA, crittografia ibrida)
• firma digitale, certificati digitali, formato X.509, enti certificatori
• algoritmo di Cesare, Vigenerè, RSA in PHP (Lab.)
Sicurezza • Sicurezza nei sistemi informativi, dati, sistemi distribuiti
nelle reti • SSL/TLS, HTTPS
• TLS Record Protocol e handshake protocol
• Valutazione dei rischi e tipologia di minacce
33Virtual • Classificazione VPN
Private • Protocollo IPSEC
Network
Firewall • Packet filter Router
• Firewall Stateful inspection
• acl standard ed estese
• Application proxy
• Dmz
• Configurazione ACL Cisco
Wireless • Reti cellulari
• Standard IEEE 801.11
• Architetture wireless: ad hoc, infrastruttura
• cdma/ca, cts, rts
• crittografia nelle reti wireless (WEP, WPA, WPA2),
• Radius
Virtualizzazio • Virtualizzazione e Cloud
ne e Cloud
Latina, 15/05/2019 PROF. CARLO DE BONIS
P ROF.SSA PATRIZIA TARANTINO
34ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
DOCENTI: CIUFO Angelo – DALLA SENTA Dennis
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. Vol. 3
Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - Nuova Edizione Openschool - HOEPLI
ARGOMENTI /
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
U1: Introduzione agli automi a stati finiti. Rappresentazione degli
automi con i diagrammi degli stati. Costruzione del diagramma degli
GLI AUTOMI
stati. Rappresentazione con le tabelle di transizione.
U2: Statechart Diagrams in UML. Rappresentazioni di protocolli di
comunicazione semplici.
U1: I sistemi distribuiti. Benefici e svantaggi legati alla distribuzione.
SISTEMI U2: Architetture distribuite hardware: classificazione di Flynn. Cluster
DISTRIBUITI E e grid computing.
MODELLI
ARCHITETTURAL U3: Il modello Client-Server. Distinzione tra client e server.
I Architetture a livelli e strati. Architetture 1-tier, 2-tier e 3-tier.
U1: Il modello ISO/OSI e le applicazioni. Applicazione di rete e
identificazione mediante socket.
APPLICAZIONI DI
RETE U2: Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete. Architettura
client-server. Architettura peer-to-peer(P2P): P2P centralizzato, P2P
decentralizzato, P2P ibrido. Servizi offerti dallo strato di trasporto alle
applicazioni.
U1: Applicazioni e protocolli di rete. Le porte di comunicazione e
I SOCKET E LA concetto di socket.
COMUNICAZIONE
CON I U2: La connessione tramite socket. Famiglie di socket. Tipi di socket:
PROTOCOLLI stream socket e datagram socket.
TCP/UDP
35U3: Socket in linguaggio C: client e server TCP in C.
U4: Il protocollo UDP nel linguaggio C. Esempio di client e server
UDP in C.
U5: Socket in Java, unicast e multicast.
LAB: Esempi di realizzazione di client e server TCP e UDP in C;
differenti esempi implementativi di un server multiplo in C.
U1: Utilizzo dell’XML. La sintassi XML. Elementi dell’XML.
IL LINGUAGGIO U2: Redazione di un documento XML.
XML U3: Uso XML con PHP.
Accenno sull’uso di AJAX e XML.
Accenno sull’uso di JSON.
Altro
Latina, 15/05/2019 PROF. ANGELO CIUFO
P ROF. DENNIS DALLA SENTA
36ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
DOCENTI: PICOZZA Laura – TARANTINO Patrizia
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
Gestione Di Progetto Organizzazione D’impresa – Juvenilia Scuola
ARGOMENTI/
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
in cui si articola la (Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo)
disciplina
GESTIONE DI Il progetto: definizione e caratteristiche
PROGETTO Project Management
Pert e Gantt
Fattibilità e analisi dei requisiti
Pianificazione
Metriche del progetto tecnico
Valutazione di costi e qualità
Ciclo di vita
ELEMENTI DI Informazione e organizzazione
ECONOMIA ED Microstruttura e macrostruttura
ORGANIZZAZI Le strutture organizzative
ONE
AZIENDALE
SICUREZZA E Normativa di sicurezza sul lavoro
RISCHI Concetti e figure della sicurezza
Rischio da videoterminali ed elettrico
LA QUALITA’ La qualità totale e il Total Quality Management
TOTALE Enti di formazione e norme ISO 9000
Latina, 15/05/2019 PROF.SSA LAURA PICOZZA
P ROF.SSA PATRIZIA TARANTINO
37ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
PROGRAMMA CONSUNTIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: ESPOSITO Antonietta
CLASSE: V SEZ. F INF
Contenuti
TESTO IN ADOZIONE e/o MATERIALE DIDATTICO:
– iReligione di Cioni – Masini – Pandolfi – Paolini
– Presentazioni realizzate tramite il software Power-Point
– Documenti Santa Sede
– Le encicliche sociali
– Articoli di giornale
– Film e documentari
ARGOMENTI/
MODULI UNITA’ DIDATTICHE
in cui si articola la disciplina (Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo )
L'amore umano e la La morale cristiana. Libertà, volontà e coscienza.
famiglia Il corpo. Morale della vita fisica, sessuale e familiare.
Gesù e l'etica dell'amore.
Etica della vita e La bioetica e il rapporto scienza-morale: il valore della
della morte vita umana e il suo rispetto, la procreazione assistita,
l'aborto, l'eutanasia, la pena di morte.
Ecumenismo e Le religioni e la morale.
rapporto con le
religioni
La Chiesa e i Il concetto di totalitarismo secondo il pensiero di E.
problemi del mondo Levinas e H. Arendt.
moderno Il diario di Etty Hillesum. 1941-1943
La Chiesa e i totalitarismi del XX secolo.
Economia e società La dottrina sociale della Chiesa: il lavoro umano e il suo
valore etico, solidarietà, sussidarietà e bene comune.
Latina, 15/05/2019 PROF.SSA ANTONIETTA ESPOSITO
38Puoi anche leggere