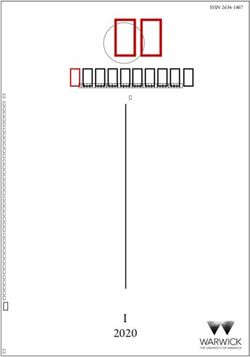CANDYMAN: LA RECENSIONE DEL FILM HORROR DI NIA DACOSTA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Candyman: la recensione del film horror di Nia DaCosta Anthony McCoy è un artista che vive a Chicago assieme alla sua ragazza, Brianna Cartwright, che dirige una galleria d’arte moderna. Il giovane uomo è in conclamata crisi creativa, e di fatto viene mantenuto dalla compagna, ma gli giunge un aiuto inaspettato. Il fratello di Brianna, infatti, una sera si ferma a casa della coppia assieme al proprio compagno, e racconta quella che sembra essere una leggenda metropolitana: negli anni novanta una giovane donna, Helen Lyle, giunge nel quartiere per compiere delle ricerche sull’esistenza di Candyman, mitico uomo nero della zona, presunto autore di innumerevoli delitti.
Helen tuttavia perde il senno, rapisce un bambino che cerca di uccidere gettandolo nel fuoco, ma il piccolo viene salvato in extremis, mentre lei si getta tra le fiamme, muorendo in modo atroce. Anthony rimane turbato dal racconto, e comincia a fare delle ricerche, indagando in ciò che rimane del vecchio quartiere di Cabrini-Green, dove incontra William Burke, il proprietario di una lavanderia che gli racconta ulteriori dettagli della storia raccapricciante. In particolare, secondo William, chiunque nomini per cinque volte consecutive il nome “Candyman” di fatto evoca il suo spirito, venendo da questi massacrato sul posto senza pietà. Anthony e Brianna hanno poi la pessima idea di provare il rituale, ma sul momento sembra non acacdere niente. Il protagonista rimane comunque affascinato dal racconto, e concepisce un’opera da esso ispirata, che viene esposta nella galleria d’arte della compagna, dove tuttavia riceve critiche per nulla lusinghiere. Gli eventi cominciano subito a precipitare. I primi a morire macellati sono un collega di Brianna e una sua fiamma del momento, che evocano per gioco Candyman davanti all’opera di Anthony. Nel frattempo il protagonista comincia a subire una mutazione fisica, che comincia da una mano, punta da un’ape mentre si aggira tra gli edifici fatiscenti di Cabrini-Green. Candyman: un horror nel quale trionfa il mito del doppio In questo film si scontrano frontalmente forze contrapposte e inconciliabili. Il primo contrasto che emerge con forza è quello urbano. Da un lato ci sono i vetusti edifici fatiscenti e polverosi della vecchia Cabrini-Green, pieni di graffiti, murales e orrori dimenticati. Dall’altra i moderni e luccicanti grattacieli costruiti
sull’antico quartiere, che un rapido processo di gentrificazione avrebbe dovuto riscattare, lanciandolo verso un radioso futuro di prosperità e benessere. Aprendo quindi un secondo contrasto: tra la povertà materiale del passato e la ricchezza del presente. C’è poi lo scontro frontale tra il mondo dei bianchi e quello dei neri, all’inizio del film sottotraccia, ma che cresce inesorabilmente durante il racconto, diventandone alla fine la chiave di lettura principale. Lo stesso protagonista comincia poi a sdoppiarsi, perché la sua identità comincia a essere lentamente ma inesorabilmente contaminata da quella di Candyman, cambiamento che verso la fine del film traspare chiaramente anche a livello fisico, dato che metà del suo corpo comincia a marcire. Il fatto poi che Candyman possa essere evocato solo davanti a uno specchio è emblematico della sua natura e gli stessi titoli di testa sono “specchiati”… Candyman: un film semplice e lineare che si lascia guardare volentieri Il tema centrale della pellicola è il rapporto conflittuale tra bianchi e gente di colore. I protagonisti sono di colore, i vecchi (e poveri) abitanti di Cabrini-Green sono di colore, ma i moderni galleristi (quelli di successo) sono bianchi, così come le forze dell’ordine, dominate dal suprematismo bianco. Anthony è in crisi di ispirazione, la sua compagna fatica a trovare una posizione di successo e di fatto è subalterna al suo socio bianco, ma è la comparsa di Candyman e rimescolare le carte. Di fatto questo personaggio mitico (e di colore) fornisce una nuova spinta creativa ad Anthony, avviandolo verso il successo, grazie agli efferati omicidi che ben presto avvengono attorno alle sue opere.
La stessa Brianna, grazie a questi tragici fatti, ha la possibilità di collaborare con espositori molto famosi. In altre parole, il successo della gente di colore può avvenire solo tramite la mattanza dei bianchi, che sono i cattivi di turno. Candyman stesso, alla fine, si rivela essere niente altro che la personificazione di tutte i soprusi subiti dalla comunità di colore per colpa dei bianchi. In esso vivono molti personaggi del passato, ingiustamente massacrati dalla comunità WASP, razzista, sadica e sfruttatrice. E vogliono vendetta. Il film è molto curato, anche dal punto di vista visivo. In particolare, gli ambienti del nuovo quartiere sono ricercati nei minimi dettagli, ma la loro perfezione formale non impedisce all’orrore di abbattersi sui suoi abitanti. La storia scorre accattivante, partendo da un punto di vista neutro, dove tutto sembra essere perfetto, impeccabile: i protagonisti sono una giovane coppia di artisti di colore apparentemente lanciati verso il successo, il fratello di lei è gay, il suo compagno è un bianco. Tutto perfettamente politically-correct. Ma sotto l’apparenza si nasconde l’orrore, che cresce piano piano lungo tutta la storia, fino a esplodere nel finale. Che forse è il punto debole del film, perché si cade nei luoghi comuni più stucchevoli. Bianchi tutti cattivi contro uomini di colore tutti vittime. E la vendetta, unica dimensione esistenziale possibile per questi ultimi, trionfa. Vabbè. Comunque il film nel suo complesso funziona bene. E di fatto è una apprezzabile continuazione del primo Candyman, del 1992, di Candy Rose, la cui storia è la base di partenza del film. In attesa del prossimo sequel…
Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: la recensione del film commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi Giovanni (Antonio Albanese) e Monica (Paola Cortellesi) sono due persone agli antipodi. Lui è un intellettuale immerso nell’ambiente della sinistra
radical-chic, impegnato nella realizzazione di un ardito quanto improbabile centro culturale in una periferia degradata, che dovrebbe servire ad aggregare ed elevare culturalmente il popolo, ma che in realtà per alcuni pare essere una mera opportunità per fare soldi, sotto la copertura dell’erudizione delle plebi. Lei fa parte del popolo teoricamente bisognoso di essere elevato, ma della cultura se ne sbatte, perché – a suo dire – non dà da mangiare. Del resto ha ben altre gatte da pelare: si ritrova incarcerata per colpa delle sue due sorelle gemelle, Pamela e Sue Ellen (le incredibili Alessandra e Valentina Giudicessa), cleptomani inveterate, che hanno nascosto la loro refurtiva nella sua pizzeria. Così chiede aiuto al suo ex amico, Giovanni, il quale diventa suo tutore legale e ottiene, grazie ai suoi appoggi politici, la conversione della pena detentiva di lei nella prestazione di servizi sociali, da effettuarsi nella parrocchia di Don Davide (Luca Argentero), centro che aiuta i disagiati, adiacente al centro culturale in procinto di essere inaugurato. Entrambi sono poi in contatto con i rispettivi pargoli, che vivono in terra straniera. Il figlio di Chiara, Alessio (Simone de Bianchi) lavora come lavapiatti e cameriere in un pub londinese, mentre la figlia di Giovanni, Agnese (Alice Maselli), frequenta l’università, sempre nella capitale britannica. Insomma una storia nella quale si confrontano realtà opposte, che forniscono mille opportunità per creare situazioni grottesche. Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: non solo una commedia In questa pellicola l’aspetto comico coesiste con la volontà di mostrare le problematiche sociali delle periferie urbane.
Il problema della carenza di alloggi, la violenza sulle donne, la mancanza di lavoro, la violenza endemica nei bassifondi, sono tutti temi che fanno capolino nella narrazione, sia pure in tono scanzonato e forse alle volte un po’ troppo stereotipato. Indubbiamente è presente una critica corrosiva nei confronti dell’ambiente della sinistra radical chic, bene rappresentato dall’ex di Giovanni, Luce (Sonia Bergamasco), persona benestante che vive in una dimensione parallela, avulsa dal mondo reale della povera gente, ma soprattutto dalla nuova compagna del protagonista, Camilla (Sarah Felberbaum), il cui impegno sociale è di facciata, in quanto di fatto è interessata solo al denaro messo in circolazione dagli sponsor per realizzare progetti a presunto scopo sociale. Lo stesso Giovanni porta dentro di sé tutte le contraddizioni connesse da una progettualità che dovrebbe usare la cultura per creare occasioni di aggregazione e crescita civica per il sottoproletariato urbano, ma che usa linguaggi distanti anni luce dagli abitanti delle periferie. Non per niente, Giovanni passa interi pomeriggi per cercare la giusta sfumatura di colore per i muri del centro culturale, o per trovare il nome corretto per le pietanze preparate per la cerimonia di inaugurazione, sotto l’occhio vigile e pensoso di intellettuali (o presunti tali) evidentemente alieni alla realtà delle borgate di periferia. Tuttavia queste attività muovono un sacco di soldi, e molti di questi finiscono nelle tasche delle maestranze e degli artisti, per cui in realtà la cultura dà da mangiare, come Giovanni ricorda a Monica durante una delle loro accese discussioni. Con visioni del mondo a distanza siderale l’uno dall’altra, i due protagonisti sono tuttavia fortemente attratti l’uno dall’altra, e la passione alla fine travolge ogni resistenza
intellettuale, trovando sfogo nell’inevitabile amplesso nel dormitorio delle suore nella parrocchia di Don Davide. Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: una commedia divertente, ottima per passare un paio d’ore spensierate Il film si fa vedere volentieri, e non si può non apprezzare anche diverse citazioni cinematografiche veramente carine, vere chicche per i cinefili capaci di vederle. Graditi omaggi a Shining, Vacanze Romane e Il Settimo Sigillo. Questo secondo capitolo di Come un Gatto in Tangenziale è più impegnato del primo, sia pure sempre in modo leggero e scanzonato, e forse per questo è ancora più apprezzabile, riuscendo nell’impresa di realizzare un sequel all’altezza, operazione per niente facile né scontata. In definitiva il film ha un messaggio positivo: si può convivere anche avendo visioni del mondo differenti, senza bisogno di rinunciare alla propria identità o di dovere cambiare per piacere all’altro. La cultura può essere sia una mangiatoia per opportunisti, che un’opportunità per riflettere, stare insieme e aiutarsi l’un l’altro. E ognuno può scegliere da che parte stare. Apprezzabile anche l’ampia gamma di improbabili personaggi messi in scena, che riempiono di simpatia la pellicola. Inevitabile qualche caduta di troppo negli stereotipi più comuni, ma forse è impossibile riuscire a evitarlo, in una commedia di questo tipo. Speriamo che il probabile terzo capitolo della saga sia all’altezza del secondo…
Josep: il grande cinema d’animazione d’autore torna al Visionario dal 30 agosto al 1°settembre! Josep è una celebrazione del potere espressivo del disegno e di una vita straordinaria, quella dell’illustratore catalano Josep Bartolí (Barcellona 1910 – New York 1995). A firmarlo Aurel, pseudonimo di Aurélien Froment, vignettista francese che tra gli altri ha lavorato per Le Monde. Miglior film d’animazione ai Cesàr 2021 e agli European Film Awards, JOSEP sarà in programma al Visionario dal 30 agosto al
1° settembre alle ore 19.15. La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema. Il film di animazione è ambientato nel Febbraio del 1939. I repubblicani spagnoli si dirigono in Francia per fuggire dalla dittatura di Franco. Il governo francese confina i rifugiati in campi di concentramento, dove si riesce a malapena a soddisfare il bisogno di igiene, acqua e cibo. È in uno di questi campi che due uomini, separati dal filo spinato, diventeranno amici. Uno è una guardia, e l’altro è Josep Bartolí, un illustratore che combatte il regime franchista. Un’affascinante lezione di storia, un film sulla memoria e sul potere fondativo degli incontri capaci di alterare il corso di una vita. Per la programmazione completa e sempre aggiornata consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario, al cinema all’aperto presso il giardino Loris Fortuna e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2). Becket: recensione del film Netflix di Ferdinando Cito Filomarino con John David
Washington Becket (John David Washington) è un cittadino statunitense in viaggio in Grecia con la compagna, April (Alicia Vikander). I due decidono di lasciare Atene, scossa da violenti tumulti popolari, per addentrarsi all’interno del paese. Durante un viaggio notturno in macchina, Becket, causa un improvviso colpo di sonno, perde il controllo del veicolo, che si ribalta fuori strada e si schianta contro un’abitazione, sfondandone un muro. Pesto e sanguinante, riesce a trascinarsi fuori dall’abitacolo, per scoprire che April è stata violentemente sbalzata fuori dall’auto, rimanendo uccisa. Prima di perdere i sensi, si accorge della presenza di una donna con un bambino, che tuttavia, inspiegabilmente, scappano. Ritorna successivamente a piedi sul luogo dell’incidente, ma viene aggredito da una donna che gli spara, centrandolo a un
braccio. Con suo grande sgomento, scopre ben presto che chi lo vuole fare fuori è in combutta con la polizia. Comincia la sua fuga nell’affascinante ma aspra campagna greca, ferito, tallonato dai suoi inseguitori, che non guardano in faccia a nessuno pur di fargli la pelle… Becket: un uomo solo contro tutti Questa pellicola è la quintessenza della situazione “l’uomo sbagliato nel posto sbagliato al momento sbagliato”. Causa una serie di fattori del tutto imprevedibili ed esterni alla sua volontà, Beckett si trova a essere testimone di qualcosa che non doveva vedere, e della quale all’inizio non si rende neanche conto. Solo, ossessionato dal senso di colpa per avere causato la morte della sua compagna, si trova a cercare di sopravvivere in un ambiente dove non sa di chi fidarsi, dove chiunque può essere un suo nemico. Non conosce la lingua dei nativi, non conosce le strade, non ha idea di quello che sta succedendo. Ben presto la sua fuga disperata lo porta nei centri urbani. Il passaggio dalla campagna alla città non cambia molto nella sua situazione: entrambi gli ambienti sono ostili e incomprensibili. Lentamente, comunque, emergono elementi che gli permettono di farsi un’idea di quello che sta succedendo. Il fatto di capire di trovarsi all’interno di un complicato intrigo internazionale non gli è tuttavia di molto aiuto, anzi. Mentre la storia si dipana, Beckett deve lottare per sopravvivere, combatte a mani nude contro sicari e forze dell’ordine, viene più volte ferito, trovandosi sempre più immerso in una situazione sempre più complicata e pericolosa.
Beckett: una storia coinvolgente che però fatica a mettersi in moto Il film comincia con un ritmo forse anche troppo lento, mostrandoci la classica situazione in cui una coppia attraversa dei temporanei momenti di difficoltà, mentre i difficili eventi vissuti da una Grecia attanagliata dalla crisi economica scorrono sullo sfondo. I dialoghi minimalistici e il modo di fare un po’ impacciato del protagonista non aiutano di certo, per cui all’inizio chi si aspetta il classico action movie può rimanere disorientato, anche perché accade poco o niente. Banali scaramucce e riappacificazioni tra una coppia di cui poco o nulla ci è dato di sapere, a parte i nomi dei protagonisti. Le cose cominciano a cambiare dopo l’incidente in macchina, ma il film nel suo complesso fatica a mettersi in moto. Certo, quando cominciano a volare i proiettili e il mondo sembra crollare addosso a Beckett è difficile non immedesimarsi nel protagonista. In questo film si parla poco, cosa può essere un punto di forza, a patto che non si voglia comprendere razionalmente tutti i dettagli di quanto sta accadendo. Perché le informazioni vengono fornite con il contagocce, e solo alla fine lo spettatore si può fare un quadro abbastanza chiaro di quello che sta succedendo. Cosa che non tutti gradiscono. I gusti son gusti, del resto. Fatte queste premesse, bisogna dire che una volta che la storia comincia agirare a pieno regime, è veramente difficile non farsi trascinare le racconto. Beckett: un John David Washington molto più credibile di quello che abbiamo visto in Tenet Tutto il film ruota attorno a Beckett, interpretato da un John David Washington molto più convincente di quello che vestiva i
panni del protagonista senza nome di Tenet. Certo, mentre Beckett è un film con una storia lineare e legata al nostro presente, Tenet è un guazzabuglio fantascientifico spazio-temporale senza forma, nel quale perdersi è facilissimo. Una differenza non da poco. I protagonisti delle due pellicole hanno dei tratti simili, probabilmente dovuti alle peculiarità attoriali di Washington, ma in Beckett il protagonista è molto più credibile e appropriato all’assurda situazione che si trova a dover affrontare. Questo film ha anche dei tratti politici, che ripropongono lo scontro frontale tra destra e sinistra nello stanco Occidente di inizio millennio, con sullo sfondo il disastro sociale provocato dall’austerità imposta dalle istituzioni europee, che in Grecia ha fatto danni considerevoli. E in questo dramma la classica contrapposizione tra città evoluta e campagna arretrata, presente più o meno in moltissime storie, perde forza fino a svanire. Ovunque scappi, Beckett viene inseguito dai suoi persecutori. Ma è nella città che viene trovato il bandolo della matassa. Insomma questa pellicola è un interessante mix di elementi coinvolgenti, e, a patto di perseverare nella visione, perché la prima parte non è di certo entusiasmante, può regalare forti emozioni allo spettatore. Anche perché, diciamolo pure, è difficile non immedesimarsi nel protagonista di questo tipo di storie, dove un un uomo si trova a lottare da solo contro tutti. Magie del cinema…
Pozzis, Samarcanda: recensione del film di Stefano Giacomuzzi con Alfeo Carnelutti (Cocco) Pozzis, Samarcanda è un film non categorizzabile in maniera precisa, situandosi in una zona indefinita compresa tra il road movie, il film autobiografico e il documentario di viaggio. I due protagonisti sono Cocco e Stefano. Due personalità e due esperienze di vita agli antipodi. Cocco è un biker settantenne, con un passato da emigrante e corridore motociclistico. Negli anni ottanta subisce un grave incidente di gara che lo costringe in ospedale per un lungo periodo, e sviluppa il morbo di Chron. Si trasferisce a Pozzis,
un paesino disabitato sulle montagne friulane, in provincia di Udine. Comincia ad organizzare i Cocco Meeting, motoraduno che ben presto diventa popolarissimo e contribuisce a regalare una seconda vita allo sperduto agglomerato di case. Nel 1999 viene accusato di un omicidio, del quale si dichiara subito colpevole. Una vicenda dai contorni molto controversi, tanto che Cocco riceve una condanna mite, dieci anni di reclusione, dei quali ne sconta otto. Nel 2018 parte per Samarcanda. Unici compagni di viaggio: la sua amata motocicletta (il cui motore è più vecchio di lui di cinque anni), Stefano e una striminzita troupe cinematografica. Il film parte da qui. Stefano ha solo ventidue anni ed è fresco di studi cinematografici. Dal loro incontro è nata l’idea di girare il film, una sorta di racconto di viaggio nel quale non ha neanche importanza la destinazione, come ci viene fatto sapere nelle prime battute del film, girate durante un Cocco Meeting a Pozzis, nel quale si vendono magliette per finanziare la spedizione. Pozzis, Samarcanda: un racconto dove convivono realtà apparentemente inconciliabili In effetti tra Stefano e Cocco c’è una differenza abissale di età, esperienze vissute e visione del mondo. La principale motivazione di Stefano nell’imbarcarsi nell’avventura è di girare un film, mentre per Cocco si tratta di vincere una sfida con sé stesso, per vedere cosa è in grado di fare alla sua età e con tutti i suoi problemi (considerando anche che la sua moto è più vecchia di lui). Anche tra Pozzis e Samarcanda la differenza è immane: il luogo di partenza è un paesino disabitato disperso nelle montagne friulane, Samarcanda è un luogo mitico e famosissimo, lontano oltre seimila chilometri. Un viaggio difficile, quindi, sotto molteplici punti di vista: una coppia eterogenea che affronta un viaggio lunghissimo, in terre lontane, sia in termini di distanza fisica che di differenza
culturale, su strade spesso al limite dell’inutilizzabilità, con una motocicletta più vecchia del suo pilota settantenne, per altro in condizioni fisiche non certo eccelse. Ma nonostante tutto e nonostante tutti, l’incredibile impresa riesce. Il film racconta tutte le tappe principali di questo viaggio, ma lo fa in maniera minimalistica, e questo lo rende ancora più credibile e coinvolgente. Perché sia Cocco (Alfeo Carnelutti) che Stefano interpretano sé stessi, senza maschere e senza filtri. E forse non potrebbe essere diversamente, visto che non stiamo parlando di attori professionisti. Niente dialoghi ricercati o fini citazioni, niente effetti speciali. Solo fatti accaduti, ripresi in tempo reale, probabilmente senza il tempo di costruire scene complesse. Probabilmente improvvisando, adattandosi agli imprevisti e alle situazioni contingenti. Pozzis, Samarcanda: il racconto di un’avventura e di una improbabile amicizia capace di superare ogni difficoltà Il viaggio tra Pozzis e Samarcanda mette a dura prova il rapporto tra Stefano e Cocco. Ma alla fine il loro legame ne esce accresciuto e cementato, perché entrambi, ognuno a modo loro, si rendono conto di avere bisogno uno dell’altro. Quella che all’inizio è una convivenza forzata, diventa un’occasione di arricchimento reciproco, e permette ai due di portare a termine l’impresa, superando anche il malore che costringe Cocco a letto per diversi giorni. Forse è proprio Cocco il vero protagonista del film. Una persona semplice, dall’esperienza di vita ricchissima, dalla forza interiore incredibile, che gli ha permesso di superare ostacoli impensabili. Con tante piccole storie da raccontare, tratte dalle sue personali esperienze, che descrive con il suo linguaggio semplice, ma efficace. In particolare, durante tutta la pellicola, Stefano cerca di strappare a Cocco la verità sui fatti oscuri che lo hanno portato a passare
tanti anni della sua vita in carcere. All’inizio il biker non vuole parlarne, ma lentamente la sua resistenza si sgretola, e alla fine si lascia sfuggire più di qualcosa, per la gioia degli spettatori. E di Stefano. Ma anche quest’ultimo si accorge che, volente o nolente, deve rinunciare a qualcosa. L’ossatura del film non può derivare dal viaggio fisico in sé: non c’è tempo per godersi gli incredibili paesaggi, esplorare città tanto lontane e differenti dalle nostre, indugiare sugli innumerevoli incontri con culture diverse. Bisogna andare avanti, a testa bassa, nonostante la stanchezza, gli imprevisti, le difficoltà. Pozzis, Samarcanda: un film che fa della semplicità e immediatezza il suo punto di forza Insomma stiamo parlando di una pellicola molto semplice, quasi improvvisata, donchisciottesca, realizzata con mezzi esigui. Ma fatta con passione, capace di dare molto allo spettatore che si lasci trasportare nel racconto. Che mette in scena la forza dell’amicizia e della volontà, capaci di trasformare un sogno in realtà. Un film nel quale il viaggio dalla sperduta Pozzis alla mitica Samarcanda è – alla fine – solo un pretesto. Anche perché, come ci viene fatto sapere, “a Samarcanda non c’è niente”. Ma non importa. Perché ci sono le vite dei protagonisti alla base del racconto. In particolare quella di Cocco, che nel film fa anche un viaggio nella sua memoria, raccontandoci frammenti delta sua vita, di certo non ordinaria. Ed è proprio Cocco che nel film, grazie alla sua gestualità spontanea, riesce a superare ogni barriera culturale e linguistica, nonostante di certo non eccella in dialettica. Il film indugia spesso sui paesaggi spesso esotici attraversati (Bulgaria, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, per citarne qualcuno), ma questo non è l’aspetto prevalente.
Quella che emerge è la componente umana, nel senso più profondo del termine, senza i filtri di complesse narrazioni o spesso inutili effetti speciali. Un film che mette in scena anche l’impresa incredibile portata a termine da tre persone, con una motocicletta e un furgone d’appoggio. Stefano Giacomuzzi (che è anche regista) e Alfeo Carnelutti (Cocco) mettono in scena sé stessi, con l’aiuto di Matteo Sacher (addetto alle riprese). Il film è stato inizialmente autofinanziato, ottenendo poi il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission, del Fondo Audiovisivo FVG e dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (il film è in lingua friulana, sottotitolato in italiano). Pozzis-Samarcanda ha vinto il premio come migliore film all’Edera Film Festival di Treviso. Complimenti ragazzi! La Casa in Fondo al Lago: la recensione del film horror subacqueo di Julien Maury e Alexandre Bastillo
Ben (James Jagger) e Tina (Camille Rowe) gestiscono un canale YouTube specializzato nell’esplorazione di edifici abbandonati, alla ricerca di fenomeni paranormali. Dopo avere fatto delle riprese in un vecchio orfanotrofio in Ucraina, i due giovani si spostano sulle sponde di un lago nella Francia. La località, lungi dall’essere un luogo sperduto e misterioso, si rivela invece essere una località turistica affollatissima. Quando la possibilità di girare un video interessante sembra essere ormai sfumata, incontrano casualmente un abitante del posto, che li porta in una remota estremità del lago, sotto la cui superficie si trova una casa, a circa quaranta metri di profondità. I due si immergono assieme a un drone telecomandato, seguendo una scalinata che li conduce davanti al vecchio edificio. Dopo avere superato il cancello d’ingresso, ancora in piedi, i ragazzi si accorgono che all’interno del perimetro della recinzione della casa non ci sono pesci, presenti invece in gran numero al suo esterno.
Cosa ancora più strana, la porte e le finestre sono chiuse con imposte metalliche, ma dopo attenta ricerca riescono a trovare un varco per passare. Superato l’entusiasmo iniziale, i due si rendono conto che inspiegabilmente tutti gli oggetti sono ancora perfettamente conservati, nonostante siano stati immersi nelle acque del lago per decenni. Ma il vero orrore li attende nello scantinato del vecchio edificio… La Casa in Fondo al Lago: l’idea originale che rende apprezzabile la pellicola è anche un suo limite Il film si presenta nelle prime inquadrature come il classico found footage, con i due protagonisti intenti a riprendersi vicendevolmente con le loro GoPro, nel vetusto edificio perso nella campagna ucraina. L’arrivo in terra francese cambia il punto di vista della telecamera, che diventa anche esterno ai due protagonisti, cosa che può lasciare inizialmente perplessi. Di fatto, dopo l’immersione nelle acque del lago, ovverosia per due terzi abbondanti del film, la storia narrata è sovrapponibile al tempo reale vissuto dallo spettatore, visto anche che viene dichiarato che i due ragazzi hanno solo un’ora d’aria nelle bombole, e assistiamo al cont down verso il loro esaurimento. L’idea di realizzare un film in cui il tempo narrato e quello vissuto dallo spettatore sono coincidenti è già stata utilizzata, basti pensare al recente Oxigène, di Alexandre Aja, del 2021, mentre quella di ambientare un film horror in cui la casa stregata è sott’acqua è originale (nella serie TV Curon il mondo subacqueo non viene mai esplorato), e rende la lunga sequenza in immersione molto interessante, almeno all’inizio. Lasciando stare l’ambiguità del punto di vista della telecamera, le scene di esplorazione iniziale della casa sono indubbiamente coinvolgenti e inquietanti. Lo spettatore sa che deve succedere qualcosa – in definitiva è andato a vedere un film dell’orrore – e le riprese subacquee sono ricche di punti oscuri, giochi di ombre e
dettagli interessanti: si rimane con il fiato sospeso a lungo. Ma quando cominciano le sequenze più propriamente soprannaturali e orrorifiche, le cose non funzionano altrettanto bene, probabilmente anche proprio per l’impaccio creato dall’ambiente subacqueo, che rallenta e rende meno credibili tutti i movimenti e, almeno in alcuni passaggi, confonde lo spettatore, rendendo meno comprensibile quanto accade sullo schermo. La Casa in Fondo al Lago: tanto di cappello per il coraggio di provare una formula nuova, ma il risultato non è eccelso Lasciando stare anche le problematiche legate all’ambiente subacqueo, ve detto che la sceneggiatura di questo film non è strepitosa. I due protagonisti sono poco caratterizzati, di loro si sa solo che provengono da New York, lui è quello più appassionato al successo del canale YouTube, mentre lei sembra essere molto più interessata alla loro vita di coppia al di fuori del mondo di Internet. Forse troppo poco per immedesimarsi nei due personaggi. Anche la storia di quello che è successo nel passato per rendere la casa maledetta viene spiegato poco e male, quasi didascalicamente. Forse sarebbe stato meglio se dei trascorsi della casa maledetta non fosse stato detto niente, lasciando tutto alla fantasia dello spettatore. In definitiva stiamo parlando di un film molto semplice, originale dal punto di vista tecnico, vista la sua ambientazione subacquea, molto tradizionale per altri. La storia ripropone la classica contrapposizione tra città e campagna, facendoci vedere i soliti giovani visitatori dell’alta borghesia metropolitana che subiscono le nefaste conseguenze di un’improvvida visita nelle campagne arretrate e neopagane. Mettendo in scena l’ancora più classica riproposizione del male che si nasconde nel buio sottosuolo, opposto alla luce celeste, scontro manicheo – questo bisogna dirlo – riproposto in maniera ancora più suggestiva grazie all’ambiente subacqueo, con la luce solare che filtra verso l’oscuro fondale del lago.
Una pellicola che comincia bene, ma che perde forza e credibilità quando comincia la parte più propriamente orrorifica, forse per un eccesso di entusiasmo e troppa fretta e faciloneria nel raccontare la storia. Peccato. Rimane comunque il plauso ai due registi per avere almeno cercato di fare qualcosa di originale, affrontando indubbi problemi tecnici, con un budget di certo non stratosferico. E complimenti per il finale, per niente prevedibile. The Suicide Squad – Missione Suicida: la recensione del film di super-antieroi di James Gunn
Bloodsport (Idris Elba) guida una squadra di improbabili super-eroi in una missione suicida nell’isola di Corto Maltese, dove governano lo spietato dittatore Silvio Luna e il suo braccio destro Mateo Suarez. Obiettivo: fare sparire ogni traccia del misterioso progetto Starfish, comandato dal bieco Thinker. L’eterogeneo gruppo è formato dallo psicopatico vigilante Peacemaker (John Cena), la giovane e romantica ammaestratrice di topi Ratcatcher II (Daniela Melchior), il complessato Polka-Dot Man, capace di lanciare ondate di mortali punti luminosi, e infine l’ibrido uomo-squalo Nanaue, che sotto un fisico indistruttibile e poderoso nasconde una mente infantile. Mentre un secondo team suicida attira i difensori dell’isola, venendo rapidamente spazzato via, i nostri (anti)eroi riescono a infiltrarsi nella giungla, riunirsi con la resistenza e penetrare nella capitale dell’isola, dove si trova il laboratorio fortificato nel quale si svolgono gli atroci esperimenti legati al progetto Starfish. Nel viaggio verso il loro obiettivo, il team si riunisce con i superstiti del secondo gruppo suicida: Harley Quinn (Margot Robbie) e il colonnello Rick Flag (Joel Kinnaman). Mentre i nostri (anti)eroi si lanciano all’assalto del munitissimo laboratorio, attirando il grosso delle truppe governative, i ribelli assaltano la sede del governo, lasciata sguarnita. Ma nessuno ha ancora fatto i conti con la creatura aliena custodita nei sotterranei del laboratorio, che costituisce la ragione d’essere del progetto Starfish… The Suicide Squad – Missione Suicida: il trionfo degli antieroi Il titolo di questo secondo episodio di Suicide Squad
differisce dal primo (Suicide Squad, del 2016, di David Ayer) solo per l’aggiunta dell’articolo “The”, ma i due film hanno un’anima completamente differente. The Suicide Squad forse costituisce una nuova tappa nell’evoluzione dei film di supereroi, una fase nella quale nessuno si prende troppo sul serio e l’autoironia è dominante. A cominciare dagli improbabili super-poteri degli (anti)eroi. Questo è particolarmente evidente nella squadra suicida inviata come esca per attirare i difensori di Corto Maltese. Oltre al colonnello Rick Flag e a Harley Quinn, essa comprende una barcollante donnola antropomorfa di nome Weasel (la prima a lasciarci le penne ancora prima che comincino gli spari), il ridicolo TDK, che può fare il solletico ai suoi nemici grazie agli arti removibili e volanti, l’aliena Mongal, che nonostante la buona volontà finisce per fare più danni ai suoi compagni che al nemico, Capitan Boomerang, che riuscirà a lanciare ben poche delle sue armi volanti, il bieco Savant, che dietro la scorza di duro combattente si dimostra essere un avvilente vigliacco, il buon Javelin, la cui unica funzione sembra essere quella di morire per dare a Harley Quinn la sua arma, dopo avere bofonchiato qualche frase con marcato accento teutonico, e il goffo Blackguard, che si rivela essere un emerito pagliaccio. Anche nella squadra principale non si scherza in fatto di cialtronaggine. Polka-Dot Man è super-complessato, riesce a combattere solo quando vede nei suoi nemici l’immagine di sua madre, scienziata malata di mente che voleva fare a tutti costi dei suoi figli dei super-eroi, l’uomo-squalo Nanaue ha una mente infantile e non disdegna cibarsi dei suoi compagni di squadra, Ratcatcher II più che una prode combattente è la lacrimosa assistente psicologica degli altri membri del gruppo, mentre Peacemaker si rivela essere uno psicopatico, in perenne competizione con Bloodsport per accaparrarsi il titolo di migliore assassino.
Quanto a Harley Quinn, conosciamo già il personaggio, ormai pienamente padroneggiato dalla bravissima Margot Robbie, che ha avuto modo di perfezionarlo sia nel precedente Suicide Squad che in Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, di Cathy Yan, del 2020. Insomma un’ammucchiata di personaggi diversissimi, accomunati da una sola cosa: nessuno di loro incarna il classico eroe senza macchia e senza paura. Un’ammucchiata di super- (anti)eroi. The Suicide Squad – Missione Suicida: un film bizzarro e violento che sa far divertire fregandosene delle regole L’eterogeneità dei personaggi non scade mai nel caos o nella citazione didascalica, ma è perfettamente amalgamata in una storia corale, nella quale è difficile individuare il personaggio principale. The Suicide Squad è un film che rende palese l’amore per il cinema del suo regista e sceneggiatore, James Gunn, che si è divertito a realizzare una pellicola che prende per i fondelli gli stereotipi del genere, ricca di situazioni e dialoghi divertenti, spesso imprevedibile, con un ritmo serrato e che racconta una storia nella quale è bello farsi trasportare. Un film che non si prende sul serio, tutt’altro, ma che riesce a intrattenere lo spettatore, tanto che le oltre due ore di racconto volano via e ci si trova ai titoli di coda senza neanche rendersene conto. Un film che, alla fine, celebra gli ultimi, i reietti, gli abbandonati da tutti, perché è questo che in fondo sono i nostri (anti)eroi, molti dei quali però nascondono sotto le loro mostruosità e imperfezioni un cuore d’oro. Ed è questo cuore d’oro che alla fin fine tiene unita la loro squadra, alla faccia delle istituzioni che vorrebbero farne delle
macchine da combattimento asservite al potere. Ed è un bel messaggio, specie in questo scorcio di inizio millennio che ci vede sempre alle prese con la pandemia da COVID-19, che rischia di renderci sempre più impauriti, isolati e timorosi dei nostri simili. Viva il cinema! The Matrix, il film cult dei fratelli Wachowski: un’applicazione da manuale del Viaggio dell’Eroe di Christofer Vogler
Christopher Vogler e il Viaggio dell’Eroe Christofer Vogler ha lavorato come sceneggiatore a Hollywood, ed è diventato famoso (anche) perché ha pubblicato Il Viaggio dell’Eroe (The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers), lavoro nato come come quaderno di appunti e diventato nel tempo un punto di riferimento per tutti gli storytellers. Vogler si è ispirato agli scritti del saggista e storico delle religioni Joseph Campbell, in modo particolare da L’Eroe dai Mille Volti. L’idea di fondo, che riprende il concetto degli archetipi dell’inconscio collettivo, di Jung, è che in ogni racconto siano individuabili degli elementi universali, per cui ogni storia può essere vista come una serie di moduli consecutivi, all’interno dei quali si muovono i vari personaggi, ognuno dei quali svolge una o più funzioni narrative.
La funzione principale è ovviamente quella dell’eroe, colui
che agisce di più nel corso della storia, affrontando un
viaggio nel quale rischia la vita, ma dal quale esce cambiato,
e grazie al quale può aiutare la sua comunità.
Il messaggero è colui – o qualcosa – che effettua la chiamata
all’avventura dell’eroe, che tuttavia in genere è riluttante
ad accettarla ed ha bisogno dell’aiuto di un mentore per
mettersi in gioco, accettando la sfida.
Nel suo viaggio l’eroe deve superare diversi ostacoli,
custoditi dai guardiani della soglia, metafora delle nostre
paure interiori. Inoltre deve vedersela con l’ombra, il suo
antagonista, e avere a che fare con i mutaforma, elementi
ambigui che spesso rappresentano l’altro sesso, mentre il
trickster dona del movimento alla storia, rimescolando i
conflitti o regalando sani momenti di ilarità al racconto.
Il viaggio dell’eroe si articola in dodici tappe, che possono
essere così sinteticamente descritte:
1. L’eroe e l’ambiente nel quale vive viene descritto nel
suo mondo ordinario,
2. nel quale riceve una chiamata per l’avventura da parte
di un messaggero.
3. L’eroe all’inizio è riluttante, e rifiuta la chiamata.
4. Compare il mentore,
5. grazie al quale l’eroe alla fine accetta la chiamata e
attraversa la prima soglia , entrando nel mondo
straordinario.
6. L’eroe familiarizza con le regole e i personaggi della
nuova realtà, nella quale avrà a che fare con prove,
alleati e nemici.
7. Successivamente attraversa una seconda soglia,
muovendosi verso la caverna più profonda,
8. nella quale subisce la prova centrale, dove rischia la
sua vita.
9. Sopravvissuto all’ordalia, riceve un premio.10. Imbocca la via del ritorno,
11. ma deve superare una seconda prova mortale, la
resurrezione.
12. Finalmente, per il nostro eroe c’è il ritorno con
l’elisir nel mondo ordinario.
Non in tutte le storie si possono trovare tutte le tappe, che
peraltro non sempre seguono l’ordine canonico. Tuttavia non si
può non notare che questa struttura è seguita quasi
pedissequamente in molte pellicole di successo, e una di
queste è indubbiamente The Matrix, film cult del 1999 scritto
e diretto dai fratelli Wachowski.
The Matrix: l’analisi del film dal punto
di vista del Viaggio dell’Eroe
In questa storia l’eroe è indubbiamente Thomas A. Anderson,
interpretato da Keanu Reeves, che nel suo mondo ordinario di
giorno è un programmatore di software per una grande azienda,
la Metacortex, mentre di notte è un famoso hacker, e assume il
nome di Neo.
Riceve una chiamata all’avventura articolata in due fasi,
prima tramite un messaggio sul monitor del suo PC (“Wake up,
Neo… The Matrix has you… Follow the White Rabbit”), che lo
spinge a seguire degli sbandati in un locale notturno dove
conosce Trinity (Carrie-Ann Moss), e poi tramite una chiamata
telefonica da parte di Morpheus (Laurence Fishburne), hacker
la cui figura è avvolta nella leggenda. Questi gli dà
istruzioni in tempo reale per sfuggire all’agente Smith (Hugo
Weaving), che lo sta cercando per arrestarlo nell’azienda dove
lavora.
Ma Anderson non è ancora pronto ad affrontare tutte le prove
che lo attendono, e quando Morpheus gli chiede di arrampicarsi
su una precaria impalcatura, penzolante ad altezza
impressionante dal grattacielo dove lavora il nostro eroe,
rifiuta la chiamata e si consegna a Smith e ai suoi tirapiedi.Questi loschi figuri gli impiantano una cimice per tracciarne i movimenti e lo rispediscono a casa, dove viene nuovamente contattato telefonicamente da Morpheus. Seguendo le istruzioni del leggendario hacker, Anderson raggiunge Trinity e altri due personaggi in un’auto. Qui gli viene levata la cimice e viene poi portato a conoscere Morpheus, che in questa sequenza non è più un semplice messaggero, ma acquisisce la funzione di mentore, in quanto stimola la curiosità di Anderson, che vuole sapere cosa è Matrix, guidando intelligentemente il nostro eroe nella scelta tra le due pillole: “Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua e crederai in quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese della meraviglie, e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio”. A questo punto il nostro eroe attraversa la prima soglia, svegliandosi nella realtà distopica di Matrix, il mondo straordinario di questa storia. Scopre così di avere sempre vissuto in una sorta di incubatore ipertecnologico. Matrix è infatti una neuro-simulazione interattiva, che mima la realtà del 1999, per mantenere gli umani immobilizzati nei loro bozzoli, ridotti alla funzione di batterie biologiche per alimentare il mondo delle macchine. Morpheus è il comandante di un hovercraft, il Nabucodonosor, che naviga nelle rovine delle antiche città umane, distrutte nel corso di una violenta battaglia contro le macchine dotate di intelligenza artificiale. Il nostro mentore ha una incrollabile fiducia nel fatto che Anderson-Neo è l’Eletto, colui che guiderà l’umanità alla riscossa, liberandola dal giogo di Matrix. Il nostro eroe impara quindi a conoscere la nuova realtà in dettaglio, affrontando prove, alleati e nemici. Nel nuovo mondo, i suoi compagni d’avventura lo chiamano sempre con il suo nome da hacker, Neo (anche se l’agente Smith
– l’ombra per antonomasia – continua a chiamarlo Anderson). In una realtà simulata che riproduce Matrix, viene addestrato al combattimento, e nel suo training si scontra con lo stesso Morpheus, fallendo però il primo tentativo di saltare da un grattacielo all’altro, conosce gli altri personaggi, tra cui il traditore Cypher (Joe Pantoliano), e in generale impara (spesso a sue spese) tutte le insidie presenti nella nuova realtà, a cominciare dagli agenti, programmi-sentinella che custodiscono la struttura di Matrix. Tra l’altro, nel suo training incontra Mouse (Matt Doran), l’inventore della donna con il vestito rosso nel programma di simulazione, che impersona il classico trickster, capace di dare un po’ ilarità a una situazione molto pesante. Rientrato nella neuro-simulazione interattiva assieme ai suoi compagni d’avventura, viene portato a conoscere l’Oracolo (Gloria Foster), ma si trova intrappolato in un edificio, a causa del vile tradimento di Cypher, che comunica la loro posizione agli agenti. Morpheus si sacrifica per salvare gli altri (acquisendo temporaneamente la funzione dell’eroe), affrontando da solo l’agente Smith in un combattimento senza speranza. Viene catturato e portato in un edificio presidiato da truppe armate fino ai denti e dallo stesso Smith e due altri agenti. Ma adesso Anderson-Neo è più consapevole del suo ruolo di eroe, e decide di superare la seconda soglia, muovendosi aiutato da Trinity verso la caverna più profonda: il munitissimo grattacielo dove Morpheus è torturato dagli agenti, che vogliono avere i codici di accesso alla città di Zion, ultimo centro di resistenza umano. La seconda soglia è sorvegliata da numerosi guardiani: nella prova centrale Trinity e Neo devono affrontare e battere, in sequenza e in ordine crescente di difficoltà, prima i poliziotti all’ingresso, poi un gruppo di militari accorsi in
aiuto nell’atrio dell’edificio, poi altre truppe sul tetto del grattacielo, infine gli stessi agenti. Neo ormai dimostra qualità eccezionali, riesce nell’impresa impossibile di salvare Morpheus, che costituisce il suo premio, cosa che lo qualifica definitamente come eroe, in quanto è riuscito in una impresa difficilissima e mai riuscita prima: affrontare gli agenti e uscirne vivo. Ma non è finita. Mentre Morpheus e Trinity si risvegliano a bordo della Nabucodonosor, Neo si trova da solo a cercare una via di fuga, tallonato da Smith e dagli altri agenti lungo la via del ritorno, come spesso accade nelle storie quando l’eroe non riesce a sconfiggere definitivamente il nemico nella prova centrale. Neo deve quindi affrontare l’agente Smith in due sequenze successive: prima in una stazione sotterranea, dove sembra soccombere, ma all’ultimo momento riesce a ribaltare la situazione, spingendo l’agente sotto la metropolitana in arrivo; poi in un edificio, dove si ha la vera e propria (e letterale) resurrezione, in quanto viene prima ucciso da Smith, che gli spara diversi colpi di pistola nel petto, ma poi, grazie un appassionato bacio di Trinity, che gli confessa il suo amore, ritorna in vita e annienta Smith e mette in fuga gli altri agenti. Neo quindi ritorna con l’Elisir, che ha un duplice aspetto: dal punto di vista umano è appena sbocciata la sua storia d’amore con Trinity, mentre, dal punto di vista della sua funzione di eroe mitico, in pratica ha acquisito la capacità di modificare Matrix dal suo interno, candidandosi come salvatore dell’umanità (e protagonista dei vari, meno riusciti, sequel), soddisfando appieno le aspettative di Morpheus.
The Matrix: una perfetta applicazione pratica della teoria del Viaggio dell’Eroe Nella storia raccontata da The Matrix si possono immediatamente riconoscere il mondo ordinario e quello straordinario: il primo è rappresentato dalla vita vissuta inconsapevolmente da quanti sono immersi nella neuro- simulazione interattiva di Matrix (che poi è il mondo reale percepito dallo spettatore), il secondo costituisce il mondo reale nella finzione cinematografica, cioè la realtà distopica del nostro pianeta, ridotto a cumulo di rovine sotto il controllo delle macchine. Peraltro i vari personaggi spesso alludono al mondo straordinario utilizzando riferimenti ad Alice nel Mondo delle Meraviglie e a Il Meraviglioso Mago di Oz, storie per ragazzi universalmente conosciute, anche per le innumerevoli versioni cinematografiche e televisive che ne sono state fatte. Neo ci viene presentato nel mondo ordinario, quando accetta la chiamata all’avventura ingurgitando la pillola rossa affronta il viaggio, veramente allucinante, verso il mondo straordinario, dove acquisisce tutte le competenze per diventare un vero eroe, e alla fine della storia ritorna nel suo mondo ordinario, portando con sé poteri enormi che però mette al servizio della collettività. In questo film l’arco narrativo dell’eroe è completo: il giovane hacker Anderson all’inizio è ego-riferito e non crede in sé stesso, ma alla fine della storia è diventato Neo, eroe che non ha esitato a rischiare la propria vita per salvare gli altri, trascendendo sé stesso. Se all’inizio, nel mondo ordinario, fa l’hacker per ingrassare il proprio portafogli, alla fine del suo percorso mette l’elisir, acquisito a caro prezzo, a disposizione di tutta
l’umanità, per affrancarla da una realtà distopica e allucinante. Bisogna ricordare che la funzione dell’eroe è – appunto – una funzione, e non è detto che debba essere esercitata da un solo personaggio. In The Matrix questa funzione viene impersonata anche da Morpheus, da Trinity e da vari personaggi minori. Ma non c’è dubbio che è Anderson-Neo il vero protagonista della storia, colui che agisce di più e che, soprattutto, evolve maggiormente, percorrendo un perfetto arco narrativo che alla fine lo rende un eroe a tutti gli effetti, dal momento che in definitiva si appresta a salvare l’umanità intera. Il viaggio dell’eroe può essere anche visto come una struttura circolare, nel senso che l’eroe può percorrere più volte lo stesso ciclo, vivendo una crescita continua, nella quale la fine di ogni ciclo può essere visto come l’inizio di quello successivo. E The Matrix ha avuto diversi sequel… Possession – L’Appartamento del Diavolo: la recensione
La prima scena di questa pellicola ci regala uno primo sguardo su quanto accade al quarto piano al civico 32 del Calle de Manuela Malasaña, nel centro di Madrid, nel 1972. Due bambini si stanno contendendo il possesso di una biglia, che malauguratamente cade rotolando sul pianerottolo davanti alla porta d’ingresso di un appartamento, occupato da una vecchia signora da cui gli abitanti dello stabile amano tenersi alla larga. La porta si apre. Uno dei bambini entra, per prendere la biglia. L’incontro con la vecchia è alquanto traumatico. La sequenza successiva avviene nello stesso luogo, ma nel 1976. La famiglia Olmedo si trasferisce nello stabile, nello stesso piano dove si sono svolti i fatti del 1972. Il nucleo familiare è costituito da Manolo, Candela, il vecchio nonno e tre figli.
Una famiglia che scappa dalla campagna, cercando nuove opportunità nella capitale. Le cose non sono facili, ma Manolo e Candela hanno già un lavoro che li aspetta e ce la mettono tutta. Hanno tagliato i ponti con il loro passato, avendo venduto la fattoria del nonno, e devono pagare il mutuo per il nuovo appartamento, comprato a un prezzo insolitamente basso. Ben presto si accorgono che c’è qualcosa che non va. Non sono soli nell’appartamento: una oscura presenza minaccia i nuovi venuti. Le cose precipitano quando il figlio minore, Rafael, scompare nel nulla… Possession – L’Appartamento del Diavolo: molto più del solito film dell’orrore Questo film è molto più del solito film dell’orrore ambientato nella solita casa infestata. Tanto per cominciare, la famiglia Olmedo non è nelle paradisiache condizioni che inizialmente gli occupanti delle case infestate spesso sembrano avere. Ben presto si viene a scoprire che Manolo (Ivan Marcos) e Candela (Bea Segura) non sono sposati, né possono unirsi in matrimonio. I loro figli provengono da letti diversi. Una cosa alquanto strana e atipica per la Spagna degli anni settanta, in faticosa transizione dal regime franchista a quello democratico. Il film comincia nel 1972, ma il grosso dell’azione si svolge nel 1976, l’anno successivo alla morte del Generale Franco. La Costituzione spagnola viene approvata nel 1978. Date importanti per inquadrare questo film, che usando la metafora della storia horror in realtà è anche un film di denuncia sociale. Pian piano dalla storia emergono elementi che permettono non solo di inquadrare bene l’atipicità della famiglia Olmedo, ma anche il profondo bigottismo di matrice cattolica e il disturbante perbenismo che attanagliava la società del tempo.
La fuga dei protagonisti dalla campagna alla capitale non ha solo motivazioni di natura economica, ma anche e soprattutto di riscatto sociale e ricerca della libertà. Gli Olmedo non devono lottare solo contro le forze oscure che infestano il loro appartamento, acquistato con tanti sacrifici, ma anche contro l’ostilità delle persone presunte normali, che invece li stigmatizzano per la loro diversità. Ma è proprio nell’oscurantismo sociale della Spagna franchista che alla fine vengono trovate le origini terrene del male metafisico che attanaglia Malasaña 32, che non per niente è il titolo originale del film. Possession – L’Appartamento del Diavolo: un film da vedere, non solo per gli amanti del genere Anche ignorando l’interessante aspetto di denuncia sociale (e implicitamente di ricostruzione storica) della Spagna nella sua difficile fase di transizione verso la democrazia, stiamo parlando di un ottimo film dell’orrore, costruito con mestiere, con un ottimo ritmo e ben recitato. All’inizio sembra essere costituito da una serie di citazioni ben confezionate, ma lentamente si rivela essere molto di più, un film con aspetti originali e assolutamente godibile, per gli appassionati del genere ma non solo. Difficile non rimanere trasportati nella storia e non saltare sulla poltrona quando lo si guarda. Perché, anche senza un uso eccessivo di effetti speciali, le emozioni forti sono assicurate. Il regista Albert Pintò ha fatto un gran bel lavoro, confezionando una pellicola che, pur non essendo un capolavoro, probabilmente rimarrà impressa nella mente di molti spettatori. Da vedere.
Puoi anche leggere