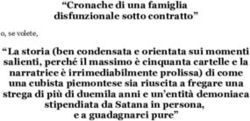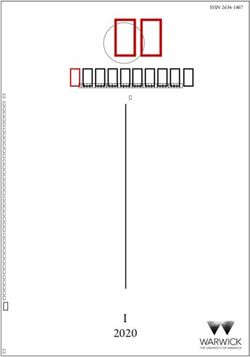Jodorowsky's Dune di Frank Pavic: un omaggio a un film mai fatto che ha cambiato l'immaginario visivo del cinema di fantascienza - Il ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Jodorowsky’s Dune di Frank Pavic: un omaggio a un film mai fatto che ha cambiato l’immaginario visivo del cinema di fantascienza Diretto da Frank Pavic, questo piacevole documentario apre una finestra su un film che Alejandro Jodorowsky avrebbe dovuto girare negli anni settanta. Stiamo parlando di Dune, tratto dall’omonimo lavoro di Frank Herbert. La figura di Jodorowsky è avvolta nella leggenda, analogamente a questo film da lui concepito e mai realizzato. Artista eclettico, polimorfo e difficilmente etichettabile, nella sua lunga vita ha fatto di tutto: il regista (cinematografico e
teatrale), l’attore, il pittore, lo scultore, il filosofo, il guru, il poeta, lo scrittore, lo sceneggiatore, il mimo, il marionettista e chi più ne ha più ne metta. Genio assoluto per alcuni, pazzo totale per altri (gli estremi si toccano, e spesso distinguerli è un’operazione aleatoria), senz’altro un creativo incredibile, capace di muoversi disinvoltamente in molteplici discipline artistiche. Buona parte del documentario di Pavic è occupato dai monologhi di Alejandro, nei quali illustra il percorso creativo che lo ha portato ad assemblare un team di lavoro eccezionale per realizzare il suo Dune. Fino al fallimento finale, quando tutto sembrava essere pronto. Per Jodorowsky questa pellicola non doveva essere un semplice film di intrattenimento, ma al contrario avrebbe dovuto essere un opera destinata a modificare la coscienza di chi la guardava, con un occhio di riguardo per le giovani generazioni. Un’affermazione che oggi forse può fare sorridere qualcuno, ma per raggiungere il suo obiettivo aveva raccolto la disponibilità di personalità artistiche di altissimo livello: H.R. Giger, Dan O’Bannon, Jean “Moebius” Giraud, i Pink Floyd, i Magma, Mick Jagger, Orson Wells, Salvador Dalì, David Carradine. Dune, di Jodorowsky: un fallimento commerciale ma un successo artistico Jodorowsky negli anni settanta interpretò e diresse due pellicole surrealiste (ammesso che sia possibile categorizzarle in questo modo), che al tempo riscossero notevole successo: il western El Topo, nel 1970, e La Montagna Sacra, nel 1973. L’anno successivo un consorzio francese diretto da Jean-Paul Gibon acquistò i diritti del libro di fantascienza Dune, di
Frank Herbert, chiedendo a Jodorowsky di dirigere la sua versione cinematografica. Alejandro accettò con entusiasmo, riuscendo a reclutare per la sua realizzazione gli artisti che a suo modo di vedere le cose avrebbero potuto fare del suo film un opera altamente innovativa, che avrebbe dovuto veicolare contenuti spirituali, capaci di cambiare la visione del mondo degli spettatori. Una concezione del cinema diametralmente opposta a quella di Alfred Hitchcock, per il quale un film deve semplicemente “tenere lo spettatore incollato alla poltrona”. Elevazione spirituale contro puro intrattenimento. Per questo motivo il film avrebbe dovuto farsi portatore un immaginario visivo rivoluzionario. E avere una lunghezza al tempo (e anche oggi) inconcepibile: oltre dieci ore di narrazione. Un progetto rivoluzionario. Probabilmente anche troppo. Anche se secondo Alejandro le sfide tecniche che le sue ardite scelte artistiche imponevano sarebbero già state risolte, nessuno studio si dimostrò disponibile a sostenere i rischi di una produzione così innovativa e dai costi difficilmente quantificabili, ma sicuramente stratosferici. I diritti per la produzione del film vennero quindi venduti a Dino de Laurentis, che affidò a David Linch la direzione del film Dune, che vide la luce nel 1984. Un opera agli occhi di Jodorowsky del tutto mediocre, come ci fa sapere nel documentario di Pavic. Tuttavia molte delle idee innovative nate dal lavoro di Alejandro sopravvissero al suo fallimento, e vennero utilizzate in numerose produzioni degli anni settanta e ottanta.
Jodorowsky’s Dune di Frank Pavic: un documentario imperdibile per gli amanti della fantascienza, e non solo Lo storyboard disegnato da Moebius, del quale rimangono pochissime copie in circolazione, continuò a girare nelle major di Hollywood per anni, influenzando l’immaginario visivo di innumerevoli film. Parliamo di pellicole ormai cult, come Alien, Blade Runner, Flash Gordon, Star Wars, tra le altre. Che a loro volta ispirarono innumerevoli altri film. In altre parole, il Dune di Jodorowsky, pur non essendo mai stato girato, ha avuto un influenza notevole sul cinema di fantascienza, e forse ne avrebbe avuta ancora di più se fosse stato prodotto. Jodorowsky’s Dune, di Frank Pavic, ha l’indubbio merito di ricordarcelo, in modo peraltro molto godibile. Incredibilmente, questo documentario è stato presentato a Cannes nel 2013, ma è stato distribuito al pubblico in Italia solo quest’anno. Meglio tardi che mai, comunque. Un’ottima occasione per conoscere la storia di un film importante nella storia del cinema di fantascienza (e non solo), e per ascoltare Alejandro Jodorowsky, un incredibile visionario purtroppo ancora sconosciuto al grande pubblico. E anche a molti cinefili, probabilmente. Aspettando il Dune di Denis Villeneuve, appena presentato al Festival del Cinema di Venezia e in uscita il 16 settembre…
King Kong del 1933, un’applicazione da manuale del viaggio dell’eroe di Christofer Vogler Premessa: Christofer Vogler e il Viaggio dell’Eroe Christofer Vogler è l’autore statunitense del libro Il Viaggio dell’Eroe (The Writer Journey: Mythic Structure for Writers), testo nato come semplice quaderno degli appunti, e diventato negli anni un bestseller, nonchè un punto di riferimento per gli storytellers. L’autore, che ha anche lavorato come sceneggiatore a
Hollywood, si è ispirato agli studi dello storico delle religioni e saggista statunitense Joseph Campbell, in special modo al libro L’Eroe dai Mille Volti. In estrema sintesi, l’idea di base, che riattualizza il concetto di archetipi di junghiana memoria, è che sia possibile individuare in ogni racconto degli elementi universali, che costituiscono i moduli costitutivi della struttura di ogni storia. Al suo interno si muovono i vari personaggi, ognuno dei quali può svolgere una o più funzioni narrative. In altre parole, comparando storie apparentemente diversissime, è possibile individuare delle similitudini sia nelle strutture narrative che nelle funzioni espletate dai vari personaggi, se si analizzano i racconti in profondità. Naturalmente la funzione narrativa principale è quella dell’eroe, che per definizione è colui che agisce di più nella storia, che rischia la propria vita e che esce trasformato dalle esperienze che attraversa, risultando alla fine non solo maturato e migliorato come persona, ma anche come membro della comunità a cui appartiene. L’eroe viene chiamato all’avventura dal messaggero, anche se in genere all’inizio si dimostra riluttante a gettarsi nella mischia. Per questo riceve l’aiuto del mentore, che spesso è una persona saggia o comunque più esperta, che lo mette in grado di affrontare la sfida. Il viaggio dell’eroe è costellato di ostacoli, ognuno dei quali è presidiato dai guardiani della soglia, che possono essere visti come una rappresentazione delle paure interiori del protagonista. Spesso questi deve affrontare il proprio antagonista, l’ombra, e rapportarsi con i mutaforma, personaggi ambigui che frequentemente rappresentano l’altro sesso. I trickster sono degli elementi che aggiungono colore alla storia, introducendo ilarità e confusione creativa.
Il viaggio dell’eroe nella sua forma canonica è articolato in
dodici tappe, che possono essere viste come moduli costitutivi
delle storie. Sintetizzando, il racconto classico è così
articolato:
1. L’eroe e il contesto iniziale della storia vengono
descritti nel suo mondo ordinario,
2. nel quale tuttavia egli ha dei problemi da affrontare, e
a un certo punto riceve la chiamata all’avventura da
parte di un messaggero,
3. ma in genere il protagonista non è ancora pronto a
mettersi in gioco e rifiuta la chiamata.
4. Tuttavia appare il mentore,
5. che riesce a motivare l’eroe, che quindi accetta la
sfida e attraversa la prima soglia, entrando nel mondo
straordinario, dove vive delle avventure destinate a
cambiarlo.
6. L’eroe deve imparare le regole e conoscere i personaggi
che popolano la nuova realtà, affrontando una serie di
prove, alleati e nemici.
7. Quindi deve attraversare una seconda soglia, per andare
verso la caverna più profonda,
8. all’interno della quale metterà in gioco la sua vita
nella prova centrale.
9. Dopo il duro scontro, riceve un premio,
10. e imbocca la via del ritorno,
11. ma deve superare una seconda prova mortale, la
resurrezione.
12. Dulcis in fundo, il nostro eroe, ormai trasformato dalle
dure esperienze vissute, ritorna con l’elisir nel mondo
ordinario.
Questa struttura deve essere vista come indicazione di
massima, in quanto non tutti gli elementi sono sempre presenti
e non è detto che l’ordine sia seguito esattamente. In alcune
pellicole di successo il viaggio dell’eroe è tuttavia
rispettato quasi pedissequamente. Un primo esempio è TheMatrix, dei fratelli Wachowski, del 1999. Un altro è il leggendario King Kong del 1933, di Merian C.Cooper ed Ernest B. Schoedsack. King Kong del 1933: l’analisi del film dal punto di vista del viaggio dell’eroe Se in alcuni film è facilissimo identificare il personaggio che incarna la funzione dell’eroe per tutta la durata del racconto, come per esempio nel già citato The Matrix, in cui l’eroe è Neo, in altre pellicole non è così semplice, specie in quelle dove l’azione è corale. La mia proposta è che nel King Kong del 1933 la scelta ricada su Ann Darrow (Fay Wray), nonostante in effetti non sia quella che agisce di più, almeno con gli occhi dello spettatore contemporaneo.
Ma bisogna tenere conto che stiamo parlando di un film girato ottanta anni fa, e nella pellicola Ann percorre il perfetto arco narrativo femminile previsto per la donna del suo tempo: da giovane single senza famiglia né lavoro, a donna sposata, per di più con un uomo che ha dimostrato il suo valore sul campo. Inoltre è a causa della sua bellezza che il mostro, King Kong, in pratica si fa uccidere per salvarle la vita e dimostrare il suo valore. In altre parole Ann, sia pure con la passività richiesta alle donne del suo tempo storico, è quella che mette in moto gli eventi e rende possibile lo svilupparsi della storia, che può anche essere vista come l’ennesima variante dell’archetipo della Bella e la Bestia. Il mondo ordinario del racconto è New York. La scene iniziali ci presentano il contesto e i principali personaggi. L’agente teatrale Weston sale a bordo di una nave, la Venture, dove lo attendono il filmmaker Carl Denhan (Robert Armstrong), il capitano della nave e il suo vice Jack Driscoll (Bruce Cabote). Weston comunica a Carl che si rifiuta di procuragli la protagonista femminile del suo prossimo film, vista la pericolosità sottesa a realizzare una pellicola in ambienti esotici, per di più non meglio precisati. Il filmmaker non si perde d’animo e decide di trovarla da solo, nella New York della Grande Depressione, della quale ci viene fornito uno scorcio. Dopo avere visto una coda di donne sconsolate, in attesa di ricevere soccorso in un rifugio femminile per persone in difficoltà, incontra casualmente Ann Darrow, mentre, divorata dalla fame, ruba una mela. Salvatala dalla furia del fruttivendolo, Carl la ristora in un bar, dove Ann riceve la chiamata all’avventura. Il filmmaker, incarnando temporaneamente la funzione di messaggero, le offre di essere la star della sua prossima pellicola, a patto che si imbarchi subito con lui e affronti
il viaggio verso la terra lontana dove la pellicola sarà girata. Lei tentenna, inizialmente rifiuta la chiamata, ma Carl insiste e, impersonando la funzione di mentore, dopo averle fatto capire che non ha secondi fini e che la sua è una semplice offerta di lavoro, riesce a fare in modo che Ann accetta la chiamata all’avventura. Ann si imbarca piena di entusiasmo e la Venture salpa affrontando l’oceano, superando la prima soglia, che di fatto è il porto di New York. In mare aperto, per la nostra eroina comincia la fase delle prove, alleati e nemici. Inizialmente Jack non le nasconde la sua ostilità, in quanto a suo modo di vedere le cose una donna a bordo (cosa mai accaduta prima) può essere solo una fonte di problemi, mentre sembra riscuotere molta simpatia da parte del capitano e dei marinai. Carl la sottopone a un provino sul ponte della nave, mentre l’equipaggio la osserva, estasiato. Nuove soglie devono essere superate affinché la storia possa procedere: prima la nave incontra un fitto banco di nebbia, poi deve trovare un varco nella scogliera, quindi una scialuppa porta i nostri eroi sulla spiaggia dell’isola dove avviene il grosso della narrazione. Il primo incontro con i nativi, intenti a celebrare un rito mai visto prima, non è dei più piacevoli. Il capo del villaggio è molto seccato dalla venuta degli stranieri, che secondo il suo stregone hanno rovinato la cerimonia. Quando vede Ann, offre sei donne del suo villaggio per poterla avere. Ovviamente, l’offerta viene declinata e nostri eroi ritornano sulla nave. Ma i nativi non mollano e, dopo che Carl dichiara a Ann il suo amore, rapiscono la bella eroina. Tutto l’equipaggio della Venture, armato fino ai denti, si precipita in suo soccorso. Quando arrivano nel villaggio, Ann è già stata legata all’altare sacrificale al di là del muraglione difensivo che
protegge il villaggio. E, sgomenti, assistono al suo rapimento da parte di King Kong, che fa la sua prima comparsa dopo 45 minuti, per poi lanciarsi all’inseguimento del bestione. Questi tragici eventi coincidono con il superamento di un’ulteriore soglia, il gigantesco muro difensivo costruito da una antica civiltà dimenticata e manutenuto dagli indigeni, e può essere visto come l’inizio del movimento verso la caverna più profonda. A questo punto la storia si divide in due racconti paralleli: da una parte abbiamo King Kong, che si addentra nel suo territorio tenendo in una sua mano l’urlante Ann, dall’altra gli inseguitori, disposti a tutto pur di salvare la giovane donna. Il gruppo di marinai, capitanati dal valoroso Jack Driscoll, affronta prima uno stegosauro, del quale riesce rapidamente ad avere ragione, per poi addentrarsi in una palude nebbiosa, nella quale subisce l’agguato di un brontosauro, che miete molte vittime. Ma i nostri non mollano, e i superstiti continuano l’inseguimento. King Kong percepisce la loro presenza, e dopo avere piazzato Ann su un vecchio albero morto, torna indietro per affrontarli, mentre cercano di attraversare un burrone, camminando su un albero abbattuto che funge da ponte tra le due sponde dell’orrido. Lo scimmione ha buon gioco nel fare precipitare la maggior parte degli inseguitori nel burrone, ma mentre sta per agguantare Jack, che è riuscito a rifugiarsi in un anfratto, viene richiamato dalle urla disperate di Ann, che viene assalita da un Tirannosuro. King Kong combatte valorosamente contro il super-predatore, riuscendo alla fine a ucciderlo. Riagguanta Ann e si dirige verso il suo rifugio, una caverna nella montagna al centro dell’idola, sempre tallonato dal valoroso Jack, unico
superstire del gruppo di inseguitori, a parte Carl, che è tornato indietro per chiedere rinforzi. King Kong raggiunge la sua tana, dove prima salva Ann dall’attacco di un enorme serpente, poi porta la giovane donna su uno sperone roccioso, dove comincia a spogliarla e ad annusarla. Una scena dagli incedibili contenuti erotici, per gli standard del tempo. Ma lo scimmione viene distratto dal rumore di un macigno fatto improvvidamente cadere da Jack nella caverna, e abbandona Ann al suolo. Un enorme pterodattilo la rapisce, ma quando tutto sembra essere perduto King Kong afferra l’enorme sauro volante, salvando la giovane donna da una fine atroce. Questa sequenza può essere vista come la prova centrale, in cui Ann, chiusa nell’antro più profondo, sopravvive consecutivamente a diversi attacchi nei quali rischia la propria vita. Mentre King Kong fa a pezzi lo pterodattilo, Jack afferra Ann e insieme si calano con una liana verso la salvezza. Lo scimmione alla fine li vede e afferra la liana tirandola verso di sé, ma i due fuggitivi si lanciano nel lago sottostante. A questo punto Ann si è riunita col suo amato (premio), e comincia il rientro nel mondo ordinario, ma come spesso accade quando l’eroe non riesce a disfarsi dell’ombra nella prova centrale, King Kong li insegue, inferocito e pronto a seminare morte e distruzione. Tutte le soglie vengono percorse in senso inverso: prima i nostri eroi riattraversano il muro costruito dalla civiltà antidiluviana, la cui porta viene subito richiusa perché King Kong li tallona a corta distanza. Il bestione distrugge la porta senza troppe difficoltà, e comincia e seminare morte e distruzione, annientando rapidamente la debole reazione dei nativi. Ma gli invasori bianchi lo aspettano sulla spiaggia, dove le bombe a gas hanno
rapidamente la meglio. A questo punto la scena si sposta direttamente a New York, ritornando quindi nel mondo ordinario, nel quale il povero King Kong è al centro di uno spettacolo organizzato dal Carl. Il mostro è in catene, ma viene fatto inferocire dalle luci dei flash dei fotografi, e scatena la sua furia. Si libera facilmente e comincia a cercare Ann, seminando morte e distruzione. Alla fine riesce ad agguantare l’eroina, e si rifugia sull’Empire State Building, stringendo Ann nel suo pugno. In cima al grattacielo, in quella che è una delle scene più famose del cinema, l’eroine supera la seconda prova mortale, la resurrezione. Infatti una squadriglia di aerei viene inviata a mitragliare King Kong e questi, per proteggere Ann, la depone su un cornicione, prima di affrontare a mani nude gli aggressori. Ovviamente ha la peggio, e viene ucciso, precipitando ai piedi dell’edificio. Nel frattempo Jack riesce a raggiungere la sua amata, che abbraccia sul cornicione, preludio amoroso che sarà coronato il giorno dopo, quando si sposeranno, fatto che sigilla l’ultima tappa del viaggio dell’eroe: il ritorno con l’elisir.
King Kong del 1933: corrispondenza tra le soglie che vengono passate nel film e i luoghi geografici della storia In questa pellicola c’è una perfetta corrispondenza tra le soglie passate dall’eroina e i luoghi fisici dove si svolge l’azione. Il mondo ordinario è la New York ai tempi della Grande Depressione, mentre il mondo straordinario è l’Isola del Teschio, luogo immaginario posto in una zona imprecisata al largo di Sumatra. La prima soglia da superare è il normale oceano: il viaggio comincia quando la Venture salpa, lasciando il tranquillo porto di New York. L’isola è protetta, oltre che dalla distanza, prima da un
impenetrabile banco di nebbia, poi da delle insidiose scogliere, che tuttavia vengono superate agilmente. L’accoglienza nel mondo straordinario da parte dei nativi non è delle migliori, ma i veri pericoli si celano dietro la misteriosa muraglia edificata in tempi antidiluviani da una civiltà dimenticata. Al di là di questa sorge infatti l’altare sacrificale, dove giovani donne vengono immolate per esorcizzare la furia di King Kong, e solo al di là dell’enorme porta fa la sua comparsa il bestione e tutti i mostri preistorici che popolano il mondo straordinario dell’Isola del Teschio. Un’ulteriore soglia è costituita dall’enorme tronco d’albero che funge da ponte tra le due rive di un orrendo precipizio, dove troveano la morte morti marinai della spedizione di salvataggio. La caverna più profonda è costituita da un inaccessibile antro posto sulla cima di una montagna, al centro dell’Isola del Teschio. Da notare che a mano che ci si avvicina alla caverna più profonda, i nostri eroi devono affrontare prove sempre più impegnative. E il luogo dove la nostra eroina deve superare l’ultima prova è una sorta di riedizione in chiave tecnologica della montagna posta al centro dell’Isola del Teschio: l’Empire State Building. Il film King Kong del 1933 non è solo una perfetta applicazione del viaggio dell’eroe, ma costituisce un esempio paradigmatico del mito della Bella e della Bestia, del conflitto tra Natura e Cultura, ed è uno dei primi esempi di film strutturalmente metacinematografici, visto che in definita vien messo in scena il tentativo di girare un film. Non per niente, questa pellicola è uno dei capolavori assoluti
del cinema… Malignant: recensione del nuovo film horror di James Wan Dopo due aborti spontanei, Madison (Annabelle Wallis) è di nuovo incinta. Derek, il suo compagno, è un uomo violento con problemi di etilismo, dal carattere instabile, che la colpevolizza per avere perso i loro figli. Durante una lite per futili motivi, lui la malmena violentemente. Madison, che rimane ferita nella colluttazione, si chiude in camera, mentre lui si rassegna a dormire sul
divano, nel salotto a piano terra. Ma qualcosa di maligno è pronto a scatenarsi nella loro villetta. Lui si sveglia nel cuore della notte. Strani rumori lo portano a controllare la cucina. Gli elettrodomestici sembrano dotati di vita propria, come le luci della casa. Improvvisamente, una figura oscura si scaglia contro di lui, uccidendolo. Madison, richiamata dal trambusto, scende a controllare, ma viene a sua volta aggredita dalla misteriosa figura. Torna a chiudersi in camera, ma viene inseguita dall’entità, che sfonda la porta, sbattendola a terra. Lei si sveglia in ospedale, confortata da sua sorella Sidney (Maddie Hasson). Madison purtroppo ha perso il suo bambino per la terza volta. Ben presto le cose peggiorano. Madison comincia a vivere terribili incubi a occhi aperti, dove è costretta ad assistere a efferati omicidi, senza potere muovere un dito. Scopre ben presto che i delitti dei quali è suo malgrado testimone accadono non solo nella sua mente, ma anche nel mondo reale. Il detective Shaw (George Young) all’inizio accoglie con scetticismo la storia raccontata da Madison. Ma quando si trova faccia a faccia con l’entità assassina, che scopre in un appartamento subito dopo che ha commesso un omicidio, su indicazione della stessa Madison, deve cambiare idea. Ma niente è quello che sembra, e la strada per arrivare all’incredibile verità è ancora lunga… Malignant: tutto e di più, ma non un semplice horror soprannaturale Specie per lo spettatore che avesse guardato il trailer di questa pellicola, nella prima parte del film si ha l’impressione di essere immerso nel classico horror soprannaturale, nel quale un entità metafisica semina terrore, morte e distruzione.
In realtà il film prende ben presto un’altra piega, perché quanto accade nella storia ha ben poco di soprannaturale ed è legato alla nostra dimensione, sia pure (ovviamente) in versione arricchita con elementi paranormali. Niente possessioni demoniache o orrorifiche visite dall’oltretomba, per capirci. Ma questo non lo si comprende subito. Uno degli aspetti più accattivanti di Malignant è proprio che si tratta di un film horror che racchiude in sé molti sottogeneri, ed è impossibile categorizzarlo in maniera precisa. In Malignant c’è di tutto: dramma familiare, action movie, detective story, body horror, splatter e chi più ne ha più ne metta, tanto che descriverlo è una operazione complicatissima, se si vuole scendere nel dettaglio. Di fatto può essere visto come un contenitore di citazioni cinematografiche e di sottogeneri, una vera chicca per gli amanti dell’horror. Perché non stiamo parlando di uno spezzatino di elementi eterogenei messi insieme alla rinfusa, ma di un film che gira benissimo, curato nei minimi dettagli e che sorprende costantemente lo spettatore più smaliziato. Malignant: James Wan ha regalati ai cultori del genere una chicca imperdibile Difficile elencare tutti gli elementi e le citazioni presenti nel film, molto più facile dire cosa non c’è. Non si trova traccia di denuncia o critica sociale (presente invece nei primi film di Romero, tanto per fare un esempio), perché questo lavoro è un omaggio di James Wan al cinema horror, concepito per intrattenere e non per veicolare messaggi. E ci riesce benissimo. La storia è veramente originale e intrigante, pur essendo alla fin fine un assemblaggio di cose già viste. Ma è un assemblaggio fatto con passione e mestiere, che ha
creato un prodotto che colpisce per la sua creatività e imprevedibilità. James Wan, che ha diretto film ormai cult come Saw, Insidious, e The Conjuring, con questa sua pellicola a basso budget dichiara tutto il suo amore per il genere horror e ha forse realizzato il suo film più creativo e autoriale. Una pellicola sorprendente, che risucchia lo spettatore nella storia, facendogli vivere mille emozioni e lasciandolo alla fine della visione quasi divertito, più che spaventato o angosciato. Assolutamente consigliato, specie per gli amanti del genere. Candyman: la recensione del film horror di Nia DaCosta
Anthony McCoy è un artista che vive a Chicago assieme alla sua ragazza, Brianna Cartwright, che dirige una galleria d’arte moderna. Il giovane uomo è in conclamata crisi creativa, e di fatto viene mantenuto dalla compagna, ma gli giunge un aiuto inaspettato. Il fratello di Brianna, infatti, una sera si ferma a casa della coppia assieme al proprio compagno, e racconta quella che sembra essere una leggenda metropolitana: negli anni novanta una giovane donna, Helen Lyle, giunge nel quartiere per compiere delle ricerche sull’esistenza di Candyman, mitico uomo nero della zona, presunto autore di innumerevoli delitti. Helen tuttavia perde il senno, rapisce un bambino che cerca di uccidere gettandolo nel fuoco, ma il piccolo viene salvato in extremis, mentre lei si getta tra le fiamme, muorendo in modo atroce.
Anthony rimane turbato dal racconto, e comincia a fare delle ricerche, indagando in ciò che rimane del vecchio quartiere di Cabrini-Green, dove incontra William Burke, il proprietario di una lavanderia che gli racconta ulteriori dettagli della storia raccapricciante. In particolare, secondo William, chiunque nomini per cinque volte consecutive il nome “Candyman” di fatto evoca il suo spirito, venendo da questi massacrato sul posto senza pietà. Anthony e Brianna hanno poi la pessima idea di provare il rituale, ma sul momento sembra non acacdere niente. Il protagonista rimane comunque affascinato dal racconto, e concepisce un’opera da esso ispirata, che viene esposta nella galleria d’arte della compagna, dove tuttavia riceve critiche per nulla lusinghiere. Gli eventi cominciano subito a precipitare. I primi a morire macellati sono un collega di Brianna e una sua fiamma del momento, che evocano per gioco Candyman davanti all’opera di Anthony. Nel frattempo il protagonista comincia a subire una mutazione fisica, che comincia da una mano, punta da un’ape mentre si aggira tra gli edifici fatiscenti di Cabrini-Green. Candyman: un horror nel quale trionfa il mito del doppio In questo film si scontrano frontalmente forze contrapposte e inconciliabili. Il primo contrasto che emerge con forza è quello urbano. Da un lato ci sono i vetusti edifici fatiscenti e polverosi della vecchia Cabrini-Green, pieni di graffiti, murales e orrori dimenticati. Dall’altra i moderni e luccicanti grattacieli costruiti sull’antico quartiere, che un rapido processo di gentrificazione avrebbe dovuto riscattare, lanciandolo verso un radioso futuro di prosperità e benessere. Aprendo quindi un secondo contrasto: tra la povertà materiale del passato e la ricchezza del presente.
C’è poi lo scontro frontale tra il mondo dei bianchi e quello dei neri, all’inizio del film sottotraccia, ma che cresce inesorabilmente durante il racconto, diventandone alla fine la chiave di lettura principale. Lo stesso protagonista comincia poi a sdoppiarsi, perché la sua identità comincia a essere lentamente ma inesorabilmente contaminata da quella di Candyman, cambiamento che verso la fine del film traspare chiaramente anche a livello fisico, dato che metà del suo corpo comincia a marcire. Il fatto poi che Candyman possa essere evocato solo davanti a uno specchio è emblematico della sua natura e gli stessi titoli di testa sono “specchiati”… Candyman: un film semplice e lineare che si lascia guardare volentieri Il tema centrale della pellicola è il rapporto conflittuale tra bianchi e gente di colore. I protagonisti sono di colore, i vecchi (e poveri) abitanti di Cabrini-Green sono di colore, ma i moderni galleristi (quelli di successo) sono bianchi, così come le forze dell’ordine, dominate dal suprematismo bianco. Anthony è in crisi di ispirazione, la sua compagna fatica a trovare una posizione di successo e di fatto è subalterna al suo socio bianco, ma è la comparsa di Candyman e rimescolare le carte. Di fatto questo personaggio mitico (e di colore) fornisce una nuova spinta creativa ad Anthony, avviandolo verso il successo, grazie agli efferati omicidi che ben presto avvengono attorno alle sue opere. La stessa Brianna, grazie a questi tragici fatti, ha la possibilità di collaborare con espositori molto famosi. In altre parole, il successo della gente di colore può avvenire solo tramite la mattanza dei bianchi, che sono i cattivi di turno.
Candyman stesso, alla fine, si rivela essere niente altro che la personificazione di tutte i soprusi subiti dalla comunità di colore per colpa dei bianchi. In esso vivono molti personaggi del passato, ingiustamente massacrati dalla comunità WASP, razzista, sadica e sfruttatrice. E vogliono vendetta. Il film è molto curato, anche dal punto di vista visivo. In particolare, gli ambienti del nuovo quartiere sono ricercati nei minimi dettagli, ma la loro perfezione formale non impedisce all’orrore di abbattersi sui suoi abitanti. La storia scorre accattivante, partendo da un punto di vista neutro, dove tutto sembra essere perfetto, impeccabile: i protagonisti sono una giovane coppia di artisti di colore apparentemente lanciati verso il successo, il fratello di lei è gay, il suo compagno è un bianco. Tutto perfettamente politically-correct. Ma sotto l’apparenza si nasconde l’orrore, che cresce piano piano lungo tutta la storia, fino a esplodere nel finale. Che forse è il punto debole del film, perché si cade nei luoghi comuni più stucchevoli. Bianchi tutti cattivi contro uomini di colore tutti vittime. E la vendetta, unica dimensione esistenziale possibile per questi ultimi, trionfa. Vabbè. Comunque il film nel suo complesso funziona bene. E di fatto è una apprezzabile continuazione del primo Candyman, del 1992, di Candy Rose, la cui storia è la base di partenza del film. In attesa del prossimo sequel…
Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: la recensione del film commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi Giovanni (Antonio Albanese) e Monica (Paola Cortellesi) sono due persone agli antipodi. Lui è un intellettuale immerso nell’ambiente della sinistra radical-chic, impegnato nella realizzazione di un ardito quanto improbabile centro culturale in una periferia degradata, che dovrebbe servire ad aggregare ed elevare
culturalmente il popolo, ma che in realtà per alcuni pare essere una mera opportunità per fare soldi, sotto la copertura dell’erudizione delle plebi. Lei fa parte del popolo teoricamente bisognoso di essere elevato, ma della cultura se ne sbatte, perché – a suo dire – non dà da mangiare. Del resto ha ben altre gatte da pelare: si ritrova incarcerata per colpa delle sue due sorelle gemelle, Pamela e Sue Ellen (le incredibili Alessandra e Valentina Giudicessa), cleptomani inveterate, che hanno nascosto la loro refurtiva nella sua pizzeria. Così chiede aiuto al suo ex amico, Giovanni, il quale diventa suo tutore legale e ottiene, grazie ai suoi appoggi politici, la conversione della pena detentiva di lei nella prestazione di servizi sociali, da effettuarsi nella parrocchia di Don Davide (Luca Argentero), centro che aiuta i disagiati, adiacente al centro culturale in procinto di essere inaugurato. Entrambi sono poi in contatto con i rispettivi pargoli, che vivono in terra straniera. Il figlio di Chiara, Alessio (Simone de Bianchi) lavora come lavapiatti e cameriere in un pub londinese, mentre la figlia di Giovanni, Agnese (Alice Maselli), frequenta l’università, sempre nella capitale britannica. Insomma una storia nella quale si confrontano realtà opposte, che forniscono mille opportunità per creare situazioni grottesche. Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: non solo una commedia In questa pellicola l’aspetto comico coesiste con la volontà di mostrare le problematiche sociali delle periferie urbane. Il problema della carenza di alloggi, la violenza sulle donne, la mancanza di lavoro, la violenza endemica nei bassifondi, sono tutti temi che fanno capolino nella narrazione, sia pure
in tono scanzonato e forse alle volte un po’ troppo stereotipato. Indubbiamente è presente una critica corrosiva nei confronti dell’ambiente della sinistra radical chic, bene rappresentato dall’ex di Giovanni, Luce (Sonia Bergamasco), persona benestante che vive in una dimensione parallela, avulsa dal mondo reale della povera gente, ma soprattutto dalla nuova compagna del protagonista, Camilla (Sarah Felberbaum), il cui impegno sociale è di facciata, in quanto di fatto è interessata solo al denaro messo in circolazione dagli sponsor per realizzare progetti a presunto scopo sociale. Lo stesso Giovanni porta dentro di sé tutte le contraddizioni connesse da una progettualità che dovrebbe usare la cultura per creare occasioni di aggregazione e crescita civica per il sottoproletariato urbano, ma che usa linguaggi distanti anni luce dagli abitanti delle periferie. Non per niente, Giovanni passa interi pomeriggi per cercare la giusta sfumatura di colore per i muri del centro culturale, o per trovare il nome corretto per le pietanze preparate per la cerimonia di inaugurazione, sotto l’occhio vigile e pensoso di intellettuali (o presunti tali) evidentemente alieni alla realtà delle borgate di periferia. Tuttavia queste attività muovono un sacco di soldi, e molti di questi finiscono nelle tasche delle maestranze e degli artisti, per cui in realtà la cultura dà da mangiare, come Giovanni ricorda a Monica durante una delle loro accese discussioni. Con visioni del mondo a distanza siderale l’uno dall’altra, i due protagonisti sono tuttavia fortemente attratti l’uno dall’altra, e la passione alla fine travolge ogni resistenza intellettuale, trovando sfogo nell’inevitabile amplesso nel dormitorio delle suore nella parrocchia di Don Davide.
Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: una commedia divertente, ottima per passare un paio d’ore spensierate Il film si fa vedere volentieri, e non si può non apprezzare anche diverse citazioni cinematografiche veramente carine, vere chicche per i cinefili capaci di vederle. Graditi omaggi a Shining, Vacanze Romane e Il Settimo Sigillo. Questo secondo capitolo di Come un Gatto in Tangenziale è più impegnato del primo, sia pure sempre in modo leggero e scanzonato, e forse per questo è ancora più apprezzabile, riuscendo nell’impresa di realizzare un sequel all’altezza, operazione per niente facile né scontata. In definitiva il film ha un messaggio positivo: si può convivere anche avendo visioni del mondo differenti, senza bisogno di rinunciare alla propria identità o di dovere cambiare per piacere all’altro. La cultura può essere sia una mangiatoia per opportunisti, che un’opportunità per riflettere, stare insieme e aiutarsi l’un l’altro. E ognuno può scegliere da che parte stare. Apprezzabile anche l’ampia gamma di improbabili personaggi messi in scena, che riempiono di simpatia la pellicola. Inevitabile qualche caduta di troppo negli stereotipi più comuni, ma forse è impossibile riuscire a evitarlo, in una commedia di questo tipo. Speriamo che il probabile terzo capitolo della saga sia all’altezza del secondo…
Josep: il grande cinema d’animazione d’autore torna al Visionario dal 30 agosto al 1°settembre! Josep è una celebrazione del potere espressivo del disegno e di una vita straordinaria, quella dell’illustratore catalano Josep Bartolí (Barcellona 1910 – New York 1995). A firmarlo Aurel, pseudonimo di Aurélien Froment, vignettista francese che tra gli altri ha lavorato per Le Monde. Miglior film d’animazione ai Cesàr 2021 e agli European Film Awards, JOSEP sarà in programma al Visionario dal 30 agosto al
1° settembre alle ore 19.15. La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema. Il film di animazione è ambientato nel Febbraio del 1939. I repubblicani spagnoli si dirigono in Francia per fuggire dalla dittatura di Franco. Il governo francese confina i rifugiati in campi di concentramento, dove si riesce a malapena a soddisfare il bisogno di igiene, acqua e cibo. È in uno di questi campi che due uomini, separati dal filo spinato, diventeranno amici. Uno è una guardia, e l’altro è Josep Bartolí, un illustratore che combatte il regime franchista. Un’affascinante lezione di storia, un film sulla memoria e sul potere fondativo degli incontri capaci di alterare il corso di una vita. Per la programmazione completa e sempre aggiornata consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario, al cinema all’aperto presso il giardino Loris Fortuna e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2). Becket: recensione del film Netflix di Ferdinando Cito Filomarino con John David
Washington Becket (John David Washington) è un cittadino statunitense in viaggio in Grecia con la compagna, April (Alicia Vikander). I due decidono di lasciare Atene, scossa da violenti tumulti popolari, per addentrarsi all’interno del paese. Durante un viaggio notturno in macchina, Becket, causa un improvviso colpo di sonno, perde il controllo del veicolo, che si ribalta fuori strada e si schianta contro un’abitazione, sfondandone un muro. Pesto e sanguinante, riesce a trascinarsi fuori dall’abitacolo, per scoprire che April è stata violentemente sbalzata fuori dall’auto, rimanendo uccisa. Prima di perdere i sensi, si accorge della presenza di una donna con un bambino, che tuttavia, inspiegabilmente, scappano. Ritorna successivamente a piedi sul luogo dell’incidente, ma viene aggredito da una donna che gli spara, centrandolo a un
braccio. Con suo grande sgomento, scopre ben presto che chi lo vuole fare fuori è in combutta con la polizia. Comincia la sua fuga nell’affascinante ma aspra campagna greca, ferito, tallonato dai suoi inseguitori, che non guardano in faccia a nessuno pur di fargli la pelle… Becket: un uomo solo contro tutti Questa pellicola è la quintessenza della situazione “l’uomo sbagliato nel posto sbagliato al momento sbagliato”. Causa una serie di fattori del tutto imprevedibili ed esterni alla sua volontà, Beckett si trova a essere testimone di qualcosa che non doveva vedere, e della quale all’inizio non si rende neanche conto. Solo, ossessionato dal senso di colpa per avere causato la morte della sua compagna, si trova a cercare di sopravvivere in un ambiente dove non sa di chi fidarsi, dove chiunque può essere un suo nemico. Non conosce la lingua dei nativi, non conosce le strade, non ha idea di quello che sta succedendo. Ben presto la sua fuga disperata lo porta nei centri urbani. Il passaggio dalla campagna alla città non cambia molto nella sua situazione: entrambi gli ambienti sono ostili e incomprensibili. Lentamente, comunque, emergono elementi che gli permettono di farsi un’idea di quello che sta succedendo. Il fatto di capire di trovarsi all’interno di un complicato intrigo internazionale non gli è tuttavia di molto aiuto, anzi. Mentre la storia si dipana, Beckett deve lottare per sopravvivere, combatte a mani nude contro sicari e forze dell’ordine, viene più volte ferito, trovandosi sempre più immerso in una situazione sempre più complicata e pericolosa.
Beckett: una storia coinvolgente che però fatica a mettersi in moto Il film comincia con un ritmo forse anche troppo lento, mostrandoci la classica situazione in cui una coppia attraversa dei temporanei momenti di difficoltà, mentre i difficili eventi vissuti da una Grecia attanagliata dalla crisi economica scorrono sullo sfondo. I dialoghi minimalistici e il modo di fare un po’ impacciato del protagonista non aiutano di certo, per cui all’inizio chi si aspetta il classico action movie può rimanere disorientato, anche perché accade poco o niente. Banali scaramucce e riappacificazioni tra una coppia di cui poco o nulla ci è dato di sapere, a parte i nomi dei protagonisti. Le cose cominciano a cambiare dopo l’incidente in macchina, ma il film nel suo complesso fatica a mettersi in moto. Certo, quando cominciano a volare i proiettili e il mondo sembra crollare addosso a Beckett è difficile non immedesimarsi nel protagonista. In questo film si parla poco, cosa può essere un punto di forza, a patto che non si voglia comprendere razionalmente tutti i dettagli di quanto sta accadendo. Perché le informazioni vengono fornite con il contagocce, e solo alla fine lo spettatore si può fare un quadro abbastanza chiaro di quello che sta succedendo. Cosa che non tutti gradiscono. I gusti son gusti, del resto. Fatte queste premesse, bisogna dire che una volta che la storia comincia agirare a pieno regime, è veramente difficile non farsi trascinare le racconto. Beckett: un John David Washington molto più credibile di quello che abbiamo visto in Tenet Tutto il film ruota attorno a Beckett, interpretato da un John David Washington molto più convincente di quello che vestiva i
panni del protagonista senza nome di Tenet. Certo, mentre Beckett è un film con una storia lineare e legata al nostro presente, Tenet è un guazzabuglio fantascientifico spazio-temporale senza forma, nel quale perdersi è facilissimo. Una differenza non da poco. I protagonisti delle due pellicole hanno dei tratti simili, probabilmente dovuti alle peculiarità attoriali di Washington, ma in Beckett il protagonista è molto più credibile e appropriato all’assurda situazione che si trova a dover affrontare. Questo film ha anche dei tratti politici, che ripropongono lo scontro frontale tra destra e sinistra nello stanco Occidente di inizio millennio, con sullo sfondo il disastro sociale provocato dall’austerità imposta dalle istituzioni europee, che in Grecia ha fatto danni considerevoli. E in questo dramma la classica contrapposizione tra città evoluta e campagna arretrata, presente più o meno in moltissime storie, perde forza fino a svanire. Ovunque scappi, Beckett viene inseguito dai suoi persecutori. Ma è nella città che viene trovato il bandolo della matassa. Insomma questa pellicola è un interessante mix di elementi coinvolgenti, e, a patto di perseverare nella visione, perché la prima parte non è di certo entusiasmante, può regalare forti emozioni allo spettatore. Anche perché, diciamolo pure, è difficile non immedesimarsi nel protagonista di questo tipo di storie, dove un un uomo si trova a lottare da solo contro tutti. Magie del cinema…
Pozzis, Samarcanda: recensione del film di Stefano Giacomuzzi con Alfeo Carnelutti (Cocco) Pozzis, Samarcanda è un film non categorizzabile in maniera precisa, situandosi in una zona indefinita compresa tra il road movie, il film autobiografico e il documentario di viaggio. I due protagonisti sono Cocco e Stefano. Due personalità e due esperienze di vita agli antipodi. Cocco è un biker settantenne, con un passato da emigrante e corridore motociclistico. Negli anni ottanta subisce un grave incidente di gara che lo costringe in ospedale per un lungo periodo, e sviluppa il morbo di Chron. Si trasferisce a Pozzis,
un paesino disabitato sulle montagne friulane, in provincia di Udine. Comincia ad organizzare i Cocco Meeting, motoraduno che ben presto diventa popolarissimo e contribuisce a regalare una seconda vita allo sperduto agglomerato di case. Nel 1999 viene accusato di un omicidio, del quale si dichiara subito colpevole. Una vicenda dai contorni molto controversi, tanto che Cocco riceve una condanna mite, dieci anni di reclusione, dei quali ne sconta otto. Nel 2018 parte per Samarcanda. Unici compagni di viaggio: la sua amata motocicletta (il cui motore è più vecchio di lui di cinque anni), Stefano e una striminzita troupe cinematografica. Il film parte da qui. Stefano ha solo ventidue anni ed è fresco di studi cinematografici. Dal loro incontro è nata l’idea di girare il film, una sorta di racconto di viaggio nel quale non ha neanche importanza la destinazione, come ci viene fatto sapere nelle prime battute del film, girate durante un Cocco Meeting a Pozzis, nel quale si vendono magliette per finanziare la spedizione. Pozzis, Samarcanda: un racconto dove convivono realtà apparentemente inconciliabili In effetti tra Stefano e Cocco c’è una differenza abissale di età, esperienze vissute e visione del mondo. La principale motivazione di Stefano nell’imbarcarsi nell’avventura è di girare un film, mentre per Cocco si tratta di vincere una sfida con sé stesso, per vedere cosa è in grado di fare alla sua età e con tutti i suoi problemi (considerando anche che la sua moto è più vecchia di lui). Anche tra Pozzis e Samarcanda la differenza è immane: il luogo di partenza è un paesino disabitato disperso nelle montagne friulane, Samarcanda è un luogo mitico e famosissimo, lontano oltre seimila chilometri. Un viaggio difficile, quindi, sotto molteplici punti di vista: una coppia eterogenea che affronta un viaggio lunghissimo, in terre lontane, sia in termini di distanza fisica che di differenza
culturale, su strade spesso al limite dell’inutilizzabilità, con una motocicletta più vecchia del suo pilota settantenne, per altro in condizioni fisiche non certo eccelse. Ma nonostante tutto e nonostante tutti, l’incredibile impresa riesce. Il film racconta tutte le tappe principali di questo viaggio, ma lo fa in maniera minimalistica, e questo lo rende ancora più credibile e coinvolgente. Perché sia Cocco (Alfeo Carnelutti) che Stefano interpretano sé stessi, senza maschere e senza filtri. E forse non potrebbe essere diversamente, visto che non stiamo parlando di attori professionisti. Niente dialoghi ricercati o fini citazioni, niente effetti speciali. Solo fatti accaduti, ripresi in tempo reale, probabilmente senza il tempo di costruire scene complesse. Probabilmente improvvisando, adattandosi agli imprevisti e alle situazioni contingenti. Pozzis, Samarcanda: il racconto di un’avventura e di una improbabile amicizia capace di superare ogni difficoltà Il viaggio tra Pozzis e Samarcanda mette a dura prova il rapporto tra Stefano e Cocco. Ma alla fine il loro legame ne esce accresciuto e cementato, perché entrambi, ognuno a modo loro, si rendono conto di avere bisogno uno dell’altro. Quella che all’inizio è una convivenza forzata, diventa un’occasione di arricchimento reciproco, e permette ai due di portare a termine l’impresa, superando anche il malore che costringe Cocco a letto per diversi giorni. Forse è proprio Cocco il vero protagonista del film. Una persona semplice, dall’esperienza di vita ricchissima, dalla forza interiore incredibile, che gli ha permesso di superare ostacoli impensabili. Con tante piccole storie da raccontare, tratte dalle sue personali esperienze, che descrive con il suo linguaggio semplice, ma efficace. In particolare, durante tutta la pellicola, Stefano cerca di strappare a Cocco la verità sui fatti oscuri che lo hanno portato a passare
tanti anni della sua vita in carcere. All’inizio il biker non vuole parlarne, ma lentamente la sua resistenza si sgretola, e alla fine si lascia sfuggire più di qualcosa, per la gioia degli spettatori. E di Stefano. Ma anche quest’ultimo si accorge che, volente o nolente, deve rinunciare a qualcosa. L’ossatura del film non può derivare dal viaggio fisico in sé: non c’è tempo per godersi gli incredibili paesaggi, esplorare città tanto lontane e differenti dalle nostre, indugiare sugli innumerevoli incontri con culture diverse. Bisogna andare avanti, a testa bassa, nonostante la stanchezza, gli imprevisti, le difficoltà. Pozzis, Samarcanda: un film che fa della semplicità e immediatezza il suo punto di forza Insomma stiamo parlando di una pellicola molto semplice, quasi improvvisata, donchisciottesca, realizzata con mezzi esigui. Ma fatta con passione, capace di dare molto allo spettatore che si lasci trasportare nel racconto. Che mette in scena la forza dell’amicizia e della volontà, capaci di trasformare un sogno in realtà. Un film nel quale il viaggio dalla sperduta Pozzis alla mitica Samarcanda è – alla fine – solo un pretesto. Anche perché, come ci viene fatto sapere, “a Samarcanda non c’è niente”. Ma non importa. Perché ci sono le vite dei protagonisti alla base del racconto. In particolare quella di Cocco, che nel film fa anche un viaggio nella sua memoria, raccontandoci frammenti delta sua vita, di certo non ordinaria. Ed è proprio Cocco che nel film, grazie alla sua gestualità spontanea, riesce a superare ogni barriera culturale e linguistica, nonostante di certo non eccella in dialettica. Il film indugia spesso sui paesaggi spesso esotici attraversati (Bulgaria, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, per citarne qualcuno), ma questo non è l’aspetto prevalente.
Quella che emerge è la componente umana, nel senso più profondo del termine, senza i filtri di complesse narrazioni o spesso inutili effetti speciali. Un film che mette in scena anche l’impresa incredibile portata a termine da tre persone, con una motocicletta e un furgone d’appoggio. Stefano Giacomuzzi (che è anche regista) e Alfeo Carnelutti (Cocco) mettono in scena sé stessi, con l’aiuto di Matteo Sacher (addetto alle riprese). Il film è stato inizialmente autofinanziato, ottenendo poi il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission, del Fondo Audiovisivo FVG e dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (il film è in lingua friulana, sottotitolato in italiano). Pozzis-Samarcanda ha vinto il premio come migliore film all’Edera Film Festival di Treviso. Complimenti ragazzi! La Casa in Fondo al Lago: la recensione del film horror subacqueo di Julien Maury e Alexandre Bastillo
Ben (James Jagger) e Tina (Camille Rowe) gestiscono un canale YouTube specializzato nell’esplorazione di edifici abbandonati, alla ricerca di fenomeni paranormali. Dopo avere fatto delle riprese in un vecchio orfanotrofio in Ucraina, i due giovani si spostano sulle sponde di un lago nella Francia. La località, lungi dall’essere un luogo sperduto e misterioso, si rivela invece essere una località turistica affollatissima. Quando la possibilità di girare un video interessante sembra essere ormai sfumata, incontrano casualmente un abitante del posto, che li porta in una remota estremità del lago, sotto la cui superficie si trova una casa, a circa quaranta metri di profondità. I due si immergono assieme a un drone telecomandato, seguendo una scalinata che li conduce davanti al vecchio edificio. Dopo avere superato il cancello d’ingresso, ancora in piedi, i ragazzi si accorgono che all’interno del perimetro della recinzione della casa non ci sono pesci, presenti invece in gran numero al suo esterno.
Cosa ancora più strana, la porte e le finestre sono chiuse con imposte metalliche, ma dopo attenta ricerca riescono a trovare un varco per passare. Superato l’entusiasmo iniziale, i due si rendono conto che inspiegabilmente tutti gli oggetti sono ancora perfettamente conservati, nonostante siano stati immersi nelle acque del lago per decenni. Ma il vero orrore li attende nello scantinato del vecchio edificio… La Casa in Fondo al Lago: l’idea originale che rende apprezzabile la pellicola è anche un suo limite Il film si presenta nelle prime inquadrature come il classico found footage, con i due protagonisti intenti a riprendersi vicendevolmente con le loro GoPro, nel vetusto edificio perso nella campagna ucraina. L’arrivo in terra francese cambia il punto di vista della telecamera, che diventa anche esterno ai due protagonisti, cosa che può lasciare inizialmente perplessi. Di fatto, dopo l’immersione nelle acque del lago, ovverosia per due terzi abbondanti del film, la storia narrata è sovrapponibile al tempo reale vissuto dallo spettatore, visto anche che viene dichiarato che i due ragazzi hanno solo un’ora d’aria nelle bombole, e assistiamo al cont down verso il loro esaurimento. L’idea di realizzare un film in cui il tempo narrato e quello vissuto dallo spettatore sono coincidenti è già stata utilizzata, basti pensare al recente Oxigène, di Alexandre Aja, del 2021, mentre quella di ambientare un film horror in cui la casa stregata è sott’acqua è originale (nella serie TV Curon il mondo subacqueo non viene mai esplorato), e rende la lunga sequenza in immersione molto interessante, almeno all’inizio. Lasciando stare l’ambiguità del punto di vista della telecamera, le scene di esplorazione iniziale della casa sono indubbiamente coinvolgenti e inquietanti. Lo spettatore sa che deve succedere qualcosa – in definitiva è andato a vedere un film dell’orrore – e le riprese subacquee sono ricche di punti oscuri, giochi di ombre e
Puoi anche leggere