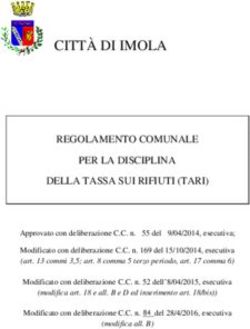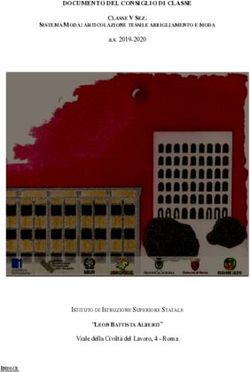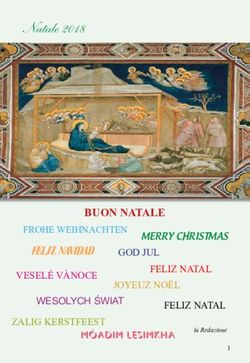Manuale di cultura birraria di Heineken Italia - € 14,90
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
A cura di Heineken Italia SpA - 2009 Tutti i diritti sui testi e sulle immagini in Italia e all’estero sono
Concept: Cantiere di Comunicazione - Direzione creativa e progetto grafico: CDA - Testi: Gea Gardini riservati ad Heineken Italia S.p.A.. I diritti di traduzione,
Foto: Studio Neon e Archivio Heineken di memorizzazione elettronica e di adattamento totale e parziale
con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche)
© Leonardo Publishing sono riservati per tutti i paesi e non possono essere concessi
Via Pietro Gaggia, 1/a - 20139 Milano a terzi senza il permesso scritto di Heineken Italia S.p.A..
Via Giuseppe Mazzini, 6 - 43100 Parma
www.leonardopublishing.com
ISBN 978-88-6284-021-7 Stampato in Italia presso Stige S.p.A. nel mese di Novembre 2009INTRODUZIONE
CAPITOLO 1
I momenti chiave del successo del Gruppo Heineken.
CAPITOLO 2
Storia e geografia della birra.
CAPITOLO 3
Alchimia della birra.
INDICE GENERALE | CAPITOLO 4
Tipologie di birra.
CAPITOLO 5
Liturgia e gestualità della birra.
CAPITOLO 6
La birra è servita.
CAPITOLO 7
La salute.È ormai passata l’epoca in cui gli Italiani amanti della birra, talvolta muti e finanche un po’ vergognosi, dovevano attendere
i raduni bavaresi per potersi deliziare con l’amato nettare, con la compagnia giusta e senza sentirsi in colpa…
Oggi “la birra è”, nel senso che è stata definitivamente sdoganata e promossa a pieni voti, titolata a sedersi anche
alle tavole più raffinate, spesso stellate, del nostro stivale. Ed ecco quindi comparire le Carte delle Birre, presentate
magistralmente e recitate con dovizia di suggestioni da Chef e Sommelier, Menu d’Autore con abbinamenti mirabolanti che
legano la birra a manicaretti eccelsi, senza comunque far vacillare lo storico e sopraffino binomio con la Pizza, raffinati
Ricettari firmati da blasonate Scuole di Cucina che guidano per mano noi, più o meno abili cuochi della quotidianità, nella
preparazione di un’ottima cucina casalinga esaltata dai gusti della birra, dimostrando che si può uscire, con successo di
critica e di pubblico, dal tunnel del solito pollo! Per non parlare dei supermercati, delle enoteche, delle grandi drogherie
che dedicano spazi crescenti alla birra nei loro preziosi scaffali, offrendo al consumatore evoluto e curioso un’insospettabile
varietà di etichette, tipologie, provenienze.
è l’inizio di una piccola ma vera rivoluzione, motivata dalla natura intrinseca di questo prodotto e non certo da una moda
passeggera. Buona, sana, allegra, versatile, e, soprattutto, democratica, è divenuta a tutti gli effetti una scelta di molti,
perfetta compagna dei riti e delle tradizioni alimentari italiane.
Ma chi, tra i milioni di consumatori di birra, conosce davvero il mondo che si nasconde dentro alla bottiglia che sta
comprando e consumando? Chi sa, davvero, come si versa una birra e qual è il bicchiere giusto? Come fare a trasmettere
la cultura più profonda di questa bevanda, affinché chi la sceglie e la consuma possa farlo al meglio e in modo realmente
consapevole? Da queste, e molte altre domande, nasce l’idea di Heineken Italia di offrire al pubblico degli appassionati
e dei curiosi italiani il ricco patrimonio di informazioni che, fino a oggi, è stato appannaggio dei soli addetti ai lavori.
Questo libro, piccolo grande manuale che racchiude il concentrato del sapere di Heineken in fatto di Birra, è per noi
una sfida: chi lo comprerà? Chi lo leggerà? Chi lo consiglierà o lo acquisterà per regalarlo? Quello che ci interessa non
è tanto il successo commerciale, ma mettere le basi per poter contare in futuro su un consumatore più consapevole, più
esigente, capace di rimproverare con garbo un barman disattento farcendogli notare “che il cappello di schiuma non è
come dovrebbe…”. Buon lettura e buon viaggio a tutti nel nostro magico mondo!
9 |CAPITOLO | UNO
I momenti chiave del successo
del Gruppo Heineken
Una storia di rispetto, piacere, passione.
1864 - Le origini del Gruppo Heineken risalgono al 1864
quando il 22enne Gerard Adriaan Heineken acquistò la
birreria De Hooiberg (the Haystack) nel cuore di Amsterdam.
A lui seguirono il figlio Henry e poi il nipote Alfred “Freddy”
Heineken: entrambi, con creatività e determinazione,
ricalcarono le orme del loro predecessore incrementando con
successo quella che oggi rappresenta la prima realtà
produttiva di birra in Europa e la quarta nel mondo.
Ancora oggi una discendente della famiglia,
Charlene de Carvalho - Heineken, siede nel Consiglio Direttivo
della Holding che governa il Gruppo ed è azionista di
maggioranza.
1873 - Heineken assume ufficialmente questo nome.
1881 - Adozione di un moderno sistema di raffreddamento
che va a sostituire il ghiaccio naturale segnando una vera
svolta alla produzione.
1886 - Invenzione del lievito A da parte del Dottor Elion,
allievo di Louis Pasteur, tuttora usato per conferire alla birra
Heineken il suo aroma caratteristico.
1890 - Nella birreria di Amsterdam si accende la prima
lampadina elettrica e dieci anni dopo le vendite raggiungono i
200.000 ettolitri.
1914 - Sotto la guida di Henry Heineken, gli ettolitri di birra
venduti diventeranno 300.000: l’azienda inizia a fare
|
13pubblicità e a espandersi in nuovi territori, specie nel vasto e promettente continente asiatico, molto più libero e accessibile del mondo oltre Atlantico. 1928 - Un aeroplano sorvola i cieli di Amsterdam in occasio- ne dei Giochi Olimpici tracciando la scritta “Heineken”: l’innovativa intuizione pubblicitaria ufficializza il rapido e ormai inarrestabile sviluppo dell’Azienda a livello internazionale. E risalgono proprio a questi anni la posa della prima pietra del nuovo stabilimento in Indonesia e l’avvio delle attività commerciali in Malesia, Cina, Nuova Zelanda e Sud-Est Asiatico. 1933 - Le prime bottiglie di Heineken sbarcano anche negli Stati Uniti: l’era del proibizionismo è finalmente conclusa. 1939 - Heineken si quota in borsa e la sua notorietà e reputazione acquistano sempre più forza. Sui mercati internazionali, a conclusione della Seconda guerra mondiale, Alfred “Freddy” Heineken avvia un processo di modernizzazione radicale. Fermamente convinto che la “birra possa viaggiare”, diviene il fautore di una reale ed efficace politica di marketing globale. 1963 - Nasce la Fondazione Heineken il cui obiettivo è sostenere la ricerca scientifica in ambito biochimico, anche attraverso il conferimento di un premio biennale ai più insigni e meritevoli studiosi. 1964 – Introduzione del nuovo logo che, tuttora, contraddistingue e rende inconfondibili tutte le confezioni immesse sul mercato. 1967 - La tecnologia produttiva fa un decisivo balzo in avanti:
nello stabilimento di Rotterdam viene installata la prima linea completamente automatizzata per la birra alla spina.
Nello stesso periodo viene anche messo a punto e introdotto un nuovo modello di fusto con tubo estraibile all’interno
- il cosiddetto “Sankey Keg” - perfettamente compatibile con la nuova tecnologia. Il sistema verrà progressivamente
adottato in tutte le birrerie del Paese.
1968 - Heineken acquisisce la Birreria Amstel e il produttore di bevande Vrumona di Bunnik, Olanda, rinforzando la
propria posizione sul mercato nazionale. Nello stesso anno il primo spot pubblicitario Heineken fa la sua comparsa in
televisione.
Anni 70 - L’assetto del Gruppo, che consta ormai di numerose e floride birrerie, si rinforza grazie all’acquisizione della
Holding Company l’Espérance, il terzo principale gruppo birrario francese, che diventerà Heineken France nel 1979.
Nel 1978 viene perfezionato al 100% anche l’acquisto del Gruppo Dreher in Italia.
1983 - Viene siglata in Brasile un’importante alleanza tra Heineken e Coca-Cola, produttrice della birra Kaiser, oggi
15 |terzo gruppo birrario del Paese. Nel frattempo, le Birrerie Kirin iniziano a produrre Heineken sotto licenza in Giappone. 1988 - Vede l’ingresso della prima Buckler analcolica in Francia, Spagna, Olanda e Irlanda. 1989 - Alfred “Freddy” Heineken si ritira per l’età avanzata: Heineken, sotto la sua guida, è divenuto il secondo più grande gruppo di birra al mondo, presente in oltre 170 Paesi. 1999 - Il marchio Heineken viene dichiarato “Marchio del Secolo” e Alfred “Freddy” Heineken “Pubblicitario del Secolo”. Morirà all’inizio del 2002 e l’azienda gli renderà onore da tutti gli angoli del globo. 2003 - Acquisizione dell’austriaca Brau-Beteiligungs, la più importante nella storia del Gruppo Heineken: l’operazione consente al Gruppo di estendere ulteriormente la propria presenza nei Paesi europei, inclusa Polonia e Repubblica Ceca, e divenire leader di mercato in Austria, Romania, Ungheria. Nel 2005 entrano nel mondo Heineken anche una serie di nuove birrerie tedesche e russe. La crescita prosegue anche negli altri continenti attraverso acquisizioni e accordi siglati negli ultimi anni in USA, Russia, Cina, Messico, Sud Africa, Namibia e Australia. 2005 - Introduzione nel mercato statunitense della nuova Heineken Premium Light Lager, una birra dal tipico aroma e qualità Heineken, ma più leggera e a inferiore apporto calorico. 2008 - Si conclude l’acquisizione di Scottish&Newcastle, storica azienda britannica.
Heineken NEL 2008:
- È il primo produttore di birra in Europa
- Impiega circa 56.000 persone
- Produce circa 162 milioni di ettolitri di birra
- Sviluppa un fatturato totale di circa 14,31
miliardi di euro
- L’utile netto è di 1,01 miliardi di euro
- La birra Heineken è commercializzata in quasi
tutti i Paesi del mondo
- Il Gruppo Heineken possiede 125 siti produttivi
in più di 70 paesi
- Dispone di oltre 200 marchi di birra
- La sede è ad Amsterdam, in Olanda
- il Gruppo Heineken è quotato alla Borsa di Amsterdam
- Non è mai venuta meno ai suoi valori:
rispetto per l’individuo, la società e l’ambiente
piacere e gioia
passione per la qualità
- e alla sua filosofia:
qualità
innovazione
17 |CAPITOLO | DUE
STORIA E GEOGRAFIA DELLA BIRRA
Dai Sumeri agli antichi Egizi, fino ai giorni nostri.
Tempi antichi
Nel 3000 a.C. in Mesopotamia esisteva una bevanda
derivata dalla fermentazione dei cereali.
La tecnica di fabbricazione della birra è arrivata poi in Egitto.
Ci sono molti documenti dell’epoca che trattano l’argomento,
tra cui la contabilità di palazzo di un Faraone.
La birra era considerata una bevanda sacra.
Dall’Egitto le conoscenze sulla birra arrivarono prima ai Greci
e poi ai Romani. Alcuni ragguardevoli personaggi della società
romana ne apprezzarono particolarmente le caratteristiche,
come ad esempio Agricola, governatore della Britannia, che
una volta tornato a Roma nell’83 a.C., portò con sé tre maestri
birrai da Glevum (Gloucester) e aprì il primo pub della nostra
penisola.
Nell’Europa centrale furono i Celti a sviluppare la tradizione
della birra derivata dal Medio Oriente, migliorandone
notevolmente le qualità. Essi erano stanziati principalmente in
Gallia e in Britannia ma la loro civiltà si sviluppò prevalente-
mente in Irlanda.
Si capisce quindi come la birra, ai tempi dei Celti e dei
Germani, fosse qualcosa di più che una semplice bevanda.
Da allora infatti essa è parte della storia, della cultura e
dell’economia di quei popoli.
Dai Conventi dell’anno 1000 all’inizio dell’Età Moderna
Notizie più precise si trovano dopo l’anno 1000 d.C.
|
21In questo periodo la birra, già largamente diffusa in tutta Europa e prodotta artigianalmente in casa o da piccole organizzazioni, inizia a essere prodotta industrialmente e nasce la figura del Mastro Birraio. Il più antico monastero noto per aver prodotto birra è quello di Montecassino, nel Lazio, che tra il 629 e il 643 d.C. produsse la prima birra di Abbazia. Segue il monastero benedettino di Weihenstephan, vicino a Monaco di Baviera, che ha iniziato verso il 750 d.C. e ancora oggi è attivo nella produzione. In Germania si può parlare di un prodotto simile al nostro già dal 1200. È infatti in questo periodo che inizia a essere utilizzato il luppolo. La produzione diventa industriale ed è regolata da leggi spesso diverse da Stato a Stato, fino a che, nel 1516, Guglielmo IV di Baviera con l’Editto sulla Purezza (Reinheitsgebot) stabilisce che la birra, in Baviera, deve essere fatta solo con malto d’orzo, luppolo e acqua. Ne fissa inoltre il prezzo per evitare speculazioni. La scoperta della ricetta con il luppolo fu determinante, non solo per le proprietà organolettiche conferite al prodotto, ma perché il luppolo possiede caratteristiche antibatteriche e conservanti, che consentono la conservazione della birra, quindi il suo trasporto e conseguentemente la sua esportazione. L’editto di Guglielmo IV fu esteso a tutta la Germania all’atto dell’unificazione nel 1871. In Gran Bretagna il luppolo cominciò a essere utilizzato nel 1400 ma a causa del conflitto di interessi tra i produttori del nuovo genere e gli agricoltori uniti nell’associazione dei produttori tradizionali (birra senza luppolo), fu vietato fino al 1600.
Anche in Belgio la storia della birra, fin dal Medioevo, è
legata ai monaci e ai loro conventi. È una storia che prosegue
ancora oggi, infatti i monaci cistercensi di stretta osservanza si
tramandano da allora ricette e metodi di produzione del loro
prodotto esclusivo.
Per curiosità diciamo che i Frati Trappisti nascono dall’Ordine
dei Cistercensi nel 1664. In quell’anno una parte dei
Cistercensi, sotto la guida di Armand le Bouthillier,
dell’abbazia di Notre Dame de La Trappe in Normandia, optò
per una regola monastica più rigida, approvata dall’allora
papa Alessandro VII, e furono chiamati “Ordine dei Cistercensi
di Stretta Osservanza” o, più comunemente, Trappisti.
Le birre Trappiste, per definirsi tali, devono essere prodotte
direttamente dai Monaci Trappisti, devono essere prodotte
rigorosamente con la ricetta originale e gli introiti derivanti
dalla vendita devono servire in parte per il mantenimento della
comunità monastica e in parte per attuare opere di carità.
I conventi che producono birra sono attualmente sette e altre
birre, prodotte secondo ricetta originale trappista ma da laici,
sono definite “di Abbazia”.
La Rivoluzione Industriale
Fino a tutto il 1600 in Europa la produzione di birra andò
migliorando qualitativamente, ma la vera rivoluzione avvenne
dai primi anni del 1700 con alcune invenzioni che
modificarono tutta la vita di allora.
Il termometro di Fahrenheit (1760) e altre invenzioni, come la
macchina a vapore di Watt (1765) e il densimetro (1770),
consentirono al produttore di birra di tenere sotto controllo
alcune delle più importanti variabili del processo, come la
|
23temperatura e la densità zuccherina dell’estratto del malto, che precedentemente erano controllati con sistemi empirici privi di ogni precisione. Anche l’invenzione del tostacaffè, in Inghilterra, da parte di Daniel Wheeler (1815), contribuì al miglioramento del processo e del prodotto. L’invenzione del tostacaffè permise di tostare il malto senza indesiderati odori di fumo e di tenere sotto controllo la tostatura. Gli studi e le scoperte di Pasteur sui lieviti e sulla fermentazione alcolica consentirono di capire la chimica della trasformazione e pertanto di migliorare il processo produttivo e la possibilità di una lunga conservazione (pastorizzazione). Anche le tecniche industriali di lavorazione del vetro contribuirono a migliorare la conservazione del prodotto e incrementare le possibilità di trasporto. Verso la metà del 1800 gli studi di Carrè e Linde sui cicli frigoriferi consentirono un primo inizio dell’industria del freddo. È in questo periodo che il sistema di produzione della birra di bassa fermentazione venne “brevettato”, cioè non fu più un fatto casuale legato alle temperature stagionali. La possibilità di controllare le temperature, nel processo produttivo della birra, permise l’utilizzo di lieviti operanti a temperature inferiori. Nel 1842 il mastro birraio Joef Groll, nato in Baviera, ma operante nella fabbrica di Pils, città della Boemia vicino a Praga, approntò un sistema di produzione a bassa fermentazione, che permetteva di produrre birra a temperature basse per tutto l’anno. Egli diede origine a un nuovo stile birrario e la birra così prodotta prese il nome di Pils o Pilsen, dalla città di origine. La caratteristica principale di tale stile è l’amaro dominante e il colore chiaro. Pochi anni dopo anche la Germania si strutturò per produrre a bassa fermentazione dando origine alle cosiddette Lager, birre chiare meno luppolate delle Pils. Con l’avvento dei nuovi sistemi di generazione artificiale del freddo divenne possibile produrre, con continuità e con un buon livello di qualità, le birre di bassa fermentazione che oggi sono le più diffuse (90% del mercato). Il XX Secolo Nel XX Secolo si acquisisce maggiore padronanza delle tecniche di produzione, si conoscono approfonditamente tutti i processi biochimici e si utilizza la catena del freddo in modo esteso. Inoltre si sviluppano le possibilità di trasporto celere e sicuro in qualsiasi parte del mondo e si assiste alla nascita dei colossi dell’industria birraria che hanno reso la bevanda birra un fenomeno globale.
Durante tutto il XX Secolo le multinazionali della birra, a partire da Heineken che per prima sbarcò negli Stati Uniti al
termine del proibizionismo (1933), hanno lavorato alla diffusione della birra e all’implementazione della sua conoscenza
attraverso una politica che rispondesse alle esigenze del mercato di destinazione.
La birra in Italia
Fu con la discesa da nord delle popolazioni barbariche, alla caduta dell’Impero Romano, che la birra cominciò ad
assumere un ruolo più importante nell’alimentazione degli italiani e ad essere apprezzata dalla popolazione.
Nel Medioevo, in Italia come in tutto il resto d’Europa, la birra cominciò a essere conosciuta e apprezzata, anche grazie
agli eserciti mercenari provenienti da nord che ne diffusero l’uso e la conoscenza.
Nell’Ottocento quasi tutte le fabbriche di birra erano legate a imprenditori austro-tedeschi stabilitisi in Italia a cui si
affiancarono in seguito imprenditori italiani.
Alla fine dell’Ottocento, a seguito delle scoperte precedentemente citate, che comportarono un incremento della qualità,
|
25una diminuzione dei costi e una più diffusa distribuzione, ci fu
un notevole aumento sia della produzione sia dei consumi.
Poi venne la Prima guerra mondiale e sorsero difficoltà di
approvvigionamento dell’orzo per la produzione di malto e,
poiché il prodotto nazionale era di scarsa qualità,
la produzione di birra subì una brusca battuta d’arresto.
Alla fine della guerra la produzione crebbe in modo
eccezionale fino al 1927, anno in cui furono varate alcune
leggi, tra cui la legge Marescalchi, atte a proteggere il settore
vinicolo dalla concorrenza della birra.
La conseguenza fu un crollo della produzione: da oltre
1.500.000 ettolitri nel 1925 a meno di 700.000 ettolitri nel
1930.
Solo verso il 1950 si può parlare di una lenta ripresa.
Nel corso degli anni Sessanta e Settanta, parallelamente allo
sviluppo dei canali della distribuzione alimentare, si diffuse nel
pubblico l’abitudine di bere birra.
Ormai la birra è entrata a pieno titolo nelle abitudini alimentari
degli italiani.
|
Storico apparecchio governativo
per il calcolo dell’accisa 27CAPITOLO | TRE
ALCHIMIA DELLA BIRRA
Buona per Natura.
Materie Prime
Malto d’orzo e altri cereali
I principali cereali utilizzati nella produzione di birra sono:
orzo, riso, mais, frumento. L’orzo, specie distichum, è il cereale
preferito dal Mastro Birraio per la produzione di birra; ma, a
seconda della ricetta, vengono utilizzati anche dei
succedanei, soprattutto mais, riso e frumento.
Acqua
Per la produzione della birra si utilizzano solo acque sotterranee,
che possono essere di sorgente o di falda, purché
batteriologicamente pure. In linea di massima le acque per la
produzione della birra devono essere povere di carbonati e
bicarbonati, perché oltre a dare precipitati indesiderati possono
comportare variazioni di pH ed estrarre sostanze indesiderate
dai cereali maltati. La presenza di sali è un elemento di tipicità
per ogni stile birrario, infatti per la produzione di birre scure
si utilizzano acque più dure mentre per la produzione di birre
chiare si utilizzano acque più dolci.
Lievito
Il lievito è l’artefice di tutto ciò che troveremo nella birra in
termini olfattivi e gustativi perché è il responsabile del processo
di fermentazione. Per la produzione di birra si utilizzano due tipi
di lievito appartenenti alla famiglia Saccaromyces Cerevisiae.
In particolare, le birre di alta fermentazione - temperatura da 15
a 25 °C - si usa il Saccaromyces Cerevisiae razza Cerevisiae.
Le birre di bassa fermentazione - temperature da 6 a 10 °C -
sono prodotte con il Saccaromyces Cerevisiae razza Uvarum.
|
31Il sistema a bassa fermentazione è attualmente utilizzato per la produzione del 90% delle birre presenti sul mercato. Nella produzione delle birre di fermentazione spontanea, che sono tipicamente artigianali e prodotte in piccole quantità e in una specifica regione vicino a Bruxelles, il lievito non viene artificialmente aggiunto, ma si trasferisce naturalmente dall’aria al mosto, dando luogo a fermentazione spontanea. Luppolo Pianta perenne, erbacea, rampicante, che produce fiori maschili e femminili e che si sviluppa preferenzialmente in zone temperate, raggiungendo un’altezza media di circa 8 metri. Per la produzione della birra vengono utilizzate solo le inflorescenze femminili non fecondate perché sono più profumate. L’utilizzo del luppolo è strettamente collegato alla ricetta del Birraio, che tendenzialmente usa un prodotto locale che abbia le caratteristiche da lui desiderate. Processo produttivo standard Come abbiamo descritto precedentemente, per la produzione della birra si usa prevalentemente il malto d’orzo. Di seguito descriviamo il processo di maltazione necessario per trasformare l’orzo in malto, e renderlo quindi utilizzabile per il “brassaggio” (brassare è il verbo con il quale si definisce l’azione del produrre birra, dall’ammostamento al confezionamento). Per maggiore comprensione, successivamente alla maltazione spieghiamo il processo produttivo, descrivendone le fasi di brassaggio con didascalie e immagini del liquido durante le relative tappe di lavorazione. Maltazione Nella malteria l’orzo viene trasformato in malto: questo significa che viene messo a macerare in acqua, in cosiddette “vasche di macerazione”, per 24 ore a 10-12 °C affinché inizi a germinare.
A seguire l’orzo viene portato in cassoni di germinazione dove resta per 6-8 giorni, periodo nel quale si formano e
cominciano ad agire gli enzimi. L’azione degli enzimi consiste nel disgregare le lunghe catene molecolari dell’amido,
che è un polisaccaride, in unità sempre più corte fino ad arrivare, come vedremo nelle fasi successive, al maltosio che
è un disaccaride e infine al glucosio, che è un monosaccaride.
Il microrganismo-lievito infatti non è in grado di “mangiare” le lunghe catene di amido e pertanto queste devono essere
disgregate fino alla “misura” che il microrganismo-lievito può accettare.
Quando si raggiunge il grado di germinazione desiderata si arresta il processo.
Maturazione ed essiccazione
Dopo il periodo di germinazione, la temperatura del malto viene portata progressivamente a 30 °C. È importante che
la massa non subisca degli shock termici, che danneggerebbero gli enzimi, pertanto gli incrementi come le diminuzioni
di temperatura devono avvenire gradualmente.
Successivamente si procede all’essiccazione portando lentamente il prodotto a circa 40-50 °C affinché si fermi la
germinazione e l’umidità decresca progressivamente fino al 5%.
Una volta essiccato, il malto viene privato delle radichette secche la cui presenza danneggerebbe le caratteristiche del
prodotto. Il processo di essiccazione dura complessivamente 1 giorno.
Essiccazione/Tostatura
Premettiamo che da un punto di vista puramente tecnico il procedimento che
andiamo a descrivere in questo sottocapitolo si definisce “tostatura”.
33 |Tuttavia precisiamo che nell’ambiente birrario si preferisce definirlo essiccazione, quindi un proseguimento di quanto descritto sopra. Da questa fase, cioè dal grado di tostatura, dipendono alcune delle principali caratteristiche di una birra: il colore e il sapore. Essa è caratterizzata dai seguenti parametri: 1) Range di temperature 2) Tempo di permanenza a una certa temperatura In base al tempo di permanenza a una determinata temperatura si producono malti di diverso tipo: i malti chiari - che danno luogo a birre chiare - vengono tostati a temperature fino a 80 °C; i malti ambrati - che danno luogo a birre rosse e ambrate - si ottengono con temperature di 100-110 °C; i malti scuri - che danno luogo a birre scure - si ottengono con temperature fino ai 150 °C; i malti speciali, come quelli coloranti, si ottengono con temperature fino ai 200 °C, oppure il tipo chocolate a 230 °C. Come per il grado di amaro, che viene definito scientificamente in IBU (International Bitterness Unit), anche per il colore è stata definita una scala europea, chiamata EBC (European Brewery Convention). Macinatura Il malto proveniente dalle malterie viene direttamente portato nelle birrerie dove viene macinato per permettere agli zuccheri contenuti nel chicco di sciogliersi nell’acqua.
| 35
1 2 3 4 5 6
1 - FASE 1
Miscela malto e acqua
Macinato il malto, lo si immette nella caldaia di miscela con acqua, dove si prepara il mosto
portandolo a temperature fino a 75 °C
2 - FASE 2
Mosto caldaia piena
Dopo aver filtrato la miscela, si porta il mosto nella caldaia di ebollizione
(il malto macinato derivante dalla filtrazione, le cosidette trebbie, viene reimpiegato come
mangime per animali ed è molto pregiato e richiesto); in questa fase viene aggiunto
il luppolo
3 - FASE 3
Fermentazione
Terminata la cottura, il mosto viene separato dalle sostanze insolubili nel whirlpool
(un secondo particolare processo di filtrazione), raffreddato e portato nei tini di
fermentazione dove viene aggiunto il lievito
4 - FASE 4
Maturazione
Dopo la prima fermentazione (4-6 gg fermentazione veloce), la birra matura e si affina
per 3/4 settimane, talvolta cambiando anche tino
5 - FASE 5
Birra
La birra è pronta per essere filtrata dai lieviti, quindi confezionata
6 - FASE 6
Salute! Prosit! Cheers!
37 |La produzione della birra e l’ambiente
Heineken Italia S.p.A. per attuare la propria politica
ambientale ha aderito alla norma ISO 14001 al fine di costruire
all’interno dell’organizzazione un Sistema di Gestione
Ambientale. Questo è uno strumento che l’Azienda mette a
punto per identificare e mantenere attiva la conoscenza delle
interazioni tra l’ambiente e i suoi prodotti, attività e servizi, al
fine di monitorare e migliorare il livello delle sue “prestazioni
ambientali”. In particolare, poiché l’acqua svolge un ruolo
essenziale nell’industria della birra - insieme all’orzo germinato
e al luppolo - Heineken ha sviluppato una “water policy” appli-
cata a livello globale in tutti gli stabilimenti produttivi. L’acqua
di approvvigionamento viene quindi trattata per renderla
adatta all’uso nel processo di fabbricazione della birra mentre
l’acqua di scarico viene depurata per renderla non inquinata
e limpida, in conformità alle norme emanate dal governo di
ciascun paese dove Heineken opera con uno stabilimento.
|
39CAPITOLO | QUATTRO
TIPOLOGIE DI BIRRA
L’imbarazzo della scelta.
Classificazione secondo il tipo di fermentazione
La classificazione per tipo di fermentazione è la seguente:
- birre di alta fermentazione
- birre di bassa fermentazione
- birre di fermentazione spontanea
La differenza tra un metodo e l’altro è data dal tipo di lievito
utilizzato e dalla temperatura a cui avviene la fermentazione.
Birre di alta fermentazione
Le birre di alta fermentazione sono prodotte con il lievito
Saccaromyces Cerevisiae razza fisiologica Cerevisiae che è
attivo a temperature più alte, dai 15° ai 25 °C.
Vediamo i principali stili birrari prodotti secondo questo sistema:
Ale - Birre britanniche. Le materie prime utilizzate sono malto
d’orzo, cereali non maltati, prevalentemente mais, zuccheri
vari, luppolo. Sono birre la cui gradazione alcolica va da
pochi gradi saccarometrici fino a 15 e più (gradazione
alcolica tra i 2 e i 6/7 gradi). Fanno parte della famiglia una
varietà di birre: Bitter Ale, Pale Ale, Scotch Ale, Strong Ale
ecc., in funzione del metodo con cui vengono prodotte.
Stout - Birra britannica erede delle Porter, la birra più
consumata in Irlanda da coloro che svolgevano lavori pesanti.
Ha le stesse materie prime delle Ale ma una colorazione più
intensa, quasi nera. Birra nazionale irlandese assai amara,
scurissima e con schiuma cremosa e consistente.
Weissbier - Birra tedesca. Prodotta con almeno il 50% di
malto di frumento. Piacevolmente acidula. Le originarie sono
rifermentate in bottiglia, perciò molto ricche di anidride
carbonica e presentano un sottile strato di lievito sul fondo.
|
43La mescita di queste birre richiede una ritualità particolare (vedi capitolo “Liturgia e gestualità della birra”). La famiglia comprende una molteplicità di tipi che hanno gradazione alcolica variabile. Altbier - Birra tedesca. È l’equivalente tedesco della Ale. È una qualità di birra ambrata, originaria della regione di Dusseldorf per la quale viene utilizzata una grande quantità di luppolo e uno specifico malto. È prodotta con il metodo dell’alta fermentazione ma maturata a freddo. Kölsch - Birra tedesca. Di colore dorato, non prodotta industrialmente. In Germania è considerata una birra che stimola l’appetito e favorisce la digestione, per questo è bevuta come aperitivo. Saison - Birra belga. Stagionale estiva, chiara, acidula, frizzante, poco alcolica, lascia un retrogusto profumato. Abbazia - Birra belga. Birra forte, corposa. Decisamente alcolica. Prodotta secondo la ricetta dei monaci in birrifici selezionati; spesso rifermentata in bottiglia. Ne esiste una grande varietà. Bière Blanche - Birra belga. Di colore bianco. In origine prodotta con 45% di orzo, 45% di frumento e 10% di avena. Attualmente è prodotta solo con malto d’orzo e frumento. Sapore fresco, dissetante. Aroma fruttato e floreale con note di coriandolo o chiodi di garofano. Trappista - Birra belga. Come l’Abbazia, ma prodotta dai monaci trappisti cistercensi con varie miscele di malto. Fortemente luppolata. Rifermentata in bottiglia. Colore dall’ambrato al bruno scuro. Tra le birre di alta fermentazione rientrano le birre rifermentate in bottiglia la cui caratteristica è una seconda fermentazione all’interno della bottiglia stessa (o del fusto). Al termine del processo di produzione standard e prima del confezionamento, si procede con un’altra aggiunta di mosto e lievito nel prodotto. A fermentazione terminata, il lievito
aggiunto si deposita sul fondo. La rifermentazione in bottiglia contraddistingue le birre Trappiste, alcune birre d’Abbazia,
le delicate birre bianche di frumento (Weizen) e altre birre strong Ale.
Birre di bassa fermentazione
Il metodo della bassa fermentazione, attualmente il più diffuso, è nato nei primi decenni del secolo scorso e con esso
viene prodotto circa il 90% delle birre nel mondo. Si utilizza il lievito Saccaromyces Cerevisiae razza fisiologica Uvarum,
che è attivo a temperature più basse, dai 6 ai 10 °C.
Vediamo i principali stili birrari prodotti secondo questo sistema:
Lager - Birra tendenzialmente chiara con un grado di amaro non accentuato e dall’alcolicità variabile. Può essere di
colore paglierino scarico come scuro. E’ il tipo di birra più diffuso nel mondo e non è particolarmente caratterizzata
negli aromi e nel gusto.
Pils/Pilsner - Originaria di Pilsen, è una birra di colore chiaro, dorato. Più amara della lager, ha un intenso aroma di luppolo
ed è molto frizzante. Si possono definire Pilsner solo le birre chiare che hanno un grado di amaro superiore a 30 IBU.
Monaco - Da Monaco di Baviera, ambrata abbastanza scura e pastosa, ha un carattere maltato. E’ stato codificato
come uno dei primi stili di birra a bassa fermentazione.
Dortmund - Dall’omonima città della Westfalia, è una birra abbastanza corposa, compromesso tra le birre molto maltate
Malto Malto Malto Malto Malto di Gritz
Riso
chiaro caramello torrefatto colorante frumento di mais
45 |della Baviera e le birre molto luppolate del nord della Germania. Bock - Chiara o ambrata, è una birra corposa. Di questo stile esistono più varianti tra cui la Maibock, prodotta per le feste primaverili e la Dopplebock, anch’essa prodotta in primavera. Birre di fermentazione spontanea Si tratta di un mondo a parte, che esiste e vive solo in Belgio, e la Birra prodotta è peculiare della zona che si chiama “Payottenland” ed è vicina a Bruxelles. I lieviti che si trovano nell’aria (in quell’aria) vengono naturalmente a contatto con il mosto, si moltiplicano ed effettuano la trasformazione degli zuccheri in alcol. In questa famiglia molto ampia di lieviti naturali ne sono stati individuati alcuni chiamati “Batteriomyces Bruxellensis” e “B. Lambicus”. La birra così prodotta si chiama “Lambic” e questo nome, che è un marchio, può essere utilizzato solo per le birre prodotte con questo metodo tradizionale e fermentate con i lieviti sopraccitati.
La Lambic, prodotta partendo da una miscela di orzo e frumento non maltato, che non può essere inferiore al 30%, è
fatta da ottobre ad aprile, perché i lieviti, con le più alte temperature dell’estate, danno luogo a fermentazioni anomale.
La birra prodotta durante l’inverno matura dopo la prima estate e può già essere bevuta come “prodotto giovane”, ma
poiché la maturazione prosegue nel tempo la birra può essere lasciata maturare per una seconda o per una terza estate
e si ottiene così un prodotto invecchiato. La Geuze è una miscela di varie Lambic che proseguono la fermentazione in
bottiglia, senza alcun intervento ulteriore, ed è chiamata anche lo Champagne del Belgio per il tipo di schiuma, per il
sapore secco e perché imbottigliata nelle bottiglie da Champagne.
Fanno parte delle birre di fermentazione spontanea anche le fruttate Kriek, alla ciliegia, e le Fromboise, ai lamponi.
Classificazione Legale
La legge italiana classifica le birre nelle seguenti categorie, in relazione al loro grado Plato (grammi di zucchero per
100 grammi di soluzione):
Denominazione Grado Plato (°P) Grado alcolico (% vol)
Birra analcolica 3-8 < 1,2
Birra light 5 - 10,5 1,2 - 3,5
Birra >10,5 > 3,5
Birra speciale > 12,5 > 3,5
Birra doppio malto > 14,5 > 3,5
Nota: la classificazione legale non tiene conto né del colore né del tipo di fermentazione, ma è stata creata dal legislatore
per stabilire i parametri utili alla definizione della tassa sulla produzione degli alcolici. Il grado alcolico finale della birra
viene determinato dalla concentrazione di zucchero nel mosto (detta “grado Plato”, dal nome del suo ideatore), e dalle
condizioni di fermentazione. La correlazione fra grado Plato e grado alcolico è piuttosto complessa e può essere calcolata
attraverso la formula di Balling.
Birre Analcoliche - Si definisce birra analcolica una birra con un contenuto alcolico inferiore all’1,2%.
Classificazione per colore
A seconda del tipo di malto e del grado di tostatura dello stesso avremo tre tipologie di birra:
Chiare, Ambrate e Scure
47 |1 - AMBRATA
Birra Moretti La Rossa
2 - AMBRATA
Affligem Rouge
i colori delle birre
chiare e ambrate
3 - AMBRATA
Mc Farland
4 - CHIARA ABBAZIA
Maredsous 6
5 - CHIARA STRONG LAGER
Birra Moretti Doppio Malto
6 - CHIARA LAGER
Heineken
7 - Chiara lager analcolica
Birra Moretti Zero1 - STOUT
Murphy’s
2 - SCURA DI ABBAZIA
Maredsous 8
rifermentate in bottiglia e scure
(rifermentata in bottiglia)
3 - SOUR ALE
i colori delle birre
Duchesse De Bourgogne
(particolare birra maturata
in botti di rovere)
4 - BLANCHE
Wieckse Witte
(rifermentata in bottiglia)
5 - WEISS / WEIZEN
Erdinger
(rifermentata in bottiglia)
6 - STRONG ALE
Duvel
(rifermentata in bottiglia)
7 - BLANCHE
Blanche de Bruxelles
(rifermentata in bottiglia)
|
49CAPITOLO | CINQUE
LITURGIA E GESTUALITÀ DELLA BIRRA
Semplici regole per gustarla al meglio.
Introduzione
Per la birra, come per il vino, esistono una serie di regole
relative alle modalità di consumo che vanno rispettate per
valorizzare le caratteristiche organolettiche e per non svilire
le proprietà del prodotto che, in quanto derrata alimentare,
è sensibile. Inoltre, la storia millenaria e la lunga catena che
dal campo di orzo porta la birra in tavola hanno permesso di
maturare e codificare regole relative alle modalità di servizio.
In questa parte del manuale prendiamo in considerazione ciò
che avviene dal momento in cui i fusti (o le bottiglie o le lattine)
arrivano nei luoghi di consumo, in particolar modo le birrerie.
L’arte della spillatura
La spillatura è parte integrante della cultura e delle modalità di
servizio e degustazione di un certo stile di birra.
Il servizio rispetta le peculiarità del prodotto tenendo conto
anche delle origini e della storia. Una corretta spillatura infatti
conferisce alla birra le caratteristiche originali che aveva
all’uscita dall’impianto di produzione.
In linea di massima si può dire che le birre di alta
fermentazione, che hanno odori secondari sviluppati, devono
essere servite a una temperatura più alta rispetto a quelle di
bassa fermentazione, perché il freddo inibisce l’aroma.
Diversi stili di spillatura
Le tre tecniche principali di spillatura sono legate alle tre
culture in cui si è sviluppata la birra e tengono conto anche dei
tre livelli di saturazione di CO2 (quantità di anidride carbonica
disciolta nel liquido) che hanno le birre tedesche,
|
53belghe/olandesi e anglosassoni. Tedesca o tradizionale La spillatura tedesca è anche definita “tradizionale” perché il tedesco tradizionalmente spilla le sue birre in tre tempi riempiendo il bicchiere con tre versate. La birra tedesca ha una saturazione alta (quantità di anidride carbonica che riscontriamo nella stessa) quindi la contro-pressione che si esercita nel fusto determina una velocità di erogazione altrettanto alta, che ci obbliga a utilizzare bicchieri grandi, da litro, per riuscire a contenere la birra che fuoriesce dalla spina. Le regole principali della spillatura tedesca sono: - tenere il bicchiere a 45 gradi e spillare facendo scendere la birra lungo la parete, successivamente raddrizzare il bicchiere e versare finché la schiuma arriva al bordo - attendere un minuto per permettere alla schiuma di compattarsi, poi dare un secondo colpo e attendere un altro minuto. - la conclusione del servizio è data dall’ultimo colpo, che crea la “cresta” o “corona” Questo tipo di spillatura consente di ricreare l’equilibrio di CO2 nella birra e di creare un cappello di schiuma alto e abbondante. Il tempo impiegato per una spillatura corretta è 7 minuti. Belga/olandese o dinamica La spillatura belga/olandese è denominata anche “dinamica” perché il bicchiere viene riempito in una sola versata. Le birre provenienti da questa area geografica hanno una saturazione differente da quelle tedesche, perciò l’impianto viene dimensionato affinché si possano riempire, in una sola versata, i bicchieri (tendenzialmente la misura del bicchiere è da 0,25 centilitri). Questo sistema di spillatura prevede, inoltre, l’uso dello strumento che identifica la cultura stessa: il taglia-schiuma. Le regole principali della spillatura belga/olandese sono: - tenere il bicchiere a 45 gradi sotto il rubinetto - aprire avendo cura di far cadere la prima goccia fuori dal bicchiere, poi raddrizzare il bicchiere in base alla quantità di schiuma che si forma progressivamente - chiudere il rubinetto quando la schiuma è al bordo, allontanando il bicchiere dal flusso spina - utilizzare il taglia-schiuma per eliminare le bolle più grosse, più evanescenti, in modo da compattare la schiuma e renderla a grana fine Irlandese o legale La birra irlandese ha una bassissima quantità di CO2, pertanto avrebbe bisogno di una contro-pressione molto alta per essere spillata dal fusto e ciò ne altererebbe la naturale saturazione (la CO2, infatti, si lega al prodotto). È stato introdotto un sistema che consente di spingere la birra dal fusto al rubinetto con una miscela di azoto + anidride carbonica perché l’azoto è un gas volatile che non si lega ai liquidi. La magia del servizio di questa tecnica di
spillatura, in due tempi, si completa con il beccuccio del
rubinetto, che, grazie a un dischetto in acciaio con 5 microfori,
disgrega l’anidride carbonica presente nella birra formando
un’emulsione spettacolare. Il risultato è la creazione di una
schiuma cremosa compatta e persistente a protezione della birra.
Le regole principali della spillatura irlandese:
- iniziare la spillatura con il bicchiere inclinato a 45 gradi
- riempire il bicchiere per ¾ del suo volume
- lasciar decantare per 30-40 secondi
- rabboccare
La spillatura irlandese è il risultato di una situazione sociale,
di un modo di vivere e di un modo di bere. È l’unione tra alta
tecnologia e aspetti sociali antichi, tuttora condivisi. Il sistema
di spillatura al carbo-azoto permette agli irlandesi di godere
di una birra sempre perfettamente spillata, con una schiuma
cremosa, finissima e molto persistente, che gli consente di
trattenersi al pub e terminare la propria pinta anche al termine
del servizio di mescita.
La schiuma
I tre diversi stili di spillatura hanno in comune l’obiettivo, ovvero
servire una birra che esprima tutte le sue potenzialità sia in
termini olfattivi sia in termini gustativi per soddisfare pienamente
il consumatore. Una corretta spillatura, in generale, dà come
risultato una birra che presenta un giusto cappello di schiuma:
alto e abbondante nella tedesca; equilibrato (almeno due dita)
nella belga/olandese; basso, finissimo e molto persistente
nella irlandese. La schiuma ha una funzione fondamentale nel
servizio della birra (spina o bottiglia non fa differenza), perché
protegge il prodotto dal suo nemico principale: l’aria. Inoltre
la creazione del cappello di schiuma permette di desaturare la
birra dalla CO2 in eccesso che altrimenti potrebbe provocare
gonfiore allo stomaco, rendendo la birra meno digeribile.
|
551 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14
5
La spillatura belga/olandese in dettaglio
Il servizio delle birre alla spina belghe/olandesi
(vedi sequenza a sinistra)
1 - Appoggiare il sottobicchiere sul banco
2 - Prendere un bicchiere
3 - Utilizzare un doppio lavello e sgrassare il bicchiere con un detergente neutro
4 - Pulire anche il fondo del bicchiere
5 - Sciacquare il bicchiere in acqua fredda
6 - Verificare che il bicchiere sia perfettamente sgrassato
7 - Aprire il rubinetto e far cadere la prima goccia fuori dal bicchiere
10 8 - Iniziare la spillatura tenendo il bicchiere a 45 gradi
9 - Raddrizzare lo stesso per dosare la quantità di schiuma
10 - Quando la schiuma è al bordo chiudere il rubinetto
11 - Spostare il bicchiere fuori dalla portata del rubinetto
12 - Tagliare la schiuma con il taglia-schiuma inclinato a 45 gradi,
eliminando le bolle larghe
13 - Risciacquare le pareti esterne del bicchiere
14 - Asciugare il bicchiere
15 - Posare il bicchiere sul sottobicchiere con il marchio rivolto al consumatore
15
|
571 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16
5 6
Il servizio delle birre in bottiglia di bassa
fermentazione al banco (vedi sequenza a sinistra)
1 - Posizionare sul bancone due sottobicchieri: uno
per la birra, l’altro per la bottiglia
2 - Togliere la bottiglia dal frigo e controllarne la
pulizia
3 - Stappare la bottiglia
4 - Controllare l’interno del tappo
5 - Mostrare il tappo al consumatore
6 - Prendere un bicchiere
11 12 7 - Utilizzare un doppio lavello (se disponibile) e
sgrassare il bicchiere con un detergente neutro
8 - Pulire anche il fondo del bicchiere
9 - Sciacquare il bicchiere in acqua fredda
10 - Verificare che il bicchiere sia perfettamente
sgrassato
11 - Versare con calma la birra nel bicchiere tenuto
inclinato senza che il collo della bottiglia
tocchi il bicchiere o la schiuma
12 - Raddrizzare lentamente il bicchiere per ottenere
il cappello di schiuma desiderato
13 - Appoggiare bicchiere e bottiglia sul piano di
17 18 lavoro
14 - Tagliare la schiuma con il taglia-schiuma
inclinato a 45 gradi, eliminando le bolle larghe
15 - Risciacquare le pareti esterne del bicchiere
16 - Asciugare il bicchiere
17 - Posare il bicchiere sul sottobicchiere di sinistra
con il marchio rivolto al consumatore
18 - La birra è servita
59 |Quale bicchiere? La finalità del bicchiere consiste nell’esaltare le caratteristiche organolettiche, al fine di consentire il massimo appaga- mento durante il consumo. - Per birre chiare di bassa fermentazione si suggerisce di utilizzare un bicchiere biconico, conico e slanciato, tulipano, cilindrico. - Per le birre d’Abbazia, un bicchiere tipo baloon. - Per le birre Trappiste un bicchiere tipo coppa. - Per le Stout, la pinta quasi cilindrica. - Per le Alt bicchieri cilindrici alti. - Per le Weizen bicchieri con la base stretta, che si allarga salendo e la chiusura in alto. La conservazione: modalità di trattamento La birra è una derrata alimentare e come tale ha una sua vita, pertanto deve essere conservata in maniera adeguata. È sensibile all’azione dell’aria e alla luce per cui, una volta aperto il contenitore, il contenuto deve essere consumato in
breve tempo.
La birra è sensibile all’azione del tempo, a eccezione di quelle
che prevedono un invecchiamento, pertanto deve essere
consumata entro la data di scadenza.
La data di scadenza è garanzia di qualità ma la birra, anche
se scaduta, non è nociva per la salute.
La durata dei fusti
I fusti, la cui birra è stata pastorizzata prima del confeziona-
mento, hanno una durata media di 6 mesi.
La data di scadenza indica il termine oltre al quale la birra
perde la sua freschezza e stabilità.
Esistono poi fusti che contengono birra non pastorizzata la cui
durata è brevissima (15 gg), ma vengono utilizzati soprattutto
in paesi grandi consumatori di birra.
In ogni caso il fusto, una volta aperto, va consumato nel più
breve tempo possibile, meglio 2-3 giorni.
Gestione della bottiglia
Abbiamo parlato dell’importanza della temperatura di servizio
al fine di esaltare gli aromi e i sapori della birra.
La regola vuole che la birra sia conservata al buio e al fresco.
Nel frigorifero è bene che le birre stile Lager siano posizionate
in basso mentre le alte fermentazione siano poste in alto.
Dritte o sdraiate?
Per quelle di bassa fermentazione, se la bottiglia è sigillata
bene non c’è differenza, invece per quelle di alta
fermentazione, rifermentate o in presenza di lieviti, le cose
cambiano. Per evitare che il lievito si depositi sulla parete della
bottiglia è bene tenerle in posizione verticale, in modo che il
lievito si depositi sul fondo. Questo ci permetterà la corretta
gestione durante il servizio.
|
61CAPITOLO | SEI
LA BIRRA È SERVITA
Con la birra c’è più gusto.
Introduzione
La birra è una bevanda che possiede le sensazioni gustative
fondamentali: acido, dolce, amaro, salato.
Può essere analizzata secondo i quattro sensi principali:
vista, olfatto, tatto, gusto. Tramite la vista possiamo valutare la
schiuma e la trasparenza, tramite l’olfatto la forza o l’assenza
degli aromi, profumi e odori che una birra sprigiona e tramite il
gusto e il tatto possiamo verificare la frizzantezza, il corpo, la
morbidezza e le sensazioni gustative, fondamentali nella scelta
per l’abbinamento a un prodotto gastronomico.
Questa premessa è necessaria perché ai fini dell’abbinamento
birra/cibo e cucina con la birra è importante riconoscere i
segnali che provengono dai sensi coinvolti al fine di ottenere
un equilibrio delle sensazioni. L’abbinamento tra birra e cibo,
infatti, avviene per la maggior parte per affinità. Se deside-
riamo che una birra e un cibo, accostati a tavola, esprimano
ognuno il meglio di sé, nessuno deve sovrastare l’altro, anzi le
caratteristiche organolettiche dell’uno devono esaltare le carat-
teristiche organolettiche dell’altro. Se in un piatto c’è un gusto
prevalente, a seconda del gusto, si abbina per analogia o per
contrasto.
La relazione tra gli abbinamenti
Il corpo della birra deve essere in armonia con la struttura della
pietanza. La prevalente sensazione amara della birra non deve
mai sovrastare il cibo. L’amaro di alcune birre non deve essere
abbinato a cibi delicati (pesce magro) ma a piatti con una
modesta presenza di amaro. L’acidità (esaltata dalla freschezza
della birra) e la frizzantezza hanno un’azione sgrassante che
|
65coadiuva l’azione della saliva. L’azione solvente dell’alcol della
birra rende meno greve la sensazione di pesantezza presente
in cibi eccessivamente grassi.
Per ogni piatto la sua birra.
Il gusto dolce attenua l’acido.
Il gusto amaro rende difficile la percezione del salato.
Il gusto acido attenua l’amaro.
Impostare gli abbinamenti tra birra e cibo
In cucina si parte dai piatti freddi e poco strutturati per
passare ai tiepidi più strutturati fino ai caldi molto strutturati.
Così anche la birra richiede che venga rispettata la giusta
sequenza di servizio a tavola. Si parte con birre dall’amaro
assente e leggere di corpo, servite a temperatura più bassa e
si procede, come per il cibo, con birre più corpose e ricche,
servite a temperatura superiore rispetto a quella iniziale. Per
essere precisi, la sequenza è la seguente:
1) prima le birre poco amare, le leggere di corpo e con
intensità olfattiva tenue, poi le birre di corpo consistente,
maggior ricchezza e persistenza retrolfattiva
2) prima le birre che vengono servite a temperatura più bassa
3) prima le birre più secche, poi le abboccate e infine le dolci
4) prima le birre chiare, poi le ambrate e infine le scure
Birra e pizza
L’abbinamento birra/pizza è tipicamente italiano e, nato negli
anni Cinquanta, si è diffuso a macchia d’olio fino a diventare
l’accoppiata per eccellenza. Spesso, in maniera inappropria-
ta, si sente commentare che birra e pizza gonfiano la pancia.
Ciò può risultare vero se la birra è stata spillata male, nel
senso che se è troppo carica di CO2 provoca gonfiore, ma
anche acidità per la reazione dell’anidride carbonica con il
pomodoro, ingrediente acido della pizza.
|
85La regola del corretto abbinamento birra/pizza è scegliere la
birra in base al gusto prevalente della pizza, cosa non facile
in quanto gli ingredienti usati per la pizza sono svariati. Per
esempio la “Quattro stagioni” o la “Quattro formaggi” sono
pizze molto ricche e variegate. Talvolta viene aggiunto olio al
peperoncino che inibisce la capacità della lingua di
percepire i gusti e rende ogni abbinamento difficile.
Peperoncino a parte, quando una pizza contiene una moltepli-
cità di sapori, tra loro in equilibrio, o con uno in leggera preva-
lenza, la birra deve essere di alta fermentazione, dal profumo
intenso e persistente, come una birra d’Abbazia. Nel caso
in cui si voglia abbinare la birra ad una pizza più semplice,
o meno complessa nei sapori, una lager fresca e dissetante
riuscirà a soddisfare in pieno anche i palati più esigenti.
Birra e salumi
Solo pensando alla bresaola d’asino e a un bel pezzo di lardo
d’Arnad ci rendiamo conto come la fastosa famiglia dei salumi
sia ampia: dal più magro al più grasso, carne bianca, rossa o
scura (la selvaggina). Per affrontare la scelta dell’abbinamento
dividiamo la famiglia dei salumi in tre categorie, tenendo presente
che questa divisione non è scientifica, ma di buon senso:
Salumi magri: consideriamo che siano quelli con contenu-
to di lipidi fino al 15%. Ad es.: bresaole, insaccati di carni
bianche, prosciutti di selvaggina, prosciutto crudo magro ecc.
Salumi semigrassi: dal 15 al 45% di lipidi. Ad es.: salami,
salamelle, coppa, mortadella, pancetta magra, ecc.
Salumi grassi: oltre il 45% di lipidi. Ad es.: lardo, salsiccia,
cotechino ecc.
Solitamente i salumi più magri sono anche i più salati e
pertanto, se seguiamo la norma citata prima, al cibo dove il
salato è preponderante dovremo abbinare una birra
decisamente amara per smorzare il salato. Se invece il salato
|
67è dominante, ma non preponderante, andrà bene una birra mediamente amara e con poco corpo (es. Lager). Per salumi meno salati, meno grassi e con una punta di dolce, come il prosciutto di San Daniele, è consigliabile una birra dolce, maltata, poco amara, come una Lager bavarese. A salumi semi grassi, come il salame, possiamo abbinare birre speciali dal medio corpo, poco amare. Abbiamo anche una vasta scelta di salumi (insaccati) speziati con cannella, chiodi di garofano, aglio, pepe ecc. Per la loro particolare composizione questi salumi hanno un gusto composito in cui il sapore della spezia è prevalente. In questi casi la birra deve essere anch’essa complessa, profu- mata e dal corpo medio o consistente in funzione della “forza” del salume. Per salumi grassi ma delicati, tipo il lardo, è consigliabile una birra di medio corpo come una doppio malto chiara, che esalta le caratteristiche organolettiche del cibo (principio di equilibrio), mentre per salumi molto grassi, in cui il grasso è ben percettibile, come alcune soppresse caserecce, è consigliabile una birra un po’ acida e frizzante, che pulisca la bocca, cioè contrasti la preponderanza della sensazione di unto. Il colore della birra nell’abbinamento con le carni segue regole semplici anche se non scritte: - Le carni bianche si abbinano a birre chiare - Le carni rosse si abbinano a birre ambrate - Le carni scure (selvaggina) si abbinano a birre scure Birra e formaggi La famiglia dei formaggi come quella dei salumi è estremamente ampia, ma nel caso dei formaggi - a parte pochi magri, come il primo sale - la maggior parte sono semi grassi (20 - 42%) o grassi (oltre il 42%). L’indice di grasso del formaggio è determinante per definire il corpo della birra da abbinare e tra i parametri bisogna
Puoi anche leggere