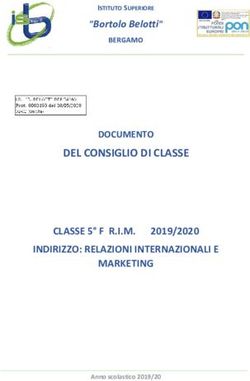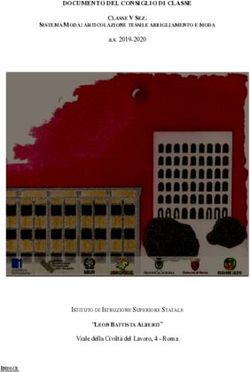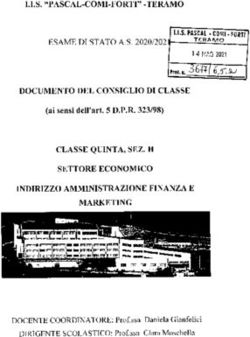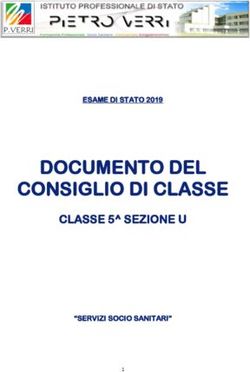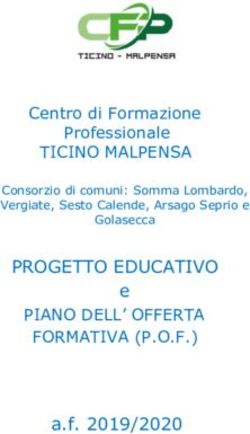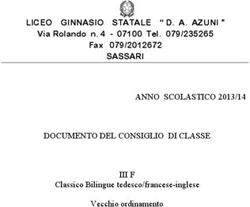DEL CONSIGLIO DI CLASSE CLASSE 5D INDIRIZZO: SIA - "Bortolo Belotti" - Istituto Superiore "Bortolo Belotti"
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ISTITUTO SUPERIORE
"Bortolo Belotti"
BERGAMO
DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE 5D
INDIRIZZO: SIA
Anno scolastico 2020/21Sommario
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2
COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 2
INTERVENTI DI RECUPERO, APPROFONDIMENTO, CONSOLIDAMENTO 3
OBIETTIVI EDUCATIVI PREVISTI 3
OBIETTIVI COGNITIVI PREVISTI METODOLOGIE 3
OBIETTIVI EDUCATIVI CONSEGUITI 4
OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI CONSEGUITI 5
DSA – BES 5
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 5
STRUMENTI 6
ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRA CURRICOLARI 6
CERTIFICAZIONI CONSEGUITE 6
PREPARAZIONE AGLI ESAMI 6
ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELABORATO 7
PERCORSI SVOLTI NELL'AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 7
PCTO 8
TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 8
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 11
1COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Continuità didattica nel triennio
Disciplina Docente
III IV V
ITALIANO E STORIA prof. Stefano D’Agostino Sì Sì Sì
MATEMATICA prof.ssa Marzia Ruffinoni Sì Sì Sì
ECONOMIA AZIENDALE prof.ssa Santa Salomone Sì Sì Sì
DIRITTO ED ECONOMIA
prof. Michelangelo Mollica Sì Sì Sì
POLITICA
INGLESE prof.ssa Nadia Cordiano Sì Sì Sì
I.R.C. prof. Giovanni Soldani Sì Sì Sì
INFORMATICA prof. Antonino Venuti Sì Sì Sì
LABORATORIO DI
prof. Alessandro Rota Sì Sì Sì
INFORMATICA
EDUCAZIONE FISICA prof.ssa Gabriella Casari Sì Sì Sì
COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE
Promossi
Classe Di cui Promossi Non
Alunni Ritirati a Ammessi
ripetenti a giugno ammessi
settembre
Terza 25 1 1 a settembre 14 9 3
Quarta 21 1 0 18 3 0
Quinta 22 0 0
2INTERVENTI DI RECUPERO, APPROFONDIMENTO, CONSOLIDAMENTO
Interventi di recupero effettuati in itinere con sospensione dell'attività didattica
Non sono stati effettuati interventi di recupero con sospensione dell’attività didattica.
Disciplina Numero alunni
Ore
coinvolti
4 (con studenti di
Economia aziendale 12
altre classi)
Interventi di recupero/approfondimento in orario extra curricolare
Tutte le discipline hanno effettuato recupero in itinere nel corso dell'anno scolastico.
OBIETTIVI EDUCATIVI PREVISTI
L’alunno: Il docente:
usa linguaggi e comportamenti corretti con è d’esempio per correttezza di
docenti, personale non docente e compagni; comportamento e linguaggio; interviene
RISPETTO NEI conosce e rispetta le regole di con fermezza in caso di comportamenti
CONFRONTI funzionamento dell’istituto; frequenta con sconvenienti; controlla che le
DELLE PERSONE E regolarità e senza assenze immotivate, è regole siano rispettate e, a seconda
DELLE STRUTTURE
puntuale all’inizio delle lezioni ed alla della gravità dell’infrazione, richiama lo
ripresa dopo gli intervalli; utilizza in modo studente ad un comportamento
appropriato i materiali, le attrezzature consono all’ambiente o redige un
scolastiche e gli strumenti di laboratorio. rapporto disciplinare;
annota sul registro di classe assenze, i
ritardi e i fuori classe e segnala al
coordinatore assenze ripetute nei giorni
di verifica;
illustra le modalità di utilizzo dei materiali
e dei laboratori, ne controlla lo stato e
riprende eventuali comportamenti
scorretti.
OBIETTIVI COGNITIVI PREVISTI METODOLOGIE
Si è fatto ricorso a diverse metodologie didattiche in relazione agli obiettivi da raggiungere nelle singole
discipline e alle ordinanze emesse dal governo in relazione alla pandemia in atto. In particolare, i docenti
hanno utilizzato lezioni dialogate frontali e a distanza, esercitazioni guidate, visioni di film, assegnazione
di lavori multimediali, esperienze laboratoriali.
3L’alunno: Il docente:
ORGANIZZAZIONE memorizza, distingue, seleziona e ordina rende lo studente consapevole
LOGICA DI DATI E dati, concetti e procedure con autonomia; dell’importanza di una corretta
INFORMAZIONI stabilisce relazioni ed opera confronti; conoscenza dei contenuti;
risolve casi pratici di media nell’intraprendere nuovi percorsi di studio
complessità esplicitando il percorso controlla le preconoscenze; controlla i
risolutivo seguito. percorsi di lavoro, corregge e/o invita
all’auto – correzione.
CONSOLIDAMENTO L’alunno: Il docente:
DEL METODO DI
STUDIO utilizza un metodo di lavoro che non si esprime in modo chiaro, conducendo gli
punti solo alla memorizzazione, studenti alla focalizzazione del messaggio
ma tenda allo sviluppo di una autonomia; globale e all’identificazione dei nuclei
riconsidera il procedimento o il percorso di concettuali;
lavoro seguito, per trovare errori verifica lo svolgimento del lavoro
o migliorare il profitto assegnato correggendo gli errori;
se il risultato non è stato soddisfacente; confronta i risultati ottenuti con quelli
Organizza scritti, schemi e prove che previsti attuando gli interventi
servono a comprendere un problema o ad correttivi ritenuti più idonei per
utilizzare prodotti, anche a distanza di l’ottenimento dell’obiettivo fissato.
tempo e da parte di persone diverse
dall’autore.
L’alunno: Il docente:
ESPOSIZIONE
risponde con pertinenza alle domande del evidenzia i termini più complessi o
docente. Espone quanto studiato con strettamente tecnici chiarendone il
efficacia ed uso appropriato della significato. Sottolinea gli errori
terminologia richiesta da ogni disciplina nell’esposizione guidando
eseguendo analisi personali. all’autocorrezione.
OBIETTIVI EDUCATIVI CONSEGUITI
Il C.d.C. ha messo in atto tutte le strategie concordate all’inizio dell’anno per il conseguimento degli
obiettivi educativi.
La classe presenta pertanto le seguenti caratteristiche:
- ha acquisito un adeguato senso di responsabilità per aver rispettato quasi sempre la puntualità e le
scadenze degli impegni;
- ha frequentato le lezioni in modo assiduo e costante;
- ha acquisito buon rispetto delle regole, dell’ambiente e degli altri;
- ha partecipato al dialogo educativo anche se talvolta in modo recettivo;
- ha manifestato soddisfacente disponibilità per le attività extrascolastiche.
4OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI CONSEGUITI
In relazione al raggiungimento degli obiettivi cognitivi la classe presenta i seguenti aspetti: un gruppo di
alunni ha acquisito una buona autonomia nella gestione dello studio, rielaborando i contenuti delle
conoscenze, un gruppo di studenti si affida ancora alla ripetizione mnemonica dei contenuti.
Nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e delle abilità si possono identificare tre gruppi di livello:
- un esiguo numero di studenti che aveva già acquisito nel corso di studi un buon livello di partenza, ha
conseguito conoscenze omogenee e adeguate abilità comunicative anche attraverso i diversi
linguaggi specifici, riuscendo ad operare collegamenti tra le discipline,
- un secondo gruppo di studenti che inizialmente aveva qualche fragilità si è costantemente applicato
nello studio raggiungendo risultati quasi soddisfacenti e una preparazione generale accettabile,
- un terzo gruppo con diverse lacune pregresse e/o difficoltà nella organizzazione del lavoro ha
conseguito gli obiettivi minimi in alcune discipline, ma non in modo omogeneo e possiede conoscenze
essenziali dei contenuti e difficoltà nelle abilità comunicative scritte e/o orali.
DSA – BES
Ai fini delle certificazioni ai sensi della Legge 170/2010, coerentemente con quanto stabilito nel piano di
lavoro per l’anno 2020-2021 e alla luce del piano didattico personalizzato approvato dal C.d.C. (PDP), sono
stati esaminati i seguenti aspetti: dati diagnostici e/o anamnestici; stile degli apprendimenti; punti di forza e
di criticità; metodologie didattiche idonee al perseguimento degli obiettivi didattici; misure compensative e
dispensative; tipologie delle verifiche formative per iscritto; tempi per la loro realizzazione; eventualità
modalità di recupero anche in relazione a quanto inoltre è previsto ai sensi del D.M. 5669/2011.
Per quanto riguarda la documentazione relativa a eventuali studenti DSA – BES che potrebbero essere
presenti nella classe, si potrà far riferimento al materiale documentale che verrà trasmesso alla commissione
d’esame.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione i docenti si sono attenuti ai criteri deliberati dal collegio dei docenti e confluiti nel P.T.O.F.
In sede di valutazione di fine anno si terrà conto dei risultati conseguiti nelle singole prove, dell'impegno
profuso, del raggiungimento degli obiettivi trasversali stabiliti dal C.d.C., della partecipazione e dell'interesse
dimostrati, del metodo di studio, della progressione nell'apprendimento, del livello di conoscenze, abilità e
competenze conseguite e della positiva partecipazione ad attività di recupero e approfondimento offerte
dall'istituto.
5STRUMENTI
Riguardo agli strumenti di lavoro, oltre ai libri di testo in versione digitale, sono state utilizzate fotocopie,
supporti audiovisivi e multimediali, piattaforma e- learning e tablet.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRA CURRICOLARI CLASSE QUINTA
Nel corso dell'anno sono state effettuate le seguenti attività:
- Fondazione Dalmine: fascismo e guerra
- Spettacolo teatrale, musica, fumetti e recitazione “Officina e libertà. L’onda della Madonnina”, seguito da dibattito
con l’autore
- Videoconferenza con la responsabile della partecipazione dei bandi di finanziamento Europeo del comune di Bergamo,
Dott.ssa Manuela Armati
CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Certificazioni linguistiche
Certificazione Livello N. Studenti
Cambridge Certificate FCE B2 2
Cambridge Certificate PET B1 1
Certificazione ICDL
Modulo N. Studenti
ICDL Essentials, Prime, Base,
1
Standard…
PREPARAZIONE AGLI ESAMI
In preparazione agli esami di stato sono state effettuate le seguenti attività: simulazioni della prova orale con
collegamenti all’interno del programma svolto della singola disciplina a partire da materiali stimolo;
simulazione della redazione dell’elaborato d’esame di economia aziendale.
6ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELABORATO
Gli Argomenti assegnati agli alunni per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), saranno raccolti in un
allegato messo a disposizione della commissione d’esame.
PERCORSI SVOLTI NELL'AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA
Nell'ambito dei percorsi previsti per l'insegnamento di Educazione Civica, nel corso dell'anno scolastico
2020/21 sono stati affrontati i seguenti argomenti
7DISCIPLINA CONTENUTI
Unione europea ONU parlamento/governo/magistratura
DIRITTO Progetti aventi oggetto la partecipazione degli studenti alla governance
delle loro classi e delle loro scuole, il contatto diretto con il governo dei
territori e delle autonomie a tutti i livelli e con i settori della società
civile, la costituzione italiana, la lettura dei giornali e le fake news ecc
LINGUA INGLESE Green economy, UK government, UK history, ONU and women
STORIA Alle radici della Costituzione italiana
SCIENZE MOTORIE Salute dinamica
PCTO
Durante l'anno scolastico gli studenti hanno effettuato i seguenti interventi relativi al PCTO
Indirizzo SIA
● Corso Sicurezza
● Modulo lessico e microlingua nel contesto aziendale
● Database e linguaggi di programmazione
● Simulazione analisi di bilancio
● Orientamento Post-diploma
● Analisi caso aziendale (Relazione descrittiva)
● Conferenza Meet con azienda DISC
● Conferenza Meet con azienda DMG MORI
● EDUFIN, strumenti di investimento (PCTO) CLASSE QUARTA
● Incubatore d’impresa presso la Fondazione Dalmine (PCTO) CLASSE TERZA
TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Ugo Tarchetti: da Fosca, L’attrazione della morte.
Gustave Flaubert: da Madame Bovary, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli.
8E. E J. De Goncourt: da Germinie Lacerteux, Un manifesto del Naturalismo. Prefazione.
Emile Zola:
Da Il romanzo sperimentale, Prefazione. Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale.
Da L’Assommoir, L’alcol inonda Parigi.
Luigi Capuana. Scienza e forma letteraria: l’impersonalità.
Giovanni Verga:
Da L’amante di Gramigna, Impersonalità e regressione.
Da Vita dei campi, Rosso Malpelo.
Da I Malavoglia, Prefazione, I vinti e la fiumana del progresso.
Da I Malavoglia cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia.
Da I Malavoglia cap. IV, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse
economico.
Da I Malavoglia cap. XV, La conclusione del romanzo.
Charles Baudelaire:
Da I fiori del male, Corrispondenze.
Da I fiori del male, L’albatro.
Da I fiori del male, Spleen.
Paul Verlaine: da Un tempo e poco fa, Languore.
Arthur Rimbaud: dalle Poesie, Vocali.
Gabriele D’Annunzio:
Da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.
Da Le vergini delle rocce, libro I, Il programma politico del superuomo.
Da Alcyone, La sera fiesolana.
Dal Notturno, La prosa “notturna”.
Giovanni Pascoli:
Da Il fanciullino, Una poetica decadente.
Da Myricae, Lavandare.
Da Myricae, X Agosto.
Da Myricae, L’assiuolo.
Da Myricae, Il lampo.
9Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno.
Filippo Tommaso Marinetti. Manifesto del Futurismo.
Sergio Corazzini: da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale.
Italo Svevo:
Da Una vita, Le ali del gabbiano.
Da Senilità cap. I, Il ritratto dell'inetto.
Da La coscienza di Zeno, Prefazione.
Da La coscienza di Zeno, Il fumo.
Da La coscienza di Zeno, La morte del padre.
Luigi Pirandello:
Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale.
Dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato.
Da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi.
Giuseppe Ungaretti:
Da L’allegria, Il porto sepolto.
Da L’allegria, Veglia.
Da L’allegria, San Martino del Carso.
Da L’allegria, Mattina.
Da L’allegria, Soldati.
10ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
MATEMATICA
ECONOMIA POLITICA
DIRITTO
INGLESE
INFORMATICA
ITALIANO
STORIA
ECONOMIA AZIENDALE
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE
EDUCAZIONE CIVICA
11Disciplina: MATEMATICA
Docente: Marzia Ruffinoni Numero di ore: 90
Obiettivi di apprendimento
Lo svolgimento del programma di matematica si pone come obiettivo quello di fornire modelli di
interpretazione e di soluzione di situazioni problematiche che ricalcano, anche se in modo semplificato,
alcuni problemi reali o relativi alla teorie economiche.
L’alunno attraverso la modellizzazione matematica di situazioni problematiche si avvicina alla realtà
rendendosi conto della molteplicità delle variabili, comprende le ipotesi semplificatrici, applica e gestisce
modelli che gli sono stati forniti, perviene inoltre ad una prima forma di rielaborazione organizzando i dati,
prospettando soluzioni, commentando i risultati ottenuti e discutendo le soluzioni
Metodologie
Gli argomenti sono stati svolti seguendo il libro di testo gli esercizi sono serviti a esemplificare le situazioni
presentate a livello teorico o per introdurre la trattazione teorica.
Alcune ore sono state dedicate al recupero di prerequisiti di Geometria Analitica, Calcolo della derivata,
Concetti di Economia Politica, Matematica Finanziaria e Variabili Casuali, al recupero in itinere, alla
programmazione dell’attività didattica, ad attività inerenti l’organizzazione scolastica.
Strumenti
Libro di testo utilizzato: Bergamini, Barozzi, Trifone MATEMATICA.ROSSO vol 4 e vol 5 Edizioni Zanichelli
Programmi applicativi: Geogebra e Excel
Prove di verifica
Prove di verifica sommative orali, prove di verifica formative scritte.
Verifiche sommative orali: sono state somministrate 2 prove nel trimestre e 3 nel pentamestre.
Verifiche formative scritte: 1 prova nel trimestre e due nel pentamestre
12Contenuti
Modulo 1 di 5
Funzioni reali di due variabili reali
Conoscenze
Definizione di funzione reale di due o più variabili reali.
Definizione di dominio. La ricerca del dominio. Soluzione di disequazioni intere, sistemi di disequazioni
intere, disequazioni fratte e prodotto.
Definizione di linee di livello e interpretazione geometrica. Rappresentazione grafica di fasci di rette,
parabole, circonferenze, ellissi ed iperboli.
Definizione di derivata parziale e interpretazione geometrica.
Calcolo delle derivate parziali prime e seconde.
Definizione di massimo e minimo relativo.
Calcolo di massimi e minimi liberi: il metodo grafico delle linee di livello e il metodo algebrico delle
derivate.
Calcolo di massimi e minimi vincolati con vincoli espressi da equazioni: il metodo elementare della
sostituzione; metodo grafico delle linee di livello per l’individuazione grafica di punti di tangenza.
Individuazione grafica dei massimi e minimi assoluti vincolati in un’area chiusa e limitata metodo delle
linee di livello.
Tempi
ore 20
Abilità
Riconoscere una funzione reale in più variabili. Determinare e rappresentare il dominio e le linee di livello
nel piano cartesiano. Riprodurre metodi risolutivi per la ricerca di massimi e minimi liberi e vincolati che
richiedono semplici procedure di calcolo. Rappresentare graficamente le funzioni e i vincoli con
GeoGebra. Interpretare le soluzioni graficamente.
Strumenti
GeoGebra
13Modulo 2 di 5
Applicazioni dell’analisi all’economia
Conoscenze
Definizione e calcolo di funzioni marginali.
Definizione e calcolo di elasticità parziali ed elasticità incrociata della funzione di domanda.
Massimizzazione del profitto di un’impresa che produce due beni in regime di concorrenza perfetta e in
regime di monopolio.
Massimizzazione della funzione di utilità del consumatore con il vincolo di bilancio rappresentato da una
retta. Soluzione del modello mediante metodo di sostituzione.
Tempi
ore 10
Abilità
Utilizzare strumenti matematici per la soluzione di problemi economici. Interpretare grandezze e indici
economici. Interpretare graficamente il problema del consumatore.
Strumenti per il problema del consumatore il libro di testo è stato integrato con materiale fornito
dall’insegnante. GeoGebra
Modulo 3 di 5
Ricerca operativa - Programmazione lineare
Conoscenze
Il modello del problema.
Il metodo grafico: problemi di programmazione lineare in due variabili,
problemi di programmazione lineare riconducibili a due variabili.
Il caso discreto.
Tempi
6 ore
Abilità
Riconoscere problemi di programmazione lineare, analizzare il problema con indicazione dei dati,
relazioni, vincoli e variabili.
Formalizzare il modello matematico.
Risolverlo con il metodo grafico.
Utilizzare il Risolutore di EXCEL
Strumenti
GeoGebra, EXCEL(Risolutore)
Modulo 4 di 5
14Ricerca operativa
Conoscenze
Scopi e metodi della ricerca operativa.
Scelte in condizioni di certezza effetti immediati.
Il caso continuo.
Problema di massimo con funzione obiettivo lineare.
Problema di massimo con funzione obiettivo non lineare.
Problema di massimo con funzione obiettivo definita da più leggi.
Problema di minimo con funzione obiettivo non lineare (costo medio).
Il problema delle scorte: il prezzo della merce è costante, il prezzo della merce dipende dalla
quantità acquistata.
Il caso discreto.
La scelta tra più alternative.
Scelte in condizioni di certezza effetti differiti.
Investimenti finanziari e industriali.
Il criterio dell’attualizzazione, il criterio del tasso interno di rendimento
(si determini il TIR graficamente mediante la lettura del punto di intersezione della funzione REA(i)
con l’asse orizzontale) e il criterio dell’onere medio annuo.
Scelte in condizioni di incertezza.
Il criterio del valor medio e la valutazione del rischio. Il criterio del pessimista
Tempi
30 ore
Abilità
Analizzare un problema con indicazione dei dati, relazioni, vincoli, variabili e prospettarne le possibili
soluzioni. Formalizzare il modello matematico (funzione, variabili, vincoli e obiettivo) e risolverlo.
Discutere le soluzioni ottenute. Utilizzare GeoGebra per le rappresentazioni grafiche e ricavare dal grafico
le informazioni necessarie alla soluzione del modello. Utilizzare un foglio elettronico per costruire tabelle
di calcolo.
Strumenti
GeoGebra, EXCEL
Modulo 5 di 5
15Interpolazione
Conoscenze
Concetto di interpolazione fra punti, regressione, correlazione
Funzione interpolante lineare: il metodo dei minimi quadrati
Regressione lineare equazione delle rette di regressione calcolate con il metodo del baricentro
Coefficienti di regressione calcolati con il metodo degli scarti
Coefficiente di correlazione lineare r=±ab
La linea di tendenza in EXCEL e GeoGebra
Tempi 6 ore
Abilità
Utilizzare EXCEL o GeoGebra per determinare la linea di tendenza e la sua equazione. Interpretare i
risultati ottenuti
Strumenti
GeoGebra, Excel, simulazione di linee di tendenza lineari e non lineari con dati reali con Desmos.
16Disciplina: ECONOMIA POLITICA
Docente: Prof. Michelangelo Mollica
Obiettivi di apprendimento
Comprendere la funzione dell’attività finanziaria dello Stato
Comprendere la funzione della spesa e dell’entrata pubblica come strumento di politica economica
Comprendere il bilancio come documento di programmazione economica
Comprendere l’evoluzione e i caratteri del sistema tributario italiano
Analizza articoli di quotidiani economici
Metodologie
Lezioni frontali; lezioni partecipate; analisi di casi
Strumenti
Libro di testo : Bianchi-Maccari-Perucci, Sistema economia, Pearson - Ipad
Articoli di quotidiani
Prove di verifica
Orali
Contenuti
L’economia pubblica
1. Introduzione storica (cenni) 2. La funzione allocativa 3. La funzione redistributiva 4. La funzione
stabilizzatrice
Articolazione dettagliata dei Contenuti:
L'ECONOMIA PUBBLICA: Il ruolo dello Stato nell'economia di mercato
La funzione allocativa.
Intervento pubblico ed efficienza nell'allocazione delle risorse -I beni pubblici
Il caso del free rider -Le esternalità. Le economie e le diseconomie esterne.
Le esternalità positive -I beni meritori -Le asimmetrie informative. La selezione avversa: insider trading,
mercato dei prodotti usati. Il comportamento sleale (soggetto assicurato)
Il monopolio.
La funzione redistributiva
La distribuzione funzione e personale -La distribuzione del reddito nelle economie di mercato
La distribuzione del reddito nel modello keynesiano -Le politiche redistributive
Le diverse idee di giustizia (distributiva e commutativa) -L'egualitarismo liberale di Rawls
La funzione stabilizzatrice
La teoria keynesiana della politica fiscale -Il principio della domanda effettiva -L'equilibrio macroeconomico
-La necessità dell'intervento pubblico -Politiche contro la disoccupazione
L'effetto del moltiplicatore del reddito -Il teorema del bilancio in pareggio (Haavelmo)
Le politiche di stabilizzazione: pieno impiego, stabilizzare il ciclo economico, l'inflazione
La crisi delle teorie keynesiane
17La finanza pubblica in Italia
1. I soggetti pubblici 2. Il Bilancio dello Stato 3. La finanza straordinaria e il debito pubblico 4. Euro 5.
Finanza locale
Articolazione dettagliata dei Contenuti:
LA FINANZA PUBBLICA IN ITALIA
I soggetti pubblici
L'operatore pubblico -Le amministrazioni pubbliche -Il settore pubblico allargato
Analisi del conto economico consolidato della PA -La pressione fiscale e la pressione tributaria
Le ragioni della spesa pubblica -Il modello Musgrave-Rostow; il modello di Wagner, il modello Peacock-
Wiseman; il modello Baumol.
Il Bilancio dello Stato
Il vincolo di bilancio -Il ruolo del Bilancio dello Stato -I caratteri del Bilancio dello Stato
Bilancio preventivo -Bilancio triennale -Il BdS e la Costituzione -La procedura di approvazione; le tappe della
procedura -Il semestre europeo -La gestione e la rendicontazione -La Corte dei conti e il giudizio di
parificazione -La struttura del Bilancio dello Stato: gli stati di previsione; missioni, programmi, capitoli
Classificazione funzionale -Il Bilancio di cassa e il Bilancio di competenza -I saldi differenziali
La finanza ordinaria -La finanza straordinaria -Teorema dell'equivalenza ricardiana
Gli effetti reali e monetari dei disavanzi pubblici: il pensiero neoliberista (effetto di spiazzamento)
Il problema del debito pubblico -L'evoluzione storica del deficit italiano -L'evoluzione storica del debito
pubblico italiano
L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO
Funzione di stabilizzazione, redistributiva, allocativa . Le ragioni economiche del decentramento: il teorema
di Oates, di Tiebout, la teoria dei club- Principio di sussidiarietà.
DAL MERCATO COMUNE ALLA MONETA UNICA EUROPEA
Le economie nazionali e l'Unione europea -Il percorso verso la moneta unica - parametri di convergenza -I
vincoli alla politica fiscale -L'euro di fronte alla crisi. Teoria delle aree valutarie ottimali (Mundell)
L’attività economica dello Stato
1. I sistemi di welfare 2. Il sistema previdenziale e assistenziale 3. Il sistema sanitario e il sistema scolastico
Articolazione dettagliata dei Contenuti:
I sistemi di welfare
Ricchezza e povertà: rapporto difficile, alle origini dei sistemi di welfare -Il Rapporto Beveridge
La crisi dei sistemi di welfare
I settori del welfare -Il rapporto tra i sistemi di welfare e le economie di mercato
Il welfare italiano oggi -Come si finanzia il welfare -Chi eroga il welfare -Il welfare tra pubblico e privato -I
modelli di welfare -I quattro regimi di welfare -Gli effetti della crisi sui sistemi di welfare.
Il sistema previdenziale e assistenziale
La spesa previdenziale in Italia -Da sistema assicurativo a sistema redistributivo
Il sistema pensionistico -I caratteri del nostro sistema pensionistico -Il sistema pensionistico italiano -Dalla
riforma Amato alla riforma Fornero -Gli ammortizzatori sociali
La spesa per l'assistenza
Il diritto alla salute
La salute non é un bene pubblico puro -L'opportunità dell'intervento statale in campo sanitario
I modelli organizzativi -Il sistema sanitario nazionale
Il diritto all'istruzione
Anche l'istruzione é un bene privato -Il sistema educativo italiano (cenni)
Il finanziamento del sistema di istruzione
18La teoria dell’imposta
1. Le entrate pubbliche 2. La classificazione delle imposte 3. I criteri di ripartizione del carico tributario
4. Gli effetti economici delle imposte
Articolazione dettagliata dei Contenuti:
ENTRATE PUBBLICHE
L'attività di governo tra entrate e spese -La funzione allocativa -La classificazione delle entrate pubbliche -Il
prezzo privato, quasi privato, la tariffa, la tassa, il contributo, l'imposta.
Entrate originarie e derivate -I tributi e gli obiettivi della politica economica
I criteri di classificazione dei tributi -I principi giuridici e amministrativi del sistema tributario
La classificazione delle tasse.
La classificazione delle imposte
La caratteristiche dell'imposta -Gli elementi del debito di imposta -Il rapporto tra aliquota e base imponibile
(imposte proporzionali, progressive e regressive) -Art. 53 Costituzione
Le forme tecniche di progressività (per classi, per scaglioni, per deduzione e per detrazione)
Il fiscal drag -Le imposte dirette e le imposte indirette -Il mix di imposte dirette e indirette
Le imposte reali e le imposte personali -Imposte generali e speciali -Imposte ordinarie e straordinarie.
I criteri di ripartizione del carico tributario
Il principio del beneficio. L'equa ripartizione del carico tributario. Una funzione puramente allocativa. La
scuola di Public Choice -Il principio della capacità contributiva. Equità distributiva, redistribuzione del
reddito e stabilizzazione del ciclo economico. -Gli indicatori della capacità contributiva. -Il principio del
sacrificio secondo Mill (nozione) -Il reddito come indicatore della capacità contributiva. La scelta della base
imponibile. La tassazione del reddito come fonte. La tassazione del reddito come entrata. La tassazione del
reddito come spesa. La doppia tassazione del risparmio. -Il patrimonio come indicatore della capacità
contributiva
Tassare il reddito o tassare il patrimonio? -La discriminazione qualitativa dei redditi
La discriminazione quantitativa dei redditi
Gli effetti economici delle imposte
L'eccesso di pressione -L'effetto reddito e l'effetto di sostituzione -Gli effetti dell'imposta
L'analisi di Laffer -Le imposte e la propensione al risparmio -Il sistema fiscale e la scelta dei fattori produttivi
-L'imposta sul capital gain -Il contribuente di diritto e il contribuente di fatto
Traslazione dell'imposta –Evasione –Elusione –Erosione
19Disciplina: DIRITTO
Docente: Prof. Michelangelo Mollica
Obiettivi di apprendimento
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi
della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
Riconoscere i principali aspetti del sistema sociale ed economico allo scopo di operare in un determinato
contesto produttivo.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Metodologie
Lezioni frontali; lezioni partecipate; analisi di casi
Strumenti
Libro di testo: Paolo RONCHETTI, Diritto Pubblico, Zanichelli - Ipad
Costituzione - Articoli quotidiani
Prove di verifica
Orali
Contenuti
Lo Stato
- Dai sudditi a cittadini
- La Costituzione repubblicana
Articolazione dettagliata dei Contenuti:
Dalla società allo Stato – Cittadino italiano- Le forme di Stato e di governo - lo Stato moderno -gli elementi
dello Stato moderno (popolo, territorio, sovranità) - Lo Stato assoluto – Verso lo Stato liberale – Lo Stato
democratico – Lo Statuto albertino – il fascismo – dalla guerra alla Repubblica – La Costituzione- La revisione
della Costituzione.
La persona nella vita sociale
- La dignità
- La libertà e le libertà
- L’uguaglianza e la solidarietà
Articolazione dettagliata dei Contenuti:
Diritto alla vita – L’integrità della persona – La tortura – La libertà personale – la libertà di circolazione – La
libertà di espressione – la libertà di religione – il diritto di associazione: i partiti - Uguaglianza formale e
sostanziale – la parità fra uomo e donna – il diritto alla famiglia; alla salute; all’ambiente; il dovere tributario
– la libertà di iniziativa economica - il sindacato – il rapporto di lavoro – il diritto di sciopero.
20L’Unione Europea
-Il processo di integrazione europea
-Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea
Articolazione dettagliata dei Contenuti:
L'UNIONE EUROPEA
Il processo di integrazione europea -La nascita dell'Unione europea -L'unione economica e monetaria
LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Parlamento europeo -Il Consiglio europeo e il suo Presidente -Il Consiglio dell'Unione
La Commissione europea e il suo Presidente -La Corte di giustizia dell'Unione -Gli atti dell'Unione
Le nostre istituzioni
- Il Parlamento
- Il Governo
- Il Presidente della Repubblica
- La Corte costituzionale
- Gli organi di rilevanza costituzionale
- La Magistratura
- Le autonomie territoriali
Articolazione dettagliata dei Contenuti:
IL PARLAMENTO: Il bicameralismo - Elettorato attivo e passivo - Senatori a vita - Parlamento in seduta
comune -Proroga e prorogatio -Incandidabilità - Ineleggibilità - Insindacabilità – Immunità -Divieto di
mandato imperativo -Organizzazione delle Camere - le maggioranze - regolamenti parlamentari - numero
legale - voto segreto e voto palese - gruppi parlamentari - commissioni - commissioni d'inchiesta -Sistema
maggioritario e proporzionale
Il sistema elettorale italiano. - La funzione di revisione costituzionale
La funzione di controllo e di indirizzo politico -La funzione legislativa del Parlamento
IL GOVERNO: La composizione del Governo - il Presidente del Consiglio - i ministri - i sottosegretari - il
Governo tecnico -La responsabilità penale dei membri del Governo - il Tribunale dei ministri-Responsabilità
penale e responsabilità politica -Il procedimento di formazione del Governo -La crisi di Governo -Le funzioni
del Governo - indirizzo politico - questione di fiducia - funzione normativa -I regolamenti governativi e
ministeriali
LE GARANZIE COSTITUZIONALI: La repubblica parlamentare -Elezione del Presidente della Repubblica -
Garante della Costituzione - impedimento temporaneo e permanente -I poteri del Presidente della
Repubblica -Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica -La composizione della Corte Costituzionale -
Le funzioni della Corte costituzionale
LA MAGISTRATURA: La funzione giurisdizionale - il potere giudiziario - Magistrati o giudici - Civil law e
common law -Indipendenza dei giudici - assenza di gerarchia -Inamovibilità - nomina per concorso - Diritto
e giustizia -Il processo: accusa e difesa -L'irretroattività della legge - il giudice naturale - l'obbligo della
motivazione -La giurisdizione ordinaria - civile e penale - il giusto processo -La responsabilità dei giudici -Il
CSM
LE AUTONOMIE LOCALI -L'autonomia - Il decentramento -La riforma costituzionale del 2001 -La Regione -Il
Comune
21Disciplina: Inglese
Numero di ore: 80 5D (al
Docente: Cordiano Nadia
29/4)
Obiettivi di apprendimento
Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Utilizzare le reti e
gli strumenti.
Metodologie
Gli studenti hanno seguito da una parte le lezioni attraverso il libro di testo ed il materiale fornito
dall'insegnante, fonti dalle quali hanno tratto la teoria utile a comprendere i fenomeni che li
circondano e che vivono, dall'altra, gli stessi sono stati chiamati a svolgere lavori di
approfondimento in gruppo e individuali, utilizzando materiale autentico reperito in rete. Si è dato
nel corso dell'ultimo biennio molto spazio alla produzione scritta per una elaborazione di testi
coerenti ed equilibrati nelle loro parti. Un notevole sforzo è stato compiuto nel tentativo di disinibire
gli studenti nella lingua parlata. A tale scopo gli allievi sono stati stimolati nella nella classe quarta
alla produzione di discorsi da presentare alla classe su tematiche a loro scelta e alla presentazione
di lavori di gruppo attraverso l’uso di powerpoint realizzati secondo i canoni della presentazione
efficace. Tale obiettivo è stato raggiunto pienamente da un numero di studenti che utilizza la lingua
inglese anche al di fuori del contesto scolastico per fruire di contenuti ad interesse personale,
mentre un ridotto gruppo di studenti ha faticato ad abbandonare un metodo di studio
prevalentemente mnemonico. Un terzo gruppo ha invece compiuto buoni progressi grazie
all'applicazione assidua.
Strumenti
Libro di testo: Bentini Bettinelli O'Malley, Business Expert, Pearson
Video e dispense fornite dal docente.
Prove di verifica
Interrogazioni orali, relazioni orali sui lavori di gruppo con il supporto di presentazioni power point,
relazione scritta sulla PCTO, verifiche scritte.
22Contenuti
Modulo 1 Music for the struggle (settembre)
• Arizona library case, racial profiling, 4th amendment of the US Constitution
Modulo 2 Globalisation (settembre - ottobre)
• What is globalisation (pp.156-157)
• Reasons against globalisation and KOF index, pp. 158-159
• The role of technology in globalisation p. 159
• Glocalisation p. 160
• Outsourcing and offshoring p.161
• Glocalisation strategies : Mc Donald’s glocalisation - burgers without beef ex. 164-165
(Presentazioni degli studenti)
Modulo 2 Business ethics and green economy (ottobre - novembre)
• Triple bottom line, pp.178-179
• Corporate social responsibility pp.180-181
• Sustainable business pp.182-183
• Fair trade pp.184-185
• Microfinance pp.186-187
• Ethical Banking pp 188-189
• (Lavori di gruppo)
Modulo 3 News Report (dicembre)
• Reported speech (materiale in classroom)
• Articles (reading and writing)
Modulo 4 The challenge of the future (gennaio)
• What has the Internet become? pp.432-433
• Future technologies pp.434-435
• Our energy future pp.436-437
Modulo 5 The role of social networks in censorship (gennaio)
• Readings and debate (Videos: what is a debate, language for debating, vocal variety)
• Essay
23Modulo 6 Europe (febbraio)
• Brexit Materiale in classroom (analysis of articles from The Telegraph, The Guardian, The Financial Times,
Politico Europe, analysis of different points of view)
• How to analyse an article (materiale condiviso in Classroom)
Modulo 7 (febbraio - marzo)
Preparazione al test INVALSI (ZANICHELLI ONLINE)
Modulo 8 UK history and US government (marzo - aprile)
• How the UK is governed (materiale in classroom)
• UK and US political parties, opinion and policies ( pp 398-400)
• Idioms in politics (materiale in classroom)
• UK history: the making of the Uk pp. 354-357
• The industrial revolution 358-359 (and documentary on You Tube: Quarrybank Cotton Mill)
Modulo 9 Reflexive writing (aprile - maggio)
• How to write a reflexive writing - PCTO - Materiale fornito dal docente (in classroom)
Modulo 10 UN and women unemployment (maggio)
• Reading: Data analysis (in classroom)
Modulo 11 I Have a dream analysis (maggio)
• Analysis of MLK’s Speech (in classroom)
Modulo 12 Marketing (maggio)
Ripasso a.s. 2019/2020:
• The extended marketing mix: the 7 Ps (in classroom)
Modulo 13 Business correspondence (Maggio)
• Complaints and remainders
24Disciplina: INFORMATICA
Docenti: Prof. Venuti Antonino
Docente tecnico pratico: Rota Alessandro
Obiettivi di apprendimento
● Gestire una base di dati a partire da una semplice situazione applicativa
● Conoscere i concetti di base della struttura dei sistemi operativi
● Proporre soluzioni a problemi aziendali
● Cogliere l'importanza del computer come strumento di comunicazione.
● Ad un livello minimo accettabile, lo studente è in grado di:
sapere
⎯ Individuare le caratteristiche di nuovi ambienti di programmazione
⎯ Conoscere gli aspetti dell’evoluzione nei sistemi operativi
⎯ Cogliere le potenzialità e i cambiamenti indotti in azienda e nella società dalle tecnologie
dell’informazione
⎯ Possedere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni dei sistemi informativi
aziendale
⎯ Rilevare le problematiche aziendali che hanno portato a soluzioni di informatica distribuita e i
vantaggi che ne derivano.
⎯ Possedere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione di dati
sulle reti.
saper fare
⎯ Utilizzare basi di dati per semplici situazioni applicative
⎯ Progettare pagine web di tipo statico
⎯ Progettare pagine web di tipo dinamico per l’accesso ai dati contenuti in un database
⎯ Utilizzare le funzioni del sistema operativo per l’accesso alle risorse hardware e software del
⎯ sistema di elaborazione
⎯ Utilizzare la rete per condividere risorse e per accedere ai servizi di Internet
Metodologie
Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Lavori di gruppo
Esercitazioni in laboratorio
Supporto e-learning per distribuzione di appunti, recupero ed esercitazioni
Didattica a distanza
Prove di verifica
● Prove scritte
● Prove orali
● Prove pratiche in laboratorio
● Test online
25Strumenti
Strumenti e attrezzature didattiche impiegate:
• Reti locali presenti in laboratorio, collegamento a internet.
Libri di testo:
• A. Lorenzi, E. Cavalli, Informatica: Progettazione dei database linguaggio sql dati in rete.Access,
mysql, pagine asp, pagine php. (Ed. Atlas).
• A. Lorenzi, E. Cavalli, PRO.SIA Informatica: Informatica e processi aziendali. (Ed. Atlas).
Materiali e tutorial tratti da internet.
• Software: Sistema operativo Windows, MySQL di Uniserver.
• Linguaggio: HTML, Fogli di stile, Javascript, PHP, Elementi di base AJAX, Librerie JQuery.
Contenuti
Modulo A: SISTEMI INFORMATIVI E DATABASE
Contenuti:
Modulo A – UdA 1: Il sistema informativo nell’azienda. (TEORIA)
A1.1 Sistema informativo [Appunti]
• Che cos’è un sistema informativo.
• Le componenti di un sistema informativo (i dati, le procedure, il sottosistema informativo e le
informazioni).
A1.2 Il ruolo del sistema informativo in un’azienda [Appunti]
• Analisi dei costi.
A1.3 Il ciclo di vita [Appunti]
• Pianificazione e analisi.
• Progettazione e realizzazione.
• Testing e manutenzione (correttiva, adattativa, perfettiva, preventiva).
A1.4 Sistemi informativi distribuiti [Appunti]
• Concetti base.
◦ Passaggio da un sistema centralizzato a uno distribuito.
◦ Fattori per la scelta di un’operazione distribuita.
• Throughput e tempo di risposta.
• Disponibilità e scalabilità.
• Organizzazione di un sistema informativo distribuito
◦ Sistemi distribuiti nei dati e nelle operazioni.
◦ Sistemi informativi distribuiti multidatabase.
◦ Organizzazione centrale-periferica.
• Basi di dati distribuite
◦ Proprietà di una base di dati distribuita.
◦ Trasparenza per gli utenti della rete.
Modulo A – UdA 2: Progetto di database. (TEORIA - Ripasso degli argomenti trattati nel precedente A.S.)
A2.1 Modellazione dei dati [Appunti e libro IV da pag. 108 a pag. 129]
• Modellazione dei dati.
• Entità e associazioni.
• Gli attributi (valori e domini degli attributi, attributi semplici e composti, identificatori, identificatori
esterni).
• Le associazioni tra entità (associazione uno a molti, associazione molti a molti, associazione uno a
uno, associazione ricorsive, generalizzazione o specializzazione).
• Regole di lettura.
Modulo A – UdA 3: Teoria relazionale. (TEORIA - Ripasso degli argomenti trattati nel precedente A.S.)
A3.1 Il modello relazionale [Appunti e libro IV da pag. 138 a pag. 176]
• Tuple.
• Relazioni.
26• Dalle associazioni del modello ER alle relazioni tra tabelle (traduzione di un’associazione uno a molti,
introduzione all’integrità referenziale, traduzione degli identificatori esterni, traduzione di
un’associazione uno a molti, traduzione di un’associazione uno a uno, traduzione di un’associazione
ricorsiva, traduzione della generalizzazione).
• Vincoli di integrità referenziale.
• Normalizzazione (Prima forma normale, seconda forma normale, terza forma normale).
• Le operazioni relazionali (proiezione e restrizione).
Modulo B: I SISTEMI ERP E CRM [Appunti da pag. 234 a pag. 245]
Contenuti:
Modulo B – UdA 1: L’integrazione dei processi aziendali. (TEORIA)
B1.1 – ERP, Enterprise Resource Planning [Appunti]
• I sistemi informativi integrati.
• Le soluzioni ERP.
• Le caratteristiche dei sistemi ERP
◦ Unicità della base dati.
◦ Configurabilità del sistema.
◦ Estensione e modularità del sistema.
• I componenti di un ERP.
• Presentazione e analisi dei dati.
B1.2 – Il passaggio a un sistema informativo integrato [Appunti]
• Il sistema informativo integrato
◦ Business Process Reengineering (BPR)
◦ Standardizzazione
◦ Integrazione
• Il passaggio a un sistema ERP
◦ Principali criticità riscontrate
• Le soluzioni ERP sul mercato
◦ Soluzioni a pagamento
• Microsoft Dynamics
• SAP
• Soluzioni open source
Modulo C : SQL [Appunti e libro IV da pag. 250 a pag. 293]
Contenuti:
Modulo C – UdA 1: Un linguaggio standard per la gestione di database relazionale. (TEORIA E
LABORATORIO TEORIA - Ripasso degli argomenti trattati nel precedente A.S.)
C1.1 – Il ruolo di SQL
• Caratteristiche principali del linguaggio
• Classificazione delle istruzioni SQL (DDL, DML e DCL)
C1.2 – Sistemi informativi e database nell’ SQL
• Creazione di un nuovo database (create database nomedatabase)
C1.3 – Le tabelle
• Definizione delle colonne (domini per le colonne)
◦ Domini per le colonne
C1.4 – Definizione dei vincoli di integrità dei dati
• Vincoli di integrità su una colonna
• valori di default [default]
• vincoli sui valori di una colonna [IN LIKE,BETWEEN]
• colonna con valori sconosciuti [NULL]
• Vincoli di integrità su una tabella
• vincoli chiave primaria
• vincolo su più colonne con CHECK.
27• Vincoli di integrità referenziale (FOREIGN KEY….REFERENCES, ON DELETE, ON UPDATE, CASCADE, NO
ACTION, SET NULL E SET DEFAULT)
• Casi particolari di applicazione dell’integrità referenziale
◦ Traduzione di un’associazione ricorsiva dello schema ER in uno schema logico relazionale
• Una relazione per sostituire un vincolo su un insieme di valori
C1.5 – Altri elementi di un database SQL
• Domini (CREATE DOMAIN)
Modulo C – UdA 2: Interrogazioni. (TEORIA E LABORATORIO TEORIA - Ripasso degli argomenti trattati nel
precedente A.S.)
C2.1 – Aggiornamento del database
• Inserimento dei dati
• Modifica dei dati
• Cancellazione dei dati
C2.2 – Elementi di base di una query
• Definizione dei dati nelle interrogazioni.
• Ridenominazione delle colonne (ridenominazione di tabelle).
• Gestione dei duplicati (distinct).
• Prodotto di più tabelle.
• Definizione della condizione di ricerca:
• Operatori di confronto
• Operatori logici
• Operatori speciali Sql (BEETWEEN, LIKE, IN, IS NULL, IS NOT NULL).
• Query con parametro di ingresso
C2.3 – Il join
• Traduzione della definizione di join in select.
• L’operatore join del linguaggio sql (join tra più di due tabelle, come si scrive un’interrogazione sql):
• join interno: inner join
• join esterno sinistro: left join
• join esterno destro: right join
• Self join
◦ Il join usato per realizzare associazioni ricorsive
C2.4 – Ordinamento, elaborazione e raggruppamento dei dati
• Ordinamento dei dati
• Elaborazione dei dati:
• colonne calcolate
• Funzioni sql aggregate (COUNT, AVG, MIN,MAX E SUM)
• Raggruppamento dei dati
• Operazioni sugli insiemi
C2.5 – Subquery
• Subquery in colonne calcolate.
• Condizione di ricerca con subquery;
• Viste
◦ Definizione di una nuova vista
◦ Costruzione di interrogazioni complesse con le viste.
◦ Le viste nelle operazioni di aggiornamento.
C2.6 – Condizioni di ricerca con IN, EXISTS e subquery
• Operatore IN e NOT IN
• Operatore EXISTS, NOT EXISTS
• Alcuni casi particolari
28◦ >ALL'equivalenza con > max
◦ >ANY equivalenza con >MIN
◦ IN equivalenza con =ANY
◦ NOT IN equivalenza con ALL
C2.7 – Protezione dello schema logico del database (Nuovo argomento)
• Permessi per le istruzioni DDL
• Permessi per i comandi DML su oggetti del database
• Revoca dei permessi: Revoke
C2.8 – Gestione delle transazioni (Nuovo argomento)
• Transazione
• Trigger
Modulo D: LE RETI COMPUTER [Appunti e libro V da pag. 110 a pag. 142]
Contenuti:
Modulo D – UdA 1: Hardware E Software delle reti. (TEORIA)
D1.1 – Aspetti hardware delle reti
• Tecnologia trasmissiva.
• Reti in funzione della scala dimensionale (locali, metropolitane, geografiche).
• Topologie di rete (a stella, ad anello, a bus, a stella).
• Regole per il trasferimento dei dati (simplex, half-duplex, full-duplex).
• Interconnessione di reti (Internetwork).
D1.2 – Aspetti software delle reti
• Architettura di rete (concetti generali).
• Servizi connection-oriented e connectionless (differenze) .
• Differenza tra Servizi protocolli.
D1.3 – La realtà nel mondo delle reti
• Modello OSI
• Internet Protocol Suite.
• Confronto fra modello di riferimento OSI e architettura TCP/IP.
• Autorità nel mondo degli standard: ISO, IEEE (differenza).
Modulo D – UdA 2: Il Livello Fisico. (TEORIA)
D2.1 – Mezzi trasmissivi
• Trasmissioni dati (definizione di segnale, definizione di durata, banda e banda larga).
• Doppino intrecciato:
• Concetti generali (diafonia, binatura).
• Classificazione dei doppini in base alla schermatura (STP, FTP e UTP).
• Fibre ottiche:
• Struttura della fibra.
• Fibre monomodali e multimodali.
• Principi fisici delle fibre ottiche (Prima legge di Snell, fenomeno della dispersione modale).
D2.2 – Dispositivi per la comunicazione
• Commutazione (circuito e pacchetto).
• ADSL.
• Rete dedicata.
• Connessione mobile alla rete (GSM, GPRS, EDGE, UMTS e HSPA). (differenze)
Modulo D– UdA 3: Il livello di Data Link. (TEORIA)
D3.1 – Le funzioni del livello di collegamento dati
• Descrizione funzioni.
• Protocolli di Data LINK: HDLC, PPP, LLC (loro utilizzo, no struttura trama dei protocolli).
29• Il progetto IEEE 802 e differenza con Ethernet v. 2.0.
• Mezzi trasmissivi e regole di configurazione (10 Base-T e 10 Base-F).
• Gestione degli indirizzi MAC.
• Interconnessione locale di reti (Bridge, Switch).
Modulo D – UdA 4: Internet Protocol Suite. (TEORIA)
D4.1 – I livelli di rete e di trasporto
• Indirizzi IP, pubblici, privati, statico e dinamico. (no struttura pacchetto protocollo IP).
• Indirizzi IPv4.
• Segmentazione di una rete.
• Indirizzi IPv6.
• Protocolli di servizio dello strato internet: ICMP, ARP e RARP (Loro utilizzo).
• Protocolli di Trasporto in Internet (differenza tra Protocollo TCP e Protocollo UDP, no struttura
segmento protocollo TCP e UDP).
Modulo D – UdA 5: I Livelli superiori del modello OSI. (TEORIA)
D5.1 – Sessione e presentazione
• Descrizione generale dello strato Sessione.
• Descrizione generale dello strato di Presentazione.
D5.2 – IL Livello Applicazione
• Descrizione generale.
• Il sistema dei nomi di dominio.
• Protocolli del livello applicazione: SMTP, POP3, FTP, HTTP, DNS (loro utilizzo).
Modulo E: LA GESTIONE DELLE RETI AZIENDALI [Appunti e libro V da pag. 92 a pag. 140]
Contenuti
Modulo E – UdA 1: I servizi di rete e la sicurezza. (TEORIA)
E1.1 – I servizi di rete.
• Gli indirizzi Internet e il DNS.
• L’utilizzo dei comandi per la rete internet.
• I servizi di internet.
• Le reti di computer.
• Le reti e i server per le aziende:
◦ Il VPS
• I livelli del cloud:
◦ Il cloud storage
• I calendari e i documenti condivisi.
• La piattaforma e l’infrastruttura cloud:
◦ Il cloud VPS
• La tecnologia di rete per la comunicazione:
◦ La comunicazione sincrona e asincrona
◦ La comunicazione nel web 2.0
• I siti Web aziendali.
Modulo E – UdA 2: La sicurezza. (TEORIA)
E2.1 – La sicurezza
• La sicurezza delle reti:
◦ I malaware
◦ Lo span e l’email spoofing
◦ Il phishing
◦ La continuità operativa
◦ Il disaster recovery
30Modulo E – UdA 3: Principi di crittografia. (TEORIA)
E3.1 – La crittografia per la sicurezza dei dati
• La crittografia per la sicurezza dei dati:
◦ Cenni storici.
◦ Il cifrario di sostituzione.
◦ Il cifrario a trasposizione.
E3.2 – La chiave simmetrica e la chiave asimmetrica
• La chiave simmetrica e la chiave asimmetrica:
◦ La crittografia a chiave simmetrica.
◦ La crittografia a chiave asimmetrica:
▪ Garanzia dell’identità del mittente
▪ Garanzia della segretezza
▪ Garanzia dell’identità e della segretezza
◦ Aritmetiche finite o modulari.
◦ Il calcolo del logaritmo nelle aritmetiche finite.
◦ Fattorizzazione di un numero.
◦ L’algoritmo RSA.
◦ L'algoritmo DH (Diffie-Hellman)-per lo scambio delle chiavi.
Modulo E – UdA 4: La firma digitale. (TEORIA)
E4.1 – La La firma digitale
• Il funzionamento della firma digitale:
◦ La smart card.
◦ Il certificato digitale.
◦ I protocolli e i software per la crittografia.
◦ La firma digitale (autenticare un documento con la firma digitale).
◦ Firma elettronica remota.
◦ Token OTP con display per la firma remota.
◦ Token OTP USB per la firma remota.
◦ Il certificato digitale.
◦ Richiesta di un certificato digitale.
Modulo E – UdA 5: La rete per la Pubblica Amministrazione. (TEORIA)
E5.1 – L’e-government
• L’e-government:
◦ Il codice dell’amministrazione digitale
• Gli strumenti e le tecnologie per l’amministrazione digitale.
Modulo E – UdA 6: Posta Elettronica certificata (PEC). (TEORIA)
E6.1 – La PEC
• Come funziona la PEC:
◦ Accesso e identificazione.
◦ Certificazione dell’invio.
◦ Integrità del messaggio.
◦ Certificazione della consegna.
◦ Vantaggi della PEC.
• La marca temporale.
Modulo F: COMMERCIO ELETTRONICO [Appunti]
Contenuti:
Modulo F – UdA 1: La vendita digitale: L’e-commerce. (TEORIA)
F1.1 – E-commerce: il commercio elettronico
• E-commerce: il commercio elettronico.
31• Cenni storici.
• Le quattro tappe nell’evoluzione dell’e-commerce:
• Pubblicazione.
• Interattività.
• Trattazione.
• Integrazione.
• Come funziona l’e-commerce:
• Vendita.
• Immissione di un ordine.
• Pagamento.
• Adempimento.
• Servizio clienti.
• Segnalazione dell’amministrazione.
• Segmenti di e-commerce:
• Business-to-Business.
• Business-to-Consumer.
• Consumer-to-Consumer.
• Consumer-to-Business.
• La tassazione.
• Vantaggi e svantaggi dell’acquisto su un sito e-commerce.
• Vantaggi e svantaggi della vendita su un sito di e-commerce.
• Sistemi di pagamento online:
• Carta di credito.
• Contrassegno.
• Bonifico Bancario.
• PayPal.
• Carte prepagate.
Modulo G: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Contenuti:
Modulo G – UdA 1: La fatturazione elettronica. (TEORIA)
G1.1 – La fatturazione elettronica
• La fattura elettronica.
• Come è fatta la fattura elettronica.
• Invio della fattura elettronica alla PA.
• La conservazione sostitutiva.
• Responsabile della conservazione sostitutiva.
Modulo H: Approvvigionamento elettronico [Appunti]
Contenuti:
Modulo H – UdA 1: Approvvigionamento elettronico. (TEORIA)
H1.1 – Approvvigionamento elettronico
• Il sistema acquisti della Pubblica Amministrazione.
• Caratteristiche del MePa.
• L’abilitazione delle imprese al MEPA.
Modulo I: HTML E FOGLI DI STILE [Appunti e libro IV da pag. 215 a pag. 272 e internet]
Contenuti:
Modulo I – UdA 1: Il linguaggio HTML (LABORATORIO - Ripasso degli argomenti trattati nel precedente
A.S.)
I1.1 – Struttura di un documento HTML
• Struttura di una pagina HTML.
• Sintassi dei tag.
32Puoi anche leggere