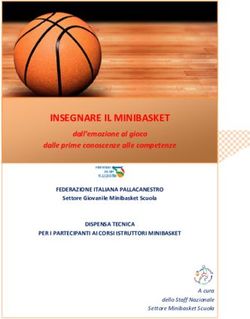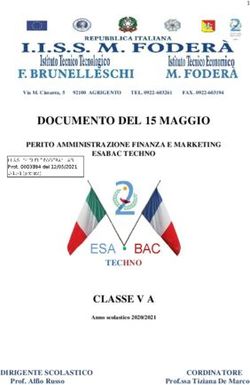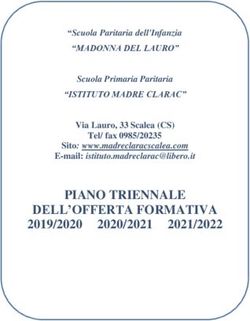PROGRAMMAZIONI CLASSE IV G ANNO 2021/2022 - COORDINATRICE : Professoressa Giorgia Vagnoli
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PROGRAMMAZIONI CLASSE IV G
ANNO 2021/2022
COORDINATRICE : Professoressa Giorgia Vagnoli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof.ssa Rita Nigri Programmazione Italiano/Latino - a.s. 2021/22 4G
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi da perseguire nel II biennio si pongono in linea di continuità con quelli raggiunti nel
biennio, rispetto ai quali si caratterizzano per i livelli di maggiore complessità e di più ampia
articolazione riguardo sia allo sviluppo delle capacità sia all'acquisizione delle conoscenze.
L'indicazione dei traguardi va riferita alla conclusione del percorso. Il loro raggiungimento sarà
graduale, attraverso il variare dei contenuti trattati e delle attività didattiche proposte.
Le mutate condizioni della didattica impongono un ripensamento, ma non un sovvertimento, della
programmazione: rispetto a una predominanza dei contenuti e delle competenze disciplinari, sui quali
tradizionalmente le programmazioni pongono l’accento, si impone forse una rimodulazione che incroci
le conoscenze e le competenze proprie delle discipline con quelle trasversali e quelle di cittadinanza.
Le competenze attese da parte degli studenti si troveranno nell’intersezione tra le competenze
disciplinari e le competenze trasversali.
Più specificatamente:
Conoscenze:
contesto storico, culturale e ideologico dell’epoca barocca
rapporti fra letteratura e altre espressioni artistiche
autori e testi fondamentali dei periodi
caratteristiche della produzione lirica di Marino e dei marinisti
caratteristiche della prosa in Italia e confronto con la prosa europea
caratteristiche del teatro italiano del Settecento
contesto storico, culturale e ideologico tra Illuminismo e Romanticismo
evoluzione delle forme e delle espressioni letterarie
caratteristiche della prosa e della lirica foscoliana
contesto storico, culturale e ideologico dell’età dell’Ottocento e del Risorgimento
caratteristiche della produzione in prosa e in versi
Competenze: padroneggiare la lingua italiana, anche nelle forme che assume alle sue origini e
comprenderne gli sviluppi tra Seicento e primo Ottocento
saper stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni culturali
cogliere la dimensione storica della letteratura
riconoscere continuità e fratture tra letteratura italiana e altre letterature europee
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del testo poetico, in
prosa e teatrale
orientarsi fra testi e autori fondamentali
cogliere il legame tra le poetiche degli autori e i mutamenti storico-culturali
comprendere i rapporti tra poetiche individuali e fenomeni culturali generali
Competenze trasversali di cittadinanza attiva:
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile (autoregolazione dell’apprendimento: obiettivi,
metodo, tempi, spazi, autocorrezione e autovalutazione)
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
Competenze digitali (competenze digitali e la competenza informativa-information literacy):
Partecipare correttamente ad una videolezione rispettando la Netiquette.
Partecipare ad una classe virtuale.
Gestire una propria casella di posta.
Produrre e consegnare compiti in formato digitale.
Creare e condividere documenti.
Identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni.
Imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a
documentarne sistematicamente l’utilizzo attraverso citazioni
Per la produzione scritta:
consolidamento della capacità di produrre testi argomentativi.
avviamento alla produzione di analisi testuali (di testi sia in poesia che in prosa)
formalmente corretti, coerenti e coesi (tipologia "A" dell'esame di Stato).
Obiettivi affettivi motivazionali
Sostenere il processo di formazione dell’identità personale e culturale;
Stimolare la capacità di offrire risposte critiche alle molteplici sollecitazioni dall’esterno;
Mantenimento dello standard di motivazione e impegno;
Autovalutazione degli allievi, perché gli alunni giungano alla consapevolezza della necessità
di avviare un recupero tempestivo ed efficace;
Autocorrezione e avvio di quelle condizioni necessarie al recupero delle conoscenze e
competenze relative ai livelli inferiori.Obiettivi relazionali
Sviluppare negli alunni la capacità di relazionarsi in una prospettiva di dialogo secondo i
principi della convivenza democratica;
Promuovere l’integrazione delle diversità nel rispetto degli altri.
Contenuti
Tra Cinquecento e Seicento:
o Concilio di Trento, crisi della figura del cavaliere: dal Rinascimento maturo al
Manierismo
o Il principe e il cortigiano: il modello di Castiglione.
o L’avventura e il fantastico, il cavaliere antico e il crociato: il modello di Ariosto e di
Tasso.
Tra Seicento e Settecento:
o La scena e il mondo: il modello di Goldoni e di Shakespeare.
o La scienza, l’artificio, la storia: il modello di Galileo (Debate).
Tra Settecento e Ottocento:
o Lo scrittore intellettuale e “cittadino”: il modello degli illuministi e di Foscolo.
o L’eroe nella prosa del mondo: il modello romanzesco di Manzoni.
Lettura di Dante Alighieri, Divina Commedia, il Purgatorio: canti I, III, VI, VIII, XI, XXIII
(vv. 76-133), XXIV.
Lettura autonoma di opere di narrativa contemporanea o del passato che siano in linea con il
programma e/o con gli interessi degli alunni.
Modulo di EDUCAZIONE CIVICA: I flussi migratori – Una panoramica sulla letteratura della
migrazione
PROGETTO EUROPA SCUOLA: DEBATE sul concetto di COMUNITA’, come gruppo di persone
che si accorda tra loro secondo leggi sociali, politiche economiche e anche ambientali. L’obiettivo è
quello di far dire ai ragazzi se è importante o meno vivere in una comunità in cui siano seguite
determinate regole, quali sono i vantaggi del vivere in comunità, quali sono i problemi che possono
essere affrontati e risolti se le persone sono riunite da un intento comune, se è necessario o importante
che i componenti possano avere voce in capitolo sulla gestione della comunità stessa.
Strumenti e materiali:
o Libro di testo
o Power point
o Materiale online
o Videolezioni fornite da web: Lesson plan da RAI (Scuola, Cultura, Play), Vimeo, YouTube;
o Videolezioni fornite dalle classi editrici: Pearson, Mondadori, Giunti T.V.P., Zanichelli
Metodologia
L’organizzazione della didattica verterà sulla centralità del testo e quindi sulla lettura diretta di una
scelta antologica che consenta di cogliere gli aspetti più significativi dell’opera e che consentano di
correlarla al sistema letterario e al contesto culturale.
Si procederà essenzialmente attraverso un percorso che privilegi l’aspetto del rapporto tra intellettuale
e potere e tra generi letterari.Accanto alle forme tradizionali della lezione frontale e della lezione partecipata si possono prevedere
forme alternative come l’utilizzo di sussidi audiovisivi, di software didattici o la metodologia Debate:
o Registro Elettronico: Didattica
o GSuite: Classroom, Meet
o Debate
o Apprendimento cooperativo tramite scrittura ed elaborazione di documenti condivisi,
attività di commento a post ed articoli sulle bacheche delle classi virtuali.
o Videolezioni registrate dai docenti o fornite dal web e dalle case editrici, da fruire in
modalità sincrona o asincrona, corredate di domande, quiz, test o spunti di riflessione.
o Presentazione in videolezione di prodotti degli studenti elaborati in gruppo o
individualmente; colloqui via Meet
o Videolezioni registrate dai docenti o fornite dal web e dalle case editrici, da fruire in
modalità sincrona o asincrona, corredate di domande, quiz, test o spunti di riflessione.
Nel caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata il riferimento è al Regolamento della DDI
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre 2020.
Verifica e valutazione
Verifica orale (formativa e sommativa):
o Colloqui
o Interrogazione lunga
o Interrogazione breve
o Discussioni collettive
o Test a risposta aperta o chiusa
o Apprendimento cooperativo tramite scrittura ed elaborazione di documenti
condivisi, attività di commento a post ed articoli sulle bacheche delle classi virtuali.
o Presentazione in videolezione di prodotti degli studenti elaborati in gruppo o
individualmente; colloqui via Meet.
Verifica scritta (in itinere e sommativa):
o Tutte le tipologie comprese nella prima prova del nuovo esame di Stato
o Relazioni - Recensioni
Criteri di valutazione:
o Progresso rispetto ai livelli iniziali
o Conoscenza dei contenuti
o Comprensione del testo
o Rielaborazione autonoma delle conoscenze
o Capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta
o Capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione scritta e orale
o Accettazione delle regole del lavoro in classe e alla vita scolastica in generale, con
particolare riguardo alla regolarità della frequenza
o Diligenza e puntualità nell’esecuzione dei lavori
o Impegno e partecipazione
o Le griglie di valutazione di Dipartimento sono pubblicate sul sito di Istituto
Obiettivi minimi della quarta classe
1. LETTERATURAa. Conoscenza essenziale del percorso storico-letterario (dalle origini fino al
Romanticismo);
b. Acquisizione del linguaggio specifico relativo al fenomeno letterario.
2. PRODUZIONE SCRITTA
a. Produzione semplice ma corretta delle varie tipologie di testo presenti nella prima prova
dell’esame di Stato;
b. Collegare i dati studiati e ragionare su di essi senza errori ortografici e morfosintattici
gravi, usando un linguaggio chiaro e con una ordinata strutturazione logica del discorso.
3. ORALE
a. Coerenza logica nell’esposizione;
b. Utilizzo pertinente del lessico specifico;
c. Capacità di ascoltare, di intervenire nel dialogo e nella discussione, di formulare e
rispondere a domande scritte e orali, usando un linguaggio chiaro.
Contenuti essenziali per la quarta classe
a. Machiavelli
b. Galilei
c. Fondamenti dell’Illuminismo
d. Goldoni
e. Foscolo
f. Fondamenti del Romanticismo
g. Manzoni
Strategie di intervento per il recupero
Si prevedono forme di intervento in itinere mediante:
percorsi individualizzati, esercitazioni frequenti e diversificate, apprendimento
cooperativo, classe capovolta;LINGUA E LETTERATURA LATINA
Finalità didattiche e pedagogiche
In linea generale l’alunno sarà portato ad acquisire:
graduale consapevolezza del ruolo storico della lingua latina che sopravvisse alla civiltà
romana attraversando i secoli come lingua della comunicazione dell’intera Europa;
coscienza della unità della civiltà latina che, anche nella diversità delle culture nazionali,
ha mantenuto sempre uno stretto legame con il mondo antico, in termini di continuità, di
opposizione, di reinterpretazione;
l’accesso diretto alla letteratura e ai testi;
le capacità di analisi della lingua e di interpretazione dei testi scritti, cogliendone
l’originalità e il valore sul piano storico e letterario;
consapevolezza della presenza di forme e generi letterari nelle letterature moderne e della
loro trasformazione.
Obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi da perseguire nel II biennio si pongono in linea di continuità con quelli raggiunti nel
biennio, rispetto ai quali si caratterizzano per i livelli di maggiore complessità e di più ampia
articolazione riguardo sia allo sviluppo delle capacità sia all'acquisizione delle conoscenze.
L'indicazione dei traguardi va riferita alla conclusione del percorso. Il loro raggiungimento sarà
graduale, attraverso il variare dei contenuti trattati e delle attività didattiche proposte.
Le mutate condizioni della didattica impongono un ripensamento, ma non un sovvertimento, della
programmazione: rispetto a una predominanza dei contenuti e delle competenze disciplinari, sui quali
tradizionalmente le programmazioni pongono l’accento, si impone forse una rimodulazione che incroci
le conoscenze e le competenze proprie delle discipline con quelle trasversali e quelle di
cittadinanza. Le competenze attese da parte degli studenti si troveranno nell’intersezione tra le
competenze disciplinari e le competenze trasversali.
Più specificatamente:
1. Lingua:
a. consolidamento delle competenze linguistiche acquisite nel corso del primo biennio
b. capacità di riflessione sulle diverse scelte di traduzione attraverso l’attività di
traduzione contrastiva
c. comprendere il contenuto di un testo individuandone l’argomento e le informazioni
principali.
d. saper ricostruire il profilo dell’autore contestualizzandolo nel suo scenario storico-
culturale.
e. individuare gli elementi fondamentali di un testo epico, di un testo storiografico e di un
testo teatrale, di un testo didascalico, di un’orazione e di un’epistola, di un testo poetico
relativamente al genere.
f. leggere, comprendere e tradurre opere in versi e in prosa, servendosi degli strumenti
dell’analisi linguistica, stilistica e retorica.
2. Cultura:
a. capacità di inserire il testo letterario nel suo contesto storico e culturale
b. capacità di cogliere elementi di continuità e di novità rispetto alla tradizione grecac. capacità di cogliere e sviluppare in prospettiva multidisciplinare argomenti e temi
emersi dalle letture in lingua o in traduzione
d. capacità di interpretare il testo letterario utilizzando gli strumenti dell’analisi testuale
3. Competenze trasversali di cittadinanza attiva:
a. Imparare ad imparare
b. Progettare
c. Comunicare
d. Collaborare e partecipare
e. Agire in modo autonomo e responsabile (autoregolazione dell’apprendimento: obiettivi,
metodo, tempi, spazi, autocorrezione e autovalutazione)
f. Risolvere problemi
g. Individuare collegamenti e relazioni
h. Acquisire ed interpretare l’informazione
4. Competenze digitali (competenze digitali e la competenza informativa-information literacy):
a. Partecipare correttamente ad una videolezione rispettando la Netiquette.
b. Partecipare ad una classe virtuale.
c. Gestire una propria casella di posta.
d. Produrre e consegnare compiti in formato digitale.
e. Creare e condividere documenti.
f. Identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni.
g. Imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web,
abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo attraverso citazioni
Obiettivi affettivi motivazionali
Sostenere il processo di formazione dell’identità personale e culturale;
Stimolare la capacità di offrire risposte critiche alla molteplici sollecitazioni dall’esterno;
Mantenimento dello standard di motivazione e impegno;
Autovalutazione degli allievi, perché gli alunni giungano alla consapevolezza della necessità di
avviare un recupero tempestivo ed efficace;
Autocorrezione e avvio di quelle condizioni necessarie al recupero delle conoscenze e
competenze relative ai livelli inferiori.
Obiettivi relazionali
Sviluppare negli alunni la capacità di relazionarsi in una prospettiva di dialogo secondo i
principi della convivenza democratica.
Contenuti disciplinari
Competenza linguistica:
o consolidamento e relativo approfondimento dell’aspetto linguistico attraverso
l’analisi concreta dei testi;
o traduzione di brani d’autore con riflessione sulla trasposizione da una lingua
all’altra.
Storia letteraria:o Il passaggio dalla Repubblica al Principato: la figura di Augusto ed il suo
programma politico
o La storiografia di Tito Livio: la biografia dell’autore, la struttura dell’opera e i temi.
o Il profilo intellettuale di Orazio: dati biografici e opere
o Il genere della satira: Lucilio, inventor generis (età arcaica); Persio e Giovenale, la
satira e la degenerazione del mos maiorum (età imperiale)
o L’esametro e i principali metri lirici
o Propaganda e mecenatismo: concetti fondamentali alla base della produzione
letteraria
o La biografia di Virgilio
o Le caratteristiche del genere bucolico e i temi delle Bucoliche di Virgilio
o Le caratteristiche del genere didascalico e i temi delle Georgiche di Virgilio
o Il poema epico e la propaganda augustea: struttura, personaggi, temi e stile
dell’Eneide
o L’Eneide e la soggettività, i sentimenti in primo piano: pietas, amore, amicizia
o L’umanizzazione del mito: il libro IV dell’Eneide e le Heroides di Ovidio
o L’elegia e la tradizione del genere
o L’esametro e il distico elegiaco
o Tibullo: i caratteri della poesia, le figure femminili, il III libro del corpus, lo stile
o Properzio: i caratteri della poesia, le figure femminili, il IV libro del corpus. lo stile
o Ovidio: la biografia e i rapporti con la società augustea, la produzione (il genere
elegiaco, la poesia didascalica, il poema mitologico), lo stile
Tempi
2 ore settimanali.
Metodologia
L’organizzazione della didattica verterà sulla centralità del testo e quindi sulla lettura diretta di una
scelta antologica che consenta di cogliere gli aspetti più significativi dell’opera e che consentano di
correlarla al sistema letterario e al contesto culturale.
Si procederà essenzialmente attraverso un percorso che privilegi l’aspetto del rapporto tra intellettuale
e potere e tra generi letterari.
Accanto alle forme tradizionali della lezione frontale e della lezione partecipata si possono prevedere
forme alternative come l’utilizzo di sussidi audiovisivi oppure di software didattici:
o lezione frontale;
o lettura guidata e autonoma di fonti;
o dibattiti e sintesi;
o Registro Elettronico: Didattica
o GSuite: Classroom, Meet
o Apprendimento cooperativo tramite scrittura ed elaborazione di documenti condivisi, attività di
commento a post ed articoli sulle bacheche delle classi virtuali.
o Videolezioni registrate dai docenti o fornite dal web e dalle case editrici, da fruire in modalità
sincrona o asincrona, corredate di domande, quiz, test o spunti di riflessione.
o Presentazione in videolezione di prodotti degli studenti elaborati in gruppo o individualmente;
colloqui via Meet
o Videolezioni registrate dai docenti o fornite dal web e dalle case editrici, da fruire in modalità
sincrona o asincrona, corredate di domande, quiz, test o spunti di riflessione.Nel caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata il riferimento è al Regolamento della DDI
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre 2020.
Strumenti e materiali:
o Libro di testo
o Power point
o Materiale online
o Videolezioni fornite da web: Lesson plan da RAI (Scuola, Cultura, Play), Vimeo, YouTube;
o Videolezioni fornite dalle classi editrici: Pearson, Mondadori, Giunti T.V.P., Zanichelli
o libri della biblioteca scolastica;
o saggi critici;
o vocabolari;
o enciclopedie;
o software didattici.
Verifica e valutazione
Verifica orale (formativa e sommativa):
o Colloqui
o Interrogazione lunga
o Interrogazione breve
o Discussioni collettive
o Test a risposta aperta o chiusa
o Apprendimento cooperativo tramite scrittura ed elaborazione di documenti
condivisi, attività di commento a post ed articoli sulle bacheche delle classi virtuali.
o Presentazione in videolezione di prodotti degli studenti elaborati in gruppo o
individualmente; colloqui via Meet.
Verifica scritta (in itinere e sommativa):
o traduzioni da opere di autori in programma;
o redazione di saggi brevi;
o relazioni
Criteri di valutazione:
o Progresso rispetto ai livelli iniziali
o Conoscenza dei contenuti
o Comprensione del testo
o Rielaborazione autonoma delle conoscenze
o Capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta
o Capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione scritta e orale
o Accettazione delle regole del lavoro in classe e alla vita scolastica in generale, con
particolare riguardo alla regolarità della frequenza
o Diligenza e puntualità nell’esecuzione dei lavori
o Impegno e partecipazione
o Le griglie di valutazione di Dipartimento sono pubblicate sul sito di Istituto
Obiettivi minimi:
1. Conoscenza delle linee essenziali della storia della letteratura latina2. Inquadramento del testo latino nel contesto storico-culturale di riferimento
3. Comprensione, interpretazione e commento del significato globale (linguistico e
culturale) di un testo noto
Contenuti essenziali
Virgilio
Orazio
Ovidio
Livio
Strategie di intervento per il recupero
Si prevedono forme di intervento in itinere mediante:
1. corsi di recupero e sostegno organizzati dall’Istituto e programmati dal Collegio dei Docenti,
dove si ritengano necessari ed efficaci;
2. percorsi individualizzati, esercitazioni frequenti e diversificate apprendimento cooperativo,
classe capovolta;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FILOSOFIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Classe 4 G - A.S. 2021/2022 Docente: Maria Natalia Bardi
Competenze Asse Storico
Asse dei Linguaggi Sociale
Competenze
Disciplinari Generali
Scegliere le
Padroneggiare gli strategiedi di
strumenti espressivi studio più
ed adeguate al
Saper cogliere gli elementi argomentativi lavoro dato
indispensabili per Ricercare parole
storici, culturali, teorici e gestire chiave
logici di un autore/tema l’interazione verbale in Individuare immagini
filosofico comprendendone il
Culturale Cognitivo
significato vari contesti significative
Saper cogliere il contenuto e il Utilizzare gli
significato di un testo Imparare strumenti Costruire mappe
filosofico, ricostruendone
nell’esposizione, se richiesto, i concettuali a
passaggi tematici a fondamentali per una partire dal
fruizione consapevole
Imparare del testoSaper indicare gli
interrogativi di diversi ambiti patrimonio artistico e
letterario
della ricerca filosofica
Saper riconoscere le
di Tipo
specificità delle risposte
filosofiche, indagandone le
condizioni di possibilità e il
Produrre testi di vario Pianificare il
“loro senso in una visione tipo percorso di
in relazione ai ricerca
Competenze
globale” differenti interdisciplinare
Costruire la scaletta
scopi comunicativi e di
un’esposizione
operativi scritta e/o
Progettare Utilizzare e produrre orale
messaggi multimediali Organizzare un testo
multimediale
Pianificare tempi e
modalità di studio
Esporre i risultati di
Padroneggiare gli un
strumenti espressivi
ed percorso di ricerca
-
argomentativi Scegliere le modalità
indispensabili per comunicative più
Espressive
Saper esporre i contenuti, dal gestire adeguate
per presentare la
punto di vista linguistico- l’interazione verbale in relazione
espressivo, in modo chiaro, vari contesti di un lavoro di
Produrre testi di vario approfondimento
coerente e corretto, con tipo su un
proprietà di linguaggio. in relazione ai argomento
differenti assegnato
Comunicare
scopi comunicativi e
Saper comprendere il lessico
e le categorie specifiche della
tradizione filosofica e la loro operativi
evoluzione storico-filosofica
Utilizzare e produrre
Materiali multimediali
Saper utilizzare
correttamente la terminologia
specifica della disciplina
Competenze
in modo ragionato, critico e Utilizzare il lessico
autonomo disciplinare pertinente Organizzare a gruppi
proposte
migliorative
rispetto al clima di
Collaborare Utilizzare e produrre classemessaggi multimediali
e
Partecipare
CONOSCENZE
Anselmo d’Aosta
Le prove dell’esistenza di Dio
Tommaso d’Aquino
Le cinque vie
La Riforma Protestante e la Riforma cattolica
Martin Lutero, Erasmo da Rotterdam
Giordano Bruno
Dio, l’universo e l’infinito
La Rivoluzione scientifica
Galileo:
fede e scienza;
le conferme del sistema copernicano;
la nascita del metodo scientifico
Francesco Bacone:
Il Novum Organum ed il superamento della logica aristotelica
IL RAZIONALISMO
R. Descartes e la nascita della filosofia moderna
Le regole del metodo
Il Cogito ergo sum
La res estensa
Il ruolo dell’idea di Dio
B. Spinoza e l’unica sostanza
G.W. Leibniz
La monade
L’armonia prestabilita
B. Pascal
L’EMPIRISMOT. Hobbes
La logica
Lo Stato assolutistico
J. Locke
Il saggio sull’intelletto umano
Critica all’innatismo e nascita delle idee
La dottrina della conoscenza
La politica
D.Hume
Impressioni e idee
Critica al principio di causalità
Lo scetticismo humiano
Kant e la fondazione della filosofia trascendentale
CONTENUTI MINIMI
CARATTERI GENERALI:
Umanesimo e Rinascimento
La rivoluzione scientifica
Autori più rappresentativi dell’Empirismo e del Razionalismo
L’Illuminismo
Il criticismo kantiano
L’Insegnante
Maria Natalia Bardi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCIENZE UMANE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE
Anno scolastico 2021.2022 INSEGNANTE: Maria Natalia Bardi
CLASSE 4G
PEDAGOGIA
J. Locke: l’educazione del gentlman ; la tolleranza.
J-J- Rousseau: l’anticipatore del romanticismo pedagogico, l’ Emilio,
l’educazione negativa, l’educazione positiva, il Contratto Sociale.H. Pestalozzi: le esperienze pedagogiche, il metodo
F. Froebel: l’infanzia come età del gioco
Metodologia e struttura del Kindergarten
I doni
PEDAGOGIA DELL’OTTOCENTO IN ITALIA
La legge Casati e la legge Coppino
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA’
L’approccio individualista :G. W. Allport
L’approccio relazionale
Test proiettivi della personalità
LA VITA EMOTIVA
Emozioni
Linguaggi emotivi
Emozioni e cultura
LA PSICOLOGIA SOCIALE
Il gruppo
La teoria del campo: Kurt Lewin
Dinamiche di gruppo
LA PSICOLOGIA: TECNICHE E PROFESSIONISTI
Lo psicologo clinico
Lo psicologo dello sviluppo
Lo psicologo di comunità
Il testista
COME SI DIVENTA PSICOLOGI
ANTROPOLOGIA
LE DINAMICHE DELLA CULTURA
- Potere, conflitto cambiamento
- Tradizione e modernità
- Oralità e scrittura
DIMENSIONI CULTURALI DELL’ESISTENZA- Corpo
- Identità
- Potere
- La dimensione del sacro
LA TRADIZIONE DEMOLOGICA ITALIANA
Il pensiero di Ernesto de Martino
SOCIOLOGIA
La stratificazione sociale
Karl Marx:
- lo studio dell’alienazione
- l’analisi del Capitale
Max Weber e la sociologia “comprendente”
W. Paredo: il metodo sociologico
La scuola di Francoforte
CONTENUTI MINIMI
ANTROPOLOGIA
1. Grandi temi antropologici
Potere e cambiamenti culturali
Tradizione e modernità
Oralità e scrittura
2. Autori e teorie
L’antropologia interpretativa
Autori classici: De Martino
PSICOLOGIA
1. Elementi di psicologia sociale
La psicologia del gruppo
La vita emotiva
PEDAGOGIA
1. Empirismo e illuminismo pedagogico
L’educazione dell’uomo borghese: John Locke
L’Illuminismo e il diritto all’istruzione
Jean-Jacques Rousseau
2. Educazione, pedagogia e scuola nell’Ottocento
Heinrich Pestalozzi
Friedrich Fröbel
SOCIOLOGIA
1. Le diverse teorie sociologiche e le molteplici forme di interpretazione del rapporto individuo/società
Temi chiave: devianza e controllo sociale; i movimenti sociali
2. I classici della sociologia tra Ottocento e primo Novecento
Karl Marx
Max WeberL’Insegnante
Maria Natalia Bardi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCIENZE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIANO DI LAVORO
ANNO SCOLASTICO: 2021-2022
DOCENTE: RAMPINO GERARDO MATERIA: SCIENZE
CLASSE: IV SEZIONE: G INDIRIZZO: SCIENZE UMANE
FINALITA’: sviluppo della capacità logiche, astrattive, deduttive e di una maturità scientifica, al fine
del raggiungimento di una autonomia di giudizio e di collegamento fra sapere scientifico e sapere
umanistico.
OBIETTIVI: al termine del corso lo studente è stato in grado di: 1) utilizzare il linguaggio specifico
fondamentale; 2) conoscere e correlare le conoscenze biologiche, chimiche e geologiche; 3) descrivere
i principali processi naturali; 4) raccogliere i dati e porli in un contesto di conoscenze e in un quadro
plausibile di interpretazione.
OBIETTIVI MINIMI: si fa assoluto riferimento a quanto stabilito e indicato nel verbale della
riunione di area tenutasi ai primi di settembre
CONOSCENZE: conoscenza, comprensione e applicazione dei principali nuclei della biologia, della
chimica e della geologia. Correttezza e specificità linguistica. Conoscenza delle interazioni tra realtà
biologica e attività umane.
ABILITA’, PRESTAZIONI: abilità analitica e sintetica; utilizzo, in modo autonomo, delle strategie
più appropriate nell’ambito delle capacità logico-interpretative; abilità nell’avvalersi di modelli
scientifici e nell’affrontare situazioni problematiche.
COMPETENZE: discrete competenze linguistiche, capacità di ascolto, di dialogo e di accoglienza
degli altri; capacità di inserirsi nella dinamica della classe in modo propositivo; capacità di
comunicazione e di estrinsecazione di un sapere operativo.
METODOLOGIA DIDATTICA: metodo induttivo-deduttivo attraverso lezione frontale, interattiva,
individualizzata con eventuali esperienze di laboratorio. Uso di videocassette e filmati, visite guidate a
musei, eventuali uscite naturalistiche.
TEMPI: secondo le possibilità della classe accertate nel corso dell’anno.
SPAZI: quelli messi a disposizione dall’edificio scolastico.
MEZZI: quelli messi a disposizione dall’istituto.CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza dei contenuti, linguaggio e capacità espositive ed
espressive, pertinenza e logica argomentative; capacità di sintesi. Indicatori: interesse, partecipazione,
impegno e frequenza.
STANDARD MINIMI: comprensione degli argomenti, conoscenza dei contenuti minimi, sufficiente
competenza linguistica, sufficiente capacità di analisi e di sintesi.
STRUMENTI DI VERIFICA: colloqui orali, questionari a domande aperte, esercitazioni scritte,
lavori di gruppo, ricerche interdisciplinari.
LIBRI DI TESTO:
Curtis-Sue Barnes, Nuovo invito alla biologia blu. Corpo umano, ZANICHELLI
Posca, Chimica più. Da struttura atomica a elettrochimica, ZANICHELLI
MODULO A BIOLOGIA
Unità didattica n. 1: Tessuti, organi e apparati. La digestione. La respirazione
Unità didattica n. 2: La circolazione
Unità didattica n.3: La risposta immunitaria e le malattie
Unità didattica n. 4: Sistema endocrino
Unità didattica n. 5: Sistema nervoso, l’encefalo e gli organi di senso
EDUCAZIONE CIVICA
Il docente svolgerà 2 ore di educazione civica sui cambiamenti climatici.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FISICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indirizzo scienze umane
classe IV Sez. G
a.s. 2021-2022
docente: Marino Abbatelli
PROGRAMMAZIONE DI FISICA
Finalità generali
Acquisizione della consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al progresso
tecnologico ed alle più moderne conoscenze
Comprensione dell’universalità delle leggi fisiche che partendo dalla scala umana si estende dalmacrocosmo al microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica organica della realtà
fisica
Sviluppo di capacità di osservazione ed indagine
Sviluppo di capacità di analisi, astrazione e generalizzazione
Capacità di organizzare il lavoro personale secondo varie fasi operative
Acquisizione di un rigore formale come mezzo di comunicazione esatta
Abitudine al rispetto dei fatti e al riscontro oggettivo delle ipotesi interpretative
Acquisizione di un bagaglio culturale indispensabile per una comprensione critica della realtà
Conoscenze
definizione operativa, unità, strumenti e metodi di misura delle grandezze introdotte
conoscenza delle formule matematiche che mettono in relazione le grandezze
conoscenza del significato concettuale delle grandezze fisiche introdotte
esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici
Capacità
Usare un linguaggio corretto, sintetico, sequenziale e specifico
Utilizzare il formalismo matematico basilare (algebrico, vettoriale, grafico) negli argomenti di
fisica e nella soluzione di problemi
Eseguire calcoli numerici su varie grandezze fisiche
Essere in grado di analizzare e schematizzare situazioni reali
Cogliere, sotto opportuni stimoli, nessi e relazioni tra i concetti studiati
Riassumere, analizzare, parafrasare testi e contenuti di argomento essenzialmente noto
Eseguire semplici misure
Raccogliere, ordinare, rappresentare (in tabelle e grafici) ed elaborare i dati
Interpretare grafici e tabelle
Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione
Competenze
Saper realizzare semplici esperienze e/o descrivere fenomeni
Cogliere analogie strutturali e individuare collegamenti
Valutare l’attendibilitàdei risultati sperimentali ottenuti
Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti
Capacità di collegamento tra argomenti correlati
Capacità di astrazione
Capacità di cogliere analogie e di sfruttare conoscenze pregresse e interdisciplinari a
problematiche fisiche
La frequenza, la partecipazione e l’impegno alle attività proposte
Metodologia
Lezione frontale
Lavori personali e di gruppo
Strumentazione multimediale
Esperienze di laboratorio
Test ed esercizi
Recupero in orario curricolare
Contenuti essenziali
Termologia: temperatura, calore; termodinamica; le onde: acustica e ottica.Obiettivi Minimi
Sapere distinguere i concetti di temperatura e calore; saper riconoscere le leggi dei gas perfetti e
l’equazione di stato dei gas perfetti;
saper distinguere il I e il II principio della termodinamica;
sapere riconoscere le caratteristiche delle onde elastiche, del suono e della luce;
ottica geometrica.
Contenuti
I Fluidi
Solidi, liquidi e gas - La pressione - La pressione nei liquidi - La pressione della forza-peso nei
liquidi - I vasi comunicanti - La spinta di Archimede - La pressione atmosferica - La misura della
pressione atmosferica - La corrente di un fluido - L’equazione di continuità - L’equazione di
Bernoulli
Temperatura
Termometro - Dilatazioni lineare e volumica nei solidi - Dilatazione volumica nei liquidi -
Trasformazione di un gas: leggi di Gay-Lussac e Boyle - Gas perfetto, equazione di stato relativa.
Calore
Calore e lavoro - Energia in transito - Capacità termica, calore specifico e calorimetro -
Conduzione, convezione e irraggiamento 37
Primo principio della termodinamica
Gli scambi energia - L’energia interna di un sistema fisico - Il principio zero della termodinamica
- Trasformazioni reali e quasistatiche - Il lavoro termodinamico - Enunciato del primo principio
ed applicazioni
Secondo principio della termodinamica
Le macchine termiche - Primo enunciato: Lord Kelvin - Secondo enunciato: Rudolf Clausius -
Terzo enunciato: il rendimento - Trasformazioni reversibili ed irreversibili - Il teorema di Carnot
ed il relativo ciclo - Cenni sull’entropia.
Le onde elastiche ed il suono
Le onde: periodiche, sonore - Caratteristica del suono - I limiti di udibilità - Eco - Onde
stazionarie
I raggi luminosi
La luce - La riflessione e lo specchi piano - Specchi curvi e sferici: legge dei punti coniugati -
Rifrazione e riflessione totale
Le onde luminose
Onde e corpuscoli - Interferenza - La diffrazione - I colori e la lunghezza d’onda - L’emissione ed
assorbimento della luce
Libro di testo: Le traiettorie della fisica 2 (seconda edizione) Ugo Amaldi ed Zanichelli 38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATEMATICA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAMMAZIONE 2021/22 DOCENTE : Marino Abbatelli MATERIA : Matematica CLASSE : 4 sez. G INDIRIZZO : Scienze Umane FINALITA' Sviluppo di capacità intuitive e logiche Capacità di ragionamento coerente e argomentato Abitudine alla precisione del linguaggio Passaggio graduale dal pensiero operativo a quello razionale astratto Possesso dei contenuti riportati nel programma Acquisizione della capacità di sviluppare dimostrazioni e di operare con il simbolismo matematico OBIETTIVI Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e dei modelli matematici Dominare attivamente i concetti e i metodi degli elementi del calcolo algebrico Dominare attivamente gli strumenti matematici per lo studio dei fenomeni fisici e la costruzione di modelli Adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informatici introdotti CONOSCENZE Conoscere i contenuti proposti : definizioni, regole, proprietà, simbolismi, operazioni e procedure COMPETENZE Possedere capacità logiche Analizzare e interpretare testi e situazioni Adoperare una terminologia appropriata CAPACITÀ Conoscere le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà Operare con le formule goniometriche Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche Conoscere le relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli Risolvere un triangolo qualunque Applicare la trigonometria METODOLOGIA DIDATTICA La metodologia adottata sarà, in linea generale, la lezione frontale presentata agli allievi in forma tale da sollecitare l’interesse e la partecipazione di tutti. L’obiettivo principale sarà quello di educare i ragazzi ad un apprendimento che si basasse soprattutto su processi di deduzione logica. L’attività di recupero sarà svolta in itinere a conclusione di un argomento o di un modulo e, per i casi più gravi, con eventuali corsi di recupero pomeridiano. CRITERI DI VALUTAZIONE Conoscenza dei contenuti Capacità espositive, di collegamento, di analisi e di sintesi Adeguatezza del linguaggio Impegno mostrato, interesse, partecipazione, frequenza CRITERI DI SUFFICIENZA (STANDARD MINIMI) Conoscenza dei principali contenuti disciplinari
Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se in un contesto espressivo personale e non
rigoroso
Capacità di risolvere con strumenti algebrici e grafici semplici problemi.
CONTENUTI ESSENZIALI
Le funzioni goniometriche;
le formule goniometriche;
le equazioni goniometriche;
la risoluzione dei triangoli.
Esponenziali e logaritmi, proprietà ed equazioni.
OBIETTIVI MINIMI
Conoscere la definizione di seno, coseno, tangente di un arco;
saper rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno e tangente;
conoscere le relazioni fondamentali della goniometria (tranne quelle con secante e cosecante);
saper applicare le relazioni con gli archi fondamentali;
sapere risolvere le equazioni goniometriche elementari e le equazioni goniometriche di II grado
in una sola funzione;
sapere risolvere i triangoli rettangoli;
saper risolvere i triangoli qualunque;
saper risolvere equazioni esponenziali elementari;
sapere risolvere equazioni logaritmiche elementari.
Contenuti nell’ottica del II biennio: disequazioni goniometriche; calcolo combinatorio;
similitudine; trasformazioni nel piano.
Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli da svolgere.
Le funzioni e le loro caratteristiche:
Cosa sono le funzioni, le funzioni numeriche, le funzioni definite per casi, Il dominio di una
funzione, la classificazione delle funzioni. Le funzioni iniettive, suriettive, biiettive, La funzione
inversa. Le funzioni pari e le funzioni dispari, le funzioni crescenti, decrescenti, le funzioni
monotòne. Le funzioni periodiche.
Le funzioni esponenziali:
le equazioni esponenziali, le disequazioni esponenziali.
La funzione logaritmica:
I logaritmi, definizione. Le proprietà dei logaritmi. le equazioni logaritmiche, le disequazioni
logaritmiche. Le equazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi.
Le funzioni goniometriche :
Conoscere e rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente e le
funzioni goniometriche inverse; Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari ;
Determinare le caratteristiche delle funzioni sinusoidali.
Le equazioni e le disequazioni goniometriche :
Calcolare le funzioni goniometriche di angoli associati; Applicare le formule di addizione,
sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche. Risolvere equazioni goniometriche elementari
; Risolvere equazioni lineari in seno e coseno ; Risolvere equazioni omogenee di secondo grado inseno e coseno ; Risolvere sistemi di equazioni goniometriche ; Risolvere disequazioni
goniometriche.
La trigonometria :
Applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli rettangoli; Risolvere un triangolo rettangolo;
Calcolare l’area di un triangolo; Applicare il teorema dei seni; Applicare il teorema del coseno;
Applicare la trigonometria alla fisica, a contesti della realtà e alla geometriaGRIGLIA DI VALUTAZIONE in uso per Matematica
GIUDIZIO
VOTO/10
Conoscenze Competenze Capacità
Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti
0–2 proposti.
Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre
distingue i dati, senza saperli classificare
corretta dei contenuti che non riesce ad applicare a
né sintetizzare in maniera precisa
3–4 contesti diversi da quelli appresi
Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo.
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale distingue e collega i dati tra loro in modo
frammentario perdendosi, se non
5 guidato, nella loro applicazione.
Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo.
Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a li sa distinguere e raggruppare in modo
6 compiere semplici applicazioni degli stessi. elementare, ma corretto.
Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato.
Ha una conoscenza completa, ma non sempre li sa analizzare e sintetizzare,
approfondita dei contenuti che collega tra loro e applica
7 a diversi contesti con parziale autonomia
Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato.
Ha una conoscenza completa ed approfondita dei li sa ordinare, classificare e sintetizzare,
8 contenuti che collega tra loro e applica a diversi
contesti.
Linguaggio specifico della disciplina pertinente.
Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che compie analisi critiche personali e sintesi
riconosce e collega in opposizione e in analogia corrette e originali.
9 – 10 (classificazione) con altre conoscenze, applicandoli,
autonomamente e correttamente, a contesti diversi.
Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STORIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE IV G – STORIA
A.S. 2021/2022
Insegnante: Francesca Cidda
Ore di lezione settimanali: 2
Libro di testo: DESIDERI CODOVINI - STORIA E STORIOGRAFIA VOLUME 2
Il percorso didattico per l’insegnamento della storia proposto dal Dipartimento di filosofia e
storia del Liceo “Eugenio Montale” tiene conto delle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi
specifici di apprendimento”, che delineano una selezione dei contenuti basata sul criterio delleconoscenze essenziali, e propone lo studio della storia come un’educazione all’esercizio critico del
pensiero e alla formazione della consapevolezza dei nessi esistenti tra passato e presente.
Si lavorerà per promuovere lo sviluppo della capacità di ricostruire i fattori che determinano la
complessità del fatto storico e le sue interrelazioni sincroniche e diacroniche. Mediante attività di
laboratorio su documenti e testi storiografici, verranno svolte esercitazioni volte a distinguere fatti e
interpretazioni e ad individuare i diversi punti di riferimento ideologici a cui le interpretazioni si
riferiscono.
Sarà inoltre riservato uno spazio adeguato al tema della Memoria e a quello della
Cittadinanza e Costituzione in modo che, al termine del quinquennio, lo studente maturi le
necessarie competenze per una vita civile responsabile e conosca i fondamenti del nostro ordinamento
costituzionale.
CONOSCENZE
Conoscere la terminologia specifica e le questioni principali (avvenimenti-cause) dell’età moderna e
risorgimentale.
COMPETENZE
Saper utilizzare gli strumenti didattici (manuale, media, cartine geografiche, ecc.) e saper costruire
diagrammi di relazioni di causalità. Uso corretto di alcune categorie del mutamento storico (continuità,
discontinuità ecc.).
CAPACITÀ
Saper distinguere processi di breve, medio e lungo periodo ponendo in corretta successione temporale i
fenomeni. Individuare i nuclei essenziali di un fenomeno storico cogliendo i rapporti di successione,
concomitanza, interazione, causalità. Individuazione delle dimensioni diacroniche e sincroniche.
Modulo 1. La Francia di Luigi XIV e il costituzionalismo inglese
Politica sociale, religiosa ed economica
Modulo 2. I nuovi equilibri in Europa e nel mondo nella prima metà del Settecento.
Le guerre di successione spagnola e austriaca e la guerra dei sette anni
Modulo 3. La rivoluzione industriale inglese
I fattori dell’industrializzazione in Inghilterra; lo sviluppo dell’industria tessile, mineraria e
metallurgica; le conseguenze sociali della rivoluzione industriale.
Modulo 4. L’Illuminismo e il dispotismo illuminato.
- Il pensiero politico, religioso ed economico dell’Illuminismo
- Il dispotismo illuminato in Austria, Prussia e Russia
Modulo 5. La Rivoluzione americana.
Lo scontro tra le colonie e la madrepatria; il congresso di Filadelfia e la Dichiarazione dei
diritti; la guerra d’indipendenza americana
Modulo 6. La Rivoluzione francese.
La crisi dell’antico regime e la rivolta del Terzo stato; dalla presa della Bastiglia alla
monarchia costituzionale; la Francia repubblicana; la repubblica giacobina e il Terrore; la
controrivoluzione di Termidoro e il Direttorio
Modulo 7. Il regime di Napoleone.
Le campagne d’Italia e d’Egitto; il colpo di stato del 1799; dal consolato all’impero
(l’accentramento amministrativo, il concordato con la Chiesa, il codice civile);
l’espansionismo militare e il crollo della campagna di Russia; il governo dei “cento giorni”
e l’esilio a Sant’Elena
Modulo 8. L’Europa della Restaurazione.
Il congresso di Vienna; le reazioni dei moti liberali degli anni 1820-1830
Modulo 9. I moti del Quarantotto in Europa e in Italia.
Modulo 10. Il processo di unificazione italiana.
La prima e la seconda guerra d’indipendenza; la nascita del Regno d’Italia
Modulo 11. L’Italia unita e i governi della Destra storica.La politica economica, la questione meridionale, la questione romana e la terza guerra
d’indipendenza, l’annessione di Roma e la legge delle guarentigie.
N.B. Gli "obiettivi minimi" riguardo le conoscenze, le competenze e le capacità, s'intendono raggiunti se conseguiti
sui "contenuti minimi" e al livello indicato come valido per il "6" nella tabella di valutazione di cui sotto.
METODOLOGIA Lezioni frontali. Connessioni in rete finalizzate all'analisi di materiali audiovisivi fruibili a
norma di legge (film e documentari storici)
STRUMENTI DIDATTICI Manuali, testi, Lim.
MODALITA' DI VERIFICA Interrogazioni, domande dal posto, questionari scritti, eventuali lavori di ricerca
CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglia confermata dal Dipartimento)
1-3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; mancanza di
organizzazione del lavoro;
disinteresse totale per il dialogo scolastico.
4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli argomenti;
scarsa organizzazione del lavoro scolastico;
eloquio frammentario ed insicuro.
5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; difficoltà di
organizzare in modo autonomo i contenuti; difficoltà di eloquio
6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita degli argomenti;
esposizione coerente e corretta anche se non scorrevole.
7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di collegamento; esposizione
scorrevole ed appropriate.
8 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti; capacità di
analisi e di sintesi; esposizione sicura ed appropriata.
9 - 10 Conoscenza organica ed approfondita degli
argomenti; capacità di individuare
autonomamente collegamenti
multidisciplinari e di sviluppare un giudizio critico consapevole;
esposizione sicura ed appropriata, adeguata nel lessico.
Considerata la particolarità di questo anno scolastico, l’insegnante propone anche una programmazione per
obiettivi minimi, qualora le condizioni sanitarie non permettano una costante didattica in presenza e si renda
necessario il frequente ricorso alla DDI.
Classe quarta – contenuti minimi
a.s. 2021/2022
Assolutismo in Francia, le rivoluzioni inglesi e il Costituzionalismo
La prima rivoluzione industriale
Illuminismo e riforme
La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America
La rivoluzione francese: cause, fasi e conseguenze
L’età napoleonica Il Congresso di Vienna e l’età della Restaurazione
I moti rivoluzionari nel primo Ottocento
Colonialismo ed imperialismo nel secondo Ottocento
L’unità d’Italia: le fasi, i caratteri, i protagonisti.
Roma 5 ottobre 2021
L’insegnante
Francesca Cidda
INGLESE
DISCIPLINA: INGLESE DOCENTE: PISANI SONIA CLASSE 4° SEZ. G
FINALITA’
• Acquisizione di un’effettiva competenza linguistica con finalità comunicative e culturali
• Ampliamento degli interessi e degli orizzonti culturali
• Sviluppo della capacità di rielaborazione e sintesi
OBIETTIVI
• Approfondire la capacità di analisi del testo letterario nelle sue varie espressioni.
• Ampliare la conoscenza della lingua e della letteratura e interiorizzare nozioni e funzioni linguistiche
per un uso più fluido e personalizzato della L2.
• Acquisire autonomia di studio ed analisi.
• Individuare le linee di evoluzione del sistema letterario oggetto di studio nel contesto europeo.
• Raggiungimento del livello B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo
CONOSCENZE
• Conoscenza delle funzioni, delle strutture e del lessico necessari ad una comunicazione su argomenti
di carattere generale e specifico.
• Conoscenza del quadro storico in cui si inseriscono le opere letterarie studiate.
• Conoscenza degli aspetti fondamentali dei generi letterari.
ABILITA’
• Saper cogliere il significato specifico di una conversazione, individuare le tematiche di un testo
comprenderne le informazioni, effettuare inferenze, riformulare testi.
COMPETENZE• Comunicare sugli argomenti del programma
• Saper analizzare brani in prosa.
• Saper produrre brevi testi scritti.
COMPETENZE DIGITALI
• Partecipare correttamente ad una videolezione rispettando la Netiquette.
• Partecipare ad una classe virtuale.
• Gestire una propria casella di posta.
• Produrre e consegnare compiti in formato digitale.
• Creare e condividere documenti.
• Identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni.
• Imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a
documentarne sistematicamente l’utilizzo attraverso citazioni
METODOLOGIA DIDATTICA
Approccio comunicativo e funzionale. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si farà costante
ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base siano usate in una
varietà di situazioni adeguate alla realtà dell’allievo. La lettura analitica dei testi sarà finalizzata a
stimolare la capacità di coglierne il significato e la strutturazione.
Accanto alle forme tradizionali della lezione frontale e della lezione partecipata si possono prevedere
forme alternative come l’utilizzo di sussidi audiovisivi oppure di software didattici:
• lezione frontale;
• lettura guidata e autonoma di fonti;
• dibattiti e sintesi;
• Registro Elettronico: Collabora
• GSuite: Classroom, Meet
• Apprendimento cooperativo tramite scrittura ed elaborazione di documenti condivisi, attività di
commento a post ed articoli sulle bacheche delle classi virtuali.
• Videolezioni registrate dai docenti o fornite dal web e dalle case editrici, da fruire in modalità
sincrona o asincrona, corredate di domande, quiz, test o spunti di riflessione.
• Presentazione in videolezione di prodotti degli studenti elaborati in gruppo o individualmente;
colloqui via Meet
• Videolezioni registrate dai docenti o fornite dal web e dalle case editrici, da fruire in modalità
sincrona o asincrona, corredate di domande, quiz, test o spunti di riflessione.
Nel caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata il riferimento è al Regolamento della DDI
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre 2020.
MEZZI
• Libro di testo;Libri di narrativa; Audiovisivi; Computer.
VALUTAZIONE
• La produzione degli allievi sarà valutata considerando la correttezza e la ricchezza di idee espresse,
il lessico utilizzato e la capacità di adattare la lingua al contesto.Puoi anche leggere