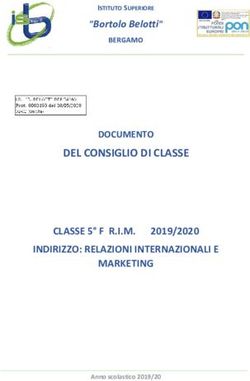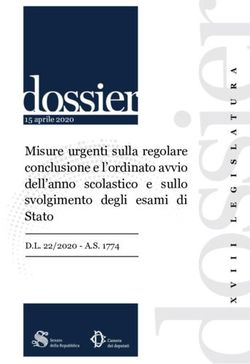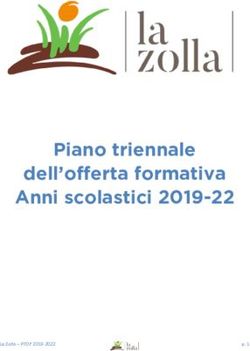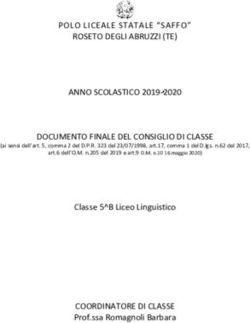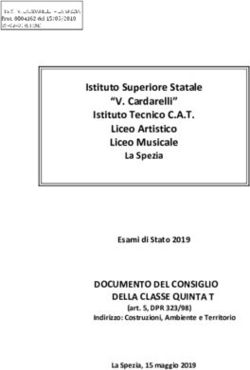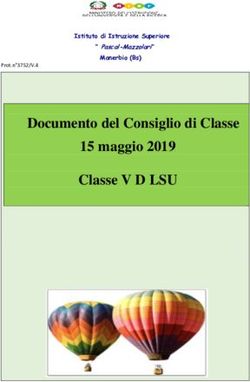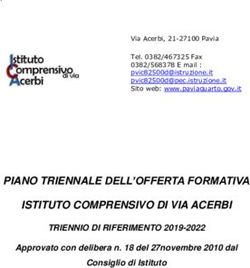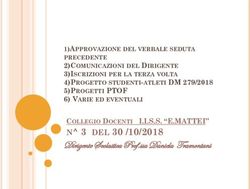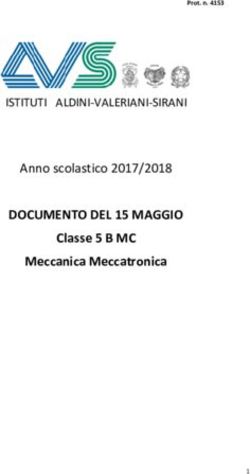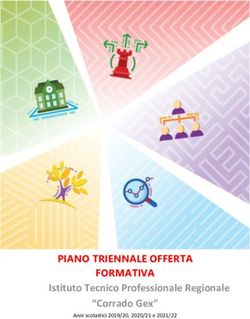Liceo Scientifico Morgagni Documento del Consiglio di Classe 15 maggio 2021 classe 5 sez. L a.s. 2020/2021
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Liceo Scientifico MORGAGNI - C.F. 80208110587 C.M. RMPS24000N - istsc_rmps24000n - Liceo Morgagni Prot. 0005982/U del 24/05/2021 15:49 Liceo Scientifico Morgagni Documento del Consiglio di Classe 15 maggio 2021 classe 5 sez. L a.s. 2020/2021 1
INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RIFERIMENTI NORMATIVI pag. 3 IL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 4 PROFILO DELLA CLASSE pag. 5 TEMPI pag. 6 VERIFICA E VALUTAZIONE pag. 6 EDUCAZIONE CIVICA pag. 7 P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) pag. 8 ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA pag. 9 PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI pag. 9 CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE MATERIE e RELAZIONE pag. 10 FINALE ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI pag. 45 OGGETTO DEL COLLOQUIO TESTI STUDIATI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO pag. 46 OGGETTO DEL COLLOQUIO FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 50 2
RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 3
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE COORDINATORE: Prof.ssa RAFFAELLA LION Continuità didattica Docente Materia insegnata 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO Raffaella Lion Lingua e letteratura italiana X X X Raffaella Lion Lingua e letteratura latina X X X Marco Petrini Storia X X Marco Petrini Filosofia X X Rossella Berto Lingua straniera Inglese X X X Valentina Durante Matematica X X X Alessandro Maccati Fisica X X Loris Leboffe Scienze naturali e chimica X X Antonella Quattrini Disegno e Storia dell’Arte X X Vivian Maria Caforio Scienze motorie X Antonia Ginefra Educazione Civica X Giada Pirrotta I.R.C. X PROFILO DELLA CLASSE 4
Parametri Descrizione Composizione La classe è formata da 25 alunni (14 ragazze e 11 ragazzi): 4 alunni si sono inseriti nella classe all’inizio del quarto anno; 2 alunne, nel corso del quarto anno, hanno trascorso un semestre di studio all’estero. Eventuali situazioni particolari (facendo vd. fascicolo personale attenzione ai dati personali secondo le Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719) Situazione di La classe ha sicuramente compiuto, pur nelle differenze, un percorso partenza di consapevolezza e di maturazione che si è potuto riscontrare nel corso dell’intero triennio. La maggior parte degli alunni, anche se in maniera diversa, è cresciuta nella partecipazione e nell’impegno rispetto al livello di partenza. Alcuni studenti in particolare hanno maturato una buona capacità critica e di rielaborazione personale, frutto di un impegno personale costante e di un interesse consapevole per le singole discipline. Livelli di profitto I livelli di profitto raggiunti sono diversificati in funzione complessivi dell’impegno, della costanza nel lavoro, della motivazione e delle capacità individuali dei singoli studenti. La classe presenta alcuni alunni che hanno raggiunto un profitto ottimo, una fascia intermedia che ha raggiunto risultati discreti, e un altro gruppo di studenti che ha evidenziato difficoltà in qualche disciplina, raggiungendo nel complesso risultati sufficienti. Atteggiamento verso La classe ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti le discipline, impegno del corpo docente, ha sempre dimostrato interesse per le lezioni nello studio e svolte in classe e una buona partecipazione al dialogo educativo. Non partecipazione al sempre però interesse e partecipazione hanno trovato una dialogo educativo corrispondenza nello studio individuale e nell’impegno personale per una piccola componente della classe e questo ha reso il lavoro scolastico non sempre proficuo. TEMPI 5
I tempi della programmazione sono stati articolati in due quadrimestri. Tuttavia, come è noto, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA STUDENTI 14/09/2020 27/10/2020 D.D.I o Didattica in presenza 100% 05/11/2020 17/01/2021 D.A.D. 100% 18/01/2021 14/03/2021 D.D.I. 50% 15/03/2021 6/04/2021 D.A.D. 100% 7/04/2021 25/04/2021 D.D.I. 50% 26/04/2021 8/06/2021 D.D.I o Didattica in presenza 70% VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO Strumenti di misurazione e n. di verifiche - Vedi Programmazione Dipartimenti per periodo scolastico Strumenti di osservazione del Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata comportamento e del processo di dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF apprendimento Credito scolastico Vedi fascicolo studenti La valutazione degli apprendimenti è stata condotta sulla base delle competenze e dei contenuti individuati nelle programmazioni dei Dipartimenti disciplinari e dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti attraverso le griglie di valutazione delle diverse discipline. 6
EDUCAZIONE CIVICA La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre macroaree specifiche: 1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza digitale. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, il Liceo Morgagni propone il seguente curriculo di Educazione Civica: Curriculo di Educazione Civica Titolo Percorso descrizione Periodo L’ordinamento della Repubblica. Gli Dal 10.11.20 al 10.2.21 Democrazia e organi dello Stato previsti dalla Repubblica Parlamentare Costituzione: composizione e funzioni. Le forme di governo e di Stato La giurisdizione civile, penale, Dal 10.2.21 al 22.4.21 amministrativa. Il sistema penale Legalità e Magistratura italiano e il processo penale. La lotta alla criminalità Cenni sulla nascita dell’ U.E. e finalità Unione Europea Dal 22.4.21 al 18.5.21 dell’U.E. La Cittadinanza digitale Cenni sulle dipendenze dalla rete Dal 18.5.21 al 25.5.21 7
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di P.C.T.O. riassunti nella seguente tabella. Per i dettagli si rimanda ai progetti sottostanti e alla certificazione delle competenze nelle schede agli atti. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO Titolo del percorso Ambito Periodo Ore La “scuola fa notizia” Dire giovani umanistico gennaio-marzo 2019 25 linguistico Edupuntozero- Viaggio d’istruzione artistico/in 18-22 marzo 2019 48 formatico “Era notte,la notte dell’Europa” progetto umanistico gennaio -aprile 2021 15/20 Memoria - linguistico 8
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA “informarsi, pensare, Università La 9-10/10/2019 scegliere”. Sapienza: Festival Progetti e del Giornalismo Manifestazioni libero culturali Progetto “Bella la vita se doni Liceo Morgagni 7/3/2021 una vita” Incontri con “ Sistema immunitario e Modalità 18/12/2021 terapie, dal cancro a Covid telematica esperti 19” tenuto dal Prof. Alberto Mantovani- Organizzato da Zanichelli. - Presentazione delle facoltà Modalità 5/02/2021 di Matematica e fisica, telematica Orientamento Economia, Filosofia. Università di Roma Tre - Presentazione delle facoltà Modalità 5/03/2021. di Ingegneria, Medicina, telematica Chirurgia e professioni sanitarie, Giurisprudenza. Università di Tor Vergata - Presentazione delle seguenti Modalità 31/03/2021 Università: NABA, Università telematica cattolica del Sacro Cuore, Università Luiss Guido Carli. PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI Cfr. anche i singoli programmi Titolo del percorso Obiettivi Discipline Periodo coinvolte Chimica e letteratura: analisi di alcuni racconti italiano e scienze gennaio/aprile Il sistema periodico del libro di Primo Levi Il sistema periodico finalizzati all'approfondimento del rapporto scienza-letteratura nella vita e nella scrittura di Primo Levi. 9
CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE DISCIPLINA Italiano DOCENTE Raffaella Lion LIBRO DI TESTO G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria IL PIACERE DEI TESTI, volumi 4,5,6, ed. Paravia DIVINA COMMEDIA :PARADISO CONTENUTI IL ROMANTICISMO IN ITALIA E LA POLEMICA CLASSICO-ROMANTICA MADAME DE STAEL: Sulla maniera e utilità delle traduzioni; G.BERCHET : Dalla LETTERA SEMISERIA DI GRISOSTOMO AL SUO FIGLIOLO: La poesia popolare; G.G.BELLI: da I SONETTI: Er giorno der giudizzio, A.MANZONI: da L’ADELCHI: coro dell’atto III; da LA LETTERA A M. CHAUVET: Storia e invenzione poetica; da L’EPISTOLARIO : La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbono essere”. GIACOMO LEOPARDI Dallo ZIBALDONE: La teoria del piacere; Il vero è brutto. Dai CANTI : L’ultimo canto di Saffo L’infinito; Il sabato del villaggio; Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o fiore del deserto (vv.87- 157; 297 -317) Da LE OPERETTE MORALI : Dialogo di Plotino e Porfirio; Dialogo della Natura e di un Islandese; Il Copernico ; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Cristoforo Colombo e Gutierrez; Dialogo di un folletto e di uno gnomo. LA CULTURA DEL POSITIVISMO LA SCAPIGLIATURA . E .PRAGA : da PENOMBRE Preludio. IL NATURALISMO FRANCESE E. e J. DE GONCOURT: da GERMINIE LACERTEUX Un manifesto del Naturalismo. E.ZOLA.: da L'ASSOMOIR L'alcol inonda Parigi IL VERISMO GIOVANNI VERGA Da VITA DEI CAMPI: Rosso malpelo; Fantasticheria. Da I MALAVOGLIA: I vinti e la fiumana del progresso; aIl mondo arcaico e l'irruzione della storia; I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico: La conclusione del romanzo. Da MASTRO DON GESUALDO La morte di Don Gesualdo. 10
IL RUOLO DEL POETA E LA FUNZIONE DELLA PAROLA NELLA POESIA DEL ‘900 IL DECADENTISMO C. BAUDELAIRE da LO SPLEEN DI PARIGI Perdita d’aureola. da I FIORI DEL MALE L’albatro GIOVANNI PASCOLI Da IL FANCIULLINO: Una poetica decadente. Da MYRICAE: L’assiuolo; Temporale; Il lampo. GABRIELE D’ANNUNZIO Da ALCYONE: La pioggia nel pineto. IL FUTURISMO F.T. MARINETTI: Manifesto tecnico della letteratura futurista A. PALAZZESCHI: da L’INCENDIARIO E lasciatemi divertire. IL CREPUSCOLARISMO G.GOZZANO : da COLLOQUI Totò Merumeni. VOCI DEL ‘900 G.UNGARETTI: da ALLEGRIA Veglia, Il porto sepolto, Commiato, Fratelli; Soldati. E. MONTALE: da OSSI DI SEPPIA I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. S. QUASIMODO: da ACQUA E TERRE Ed è subito sera G. CAPRONI: da IL MURO DELLA TERRA Anch’io A.MERINI: da LA TERRA SANTA Il dottore agguerrito nella notte. IL ROMANZO DEL’900 : DALL’ESTETA ALL’INETTO G. D’ANNUNZIO : da IL PIACERE Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. I romanzi del superuomo: caratteri generali LUIGI PIRANDELLO Da L’UMORISMO: Un'arte che scompone il reale. Da IL FU MATTIA PASCAL : Premessa; Premessa seconda( filosofica) a mo’ di scusa; Cambio treno; Un po’ di nebbia; L’occhio e Papiano; Il lanternino; Adriano Meis; Il fu Mattia Pascal. Da UNO, NESSUNO, CENTOMILA: "Nessun nome 11
ITALO SVEVO UNA VITA e SENILITA’ : la figura dell’inetto (caratteri generali) Da LA COSCIENZA DI ZENO: Il fumo; La morte del padre. IL NEOREALISMO: LA SCRITTURA DELL’IMPEGNO I.CALVINO. LA GIORNATA DI UNO SCRUTATORE (lettura integrale) P.LEVI . Da IL SISTEMA PERIODICO : Argon, Ferro, Fosforo, Zolfo, , Carbonio PIRANDELLO E IL TEATRO Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. Da COSI’ E’ SE VI PARE: Atto I, scena II I GIGANTI DELLA MONTAGNA: il teatro dei miti e ia riflessione finale sul valore dell’arte. DANTE ALIGHIERI : IL PARADISO: L’ineffabile : canto 1 La beatitudine: canto 3 Impero e Chiesa: canti 6 e 11 La missione del poeta: canto 17 La visione di Dio: canto 33. DISCIPLINA Latino DOCENTE Raffaella Lion LIBRO DI TESTO G. Garbarino LUMINIS ORAE, Paravia vol.3 CONTENUTI LA PRIMA ETA’ IMPERIALE DA TIBERIO AI FLAVI (14-96 d.C.) SENECA Il valore del tempo Da DE BREVITATE VITAE: E’ davvero breve il tempo della vita ? 1;2,1-4 latino Dalla EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM: Solo il tempo ci appartiene,1 italiano Il rapporto con il potere tra otium e negotium Da L'APOKOLOKYNTOSIS: Morte e ascesa al cielo di Claudio, italiano 12
Dal DE CLEMENTIA: la clemenza ,italiano Dal DE TRANQUILLITATE ANIMI: la partecipazione politica: resistere o cedere le armi? Italiano Dal DE OTIO: Il filosofo giova all'umanità, italiano Il sapiente e gli altri uomini Dalle EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM 47,1-4 Uno sguardo nuovo sulla schiavitù, latino LUCANO Dal BELLUM CIVILE: L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini romani, italiano I ritratti di Pompeo e Cesare, italiano Una scena di negromanzia, italiano. PETRONIO Dal SATYRICON: L'ingresso di Trimalchione, italiano; Presentazione dei padroni di casa 37,I latino Chiacchere di commensali, italiano Da schiavo a ricco imprenditore ,italiano QUINTILIANO Dall’INSTITUTIO ORATORIA: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore, italiano I vantaggi dell'insegnamento collettivo, italiano L'intervallo e il gioco, italiano Le punizioni, italiano Il maestro come secondo padre II,2,4-8, latino. MARZIALE Dagli EPIGRAMMATA: La scelta dell'epigramma, italiano Matrimonio d'interesse I,10,latino Fabulla ,VIII,79,latino 13
La bellezza di Bilbili, italiano Erotion,italiano. Plinio il Vecchio Da LA NATURALIS HISTORIA : Un esempio di geografia favolosa : mirabilia dall’India, italiano DA NERVA AL TARDO IMPERO (96-192 d.C) GIOVENALE Dalle SATIRE: Perché scrivere satire?, italiano Un singolare consilium principis, italiano L’invettiva contro le donne, italiano. PLINIO IL GIOVANE Dalle EPISTOLE: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio, italiano TACITO Da L’AGRICOLA: Un’epoca senza virtù, italiano Dalla GERMANIA: Caratteri fisici e morali dei Germani 4,latino Dagli ANNALES: Scene da un matricidio: il tentativo fallito, italiano L’incendio di Roma ,italiano La persecuzione contro i cristiani, italiano APULEIO Dalle METAMORFOSI: Il proemio e l’inizio del racconto, italiano; Lucio diventa asino, italiano; Psiche fanciulla bellissima e fiabesca, italiano; La trasgressione di Psiche, italiano. 14
Relazione finale di Italiano e Latino L’insegnamento di queste due discipline ha avuto degli obiettivi didattici comuni: partendo dallo studio degli autori e delle loro opere, guidare gli alunni a comprendere la complessità del reale, a interrogarsi sulle problematiche dell’esistere di tutti i tempi , a saper andare oltre l’analisi della superficie per scendere in profondità e cogliere il vero significato delle cose. La metodologia didattica applicata per raggiungere questi obiettivi è stata, per entrambe le discipline, partire dal contesto storico e socio-culturale nel quale un autore ha vissuto e operato . Non si comprendono l’autore e la sua opera se non ci si interroga su cosa l’autore con quell’opera ha voluto esprimere in rapporto con la realtà sociale e culturale del suo tempo. Fondamentale per la mia didattica, è stato poi il lavoro sui testi: gli alunni sono stati guidati nella lettura e nell’analisi testuale. E’ stato loro chiesto di saper analizzare e comprendere il testo, di saper cogliere le peculiarità stilistiche del singolo autore in relazione con la corrente letteraria nella quale l’opera s’inserisce, di operare una rielaborazione personale e critica del testo con la guida dell’insegnante. Strumento fondamentale è stato poi nella pratica della scrittura, accanto all’analisi del testo, l’uso della tipologia del testo argomentativo, per mettere a punto quanto studiato e approfondito. Nella pratica della scrittura mi sono inoltre servita della nuova metodologia didattica del debate : proporre agli alunni un topic legato ad argomenti letterari, mi ha permesso di valutare la loro capacità di sostenere una tesi, come avviene nell’ambito del dibattito, e di supportare con opportuni riferimenti testuali la tesi sostenuta. E’ stato un anno particolare: l’alternanza di DAD, DDI e Didattica in presenza (nell’ultimo mese dell’anno), non hanno certo favorito l’attività scolastica. A fronte di ciò devo riconoscere che la classe ha risposto sempre in maniera positiva alle mie sollecitazioni. Le lezioni sono sempre state seguite e partecipate. I momenti di condivisione di lavori di gruppo e di approfondimento svolti dagli alunni , sono serviti in parte ad attenuare le difficoltà che la didattica davanti a uno schermo comporta. Ogni alunno con le sue capacità si è messo alla prova e ha raggiunto i propri personali risultati. 15
CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE DISCIPLINA Filosofia DOCENTE Marco Petrini LIBRO DI TESTO Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, volumi 3A + 3B, Paravia. CONTENUTI Immanuel Kant e il criticismo come riflessione liminare La biografia e le opere. La nozione di criticismo. Il legame tra esperienza e conoscenza. La classificazione dei giudizi. I temi affrontati nella Critica della ragion pura. La distinzione tra fenomeno e noumeno e le nozioni di per sé e in sé nella prima Critica. La rivoluzione copernicana della conoscenza. La sensibilità e il ruolo dello spazio e del tempo. L’intelletto e la funzione delle categorie. La deduzione delle categorie e il carattere preliminare dell’Io penso. I temi della Critica della ragion pratica. La distinzione tra ragion pratica empirica e ragion pratica pura. L’imperativo ipotetico e il compromesso tra ragione e sensibilità. Le formule dell’imperativo categorico. Il formalismo dell’etica kantiana e i postulati della ragion pratica. La contraddizione tra il determinismo della prima Critica e la libertà teorizzata dalla seconda. Lo svuotamento di significato del criticismo kantiano Cenni sulla vita e sulle opere di Johann Gottlieb Fichte. 16
Dal dibattito sul noumeno al rifiuto della cosa in sé: la trasformazione del criticismo in idealismo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel ed il trionfo dell’idealismo La biografia e gli scritti. Le tesi fondamentali dell’idealismo hegeliano. Il carattere infinito dell’ente finito. La razionalità della realtà: la nozione di aufhebung. La distinzione tra pensiero tetico, antitetico e sintetico: il significato della dialettica. La nozione di Spirito. Karl Marx: l’analisi scientifica della società industriale e l’urgenza rivoluzionaria Cenni sulla vita e sulle opere. La concezione della filosofia come prassi rivoluzionaria. L'analisi del fenomeno religioso condotta da Feuerbach . Le critiche nei confronti di Hegel e Feuerbach. L’ideologia tedesca: il concetto marxiano del lavoro. Le nozioni di struttura e sovrastruttura. La religione come oppio dei popoli. Alla radice di ogni processo rivoluzionario: la dialettica tra le forze produttive e i rapporti di produzione e il concetto di classe sociale. La concezione materialistica della storia. Il sistema economico capitalistico e la contraddizione presente al suo interno. La transizione verso la società senza classi: dalla dittatura del proletariato all'uomo onnilaterale. Lo scientismo positivista di Auguste Comte L’esaltazione della scienza e la fede nel progresso: la legge dei tre stadi. Un maestro del sospetto: Friedrich Nietzsche 17
La vita e gli scritti. Le caratteristiche della scrittura nietzscheana. Il ruolo di Elisabeth Nietzsche. La crisi del soggetto. Lo spirito apollineo e quello dionisiaco. Le menzogne millenarie riguardanti l’esistenza dell’io e quella dei fatti. L’annuncio della morte di Dio e il superuomo . * La volontà di potenza. * Sigmund Freud e la scoperta di un nuovo linguaggio La tecnica delle associazioni libere. * L’analisi della personalità umana: Es, Io e Superio. * DISCIPLINA Storia DOCENTE Marco Petrini LIBRO DI TESTO Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Lo spazio del tempo, volume 3, Editori Laterza. CONTENUTI La miopia del nuovo ordine viennese L'alleanza trono-altare. Le caratteristiche degli Stati italiani dopo la conclusione del Congresso di Vienna. La nazione come necessità o come possibilità. L'opposizione clandestina: le società segrete. I primi fermenti: i moti del 1820-21. I moti del 1830-31: l'Europa in bilico tra liberalesimo, conservazione e reazione. Le principali correnti risorgimentali italiane. La prima guerra di indipendenza. Cenni sulla repubblica romana del 1849. La strategia diplomatica di Cavour: gli accordi di Plombières. 18
Dalla seconda guerra di indipendenza ai plebisciti del 1860. La spedizione dei Mille e la nascita del Regno d'Italia. Le caratteristiche dello Stato unitario italiano. L’evoluzione del Regno d’Italia La natura della Destra e della Sinistra storica. La radicalizzazione della questione cattolica: dalla legge delle guarentigie (1871) al Non expedit (1874). La nascita della Triplice Alleanza. La questione dell’articolo 7. La nascita del II Reich La trasformazione dell’Impero austriaco in Impero austro-ungarico (1867). La guerra franco-tedesca del 1870-71 e la proclamazione del II Reich. Dalla crisi di fine secolo all’avvio del processo di democratizzazione in Italia La crisi di fine secolo: dal movimento dei Fasci siciliani all’assassinio di Umberto I. La nascita dei primi partiti socialisti: la frattura tra minimalisti e massimalisti. Giolitti e Crispi: le due diverse letture della radicalizzazione dello scontro sociale in Italia. L’inizio del processo di democratizzazione: analisi del discorso giolittiano del 4 febbraio 1901. La distinzione tra Paese legale e Paese reale. Il dialogo giolittiano con l’ala minimalistica del PSI turatiano, il suffragio universale maschile e il superamento del Non expedit. La politica estera giolittiana e la guerra italo-turca (1911-1912). I fragili equilibri internazionali dal 1871 all’inizio del ’900 La Questione d’Oriente e i suoi numerosi risvolti. Cenni sulla politica estera di Bismarck: lo scudo contro il revanscismo francese e gli accordi con gli Asburgo e i Romanov. La Weltpolitik di Guglielmo II e la Duplice Intesa franco-russa (1894). Le ragioni della guerra cino-giapponese (1894-1895). Gli accordi italo-francesi del 1901 e la reazione tedesca del 1902. 19
L’Intesa Cordiale tra Londra e Parigi (1904). Cenni sulla guerra russo-giapponese (1904-1905). La prima crisi marocchina (1905-1906). L'accordo di San Pietroburgo e la nascita della Triplice Intesa (1907). L’annessione della Bosnia Erzegovina da parte dell’impero austro-ungarico (1908). La seconda crisi marocchina (1911). La tragedia della Grande Guerra Lo scoppio della prima guerra mondiale e le ragioni della neutralità italiana. Le caratteristiche della Grande Guerra. Una veloce panoramica sui fronti. La firma del patto di Londra e l’intervento italiano nel conflitto. Il 1916: gli accordi Sykes-Picot e l’apertura del fronte mediorientale. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e la disfatta italiana di Caporetto. La Dichiarazione Balfour del 1917 e le radici della questione israelo-palestinese. I Quattordici Punti di Wilson: le linee guida del dopoguerra. La fine delle operazioni militari e la dissoluzione degli Imperi centrali. La Conferenza di Parigi: il trattato di Versailles e quello di Saint-Germain. La questione di Fiume. La creazione della Società delle Nazioni: le ragioni della sua debolezza. Dal crollo dell’Impero zarista alla nascita dell’URSS Le caratteristiche dell’impero russo alla fine del XIX secolo. Una panoramica sui partiti esistenti in Russia al principio del ’900. La rivoluzione di febbraio: dal rovesciamento di Nicola II alla diarchia rappresentata dal soviet di Pietrogrado e dal governo provvisorio. Dal rientro di Lenin in Russia alla rivoluzione di ottobre. Dallo scioglimento dell’assemblea costituente allo svuotamento di significato dei soviet. La nozione di totalitarismo. Cenni sulla guerra civile tra armate bianche e armata rossa. 20
La nascita del partito comunista russo e la frattura tra socialisti e comunisti. Dalle tensioni del dopoguerra alla presa del potere di Mussolini. La composizione della società italiana all'inizio del primo dopoguerra. La distanza tra alcuni settori della società italiana e i governi del 1919-1922. Le novità politiche del 1919. La costituzione dei Fasci Italiani di Combattimento e il programma di San Sepolcro. La vicenda dell’occupazione delle fabbriche del nord: la sconfitta dell’ipotesi rivoluzionaria e la crescita dei consensi intorno al fascismo. La nascita del partito comunista italiano. L’ingresso dei primi fascisti in parlamento (maggio 1921). La marcia su Roma e le ragioni dell’avvento al potere di Mussolini. L’Italia fascista L’inizio dello smantellamento dello stato liberale italiano: dalla legge Acerbo al delitto Matteotti. Dalla svolta del 3 gennaio 1925 alla costruzione dello stato totalitario: le leggi fascistissime. La politica estera di Mussolini. * Le leggi razziali. * Democrazie e totalitarismi Cenni sulla repubblica di Weimar: le ragioni della sua fragilità. * L’avvento al potere del Führer e la costituzione del III Reich. * Il crollo dell’Europa di Versailles Il fallimento della politica dell’appeasement. * Dal patto d’acciaio a quello di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica. * La seconda guerra mondiale Una veloce panoramica sui fronti. * Dal crollo del fascismo alla Liberazione. * 21
Relazione finale di Filosofia e Storia Una panoramica della classe La V L è una classe composta da 25 alunni (11 maschi e 14 femmine), che lo scorso anno ha cambiato il docente di Filosofia e Storia. L’arrivo di un nuovo insegnante è stato tuttavia metabolizzato dagli studenti che, dimostrando una buona duttilità, si sono adattati a richieste e metodologie fatalmente differenti. Sul piano disciplinare non si sono registrati problemi di alcun tipo e le lezioni si sono svolte in entrambe le discipline in un clima sereno. Filosofia L'innegabile diversità della filosofia e il carattere preliminare delle sue domande hanno suscitato la curiosità di una parte non trascurabile della classe, spingendola ad interagire con il docente. Le lezioni, seguite con scrupolo da tutti gli studenti, sono state ora frontali ora partecipate. Un notevole spazio è stato dedicato alla chiarificazione dei termini fondamentali del vocabolario dei pensatori presi in esame. Le verifiche sono state orali e scritte. Le condizioni eccezionali nelle quali si è svolto l'intero anno scolastico hanno profondamente influito non solo sullo svolgimento del programma, ma anche sul consolidamento di un approccio non meccanico alla disciplina. Il ricorso alla DAD, da un lato, ha impoverito l'insegnamento, condannando la didattica ad essere emergenziale, e, dall'altro, ha reso impossibile un’autentica ripresa della lenta ma graduale crescita, che la classe aveva intrapreso nel corso del quarto anno e che si era bruscamente interrotta dopo la chiusura dell'Istituto decretata il 04/03/2020. Con la cautela dettata da verifiche che si sono svolte in presenza solo negli ultimi due mesi, i risultati conseguiti dalla classe sono stati complessivamente positivi. Storia Allo svolgimento del programma di Storia è stata dedicata, pur nelle condizioni nelle quali si sono svolte le lezioni, un’attenzione meticolosa. Il docente, attraverso una didattica prevalentemente frontale, ha ricostruito i fatti, cercando di intrecciare il passato con il presente. Gli studenti hanno mostrato una sufficiente dose di curiosità nei confronti della disciplina . Sul versante dei contenuti la scelta è stata quella di privilegiare la qualità, rinunciando fin dall'inizio al tentativo di imporre carichi di lavoro che la classe non sarebbe stata in grado di sostenere non solo perché provata dalla pandemia e dalla didattica a distanza, ma anche perché complessivamente poco autonoma nello studio. Alcuni temi sono stati trattati in modo articolato e una particolare cura è stata posta nella chiarificazione dei termini del vocabolario storiografico. Le verifiche sono state orali e scritte. Fatalmente le condizioni eccezionali nelle quali si è svolto l'intero anno scolastico hanno influito sulla didattica. A rallentare lo svolgimento del programma hanno contribuito, tuttavia, anche altri fattori: in primo luogo, la scelta dell’insegnante di ricostruire in modo articolato le vicende risorgimentali; in secondo luogo, la necessità di guidare gli studenti nella comprensione dei meccanismi della politica, procedendo, dove necessario, con studiata lentezza. Inevitabilmente alcuni temi, nella parte finale dell’anno, sono stati affrontati in modo sommario. Come è doveroso che sia, il docente si assume l’intera responsabilità di tutte le scelte compiute. Con la cautela dettata da verifiche che si sono svolte in presenza solo negli ultimi due mesi, i risultati conseguiti dalla classe sono stati complessivamente positivi. 22
CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE DISCIPLINA Lingua straniera Inglese DOCENTE Rossella Berto LIBRO DI TESTO M.Spiazzi-M.Tavella “Performer Heritage” Vol.1 and 2 Ed.Zanichelli CONTENUTI Dal libro di testo “Performer Heritage” Vol.1 Ed.Zanichelli sono stati svolti i seguenti argomenti: George Gordon Byron:life and works.The Byronic hero. “Childe Harold’s Pilgrimage”. “Harold’s journey” Canto III. John Keats: life and works.Keats’s poetry and theory of Imagination.The theme of “beauty”. “Ode on a Grecian Urn”.(Text analysis) Dal libro di testo “Performer Heritage” Vol.2 Ed.Zanichelli sono stati svolti i seguenti argomenti: Victorian Age:historical-social and literary context.The dawn of the Victorian Age. The Victorian Compromise.Life in Victorian Britain.Early Victorian Thinkers. The later years of Queen Victoria’s reign.The Late Victorians, the spread of socialist ideas and Patriotism. The Victorian Novel: setting-characters-narrative technique-types of novels-women writers. Pre-Raphaelite Brotherhood-Aestheticism and Decadence-The European Decadent Movement. The figure of the “dandy”. Charles Dickens: life and works-characters-style and reputation. “Oliver Twist”: plot-setting-characters-the world of “workhouses”.Text analysis of the excerpts “The workhouse” and “Oliver wants some more”. 23
“Hard Times”: plot-characters-setting-structure-a critique of Materialism and Utilitarianism.Text analysis of the excerpts “Mr Gradgrind” and “Coketown” till line 35 included. Across Cultures “Work and alienation”. The Bronte Sisters: Charlotte and Emily Bronte: life and works. Charlotte Bronte: “Jane Eyre”: plot-setting-characters-themes- a woman’s standpoint. Text analysis of “Women feel just as men feel” and “Jane and Rochester”. Emily Bronte:”Wuthering Heights”: plot-setting-characters-structure and style-themes-the wilderness as homeland. “Catherine’s ghost”: (Text analysis);”I am Heathcliff”(Text analysis); “Heathcliff’s despair” (Text analysis). Oscar Wilde: life and works.The “rebel” and the “dandy”. “Art for art’s sake”. “The Picture of Dorian Gray”: plot-setting-characters-narrative technique-allegorical meaning. “The Preface”. Victorian Drama: “The Importance of Being Earnest”: a “Comedy of Manners”: plot-setting- characters-themes-irony and appearance. “The Interview” (Text analysis). The Modern Age:historical-social and literary context. Edwardian England:The “Suffragettes”. Britain and the First World War. The “Easter Rising” in England. “The Age of Anxiety”: the crisis of certainties-Freud’s influence-the collective unconscious- the theory of relativity-a new concept of “Time” by Henri Bergson. Modernism: the Advent of Modernism-main features of Modernism. Modern Poetry: the “Georgian” poetry, the “War” Poets, Imagism and Symbolism. The Modern Novel: the new role of the novelist-new narrative techniques-the “Stream of consciousness” technique di W.James-a different use of “Time”. Three groups of poets. “The War Poets”: Rupert Brooke: life and works.Text analysis of the sonnet “The Soldier”. 24
Wilfred Owen: life and works. Text analysis of the poem”Dulce et Decorum est….” James Joyce: life and works: Zurich-Paris-Zurich-ordinary Dublin-a subjective perception of “Time”- the rebellion against the Church-style. “Dubliners”: structure-setting-characters-realism and symbolism-the use of “epiphany”- style-the themes of “paralysis”,”failure”, “escape”. “Eveline” (Text analysis). “The Dead”-”Gabriel’s epiphany” (Text analysis). “Ulysses”: plot-setting-characters-the relation to the Odyssey-themes-style.(Photocopies Text Bank 99 from Performer Heritage Vol.2). “Molly’s monologue”: “Yes I said Yes, I will Yes” (Photocopy from “Only Connect……...New Directions Vol.2). George Orwell:life and works-first-hand experiences-the artist’s development-social themes. “Animal Farm”: historical context-plot-characters-animals-themes-(Photocopies taken from the Text Bank 106 of Performer Heritage Vol.2) “Old Major’s speech” (Text analysis-Photocopies). Durante l’anno scolastico tutti gli alunni hanno letto il romanzo “The Picture of Dorian Gray” di O.Wilde. Relazione finale di Lingua straniera Inglese La classe, nel corso di questi cinque anni, ha lavorato con discreto impegno e assiduità conseguendo, nel complesso, risultati quasi buoni. Il rapporto con l’insegnante è stato sempre corretto ed educato sia in presenza che in DAD. Nel gruppo classe si distinguono alcuni alunni che grazie ad una buona conoscenza della lingua e padronanza lessicale, nonché capacità di rielaborare in modo personale ed uno studio assiduo e costante, hanno ottenuto risultati più che discreti e buoni. Altri studenti invece hanno raggiunto risultati meno brillanti a causa di un impegno discontinuo e di carenze di base che non sono riusciti a recuperare. E’ presente inoltre un gruppo di pochi alunni che hanno conseguito un profitto mediocre e non del tutto sufficiente a causa di un impegno poco continuo e costante e di pregresse difficoltà non superate sia nella produzione orale che scritta. Il programma è stato svolto affrontando il discorso letterario sempre partendo dal contesto storico-sociale e letterario di ogni autore, di cui si sono analizzati i testi principali, per avviare gli studenti alla conoscenza delle singole tematiche trattate e ad una produzione e rielaborazione autonoma di quanto appreso. 25
CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE DISCIPLINA Matematica DOCENTE Valentina Durante LIBRO DI TESTO M. BERGAMINI, A. TRIFONE, G. BAROZZI – MATEMATICA.BLU 2.0 VOL. 5 – ZANICHELLI CONTENUTI Funzioni reali di una variabile reale. Le funzioni reali di variabile reale Funzioni elementari: le funzioni razionali (i polinomi, le funzioni razionali fratte) le funzioni algebriche irrazionali le funzioni trascendenti (la logaritmica, l’esponenziale, le goniometriche) Dominio, intersezioni con gli assi, segno di una funzione Esercizi I Limiti Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito Limite sinistro e limite destro Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) teorema del confronto (con dimostrazione) teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) Le funzioni continue e il calcolo dei Limiti Le funzioni continue Operazioni sui limiti: il limite della somma lim [ ( ) + ( )] (con dimostrazione) → 0 il limite della prodotto lim [ ( ) × ( )] (senza dimostrazione) → 0 il limite del prodotto di un numero reale per una funzione lim [ ∗ ( )] → 0 (con dimostrazione) il limite di una combinazione lineare di funzioni lim [ ( ) + ( )] (senza → 0 dimostrazione) il limite di una funzione elevata a un esponente naturale lim [ ( )] (senza → 0 dimostrazione) 1 il limite della funzione reciproca lim (senza dimostrazione) → 0 ( ) ( ) il limite del rapporto di due funzioni lim (senza dimostrazione) → 0 ( ) 26
il limite del valore assoluto di una funzione lim | ( )| (senza dimostrazione) → 0 il limite del logaritmo di una funzione lim log ( ) (senza dimostrazione) → 0 il limite di un numero reale elevato a una funzione lim ( ) (senza → 0 dimostrazione) il limite di una funzione elevata a un esponente reale lim [ ( )] (senza → 0 dimostrazione) il limite di una funzione elevata a un’altra funzione lim [ ( )] ( ) ] (senza → 0 dimostrazione) Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate Limiti notevoli sin lim = 1 (con dimostrazione) →0 1 lim ( 1 + ) = (senza dimostrazione) →0 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto Gli asintoti e la loro ricerca: asintoti verticali asintoti orizzontali asintoti obliqui (senza dimostrazione) I teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie (esempi) discontinuità di seconda specie (esempi) discontinuità di terza specie (esempi) Esercizi La derivata di una funzione Definizione di derivata e suo significato geometrico significato geometrico del rapporto incrementale significato geometrico di derivata Derivata destra e derivata sinistra Continuità delle funzioni derivabili (teorema sulla continuità delle funzioni derivabili con dimostrazione) Le derivate fondamentali e le regole di derivazione: derivata di una costante (con dimostrazione) derivata della funzione identità y = x (con dimostrazione) derivata della funzione identità y = x2 (con dimostrazione) derivata della funzione y sin x (con dimostrazione) derivata della funzione y cos x (con dimostrazione) derivata della funzione logaritmica y ln x (dimostrazione facoltativa) e y loga x (senza dimostrazione) derivata della funzione esponenziale y ex (dimostrazione facoltativa) e y ax (senza dimostrazione) 27
derivata del prodotto di una funzione per una costante (con dimostrazione) derivata della somma di funzioni (con dimostrazione) derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione) derivata della potenza di una funzione (senza dimostrazione) derivata del reciproco di una funzione (senza dimostrazione) derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione) derivata della funzione composta (senza dimostrazione) derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) regole di derivazione del formulario (a memoria) Le derivate di ordine superiore al primo I punti di non derivabilità La retta tangente al grafico di una funzione Esercizi Teoremi fondamentali del calcolo differenziale Teorema di Rolle (con dimostrazione) Teorema di Cauchy (con dimostrazione) Teorema di Lagrange (con dimostrazione) Teorema sulla crescenza/decrescenza delle funzioni in relazione al segno della derivata prima (senza dimostrazione) Forme indeterminate Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) Esercizi Massimi e minimi assoluti Massimi e minimi assoluti Massimi e minimi relativi La concavità I flessi La ricerca i massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima La ricerca dei flessi a tangente obliqua con lo studio del segno della derivata seconda La ricerca di massimi, minimi e flessi con lo studio del segno delle derivate successive Problemi di massimo e minimo assoluto Esercizi Lo studio delle funzioni Studio del grafico di una funzione: funzioni razionali intere e fratte funzioni algebriche irrazionali funzioni goniometriche funzioni esponenziali funzioni logaritmiche Esercizi Gli integrali indefiniti L’integrale indefinito e sue proprietà Integrali indefiniti immediati Integrazione per sostituzione Integrazione per parti Integrazione delle funzioni razionali Esercizi Gli integrali definiti e le loro applicazioni (*) L’integrale definito e le sue proprietà 28
Teorema della media (con dimostrazione) La funzione integrale: Teorema di Torricelli e Barrow (con dimostrazione) Il calcolo delle aree (senza dimostrazione) Esercizi Relazione finale di Matematica La classe, nel complesso, ha raggiunto una preparazione adeguata in matematica. Appare eterogenea per interesse e apprendimenti. Vi sono alcuni elementi di spicco, che hanno dimostrato una grande crescita sia a livello personale sia a livello didattico. Vi sono altresì alcuni alunni che hanno avuto un percorso più discontinuo e hanno faticato molto a tenere il passo in questi anni. Questo ultimo anno scolastico, costellato di troppe incertezze e quasi privo di relazioni umane reali, si è rivelato molto stressante e faticoso per la quasi totalità degli alunni e delle alunne. 29
CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE DISCIPLINA Fisica DOCENTE Alessandro Maccati LIBRO DI TESTO U.Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, voll.2-3, Zanichelli, Bologna 20162 CONTENUTI Fenomeni magnetici fondamentali La forza magnetica e le linee del campo magnetico Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e Faraday Forze tra correnti: la legge di Ampère Intensità del campo magnetico Campo magnetico di: un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart), una spira e un solenoide Motore elettrico: spira percorsa da corrente in un campo magnetico e momento magnetico Campo magnetico Forza magnetica su una carica in movimento: la forza di Lorentz Moto di una carica in un campo magnetico uniforme Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère Proprietà magnetiche dei materiali e corrente di magnetizzazione: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche, magnetizzazione permanente e elettrocalamita Induzione elettromagnetica Corrente indotta e variazione del flusso del campo magnetico Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz Autoinduzione: induttanza e circuito RL 30
Energia e densità di energia del campo magnetico Alternatore: forza elettromotrice alternata, corrente alternata e valori efficaci Trasformatore: trasformazione delle tensioni e delle correnti Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche Forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto Campo magnetico indotto: corrente di spostamento e legge di Ampère-Maxwell Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico: caso statico e dinamico Onde elettromagnetiche e luce Onde elettromagnetiche piane: caratteristiche, densità di energia e irradiamento Spettro elettromagnetico Relatività ristretta Velocità della luce e sistemi di riferimento inerziali Il problema dell’etere e l’esperimento di Michelson-Morley Gli assiomi della relatività ristretta: relatività della simultaneità Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze: tempo proprio e lunghezza propria Esempi notevoli: paradosso dei gemelli e viaggio dei muoni Trasformazioni di Lorentz e composizione relativistica delle velocità Effetto Doppler relativistico e redshift Spazio-tempo quadridimensionale e diagramma di Minkowski Intervallo invariante e classificazione (tipo tempo, spazio e luce): il cono luce Dinamica relativistica: le equazioni del moto Relazione tra energia totale, cinetica e di massa per una particella libera Conservazione dell’energia e della quantità di moto L’invariante relativistico energia-quantità di moto 31
Esistenza di particelle di massa nulla Teoria dei quanti Il problema del corpo nero e l’ipotesi di Planck L’effetto fotoelettrico e l’ipotesi di Einstein L’effetto Compton e la realtà dei fotoni Dualità onda-particella della luce Il quanto d’azione nella materia: le ipotesi di Bohr nel modello di atomo d’idrogeno Il modello di Bohr giustifica lo spettro dell’atomo d’idrogeno Esperimento di Franck e Hertz e la quantizzazione dell’energia Ipotesi di de Broglie: la lunghezza d’onda dell’elettrone Esperimento di Davisson e Germer: la diffrazione degli elettroni Dualità onda-particella della materia Principio d’indeterminazione di Heisenberg: prima e seconda forma Meccanica ondulatoria: l’equazione di Schrödinger e l’interpretazione fisica della funzione d’onda Relazione finale di Fisica L’ingresso di un nuovo docente a partire dalla classe quarta ha provocato negli studenti una rimodulazione degli equilibri acquisiti: differente il metodo e le richieste. Si è tentato di abituare gli studenti a una trattazione rigorosa degli argomenti proposti sollecitandoli a un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e a una corretta esplicazione delle leggi studiate mediante un linguaggio specifico appropriato. La classe ha generalmente reagito con prontezza mostrando in media un discreto interesse per la materia e intervenendo, talvolta attivamente, alle discussioni emerse nel corso delle lezioni. La lezione, sia frontale che partecipata, è stata organizzata in modo da alternare alla spiegazione teorica il momento applicativo favorendo la partecipazione degli alunni al dialogo educativo al fine di consentire una rapida verifica dell’apprendimento delle conoscenze proposte e di facilitare l’interiorizzazione delle leggi studiate. Le verifiche sono state sia orali che scritte con risultati complessivamente positivi. Tuttavia alcuni studenti, anche a causa di lacune di base mai completamente sanate, hanno mostrato difficoltà, in prevalenza nelle prove scritte, laddove gli esercizi richiedessero un uso articolato delle conoscenze apprese attestandosi su valutazioni spesso poco soddisfacenti. La maggior parte della classe ha comunque manifestato volontà di impegnarsi anche nello studio personale per migliorare il rendimento scolastico, intraprendendo così un apprezzabile percorso di crescita culturale. 32
CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONE FINALE DISCIPLINA Scienze DOCENTE Loris Leboffe LIBRO DI TESTO D. Sadava, D. Hillis, V. Posca “Il carbonio, gli enzimi , il DNA Chimica organica, biochimica e biotecnologie” Zanichelli. E. Lupia Palmieri M. Parotto "Fondamenti - tettonica delle placche, interazioni fra geosfere" Zanichelli CONTENUTI CAP.C 1 CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME. I composti del carbonio- I composti organici; le caratteristiche dell’atomo di carbonio; le formule dei composti organici. L’isomeria- Definizione di isomeri. Gli isomeri di struttura: isomeri di catena, di posizione, di gruppo funzionale; gli stereoisomeri: gli isomeri conformazionali, gli isomeri configurazionali. Gli isomeri geometrici, gli enantiomeri e la chiralità l’attività ottica delle molecole. Le caratteristiche dei composti organici- Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari. La reattività dei composti organici: i gruppi funzionali, l’effetto induttivo, le reazioni omolitiche ed eterolitiche, i reagenti elettrofili e nucleofili. CAP. C 2 CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI Gli alcani- Gli idrocarburi: definizione e classificazione. Gli alcani e l’ibridazione del carbonio. La formula molecolare e la nomenclatura. L’isomeria di catena e conformazionale. Le proprietà fisiche. Le reazioni chimiche: reazione di combustione e di alogenazione I cicloalcani- La formula molecolare e la nomenclatura. Gli isomeri di posizione e gli isomeri geometrici. Le proprietà fisiche. Le conformazioni a sedia e a barca. Le reazioni chimiche: reazione di combustione, alogenazione, addizione Gli alcheni- Ibridazione del carbonio degli alcheni. La formula molecolare e la nomenclatura. L’isomeria: di posizione, di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Le reazioni chimiche: reazione di addizione elettrofila e la regola di Markovnikov , reazione di idrogenazione , reazione di polimerizzazione. Gli alchini- Ibridazione del carbonio degli alchini. La formula molecolare e la nomenclatura. L’isomeria: di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni chimiche: reazione di addizione elettrofila, reazione di idrogenazione. 33
Gli idrocarburi aromatici- Il benzene. L’ibridazione del benzene . La reazione di sostituzione elettrofila . La reattività del benzene monosostituito e l’orientazione del secondo sostituente. Ruolo biologico dei composti aromatici eterociclici ( solo pirimidina e purina) CAP. C 3 CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI Gli alogenuri alchilici- . La nomenclatura e la classificazione. Le proprietà fisiche. Le reazioni di sostituzione nucleofila SN2 SN1 , la reazione di eliminazione Gli alcoli - Gli alcoli e il gruppo ossidrile. La nomenclatura e la classificazione. La sintesi degli alcoli: reazione di idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e di chetoni. Le proprietà fisiche. Le proprietà chimiche. Le reazioni degli alcoli: il comportamento acido, la reazione di disidratazione, la reazione di ossidazione . Gli alcoli polivalenti. Gli eteri- Nomenclatura, proprietà fisiche. I fenoli - Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni. Le aldeidi e i chetoni- Il gruppo funzionale carbonilico. La nomenclatura. La sintesi delle aldeidi e dei chetoni: reazione di ossidazione di alcoli primari e secondari. Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni. Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni: reazione di addizione nucleofila, reazione di riduzione, di ossidazione, i reattivi di Fehling e di Tollens. Gli acidi carbossilici- Il gruppo funzionale carbossilico. La nomenclatura. La sintesi degli acidi carbossilici. Le proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli acidi carbossilici. Gli esteri- La nomenclatura. La sintesi: reazione di sostituzione nucleofila acilica. Le reazioni degli esteri. Le ammidi- Il gruppo funzionale, la nomenclatura e la classificazione. La sintesi e le reazioni delle ammidi. Gli acidi carbossilici polifunzionali: Gli idrossiacidi ( acido lattico), i chetoacidi (acido piruvico). Le ammine- Il gruppo funzionale amminico. La nomenclatura delle ammine aromatiche e alifatiche. Le proprietà fisiche e chimiche. CAP. B 1 BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE I carboidrati- I monosaccaridi aldosi e chetosi. La chiralità e le proiezioni di Fisher. Le strutture cicliche dei monosaccaridi. Le proiezioni di Haworth. Le reazioni dei monosaccaridi: reazione di riduzione, di ossidazione. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. I lipidi- Lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi. Le reazioni dei trigliceridi: reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina. L’azione del sapone. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli 34
steroidi: il colesterolo, gli acidi biliari e gli ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili. Gli amminoacidi e le proteine- I gruppi funzionali degli amminoacidi. La chiralità degli amminoacidi. La classificazione. La struttura ionica dipolare. Le proprietà chimiche e fisiche. I peptidi. La classificazione delle proteine. La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. CAP.B2 BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI L’energia nelle reazioni biochimiche- Accenni sul primo e secondo principio della Termodinamica: l’energia libera. Le reazioni anaboliche e cataboliche. Il ruolo dell’ATP- La struttura dell’ATP, l’idrolisi e la sintesi . Che cosa sono gli enzimi- L’energia di attivazione e i catalizzatori biologici. La specificità degli enzimi. Meccanismi della catalisi enzimatica- L’interazione enzima e substrato. L’adattamento indotto. Cofattori e coenzimi. La regolazione dell’attività enzimatica: inibizione reversibile ed irreversibile. L’azione del pH e della temperatura sull’enzima. CAP.B 3 BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme- Le vie metaboliche. Le reazioni redox. Il NAD, il NADP e il FAD. L ’ossidazione del glucosio. Il catabolismo del glucosio. La glicolisi- Le fasi della glicolisi. La reazione completa della glicolisi. Il destino del piruvato. La fermentazione- la fermentazione lattica ed alcolica. La respirazione cellulare- le fasi della respirazione cellulare e la struttura del mitocondrio. La decarbossilazione del piruvato. Il ciclo di Krebs . La fosforilazione ossidativa e i complessi della catena respiratoria. La chemiosmosi . Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. Gli altri destini del glucosio: l’ importanza della via dei pentoso fosfati e della gluconeogenesi. Il glicogeno, la glicogenolisi e la glicogenosintesi. Il metabolismo dei lipidi- il destino dei lipidi nella dieta dei vertebrati . I corpi chetonici. Il metabolismo degli amminoacidi- Il catabolismo e il destino dello ione ammonio. Gli amminoacidi come precursori di biomolecole. CAP.B 5 Regolazione della trascrizione genica- Trascrizione nei procarioti (operoni) e negli eucarioti. I Virus Ciclo lisogeno e ciclo litico. Modalità di duplicazione dei virus a RNA. Il coronavirus. CAP.B 6 35
Puoi anche leggere