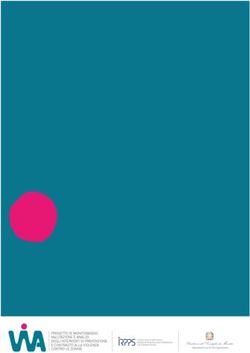Rassegna stampa del centro di Documentazione Rigoberta Menchù marzo 1-2019 Donne, dalle parole ai fatti? - CSV Lombardia
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Rassegna stampa del centro di Documentazione Rigoberta Menchù
marzo 1-2019
Donne, dalle parole ai fatti? …
“Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la
convivenza comune” che il 4 febbraio scorso è stato sottoscritto da
Papa Francesco e da Ahmad Al-Tayyeb, Grande Imam di Al-Azhar, c'è
un paragrafo dedicato alla condizione della donna. Sicuramente sarà stato
oggetto di discussioni e negoziazioni tra le parti ma alla fine, nero su bianco,
dice: “È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna
all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve
lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della
propria fede e della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo
sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di
guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche
disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per
modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri
diritti”.
Perché le donne scioperano l’8 marzo
5 marzo 2019 11.40 Internazionale
Venerdì 8 marzo – giornata internazionale della donna – in più di cento paesi
del mondo ci sarà uno sciopero delle donne organizzato dai movimenti femministi. In
Italia lo sciopero generale dura ventiquattr’ore, coinvolge il settore pubblico e quello
privato, ed è organizzato da Non una di meno, che lo proclama per il terzo anno
consecutivo. Non si tratta solo di uno sciopero dal lavoro, ma anche dell’astensione da
ogni attività di cura e di consumo. In settanta città italiane si svolgeranno
manifestazioni e presidi.
Le attiviste di Non una di meno sul loro sito hanno chiarito che lo sciopero è stato
indetto per protestare contro tutte le forme di violenza maschile sulle donne: dalla
disparità salariale tra uomini e donne, agli ostacoli alla loro libertà riproduttiva, fino al
sessismo, all’omofobia e al razzismo. In Italia lo sciopero delle donne ha incluso in
particolare anche il tema dell’antirazzismo tra le motivazioni della protesta contro la
recente approvazione del decreto sicurezza e immigrazione. “C’è un legame tra le
politiche contro le donne come il ddl Pillon su separazione e affido e le politiche
repressive contro l’immigrazione come il decreto Salvini, perciò quest’anno ci sarà
un’attenzione particolare anche all’antirazzismo”, spiega Tatiana Montella, portavoce
di Non una di meno.
Nel comunicato con cui lo convocano le femministe spiegano perché è necessario
protestare: “Ci ammazzano nelle case e nelle strade; perché ci pagano di meno,
perché ci sfruttano e ci discriminano per il colore della pelle o per la nostra origine, ma
anche perché molte di noi sono lasciate annegare in mare, dopo essere state torturate
in Libia, e ancora, scioperiamo perché ci negano di essere cittadine, perché ci tolgono
la protezione umanitaria, perché subiamo il razzismo in tutte le sue forme”. Allo
sciopero hanno aderito alcuni sindacati di base e quindi esiste una copertura sindacale
per tutte le categorie di lavoratrici.
Tra le motivazioni dello sciopero c’è la disuguaglianza di genere: secondo l’ultimo
rapporto sul Global gender gap (2016) del World economic forum, l’Italia è alcinquantesimo posto nella lista dei 144 paesi indicizzati. In particolare per la disuguaglianza salariale l’Italia è al 127° posto. Le lavoratrici italiane, infatti, percepiscono mediamente il 30 per cento in meno dei loro colleghi maschi. 8 marzo: “Preoccupante clima di misoginia istituzionale” 8 marzo 2019 Amnesty Italia Un crescente clima di misoginia istituzionale caratterizza l’Italia degli ultimi tempi. Un fenomeno che avevamo già misurato in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano e che, a distanza di qualche mese, ritroviamo più forte e pericolosa. “La misoginia è diffusa particolarmente sui social, negli insulti e nelle offese di esponenti politici nei confronti di donne che rivendicano diritti o prendono la parola su questioni come l’immigrazione – spiega in una nota ufficiale diffusa in occasione della Giornata internazionale della donna Tina Marinari, campaigner sui diritti delle donne di Amnesty International Italia –; e rischiamo di vederla ufficializzata nella legislazione, se verrà approvato il ddl Pillon, alcuni elementi del quale, come l’obbligo della mediazione, sono inaccettabili”. Come i discorsi d’odio a sfondo razzista favoriscono crimini dall’identico movente, così la misoginia istituzionale rischia di alimentare gravi violazioni dei diritti umani contro le donne, in un paese nel quale i femminicidi si ripetono di settimana in settimana, anche a causa del non rispetto o della mancata previsione di misure di protezione in favore delle donne minacciate. “In un paese nel quale emergono sempre di più ulteriori comportamenti criminali contro le donne, come il cyberbullismo e il revenge-porn, rileviamo con sconcerto come in intere zone la legislazione in materia d’interruzione di gravidanza sia di fatto inapplicabile per l’indisponibilità del personale sanitario preposto alla sua attuazione“, ha aggiunto Marinari. Infine, come emerso da recenti ricerche di Amnesty International, l’Italia resta uno degli stati europei la cui legislazione sullo stupro è obsoleta e non rispetta gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Istanbul – che l’Italia ha sollecitamente ratificato – in quanto non è basata sull’espressione esplicita del consenso. «Chiediamo la de-canonizzazione di Giovanni Paolo II» di Anne Soupa* e Christine Pedotti* in “Le Monde” dell'11 marzo 2019 (traduzione: www.finesettimana.org) Christine Pedotti e Anne Soupa, del Comité de la jupe, denunciano, tanto quanto gli abusi perpetrati contro delle religiose da parte di preti, il concetto avvilente della “Donna” nella Chiesa cattolica, di cui Karol Wojtyla è stato l'artefice. La giornata dei diritti delle donne del 2019 sarà per noi, donne, cattoliche o no, una giornata di lutto e di indignazione. Gridiamo il nostro orrore dopo la recente trasmissione da parte di Arte del documentario Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Eglise (Religiose abusate, l'altro scandalo della Chiesa), di Marie- Pierre Raimbault e Eric Quintin, dedicato agli abusi e stupri di religiose da parte di preti. Da più di dieci anni, molte donne, e in particolare quelle del Comité de la jupe, continuano ad interrogare la Chiesa sul suo atteggiamento nei confronti delle donne, ottenendo risposte di sprezzanti come quella di André Vingt-Trois, allora cardinale arcivescovo di Parigi, di cui bisogna ricordare le parole: “L'importante non è avere una gonna, bisogna avere qualcosa nella testa”. Non abbiamo parole per condannare quei preti che, in fatto di gonna, hanno soprattutto sollevato quelle delle religiose. Dato che esse donavano la propria vita per “servire”, si sono serviti loro, si sono serviti dei corpi di quelle donne, negando i loro voti, la loro parola, la loro dignità (così spesso invocata dalla Chiesa), la loro stessa persona di esseri umani liberi e responsabili del proprio corpo. Nelle loro sgrinfie, quelle donne sono state espropriate e ridotte ad una funzione sessuale, un uso che ci si concede più di quanto non lo si “rifili” ad un altro perché “ne approfitti”, in piena impunità. Ci indigna il sistema nel quale si inscrivono questi fatti. Non sono semplici abusi isolati perpetrati da qualche perverso. Siamo
obbligate a constatare che provengono da quella “cultura dell'abuso”, denunciata da papa Francesco nella sua lettera del 20 agosto 2018 rivolta al “popolo di Dio” a proposito degli abusi sui bambini. Un sistema e una cultura che negano il corpo dell'altro, quello dei bambini come quello delle donne. Questo sistema si radica nell'ambito maschile, chiuso in se stesso, e si perpetua grazie all'idolatria che continua ad essere riservata alla funzione del prete. Ma c'è di peggio. C'è il concetto, un'ideologia forgiata dalla Chiesa cattolica, chiamata la “Donna”. Ne denunciamo la povertà e la miseria così come l'obiettivo di dominazione che anima questa visione. Voce decisiva che ha condotto papa Paolo VI a condannare la contraccezione (enciclica Humanae Vitae), Karol Wojtyla, divenuto papa Giovanni Paolo II, a elaborare una teologia della “Donna”, sempre riferita alla Vergine Maria, figura di silenzio e di obbedienza. Sotto la sua influenza, la “Donna” diventa un concetto, un'ideologia concepita esclusivamente da uomini – celibi per di più -, la cui unica vocazione è aiutare l'uomo attraverso il matrimonio e la maternità oppure servire la Chiesa nella castità religiosa: una visione che non ha alcun rapporto con le donne in carne e d'ossa, di sangue, di mente e di anima, che costituiscono, bisogna ricordarlo, la metà del genere umano e almeno i due terzi dei cattolici praticanti. Osiamo dire che il primo abuso commesso contro le donne è questa idealizzazione, questo inganno, che maschera le innumerevoli discriminazioni di cui sono oggetto le donne nella loro Chiesa. È sull'altare di questa idea di donna che sono sacrificate le vite delle donne vere. Nella Chiesa cattolica, la “Donna” deve rispondere ad una duplice vocazione: “vergine o madre”. È assegnata al suo corpo sessuato: il “non-uso” del suo corpo sessuato nella verginità, o il suo “uso” nella maternità, senza che sia lasciato alcuno spazio alle altre dimensioni dell'essere umano! Denunciamo la menzogna e l'ipocrisia di questa ideologia che pesa su di noi. E che è rivelata dagli abusi sui corpi delle religiose. Hanno fatto voto di castità, e la loro parola è violentata insieme al loro corpo. Quando questi stupri conducono ad una gravidanza, le religiose vengono fatte abortire a forza oppure il loro bambino è cinicamente abbandonato, su ordine espresso della responsabile della comunità. La violenza fatta al loro corpo è allora al colmo, dato che perfino la maternità, la loro altra vocazione, viene loro vietata. Così, non solo i responsabili della Chiesa cattolica impongono a tutte le donne la loro ideologia della “Donna”, ma – aiutati dal alcune donne acquisite al sistema – violano essi stessi le regole che impongono a tutte. La nostra accusa non riguarda solo i criminali e gli stupratori. Riguarda la cospirazione del silenzio che ha circondato quei comportamenti mostruosi. “I panni sporchi si lavano in famiglia”, si dice per giustificare l'allontanamento dei media e della giustizia. Ma quei panni sporchi vengono solo spostati, senza mai aver a che fare con sapone o lavatrice. Siamo forse in un esercito che gestisce il suo “bordello militare” come un male minore? Forti del Vangelo e dell'atteggiamento di Gesù nei confronti delle donne, riaffermiamo i diritti imprescindibili delle donne, che sono quelli di ogni essere umano, ovunque e specialmente nella Chiesa. Chiediamo la de-canonizzazione di papa Giovanni Paolo II, protettore di abusatori in nome della “ragione della Chiesa” e principale artefice della costruzione ideologica della “Donna”, così come chiediamo che sia vietato insegnare, diffondere o pubblicare la “teologia del corpo” da lui predicata nel corso delle sue catechesi del mercoledì. . *Christine Pedotti è direttrice della redazione di “Témoignage chrétien”. Scrittrice e cristiana impegnata, ha lanciato un appello nell'ottobre 2018, che chiede la creazione di una commissione di inchiesta parlamentare sulla pedofilia nella Chiesa. Ha da poco pubblicato “Qu'avez-vous fait de Jésus? Les silences coupables de l'Eglise” (Albin Michel). *Anne Soupa è giornalista, teologa e biblista. Ha fondato nel 2008 insieme a Christine Pedotti il Comité de la jupe. Questo comitato, di cui è presidente, promuove l'uguaglianza delle donne e degli uomini nella governance delle comunità religiose, in particolare nella Chiesa cattolica. Ha da poco pubblicato “Consoler les catholiques” (Salvator) TURCHIA.La polizia attacca la marcia delle donne Poliziotti in tenuta anti-sommossa hanno lanciato lacrimogeni e impedito al corteo di Istanbul di proseguire. Manifestazioni anche in altre città turche, a sud
est focus sugli scioperi della fame in carcere guidati dalla parlamentare Leyla
Guven
della redazione
Roma, 9 marzo 2019, Nena News – La polizia turca ha aggredito e lanciato gas
lacrimogeni contro migliaia di donne che ieri si sono ritrovate nel centro di Istanbul per la
marcia dell’8 marzo. Nonostante il divieto delle autorità, che impediscono proteste
di piazza da tempo, le donne sono scese in strada in massa in Piazza Taksim,
simbolo delle mobilitazioni turche da anni. Centinaia di poliziotti in tenuta anti-
sommossa hanno impedito alla marcia di camminare su Istiktal Avenue.
“Non stiamo zitte, non abbiamo paura, non obbediamo”, hanno gridato le donne
circondate dalla polizia, tante con il colore fucsia simbolo del movimento globale
Non una di meno, mentre tanti cartelli rilanciavano gli slogan della manifestazione:
“Rivolta femminista contro la violenza maschile e la povertà”, “Sono nata libera e vivrò
libera”.
La protesta delle donne turche non è una realtà nuova, ma radicata, soprattutto negli
ultimi due decenni di governo Akp con Erdogan, che prima da premier e ora da
presidente, porta avanti una chiara campagna di islamizzazione di una società
tradizionalmente laica, incentrata su un ruolo della donna relegata a madre e
moglie. Una politica misogina che è stata accompagna da un incremento delle
violenze e degli abusi contro le donne: secondo la nota ong turca Umut, nel 2018
477 donne sono state uccise e 232 ferite da uomini, con il bilancio di femminicidi
degli ultimi quattro anni salito a 1.760 casi.
Uno degli ultimi femminicidi ha provocato un’ondata di indignazione e proteste: a
febbraio Sule Cet, una giovane di 23 anni, è stata violentata e uccisa dal suo capo
e un altro uomo, gettata dal 20esimo piano di un palazzo. Durante le udienze il
procuratore ha spostato l’attenzione sulla vittima, Cet, colpevolizzandola per non
essere vergine e per aver bevuto.
Manifestazioni non si sono tenute solo a Istanbul. Migliaia di donne hanno fatto
altrettanto ad Ankara, a Smirne e tante altre nel sud est a maggioranza curda,
dove al centro della protesta c’erano gli scioperi della fame dei prigionieri e le
prigioniere politiche nelle carceri turche. Simbolo della lotta resta Leyla Guven,
parlamentare del partito di sinistra Hdp, che non tocca cibo da novembre per protestare
contro l’isolamento imposto al leader del Pkk Abdullah Ocalan nell’isola-prigione di Imrali.
Nena News
Uno sciopero particolare nato per uno stupro, cresciuto contro ogni
forma di oppressione di Lea Melandri in “il manifesto” del 8 marzo
2019
• Alla faccia della parità ecco perché in Italia il potere non è donna di Maria Novella De Luca
e Luisa Grion in la Repubblica del 8 marzo 2019
Sono 6 contro 76 tra i rettori, mille contro 7mila tra i sindaci, 5mila contro 17mila tra i manager
Rapporto sulle discriminazioni: ai vertici della società e delle istituzioni restano gli uomini
• La scelta obbligata tra lavoro e famiglia di Chiara Saraceno in la Repubblica del 8 marzo
2019
C'è poco da festeggiare, quindi. Per questo l'8 marzo quest'anno torna alle origini. Le donne
scioperano e tornano in piazza per protestare e chiedere, pretendere, un cambiamento delle
regole del gioco.La lega ha un problema con le donne di Concita De Gregorio in “la Repubblica” del 7 marzo 2019 TORNA A SOFFIARE IL VENTO DI RIACE – di Alex Zanotelli Il legame con Riace nasce in occasione del campo di lavoro che abbiamo fatto da quelle parti, i primi dieci giorni dell’agosto scorso, con un gruppo del Gim (Giovani impegno missionario) dei missionari comboniani. In breve tempo, siamo entrati in sintonia con i migranti, con Mimmo Lucano e con l’esperienza di Riace. Quando lo abbiamo invitato a parlare ai giovani, Mimmo si è commosso e ci ha detto che avrebbe iniziato un digiuno a oltranza per sollecitare il ministero degli interni a erogare i fondi dovuti per il funzionamento dello Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.Siamo rimasti sempre in contatto e abbiamo vissuto da vicino l’iniziativa giudiziaria della Procura di Locri sulla gestione dei progetti d’accoglienza dei migranti e gli arresti domiciliari che Mimmo ha dovuto subire in ottobre. In seguito ha avuto il divieto di dimora a Riace e ora vive a Caulonia, piccolo centro dell’Alta Locride. È inconcepibile che un uomo che ha fatto del bene sia stato trattato in questo modo e la sua opera devastata. In questi mesi molti migranti se ne sono andati da Riace – dei trecento che erano ne sono rimasti una sessantina – e l’opera di accoglienza e di integrazione, che è stata e che può tornare a essere un esempio per tante realtà italiane, è stata di fatto smantellata.Tuttavia è accaduto che molte realtà e associazioni, in giro per l’Italia, non si sono arrese a questa situazione e stanno provando a fare ripartire l’esperienza che è antitetica alle scelte che la politica italiana sta facendo.Così è stato messo a punto il progetto di far nascere una Fondazione di Partecipazione che avrà nome “È stato il vento” (una frase che Mimmo Lucano spesso usa, per ricordare che è stato il vento a portare, anni fa, la cinquantina di curdi sulle spiagge di Riace e da lì è nato tutto), che ha appunto l’obiettivo di riprendere i progetti di Riace. E siccome per mettere in piedi la Fondazione ci vogliono centomila euro abbiamo deciso di costituire un Comitato promotore che si occupi degli aspetti procedurali e della raccolta fondi. Lo si è fatto il 12 gennaio a Caulonia nella biblioteca comunale strapiena di gente. Mimmo Lucano, provato ma intenzionato a non mollare, era lì con noi. Gli abbiamo detto che il vento tornerà a soffiare su Riace. Tra l’altro, proprio quel giorno un gruppo di curdi è arrivato sulla spiaggia di Crotone e la gente si è buttata in acqua per aiutare quelle persone…Intanto il Comitato promotore ha un presidente onorario, Giuseppe Lavorato ex sindaco di Rosarno; una presidente, Chiara Sasso coordinatrice della Rete comuni solidali; tre garanti: Livio Pepino ex magistrato, Emilio Sirianni giudice, e io; tra i consiglieri, Gianfranco Schiavone dell’associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi); Felicetta Parisi pediatra impegnata come volontaria nel rione Sanità a Napoli; Barbara Vecchio della rete di cooperative agricole Longo Mai.Ora si tratta di raccogliere questi centomila euro e di partire al più presto con la Fondazione. Abbiamo tanta speranza che l’esperienza di Riace vada avanti perché è valida e perché potrebbe essere imitata da tanti paesini italiani che stanno morendo per mancanza di abitanti. - Fonte: Nigrizia.it Sondaggio, un italiano su tre tentato dal razzismo Il 34% discrimina in vari modi chi non è bianco. Dieci anni fa erano solo 7 su 100
di ANTONIO NOTO, direttore di Noto Sondaggi Roma, 24 febbraio 2019 - Dieci anni fa, nel 2009 il tasso di razzismo" in Italia era del 7%. Cioè 7 cittadini su 100 ritenevano che la razza bianca fosse superiore a quella nera. Nel 2019 tale percentuale è più che raddoppiata arrivando al 18%. Questa però è solo la quota di quanti ‘ideologicamente’ si dichiarano razzisti. C’è da aggiungere quelli che, pur non definendosi segregazionisti, nella realtà mettono in atto comportamenti sociali che fanno il verso al razzismo, o almeno ad una marcata intolleranza verso il colore della pelle. In pratica c’è una ulteriore quota pari al 16% di italiani che pur non ritenendo la razza bianca superiore a quella nera, assume atteggiamenti chiaramente discriminatori nei confronti di chi ha la pelle di colore diverso. Pertanto se si considerano, sia quelli che ideologicamente ritengono la razza bianca superiore (18%), sia coloro i quali discriminano gli uomini in base al colore della pelle (pur non dichiarandosi razzista), si può affermare che il tasso di razzismo in Italia è del 34 (…) * Il sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi per Quotidiano nazionale, è stato condotto il 23 febbraio 2019 su un campione di mille persone, con metodo Cawi Il Vangelo per sentito dire di Luca Baratto in “Nev” - Notizie evangeliche – del 27 febbraio 2019 Il Vangelo per sentito dire. Non si può che definire così l’uscita di Lorenzo Fontana, il ministro per le politiche della famiglia, che a Pisa due giorni fa ha giustificato la politica sovranista – “prima gli italiani” – del suo partito con l’insegnamento di Gesù. Sui migranti, ha affermato Fontana, “ci dicono che [noi leghisti] siamo cattivi cristiani. Però bisognerebbe anche guardare un po’ il catechismo. C’è un passaggio da tener conto: ‘ama il prossimo tuo’, cioè quello in tua prossimità. Quindi, prima di tutto cerchiamo di far star bene le nostre comunità”. Il ministro associa la parola “prossimo” alla parola “prossimità”, suggerendo che il mio prossimo è quello che mi sta e mi è più vicino. Una interpretazione ap-prossima-tiva, se vogliamo continuare con le assonanze, buona per chi si accontenta del Vangelo per sentito dire, ma non ha intenzione di leggere le Scritture. Nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 10, è un maestro della legge a chiedere a Gesù: “Chi è il mio prossimo”. Una domanda posta precisamente per definire i limiti della responsabilità verso l’altro: sono limiti ristretti al mio gruppo o mi spingono a guardare più lontano? Gesù risponde con la parabola del buon samaritano, quella in cui un sacerdote e un levita – persone autorevoli della comunità a cui appartenevano gli ascoltatori di Gesù – lasciano sulla strada un poveretto malmenato dai briganti, mentre un samaritano – una persona particolarmente disprezzata dagli uditori del racconto – lo aiuta. E fin qui siamo nell’ambito del “Vangelo per sentito dire” perché l’originalità dell’insegnamento di Gesù sta nella domanda che segue la parabola. “Gesù chiede al dottore della legge: ‘Quale dei tre personaggi ti pare essere stato il prossimo di colui che s’imbatté nei ladroni?’ Egli rispose: ‘Colui che gli usò misericordia’. Gesù gli disse: ‘Va’, e fa’ anche tu la stessa cosa’”. Nella parabola il prossimo non è la persona soccorsa, ma il soccorritore! Non è l’altro, sei tu! Il prossimo non è la persona identificabile da particolari criteri di necessità – aiutiamo gli stranieri che ne hanno veramente bisogno, dice il ministro – o geografici – prima gli italiani. Il prossimo sei tu che decidi di farti vicino e di prenderti cura dell’altro, chiunque sia e a qualunque luogo appartenga. E, comunque, è sempre bene che ognuno si p
Il prossimo non è una categoria, ma frutto di una decisione, è una relazione nella quale tu decidi di renderti disponibile oppure no. Ha ragione il ministro quando dice “Se io amo le persone che arrivano dall’altra parte del mondo, però poi mi dimentico del disabile o della persona in difficoltà o del vicino di casa, sono un ipocrita”. Verissimo, ma è altrettanto vero il contrario, perché è soltanto la tua decisione di renderti indisponibile verso lo straniero a definirlo come un “non prossimo”. L’interpretazione data dal ministro è dunque un travisamento del Vangelo proposto attraverso un linguaggio bonario, dall’apparenza ragionevole. “Parlo con il buon senso di un padre di famiglia ….” ha più volte affermato, proponendo la retorica pericolosissima, tipica dello scenario politico attuale, in cui il mondo in cui viviamo è descritto con frammenti di problemi veri uniti a elementi che invece travisano la realtà e, nel caso del Vangelo, la verità. Il fatto è che in Italia e in Europa esiste ormai un cristianesimo di identità che assume caratteri diversi, se non opposti, al cristianesimo di fede. Il cristianesimo di identità è ben descritto da Fontana quando afferma che il suo è un partito che ama: “amiamo il nostro territorio, la nostra gente, la nostra comunità, la nostra tradizione, la nostra identità”. Questo tipo di amore che definisce un’identità più che una fede e definisce strettamente chi è dentro e chi è fuori, è quello che meno di tutti si adatta all’insegnamento di Gesù che è un continuo sconfinare, superare i confini geografici ma soprattutto culturali del mondo per un messaggio universalista di inclusione. Prima o poi qualcuno di autorevole nel mondo cristiano dovrà dire chiaramente che il cristianesimo di identità e il cristianesimo di fede sono due cose diverse che si assomigliano solo per ap-prossimazione. E, comunque, è sempre bene che ognuno si prenda le responsabilità delle proprie opinioni politiche evitando di citare il Vangelo per sentito dire. Venezuela in crisi, cosa nasconde il grande imbroglio di Pino Arlacchi* in “il Fatto Quotidiano” del 27 febbraio 2019 Se c’è una lezione che si impara dirigendo una grande organizzazione internazionale come l’Onu è che, nelle cose del mondo, la verità dei fatti raramente coincide con la sua versione ufficiale. Le idee dominanti – come diceva il vecchio Marx – restano quelle della classe dominante. E il caso del Venezuela di questi giorni si configura appunto nei termini di una gigantesca truffa informativa volta a coprire la sopraffazione di un popolo e la spoliazione di una nazione. Il principale mito da sfatare riguarda le cause di fondo del dramma venezuelano. I media occidentali non hanno avuto dubbi nell’additare gli esecutivi succedutisi al potere dopo l’elezione del “dittatore” Chávez alla presidenza nel 1998 come unici responsabili della crisi, nascondendone la matrice di gran lunga più importante: le barbare sanzioni americane contro il Venezuela decise da Obama nel 2015 e inasprite da Trump nel 2017 e nel 2018. Spese sociali mai così alte. La “dittatura” di Chávez, confermata da 4 elezioni presidenziali e 14 referendum e consultazioni nazionali successive, è stata condotta sotto il segno di uno strappo radicale con la storia passata del Venezuela: i proventi del petrolio sono stati in massima parte redistribuiti alla popolazione invece che intascati dall’oligarchia locale e imboscati nelle banche degli Stati Uniti. Nonostante Chávez abbia commesso vari errori di malgoverno e corruzione tipici del populismo di sinistra – errori confermati in seguito dal più debole Maduro – sotto la sua presidenza le spese sociali hanno raggiunto il 70% del bilancio dello Stato, il Pil pro capite è più che triplicato in poco più di 10 anni, la povertà è passata dal 40 al
7%, la mortalità infantile si è dimezzata, la malnutrizione è diminuita dal 21 al 5%, l’analfabetismo è stato azzerato e il coefficiente Gini di disuguaglianza è sceso al livello più basso dell’America Latina (dati Fmi, Undp e Banca Mondiale). Ma la sfida più temeraria lanciata dal Venezuela “socialista” è stata quella contro l’egemonia del dollaro. L’economia ha iniziato a essere de-dollarizzata favorendo investimenti non statunitensi, tentando di non farsi pagare in dollari le esportazioni, e creando il Sucre, un sistema di scambi finanziari regionali basato su una cripto-moneta, il Petro, detenuta dalle banche centrali delle nazioni in affari col Venezuela come unità di conto e mezzo di pagamento. Il tempo della resa dei conti con il Grande Fratello è arrivato perciò molto presto. Molti hanno evocato lo spettro del Cile di Allende di 30 anni prima. Ma il Venezuela di oggi è preda ancora più consistente del Cile. Dopo la Russia, è il Paese più ricco di risorse naturali del pianeta: primo produttore mondiale di petrolio e gas, secondo produttore di oro, e tra i maggiori di ferro, bauxite, cobalto e altri. Collocato a tre ore di volo da Miami, e con 32 milioni di abitanti. Poco indebitato, e capace di fondare una banca dello sviluppo, il Banco do Sur, in grado di sostituire Banca Mondiale e Fondo monetario come sorgente più equa di credito per il continente latinoamericano. È per queste ragioni che la “cura cilena” è inizialmente fallita. Il tentato golpe anti-chavista del 2002 e le manifestazioni violente di un’opposizione divenuta eversiva e anti-nazionale, si sono scontrati con un esecutivo che vinceva comunque un’elezione dopo l’altra. Perché anche i poveri, dopotutto, votano. L’occasione per chiudere la partita si è presentata con la morte di Chávez nel 2013 e il crollo del prezzo del petrolio iniziato nel 2015. La strategia delle sanzioni. La raffica di sanzioni emesse l’anno dopo con il pretesto che il Venezuela fosse una minaccia alla sicurezza nazionale degli Usa mettono in ginocchio il Paese. Il Venezuela viene espulso dai mercati finanziari internazionali e messo nelle condizioni di non poter più usare i proventi del petrolio per pagare le importazioni. Quasi tutto ciò che entra in un’economia che produce poco al di fuori degli idrocarburi deve essere pagato in dollari contanti. E le sanzioni impediscono, appunto, l’uso del dollaro. I fondi del governo depositati negli Usa vengono congelati o sequestrati. I canali di rifinanziamento e di rinegoziazione del modesto debito estero del Venezuela vengono chiusi. Gli interessi sul debito schizzano in alto perché le agenzie di rating al servizio di Washington portano il rischio paese a cifre inverosimili, più alte di quelle della Siria. Nel 2015 lo spread del Venezuela è di 2 mila punti, per raggiungere e superare i 6 mila nel 2017. Gli economisti del centro studi Celag hanno quantificato in 68,6 miliardi di dollari, il 34% del Pil. l’extra costo del debito venezuelano tra il 2014 e il 2017. Ma il più micidiale degli effetti del blocco finanziario del Venezuela è il rifiuto delle principali banche internazionali, sotto scacco americano, di trattare le transazioni connesse alle importazioni di beni vitali come il cibo, le medicine, i prodotti igienici e gli strumenti indispensabili per il funzionamento dell’apparato produttivo e dei trasporti. Gli ospedali venezuelani restano senza insulina e trattamenti antimalarici. I porti del paese vengono dichiarati porti di guerra, portando alle stelle le tariffe dell’import-export. Il valore delle importazioni crolla da 60 miliardi di dollari nel 2011-2013 a 12 miliardi nel 2017, portandosi dietro il tonfo del 50% del Pil. Le banche di Wall Street I beni che riescono comunque a essere importati vengono accaparrati e rivenduti di contrabbando dagli oligopoli dell’industria alimentare che dominano il settore privato dell’economia venezuelana. La stessa delinquenza di alto livello che tira le fila del sabotaggio del Clap, il piano di emergenza alimentare del governo che soccorre 6 milioni di famiglie. È stato calcolato che tra il 2013 e il 2017 l’aggressione finanziaria al Venezuela è costata tra il 110 e il 160% del suo Pil, cioè tra i 245 e i 350 miliardi di dollari. Senza le sanzioni, l’economia del Venezuela, invece
di dimezzarsi, si sarebbe sviluppata agli stessi tassi dell’Argentina. Durante il 2018 si sviluppa in Venezuela una crisi umanitaria interamente indotta. Che si accompagna a un’iperinflazione altrettanto fasulla, senza basi nei fondamentali dell’economia, determinata da un attacco del mercato nero del dollaro alla moneta nazionale riconducibile alle 6 maggiori banche d’affari di Wall Street. È per questo che il rapporto dell’esperto Onu che ha visitato il Venezuela nel 2017, Alfred De Zayas (di cui non avete mai sentito parlare ma che contiene buona parte dei dati fin qui citati), propone il deferimento degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l’umanità perpetrati in Venezuela dopo il 2015. * Vicesegretario Generale dell’Onu dal 1997 al 2002 A Caracas il buio del mondo di Tommaso Di Francesco in “il manifesto” del 10 marzo 2019 Ieri su questo giornale Alberto Negri raccontava come, dopo otto anni, non sia ancora finita la giostra sanguinosa della guerra in Siria. Con la sua scia di vittime, di migrazioni in massa, di terrorismo di ritorno a casa dei foreign fighters. Le spoglie delle macerie che restano vengono ancora contese proprio da chi, Stati uniti, Turchia e Arabia saudita – intervenuti con lo schieramento degli «Amici della Siria» dov’erano in prima fila tanti Paesi europei a cominciare dalla Gran Bretagna e dalla Germania – non solo non ha combattuto l’integralismo armato e criminale dell’Isis, ma di quello si è servito per distruggere il Paese tentando, ma senza riuscirci stavolta, la stessa operazione di destabilizzazione avviata con la guerra Nato in Libia. Bene. Mentre questo circo è ancora in piedi, ecco che in un altro emisfero, e sempre con la parola d’ordine dell’«intervento umanitario», un nuovo luna park si allestisce in Venezuela da nuovi «amici», stavolta del Venezuela. Gli «amici» hanno iniziato una campagna di sostegno all’autoproclamato presidente Guaidó e contro il «dittatore» Maduro – inesorabilmente giudicato come dittatore. Nonostante che in quel Paese dall’avvento di Chavez nel 1998 a oggi di elezioni, locali, politiche e presidenziali, quasi tutte con partecipazione dell’opposizione, ce ne siano state 25, tutte vinte dai governi «bolivariani» in carica, tranne due invece perse. Non spiegando però come sia possibile che esista, in una «dittatura» un parlamento eletto e una Costituzione sulla quale – con imbroglio, visto che un presidente della repubblica eletto c’è – ha giurato l’autoproclamato Guaidó per dichiararsi presidente il 22 gennaio scorso. Così l’Unione europea ha dato un ultimatum e avviato il riconoscimento di Guaidó; poi ha bloccato a Londra, come da copione libico-balcanico e in aperto disprezzo del diritto internazionale, quasi dieci miliardi in oro della divisa di Stato venezuelana che deriva dal commercio internazionale del suo petrolio – giacché, non dimentichiamolo, ci troviamo di fronte al Paese che detiene le principali risorse petrolifere del pianeta. La puzza di petrolio in questa crisi è asfissiante. Infine, mentre privava quel popolo di una fonte così rilevante di sostentamento, ha inviato «ben» 20 milioni di derrate alimentari e farmaceutiche alla frontiera della Colombia – paese dove alligna una drammatica, quanto nascosta dai media internazionali, crisi umanitaria. È passato un mese e mezzo, e la prova di golpe che puntava alla divisione delle Forze armate da subito, schierandole a favore o contro l’ingresso dei cosiddetti «aiuti umanitari», è di fatto fallita; Guaidó stesso – un signor nessuno, diventato per caso capo dell’Assemblea nazionale e cresciuto nelle scuole delle rivoluzioni eterodirette di Otpor, finanziate dagli interessi statunitensi – è sparito per due settimane. Periodo nel quale a quanto è dato sapere, ha preso suggerimenti dal «democratico» Bolsonaro, il fascista ex militare diventato capo di stato in
Brasile, e dai presidenti d’estrema destra riemersi in quello che si profila, in America latina, come il nuovo «cortile di casa» degli Stati uniti. Aiuti? No, la destabilizzazione, che approfitta della reale crisi economica interna e del caos inflattivo, prodotti in primis da una economia monoculturale e dalla corruzione che strettamente ne deriva, può e deve continuare. Non solo mettendo popolo contro popolo, manifestazione contro manifestazione, ma con azioni di boicottaggio mirate. Da due giorni il Venezuela è quasi completamente al buio. Maduro grida al sabotaggio esterno e Guaidó incredibilmente «rivendica», annunciando che con lui al potere «la corrente tornerà». Di sabotaggio purtroppo si tratta, ed è il primo passo materiale per un conflitto civile la cui vastità e gravità sono impensabili, ma del quale c’è già stato l’esperimento delle guarimpas: le provocazione violente messe in piazza da una opposizione violenta, divisa e da sempre filogolpista: le decine e decine di vittime degli scontri del 2017-2018 sono infatti dell’una e dell’altra parte. Senza dimenticare i due pronunciamenti militari che ci sono stati. Ecco il luna park che ricomincia, ecco il buio del mondo che stavolta precipita sul Venezuela. Se continua, esploderà in una guerra civile diretta dall’esterno, con tanto di strategia dell’Occidente, impegnato in uno scontro strategico contro i nuovi interessi russi e soprattutto cinesi nel paese e nel Continente latinoamericano, mentre già si pensa a nuove sanzioni contro Cuba. Il tutto al seguito della volontà dello psycho-presidente Usa Trump, «razzista, imbroglione, truffatore e interessato solo ai suoi affari», secondo le parole del suo avvocato reo confesso Michael Cohen, ma è l’accusa che ripetono in questi giorni i Democratici americani. Lo psycho-Trump intanto ha nominato come inviato speciale per il Venezuela l’esperto Elliot Abrams, l’ispiratore degli squadroni della morte in salvador e Guatemala negli anni Ottanta. L’unica soluzione sarebbe il dialogo e l’avvio di un tavolo negoziale sul processo democratico, con riaccreditamento a ruolo di pace della Chiesa locale, però non proprio amica del papato di Bergoglio. Ma invece che promuovere una mediazione, l’Unione europea – che vive una crisi d’identità e di democrazia profonde, a Londra preparano l’evacuazione militare dei monarchi di fronte al «deal» della Brexit, in Spagna i presidenti eletti dell’autonomia catalana sono in esilio e i governanti in galera, in Francia una parte dei jilets jaunes chiama alla guerra civile e in Polonia i leader dell’opposizione li ammazzano – acclama e soccorre l’autoproclamato Guaidò e rivendica il sequestro della divisa aurea del Venezuela, tagliando così i piedi ad ogni possibile dialogo. «Se la prova di golpe non viene fermata – ammonisce l’autorevole sociologo Raúl Zibechi, pur critico di Maduro – salta tutto»; e non ci sarà alcuna possibilità di critica, necessaria, sui limiti e sui gravi errori di quello che è stato chiamato «socialismo bolivariano», che pure per due decenni, rimettendo in discussione i rapporti di proprietà, aveva trasformato positivamente il Paese, ma che ora – come negarlo – sopravvive in difesa e rischia un drammatico crepuscolo. Il giorno della vergogna di Carlo Bonini in “la Repubblica” del 28 febbraio 2019 L’Arma dei Carabinieri conosce il suo giorno della vergogna. Perché raggelante è stato lo spettacolo offerto ieri, nell’aula di Corte di Assise dove vengono processati i carabinieri imputati dell’omicidio di Stefano Cucchi, dal convitato di pietra di questo processo, il generale di corpo d’Armata Vittorio Tomasone, l’ufficiale al vertice della catena di comando che depistò la ricerca della verità. E perché raggelante è ora la prova della macchinazione, documentata dalle nuove, decisive carte prodotte dalla pubblica accusa, con cui l’Arma, nell’ottobre del 2009, indusse un ministro della Repubblica (Angelino Alfano, allora alla Giustizia) a mentire al Parlamento, a far deragliare per nove anni la ricerca della verità di una Procura della Repubblica impegnata in una partita che ignorava fosse «truccata», a predisporre, prima ancora
che la scienza medica si chinasse sul corpo martoriato di quel ragazzo, gli argomenti medico-legali che avrebbero dovuto nel tempo elidere anche solo il sospetto che fosse stato selvaggiamente pestato in una caserma. È stato penoso e a tratti oltraggioso dover ascoltare un ufficiale di Stato Maggiore, un pezzo della storia recente dell’Arma, farfugliare con una qualche prosopopea una ventina almeno di «non ricordo». E riferirsi ripetutamente a Stefano come al «geometra Cucchi», in un precipizio lessicale che teneva insieme l’ipocrisia postuma per ciò che nelle carte false dell’Arma di quel ragazzo era stato detto — «tossicodipendente, anoressico e sieropositivo» — e il cinismo che si riserva a un “danno collaterale”. Così penoso e così oltraggioso che da oggi, possiamo dire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, simbolicamente, il caso Cucchi stia all’Arma dei carabinieri come la “Diaz” lo è stata alla Polizia di Stato. Perché in quella buia caserma della Casilina dove Stefano venne pestato una notte di ottobre del 2009, si è consumato prima e dopo il medesimo doppio oltraggio che si era consumato otto anni prima, una notte di luglio del 2001, in una scuola alle pendici di Genova. Innocenti nella custodia dello Stato vennero prima abusivamente violentati nel corpo. E quindi, con altrettanta violenza e protervia, i nomi dei responsabili dell’abuso vennero coperti e sottratti alle loro responsabilità. Contesti diversi. Identica grana. Identica miopia di un apparato dello Stato nel cercare rifugio prima nella medicina del tempo e quindi in quella di un accertamento infinito della verità giudiziale. Identica posta in gioco, come ha voluto sottolineare ieri in aula il coraggioso pubblico ministero Giovanni Musarò che, con e grazie alla solidità del suo procuratore Giuseppe Pignatone, ha ostinatamente trovato e dipanato il bandolo della menzogna. «Oggi — ha detto — la questione non è più solo la doverosa verità a una famiglia, ma la tenuta del sistema». Hanno pensato per nove anni di farla franca. Poi, quando le cose si sono messe male, di cavarsela con la storiella di un drappello di mele marce in divisa capaci prima di ammazzare di botte Stefano e poi di farla sotto il naso a una catena di comando come a un Pulcinella in mezzo ai suoni. Perché questo provano le carte. Perché questo ha detto l’udienza di ieri. L’intera catena di comando dei carabinieri di Roma, nel 2009, a titolo diverso, dal più alto ufficiale in grado, all’ultimo degli appuntati, manipolò la verità, la orientò, o, peggio, preferì non vederla per pavidità, ossequio, cinismo, carrierismo. Per omertà di Corpo, se la vogliamo dire con una parola sola. (…) Onu accusa Israele dicrimini di guerra contro manifestanti palestinesi a Gaza “I militari israeliani hanno violato la legge internazionale. Alcune di queste violazioni potrebbero costituire crimini di guerra o contro l’umanità”, afferma Santiago Canton, presidente della Commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sulle proteste nei territori palestinesi occupati della redazione Gerusalemme, 28 febbraio 2019, Nena News – Le Nazioni Unite condannano Israele per le uccisioni sulle linee con la Striscia di Gaza dei manifestanti palestinesi della Grande Marcia del Ritorno cominciata quasi un anno fa, il 30 marzo. L’indagine svolta da Santiago Canton, presidente della Commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni unite sulle proteste nei territori palestinesi occupati, ha raccolto le prove di crimini contro l’umanità commessi dall’esercito israeliano nel respingere le proteste poiché i cecchini hanno preso di mira bambini e persone facilmente identificabili come operatori sanitari e giornalisti. “I militari israeliani hanno violato la legge internazionale sui diritti umani e del diritto umanitario – afferma
Caton – Alcune di queste violazioni potrebbero costituire crimini di guerra o crimini contro
l’umanità”.
Circa 250 palestinesi sono stati uccisi in 11 mesi durante le manifestazioni lungo le linee di
demarcazione tra Gaza e Israele per chiedere la fine del blocco israeliano e il diritto dei palestinesi
di poter tornare ai loro villaggi di origine. Migliaia sono stati feriti da proiettili e fra questi molti
rimarranno disabili a vita. La commissione ha condotto 325 interviste con le famiglie degli
uccisi, con i feriti, testimoni e altre fonti, esaminando oltre ottomila documenti. Ha inoltre
esaminato filmati girati da droni e altri materiali.
L’inchiesta era stata commissionata dal Consiglio diritti umani dell’Onu e ha indagato sulle
uccisioni avvenute dall’inizio della protesta fino al 31 dicembre. “Oltre 6mila manifestanti
disarmati sono stati colpiti dai cecchini militari sui luoghi delle proteste”, ha aggiunto Caton –
“l’indagine ha evidenziato ragionevoli basi per ritenere che i cecchini israeliani abbiano sparato a
giornalisti, sanitari, bambini e persone con disabilità, sapendo che erano chiaramente riconoscibili
in quanto tali…(sono stati uccisi e feriti palestinesi)…che non partecipavano direttamente alle
ostilità né rappresentavano una minaccia imminente”.
La commissione nel suo rapporto smentisce la narrazione israeliana secondo la quale le
proteste erano volte a mascherare atti di terrorismo. “Le manifestazioni erano di natura civile,
con obiettivi politici enunciati chiaramente” – si afferma nel rapporto – “nonostante alcuni atti di
violenza significativi, la Commissione ha rilevato che le manifestazioni non costituirono dei
combattimenti o campagne militari”. Caton sottolinea che le autorità israeliane non hanno
collaborato all’indagine.
Da parte sua Israele respinge le conclusioni dell’inchiesta dell’Onu. Il ministro degli Esteri,
Yisrael Katz, l’ha definita “ostile, falsa e prevenuta…”Nessuna istituzione – afferma Katz – può
negare il diritto di Israele all’autodifesa e a difendere i propri cittadini e le frontiere dagli attacchi
violenti. Israele respinge quel rapporto”. Nena News
Sul sito di Radio3 mondo “Israele e territori occupati: tempo di
giustizia! 4 marzo 2019
Le testimonianze di Ahmad Azzam e Jannat Salayma, due giovani attivisti di Hebron
che raccontano cosa significa essere nati nella città della Cisgiordania
“Le forze israeliane hanno sparato intenzionalmente contro bambini, operatori sanitari,
giornalisti e persone con disabilità mettendo in evidenza un crudele e spietato disprezzo per il
diritto internazionale umanitario. Oltre 6.000 persone sono state ferite da proiettili veri e
questo ha messo in ulteriore difficoltà il sistema sanitario di Gaza già allo stremo”. Con queste
parole il vicedirettore di Amnesty International per il Medio Oriente e l’Africa del Nord Saleh
Higazi ha commentato il nuovo rapporto realizzato da una commissione
d’inchiesta delle Nazioni Unite, secondo le quali le forze israeliane potrebbero aver
commesso crimini di guerra durante le proteste di Gaza dello scorso anno, anche sparando
intenzionalmente contro civili palestinesi. Nel tentativo di trovare una soluzione pacifica, ogni
anno i Palestinesi di Hebron promuovono in tutto il mondo una campagna, della durata di una
settimana, per chiedere la fine della occupazione israeliana e degli insediamenti coloniali che,
per le modalità con le quali sono promossi, rientrano nella fattispecie dei “crimini di guerra” di
cui al comma 4 dell’Art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Quest’anno la
Settimana Open Shuhada Street va dal 23 Febbraio al 6 Marzo e proprio per questo avremo in
studio due giovani di Hebron che racconteranno cosa significa essere nati nella città della
Cisgiordania che sorge nella zona detta C e che, secondo gli Accordi di Oslo, dovrebbe essere
sotto il totale controllo militare, politico ed amministrativo dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Ma non è così.
Lunedì 4 marzo alle 11.00 Laura Silvia Battaglia ne parlerà con Ahmad Azzam e
con Jannat Salayma, poco più che adolescenti, nati e cresciuti a Hebron. Ascolta L’AUDIOSave The Children: tre ragazzi su cinque vittime di bullismo, tutti contro gay, neri, obesi e rom Sondaggio tra gli studenti, nove su dieci hanno assistito a episodi di discriminazione nei confronti dei loro coetanei. Solo un adolescente su venti si rivolge ai docenti Omosessualità, appartenenza alla comunità rom, obesità, essere neri: sono le etichette per cui le persone rischiano di essere discriminate, secondo l'80 per cento dei ragazzi che hanno risposto al sondaggio diffuso da Save The Children alla vigilia della Giornata internazionale contro le discriminazioni. L'indagine ha interessato più di 2.000 studenti delle scuole superiori: ne emerge che più di tre ragazzi su cinque vittime sono discriminati, emarginati o derisi dai loro coetanei; nove su dieci sono stati testimoni diretti di episodi contro i loro compagni, soprattutto a scuola. Ai più diffusi motivi di discriminazione seguono il professare la religione islamica, l'essere povero o disabile (lo rivela il 70 per cento degli intervistati). Il sondaggio, realizzato da SottoSopra, il Movimento giovani di Save the Children, con il sostegno dell'Invalsi (ente controllato dal Miur), rientra nell'ambito della campagna nazionale "Up-prezzami" contro gli stereotipi, la prima ideata dagli oltre quattrocento ragazze e ragazzi tra i 14 e i 22 anni impegnati in azioni di sensibilizzazione e cittadinanza attiva in quindici città italiane. Immagine simbolo della campagna è un codice a barre che rappresenta le etichette con le quali si giudicano gli altri in modo superficiale, limitandosi al loro aspetto esteriore: "Non fermarti all'etichetta", è lo slogan. Gli organizzatori chiedono di condividere sui social il simbolo utilizzando l'hashtag #UPprezzami e sfidando i propri amici e familiari a postare foto e video disegnandosi un codice a barre sulla guancia per "liberarsi dalle etichette e a dire no alle discriminazioni". Il 61 per cento degli studenti intervistati - secondo i risultati del sondaggio - ha subìto direttamente situazioni di discriminazione dai coetanei. Tra questi, il 19 cento ha dichiarato di essere stato emarginato ed escluso dal gruppo, il 17 per cento è stato vittima di voci maligne messe in giro sul proprio conto, il 16 per cento deriso e uno su dieci ha subito furti, minacce o pestaggi. Tra chi ha subito discriminazioni, il 32 per cento ha scelto di rivolgersi ai genitori, un altro 32 per cento ha preferito parlarne agli amici, un significativo 31 per cento non si è rivolto a nessuno. Solo un intervistato su venti ha scelto di rivolgersi agli insegnanti: un dato - viene fatto notare - che assume ancor più peso visto che proprio la scuola si configura come il luogo principale (45 per cento dei casi) dove gli studenti assistono a discriminazioni. Segue, come ambito di vessazioni, il contesto della strada (30 per cento) e i social (21 per cento). Tra gli studenti che hanno dichiarato di essere stati testimoni di un comportamento discriminatorio verso un loro coetaneo - quasi il 90 per cento degli intervistati - il 16 per cento ha detto che la vittima era tale perché omosessuale o giudicata grassa, in più di un caso su dieci perché di genere femminile, nel 9 per cento dei casi si è trattato di una discriminazione dovuta al colore della pelle, nell'8,5 per cento a una condizione di povertà economica e nel 7 per cento perché la vittima era disabile. I ragazzi intervistati hanno anche stilato una sorta di classifica di quelle che, per loro, sono le categorie di persone che nella vita rischiano maggiormente di essere discriminate : in testa, per l'88 per cento degli studenti, ci sono le persone
omosessuali, seguite da persone di origine rom e gli individui grassi (in entrambi i cassi siamo all'85 per cento), quindi le persone di colore (82 per cento), di religione islamica (76 per cento), poveri (71 per cento), persone con disabilità (67 per cento), arabi (67 per cento), asiatici ed ebrei (53 per cento per entrambi). L’Onu: "L’Italia viola i diritti umani dei migranti" di Alessandra Ziniti in “La Repubblica” del 2 marzo 2019 Non solo gli episodi di xenofobia, i porti chiusi e l’ostracismo nei confronti delle Ong. Per gli Special rapporteurs dell’Onu, l’Italia « viola i diritti umani e gli obblighi internazionali» in un clima di preoccupanti attacchi verso i difensori dei diritti umani. «Le campagne di diffamazione contro i diritti dei migranti, i loro difensori e le Ong, e la loro criminalizzazione alimentano la xenofobia in Italia», si legge nell’ultima relazione, firmata da ben dieci esperti indipendenti dell’Onu. Che si dicono preoccupati «per le campagne diffamatorie attuate dalle autorità contro i migranti e i difensori dei diritti, compresi i giornalisti che criticano il governo per la gestione dei migranti. E contro gli attori della società civile impegnati in operazioni di salvataggio a mare e nel fornire assistenza umanitaria a terra. Siamo profondamente preoccupati per l’" effetto raggelante" che questi attacchi e misure potrebbero avere sui difensori dei diritti dei migranti e sulla società civile in generale». Un nome su tutti viene citato: quello di Roberto Saviano che, si denuncia nel rapporto, «ha ricevuto minacce verbali da parte del ministro dell’Interno Salvini, relative alla possibile perdita della protezione, subito dopo aver espresso le sue critiche sulla politica anti-immigrazione del governo». (…) Accoglienza, scure sui centri «A rischio 50mila posti» di Stefano Pasta in “Avvenire” del 2 marzo 2019 Valeria Cattaneo, 35 anni di Brescia, è preoccupata. Tra poche settimane sarà licenziata. Alcuni suoi colleghi sono già a casa. «Ho paura – spiega Valeria – per le spese mensili che faticherò a sostenere, ma c’è anche amarezza nel vedere svilito il lavoro su cui in tanti abbiamo investito». Dopo una laurea in Lingua, la futura disoccupata ha conseguito un master in didattica, frequentato corsi di aggiornamento e addirittura scritto dei testi sul tema. Da tre anni insegna italiano ai profughi accolti nel Bresciano. Oggi la sua cooperativa è scesa da 180 ospiti in diversi sedi a una quarantina («Non sono né scomparsi, né rimpatriati», precisa). A breve è prevista una nuova riduzione, per questo ha perso il posto. La nuova sicurezza in salsa gialloverde, quella prevista dalla legge 132 voluta da Salvini, passa anche da qui: il licenziamento di tanti operatori. Sono 50mila quelli a rischio in tutta Italia, secondo la Funzione Pubblica-Cgil; a questi vanno aggiunti i lavoratori assunti in altro modo, come i 75 lasciati a casa dopo la chiusura del centro di via Corelli a Milano, che erano impiegati con il contratto del commercio. Una forza lavoro a maggioranza femminile e prevalentemente giovane. Spiega Maurizio Bove, responsabile Immigrazione della Cisl: «La nuova legge colpisce migliaia di giovani professionisti: insegnanti, psicologi, mediatori culturali, tutti con lauree e master specifici. Con le loro competenze e la loro passione, queste persone stavano provando ad andare oltre l’approccio emergenziale che finora ha caratterizzato l’accoglienza, ma oggi si trovano all’improvviso espulsi dal mercato: non si tratta di mettere fine alla 'mangiatoia', ma di tagliare fondi ad un nuovo settore che poteva caratterizzarsi come un’eccellenza».
Puoi anche leggere