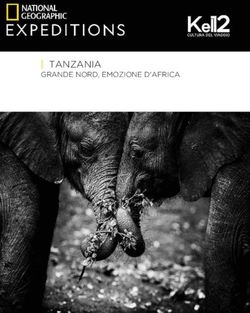Mappe dipinte, mappe narrate: esercizi di deterritorializzazione
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Mappe dipinte, mappe narrate: esercizi di deterritorializzazione
dell’immaginario
Paola Zaccaria
In a blue while, […] once in a blue while
Dionne Brand
1. A partire dalla definizione canonica di ékphrasis come strategia
retorica messa in atto da un medium espressivo – il linguaggio poeti-
co, secondo la definizione più diffusa – al fine di descrivere l’essenza
e la forma di un altro medium, solitamente un’opera visuale, non si
può non convenire che, nonostante millenni di riflessione su questo
termine, e di conseguenza nonostante le evoluzioni della sua applica-
zione e interpretazione, ad oggi:
L’attuale dibattito concernente l’ékphrasis riguarda come meglio limitare ed
espandere il significato della parola per poter continuare a scavare nel lavoro
produttivo che scaturisce dall’investigazione della dialettica parola/immagine.
Questa dialettica è, oggi più che mai, centrale nella discussione contemporanea
che si occupa di teoria dei media. Come Wagner e Heffernan indicano, mentre
il problema parola/immagine si dilata, coinvolgendo sempre più discipline, vi
è un interesse crescente per i modi in cui l’ékphrasis, un termine antico, possa
far parte di una visione moderna1.
Nell’avviarmi in questo percorso teorico-analitico, specifico di non
aver ritenuto necessario riportare le attuali considerazioni sull’ékphrasis2,
dato il ricco e qualificato dibattito recentemente accessibile anche in Italia,
1 R. Welsh, Ekphrasis, in Keywords Glossary, The University of Chicago, Chicago
2007 (http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/ékphrasis.htm).
2 Si riportano alcuni lavori di riferimento in ambito anglo-americano e germanistico:
J. Hollander, The Poetics of Ekphrasis, in «Word & Image», 4 (1988), pp. 209-219; W. J.
T. Mitchell, Ekphrasis and the Other, in Id., Picture Theory, The University of Chicago
Press, Chicago 1994, pp. 151-181; J. D. Bolter, Ekphrasis, Virtual Reality, and the Future
of Writing, in G. Nunberg (a cura di), The Future of the Book, University of California
Press, Berkeley 1996, pp. 253-272; P. Wagner (a cura di), Icons-Text-Iconotexts: Essays
on Ekphrasis and Intermediary, de Gruyter, New York 1996; T. Yacobi, Interart Narrative:
(Un)Reliability and Ekphrasis, in «Poetics Today», 21 (2000); R. Welsh, Ekphrasis, cit.226 paola zaccaria
dove la trattazione di questioni legate all’ékphrasis e alla trasmigrazione
di codici tra arti si sta diffondendo nell’area degli studi letterari e visuali
nell’ultimo decennio grazie alle traduzioni di studi pubblicati, soprattutto
in ambito anglo-americano e germanistico, negli anni Ottanta e Novanta
del Novecento, ma anche grazie alla ricerca disseminata da Michele
Cometa e gli studiosi del progetto “Letteratura e cultura visuale”, che
coniugando teorie anglosassoni, germaniste e francesi, hanno porta-
to il concetto d’intertestualità oltre i recinti della semiotica, apren-
dolo alle declinazioni offerte dallo spazio dell’interdisciplinarietà e
degli studi culturali. Né andrò a riarticolare il legame tra ékphrasis e
intertestualità egregiamente discusso – a partire dai testi canonici di
Kristeva su transposizione e intertestualità, di Genette su transtestua-
lità, di Barthes e Riffaterre su intertestualità3, e di molti altri studiosi
– da studi comparatistici del nostro tempo che si muovono nell’area
dell’interdisciplinarietà, quando non proprio dell’intermedialità.
All’interno della discussione contemporanea, in questo saggio ho
privilegiato la prospettiva dell’intermedial criticism che considera
l’ékphrasis come pratica di scrittura finalizzata a illustrare opere, og-
getti e scene artistiche non esclusivamente per il tramite della codifica-
zione poetica, ma come trascrizione estensibile ad altri generi letterari
e ad altre espressioni artistiche, per esempio: una scultura ispirata a
un personaggio letterario; un film/una danza/performance il cui ipote-
sto, fosse anche un solo verso o nucleo d’ispirazione ecfrastica, ovvero
figura(zione) significativa, è rintracciabile in un’opera letteraria.
Anche in queste pagine sussumerò la posizionalità critica ed erme-
neutica illustrata in precedenti lavori secondo cui la procedura ecfra-
stica è ascrivibile a e/o rintracciabile anche nell’ambito di pratiche di
traduzione, transmediazione, trasposizione4.
3 Alcuni riferimenti: J. Kristeva, Revolution in Poetic Language, traduzione di Margaret
Waller, Columbia University Press, New York 1984; G. Genette, Palinsesti. La lettetteratura
al secondo grado, Einaudi, Torino 1997; V. Robillard, In Pursuit of Ékphrasis: An Inter-
textual Approach, in V. Robillard, E. Jongeneel (a cura di), Pictures into Words: Theoretical
and Descriptive Approaches to Ékphrasis, VU University Press, Amsterdam 1998; M. Rif-
faterre, Compulsory Reader Response: The Intertextual Drive (1990), in M. Worton, J. Still
(a cura di), Intertextuality. Theories and Practices, Manchester University Press, Manchester
1990, pp. 56-78. L’intero volume di Morton e Still contiene contributi notevolissimi.
4 Cfr. P. Zaccaria, Transcodificazioni, Meltemi, Roma 2005; Ead., La macchina da
scrivere, la macchina fotografica, la macchina da presa, in G. Barletta, Machinae. Tecniche
Arti Saperi nel Novecento, Graphis, Bari 2008, pp. 381-428; Ead., Nero su bianco: narra-mappe dipinte, mappe narrate 227
Le ipotesi teoriche e le conseguenti interpretazioni testuali di questo
lavoro muovono dal desiderio di coniugare gli spunti sulla rappresenta-
zione offerti da decine di secoli di analisi delle procedure ecfrastiche con-
dotte da poeti, artisti e studiosi di culture ancor oggi egemoniche, con le
produzioni creative e teoriche di poeti, artisti e studiosi alterNativi5 ri-
spetto alle comunità culturali a discendenza eurocentrica. Il tutto si col-
loca in un processo ermeneutico di conoscenza che richiede innanzitutto
la ricerca di varchi – a volte può trattarsi di piccole crepe – che aiutino sia
a decifrare segnature della differenza dentro testualità narrative di autori
e autrici discendenti dalla diaspora africana che ho appena definito alter-
Nativi, sia a comprendere se e come il Middle Passage (quel movimen-
to diasporico imposto da uno strappo inciso dal dominio colonialistico
tramite il sistema della schiavitù che la mia strategia critica geo-politica
mostra in qualche modo correlata, se non fondativa, delle dinamiche che
portano all’attuale movimento di attraversamento del Mediterraneo da
parte dei migranti che partono dall’Africa), sebbene indiscutibilmente
agito come strategia di violenza imperiale e oppressione geopolitica nei
confronti dei colonizzati, degli schiavizzati, dei marginalizzati, dei senza
potere e senza appartenenze6 purtuttavia involontariamente produceva,
oltre alla creolizzazione dei corpi e delle culture, il proliferare di incroci
tra stili e linguaggi intessuti di tracce di immagini e ritmica sconfinanti,
indecidibili che, consapevolmente oggi, nei discendenti della diaspora e
della colonizzazione, si esprimono nell’ideazione di strategie intermedia-
li, multimediali, transculturali e jammed.
Il mio interesse per un certo tipo d’interazione tra le varie arti
che s’incarna, a partire dalla pratica ecfrastica, in una relazione di
reciprocità, di jamming e integrazione chiamata, a seconda dei casi,
zione e fotografia nella (contro)sfera pubblica, in S. Albertazzi, F. Amigoni, Guardare oltre.
Letteratura, fotografia e altri territori, Meltemi, Roma 2008, pp. 31-49; Ead., Ripresa
(cine)fotografica e/come traduzione: il caso Nuovo Mondo, in L. Perrone Capano (a cura
di), Il testo oltre i confini, Palomar, Bari 2009, pp. 173-207.
5 Questa grafia è strumentale per designare le identità culturali nord-americane e ca-
raibiche non riconducibili a migrazioni né assimilabili ai colonizzatori, ovvero (I) i nativi
comunemente chiamati red-skins, pellerossa; (II) i messico-americani definiti colored, as-
soggettati a metà Ottocento attraverso l’annessione delle terre del Sud-Ovest americano di
cui gli indios erano legittimi abitanti; (III) i discendenti degli schiavi, un tempo chiamati
niggers e negroes, oggi africani americani, trasportati con il sistema della la tratta nel corso
di quattro secoli.
6 S. Mezzadra, La condizione postcoloniale, ombre corte, Verona 2008; A. Sayad,
L’immigrazione o i paradossi dell’alterità, ombre corte, Verona 2008.228 paola zaccaria
ri-mediazione, intermedialità, trasmigrazione di codici, transcodi-
ficazione, interferenza, discende, in qualche modo inevitabilmente,
dalla frequentazione di testualità transculturali (siano esse letterarie,
visuali, musicali o plastiche), originatesi nelle contact zones – intese
non solo in senso prattiano come compresenza di più culture in uno
spazio comune determinata dall’incontro coloniale7, ma anche come
con-tatto/con-(t)agio/con-versazione che nel mondo odierno si crea a
causa dei flussi e della mobilità dei corpi e quindi dei mescolamenti
di culture in zone di contatto che non sono permanenti, ma possono
essere transitori, instabili – come discontinuo e fluido è lo statuto dei
media attraverso cui le transculturazioni si esprimono.
È stato dunque il mio orizzonte d’interesse per le produzioni ar-
tistiche delle zone di contatto che mi ha messo tra le mani e sotto gli
occhi testi che Brian McHale sosterrebbe muoversi, dal punto di vista
postmodernista, in una «intertextual zone»8 – testualità per le quali mi
è parso che l’approccio critico intermediale fosse una via, una modalità
che avrebbe aiutato se non proprio ad aprire, scoprire lo stretto in-
treccio di codificazioni letterarie, visuali e plastiche, almeno a cogliere
alcuni dei motivi e dei fili del disegno, e l’ékphrasis è certamente una
delle modalità al cuore, nel cuore di questo tipo di produzioni.
Aggiungo che ho ritenuto strumentale derivare, entro questo
frame di riferimenti testuali, culturali e visuali, il termine geocor-
pographies da Joseph Pugliese in quanto funzionale per «mettere a
fuoco l’intreccio (enmeshment) violento della carne e del sangue del
corpo con la geopolitica di razza, guerra ed impero»9, e tuttavia si è
reso necessario integrare il “violento intreccio” del corpo con razza,
guerra e impero, con due ulteriori coordinate omesse da Pugliese: ge-
nere e potere (anche se il potere è implicito in razza, guerra e impero,
va nominato), al fine di allargare «l’enfasi posta su questioni formali
alle questioni culturali e storiche di potere e genere, entro una pro-
spettiva che si rifà sia alla semiotica sia al post-strutturalismo» 10.
7 M. L. Pratt, Imperial Eyes: Studies in Travel Writing and Transculturation, Routled-
ge, New York 1992.
8 B. McHale, Postmodernist Fiction, Routdledge, London 1991, p. 56.
9 J. Pugliese, Geocorpographies of Torture, in «Australian Critical Race and Whiteness
Studies Association Journal», 3.1 (2007), p. 1 (http://www.acrawsa.org.au).
10 Cit. dalla proposta dei curatori per il seminario “Word-image: (Re)defining inter-
medial criticism”, a cura di L. Louvel, L. Petit, P. Brinzeu, Convegno ESSE 2012, Istanbul,
all’interno del quale ho presentato un intervento che conteneva in nuce il presente lavoro.mappe dipinte, mappe narrate 229
Il cultural turn dei primi anni Novanta richiese un approccio cri-
tico alle produzioni visuali e letterarie che faceva ricorso a una meto-
dologia che assemblava, come dichiarò Liliane Louvel nel suo saggio
sulla fotografia, sia i preziosi strumenti eurocentrici offerti dalla di-
mensione intertestuale così come posta da Genette, sia le questioni
poste dal pensiero occidentale post-coloniale circa il transnazionali-
smo e postcolonialismo11.
Data la complessità culturale dei testi di cui mi occupo, mi è parso
necessario integrare quel bagaglio di strumenti, connettendo l’eredità
critica cui fa riferimento Louvel alla ricchezza teorica che emerge da
lavori prodotti a partire dal complesso intreccio tra radici e movimen-
to (inglese: roots e routes), frontiere e barriere, stadi della coscienza e
stadi della creatività ad opera di pensatori, studiosi, artisti dell’altro-
ve e/o dell’altrimenti culturalmente segnati, come appunto quelli che
ho definito alterNativi riferendomi alle Americhe, ma anche come i
cosiddetti soggetti migranti che oggi ci mettono nelle mani e sotto
gli occhi scritture, segni e visioni in cui l’altrove si coniuga al qui.
AlterNativi delle Americhe e migranti di ogni Sud mettono in sce-
na interessanti pratiche di sperimentazione che si concreano in spazi
di de-colonizzazione nonostante il neo-colonialismo e le formazioni
neo-schiavistiche nelle Americhe, nell’Africa e in ogni dove, come ad
esempio le neo-slave narratives, ovvero le ri-scritture della schiavitù
e delle sue conseguenze nel presente. Siamo di fronte a produzioni
artistiche che, svelando peraltro l’impossibilità del modello multi-
culturale, offrono la novità di testualità che a livello di formazioni
artistiche implicano il ricorso alla multi-medialità, cross-medialità,
inter-medialità e che allo stesso tempo propongono la sperimentazio-
ne di nuovi modelli di convivenza e creatività attraverso le modalità
dell’interculturalità, creolizzazione, transculturazione.
Alcune straordinarie intuizioni della scrittrice e pensatrice visio-
naria messico-americana Gloria Anzaldúa sul rapporto tra parole e
immagini, immaginazione e creazione artistica ricollegabili a tracce
di epistemologie indigene (che tuttavia a volte s’intrecciano a sentori
di studi europei sull’inconscio e sull’inconscio collettivo) penetrano le
strettoie del pensiero di derivazione coloniale eurocentrico e aprono
11 L. Louvel, Photography as Critical Idiom and Intermedial Criticism, in «Poetics
Today», 29.1 (2008), pp. 31-48.230 paola zaccaria
prospettive teoriche e critiche circa l’immaginazione trasformativa
che mi fanno da guida nell’interrogazione di procedure insolite messe
in campo da artiste alterNative, come per esempio la scrittrice afri-
cana caraibica canadese Dionne Brand e l’artista, docente e promo-
trice di arte pubblica nativa americana con ascendenze francesi-Cree
e Shoshona, Jaune Quick-to-see Smith: entrambe, seppure attraverso
media e tecnologie differenti – rispettivamente scrittura letteraria e
scrittura pittorica – lavorano sulla ri-articolazione del concetto e del-
la scritturazione-trascrizione di mappe.
Riporto qui, a mo’ d’introduzione alle concezioni e metodologie
della creazione artistica alternativa, tre citazioni da opere di Anzaldúa:
Le immagini sono più dirette, più immediate delle parole, più vicine all’in-
conscio. Il linguaggio delle immagini precede il pensare articolato in parole12.
Quando scrivo, per organizzare il mio pensiero, abbozzo immagini. Per
quanto mi riguarda, schizzare mi è più d’aiuto che buttar giù uno schema.
Un’immagine vale mille parole perché c’è un gruppo di significati associati a
ciascuna immagine e a ciascuna cosa che disegno. C’è differenza tra le persone
che usano un pensiero razionale e quelle che usano immagini visive o chi usa
immagini sensoriali per organizzare i propri pensieri. Le immagini ci parlano13.
Spesso, una poesia o una storia prima ancora […] di raggiungere la mente,
ha già attivato l’immaginazione. È possibile sentire e provare cose non solo in
modo visivo e cinestetico, ma con tutto il corpo e la mente. […] il corpo non
distingue tra ciò che accade nell’immaginazione e ciò che accade nel mondo
materiale […]. Ciò che accade nell’immaginazione non è finzione14.
Nel caso della scrittura di Dionne Brand sto enucleando una let-
tura che intreccia teorizzazioni alterNative con il concetto di notio-
nal ékphrasis, pratica in qualche modo accostabile a quegli stadi di
coscienza che Anzaldúa ritiene ricollegabili al mondo dell’immagi-
nazione. Difatti, a partire dalla definizione di Hollander della notio-
nal ékphrasis come descrizione o rappresentazione di quei processi
mentali che riguardano il pensiero immaginativo, e quindi anche la
12 G. Anzaldúa, Borderlands/La Frontera (1987); trad. it. di P. Zaccaria, Terre di con-
fine/La frontera, Palomar, Bari 2000, p. 110.
13 G. Anzaldúa, Creativity and Switching Modes of Consciousess (1986), in A. Keating
(a cura di), The Gloria Anzaldúa Reader, Duke University Press, Durham (NC) 2009, p. 107.
14 Ivi, p. 108. Il corsivo è mio.mappe dipinte, mappe narrate 231
descrizione di un’opera d’arte immaginaria, la critica visuale ha co-
minciato ad usare il termine in riferimento a: «processi mentali come
i sogni, i pensieri e le fantasticherie dell’immaginazione».
Sia il procedimento d’abbozzare, prima della messa in scrittura,
l’opera letteraria in nuce nella forma del disegno (come ci racconta
Anzaldúa nella citazione 2), sia la consapevolezza della scrittrice che
le formazioni letterarie sono attivate dall’immaginazione (citazione
3), ovvero che allo stadio aurorale la letteratura è immagine e che di
conseguenza il linguaggio discende dalla formazione d’immagini at-
tivate non solo dalla vista, ma dalle percezioni sensorie, ossia da tutti
i sensi (citazione 1 e 3), sono procedure in qualche modo accostabili
alla definizione di ékphrasis come «un’arte che descrive o dipinge
un’altra opera d’arte che fino a quel momento è ancora in uno stato
incompleto di creazione, in quanto il lavoro descritto potrebbe an-
cora essere a riposo nell’immaginazione dell’artista, prima che questi
dia inizio al suo processo creativo»15.
15 J. Hollander, The Gazer’s Spirit, Poems Speaking to Silent Works of Art, University
of Chicago Press, Chicago 1995. Per un’esaustiva illustrazione del dibattito anglo-ameri-
cano del Novecento sull’ékphrasis cfr., di Federica Mazzara, Il dibattito anglo-americano
del Novecento sull’ékphrasis in Intermedialità ed Ékphrasis nel Preraffaelitismo. Il caso
Rossetti, Università di Napoli, Napoli 2007, pp. 1-70; l’autrice, considerando la specifici-
tà dell’ékphrasis nozionale rispetto all’ékphrasis tout court, conclude: «Le due differenti
tipologie comportano ovviamente l’applicazione di una diversa modalità descrittiva, poi-
ché avere un referente pittorico (o scultoreo) reale, di cui è potenzialmente a conoscen-
za lo stesso lettore, incide nella stessa produzione e ricezione del testo. Inoltre, mentre
l’ékphrasis nozionale mette in gioco l’abilità creatrice della parola, quella mimetica sposta
l’attenzione verso la questione della riproduzione e ri-rappresentazione, con una tecnica
quasi di mise-en abyme, che pone a confronto le abilità dei due mezzi espressivi e, come ha
precisato Heffernan, ci consente di vedere come le parole del poeta cerchino di acquisire
superiorità rispetto all’immagine del pittore» (ivi, nota 187, pp. 62-63). Mazzara aggiunge
quindi che: «Qualsiasi ékphrasis, dunque, gioca inevitabilmente nel terreno della limi-
nalità, poiché è una descrizione che tiene viva la sua coscienza narrativa, che evoca una
dimensione spaziale pur rimanendo connessa alla temporalità del suo mezzo, ed inoltre
esprime il desiderio di passare dall’arbitrarietà del suo segno alla trasparenza del segno
naturale. Questa sintomatologia variegata spiega anche la flessibilità della diagnosi ecfra-
stica e, dunque, il fatto che il termine ékphrasis si presti a più definizioni, a volte anche
contrastanti. Nella moderna teorizzazione c’è di base da un lato il referente artistico, e non
importa se reale o immaginario, ciò che conta è che utilizzi un mezzo espressivo diverso da
quello verbale nella rappresentazione o ri-presentazione di un evento. Dall’altro lato, una
voce poetante o narrativa che ripropone attraverso il suo mezzo artistico quell’oggetto, o
meglio la sua immagine: come i suoi “occhi” la vedono. La sua voce può animare quell’og-
getto o lasciarlo nella sua immobilità plastica, in ogni caso chi descrive proietta se stesso, la
sua immaginazione e la sua esperienza nella cornice verbale che sceglie per il suo “ritratto232 paola zaccaria
Dal momento che l’espressione notional ékphrasis si può appli-
care, sostiene Hollander, anche «ad un’arte che descrive l’origine di
un’altra arte, come è stata creata e le circostanze che pertengono
all’atto di creazione», essa mi permette di provare a considerare il
lavoro sulle mappe condotto tramite il medium verbale e plastico
dalle due artiste di cui mi occupo come pratica di riarticolazione del-
la forma-scrittura “mappa” e, nel caso del testo di Brand A Map to
the Door of no Return. Notes to Belonging (2001) – inclassificabile
entro le griglie offerte dalla critica letteraria sia rispetto al genere sia
rispetto alla codificazione verbale – sto sondando se considerare la
sua forma espressiva come una trans-mediazione a doppio senso tra
immagini e parole, processo che potrebbe peraltro discendere dalla
condizione e dall’immaginazione diasporica, articolata, nel suo caso,
intorno ad una costruzione al contempo reale, immaginaria e imma-
ginata: la porta del non ritorno16.
L’accostamento del lavoro pittorico di ri-mappature, condotto esat-
tamente sul passaggio di secolo, intorno al 2000, dall’artista nativa
americana Jaune Quick-to-see Smith (in particolare alcune opere del
2000 collegabili al dipinto intitolato State Names), al lavoro letterario
del 2001 della scrittrice caraibica africana canadese Dionne Brand, sol-
leva innanzitutto questioni circa la destrutturazione, immaginazione e
riarticolazione di mappe non delimitatorie ad opera di artisti e autori
non propriamente bianchi non propriamente di origine europea.
Se l’istituto della colonizzazione sceglieva come scrittura del viag-
gio e dell’appropriazione la grafia del mappare – incidendo la traccia
del percorso, corografando, ovvero disegnando contorni e confini dei
ecfrastico”. In questo probabilmente consiste il vero fascino dell’ékphrasis, nell’essere cioè
una questione circondata da mille specchi, pronti a riflettere diverse possibilità interpreta-
tive» (ivi, p. 64. Il corsivo è mio).
16 “Porta del non ritorno” è il nome dato alle fortezze costruite lungo la costa ovest dell’A-
frica dove gli schiavi venivano trattenuti al loro arrivo dall’entroterra in attesa di partire per un
luogo di cui non conoscevano neanche il nome. È dunque il luogo che simbolicamente butta
milioni di corpi africani nel Middle Passage, ovvero nella schiavitù. Simboleggia il primo passo
nello stato di diaspora, uno luogo di disperazione e terrore. Come spiega Daniel Wideman:
«Il buco scavato nella roccia che i prigionieri africani attraversavano per andare dal forte alla
nave, dalla prigione alla stiva, dalla terra al mare, dalla patria all’esilio, era conosciuto a livello
locale come la porta del non ritorno perché di nessuno di quelli che venivano condotti attra-
verso quella porta si aveva più notizie. Nessuno era mai ritornato. Era il cancello verso l’oblio»
[D. J. Wideman, The Door of No Return?: A Journey through the Legacy of the African Slave
Forts an Excerpt, in «Callaloo» 21.1 (1998), pp. 1-11, qui p. 1].mappe dipinte, mappe narrate 233
territori, e quindi sottolineando appartenenze ed esclusioni, proprie-
tari e sottoposti17 – quelle grafie, ricreate dai geografi e cartogra-
fi a casa, nei vari paesi europei, venivano trasformate in mappe ed
esposte nelle case dei cittadini comuni e a ciascuno, e dunque anche
ai letterati, era dato di visualizzare lo spazio della conquista, l’altro-
ve “primitivo” rispetto alla immagine culturale rinascimentale che
l’Europa aveva di sé – era possibile immaginare, sognare, tradurre
l’altrove in racconto (si pensi al caso più conosciuto, l’opera teatrale
La tempesta (1611), di William Shakespeare, che essendo appunto
destinata alla messa in scena, raggiungeva un pubblico vasto di sud-
diti dell’impero, anche quello meno alfabetizzato) o in pittura (un
esempio: i dipinti seicenteschi di Vermeer, la gran parte rappresentan-
ti interni con donne, offrivano allo spettatore una costante: la veduta
di grandi mappe geografiche alle pareti – un caso esemplare dell’in-
termediazione delle mappe geografiche coloniali nella vita domestica
e pubblica della piccolo città di Ghent –, per cui oggi è possibile
storicizzare, attraverso i segni della pittura, la presenza e dunque la
conoscenza del sistema della colonizzazione nella vita privata e pub-
blica di un piccolo centro europeo).
Se i racconti di viaggio e le cartografie trasmigravano e trasmi-
grano nell’arte figurativa e nella letteratura, che segnatura può in-
cidere l’autore e l’artista post-coloniale, post-moderno, consapevole
delle inevitabili traduzioni, intermediazioni e transculturazioni, per
rimemorare e al contempo rinnovare, spostare, dissipare la cappa
ideologicamente ancora imperialistica della mappatura come appro-
priazione dell’altrove ed espropriazione dei nativi e degli alterNativi?
Naturalmente questo scenario richiede agli studiosi che si occupa-
no dei rapporti tra arti, segni e potere, di tener conto delle geo-cor-
17 Nel libro precedente di Brand, il romanzo At the Full and Change of the Moon
(Grove Press, New York 1999), ci sono pagine straordinarie sul differente modo di con-
cepire la cartografia da parte dei colonizzatori (per i quali «una mappa può solo descri-
vere la volontà dei proprietari terrieri e dei governatori», p. 52) e le mappe “soggettive”
degli schiavi fuggiaschi ribelli (maroons) in cerca di luoghi di libertà, in cui «i confini si
muovono incessantemente» (ibid). Queste mappe, incise nella polvere e nelle narrazioni,
disegnano spiagge, baie, oceani, correnti e maree notturne per cercare di capire quali sono
i punti da cui ripartire. In uno dei reiterati passaggi in cui Brand narra di questa differente
cartografia-mondo, leggiamo: «tutti i suoi avvistamenti – di Kamena, il maroon – erano
sepolti in una terribile poesia»; la sua cartografia instabile insegue odori, «stracci di storie,
suggestioni di direzioni possibili» (ivi, p. 54).234 paola zaccaria
pografie e delle politiche normativizzanti imposte ai generi sessuali e
ai generi artistici: si tratta di cogliere come i corpi dei soggetti dislo-
cati, i corpi delle donne in processo di decolonizzazione ad esempio,
scrivono e sono scritti in rapporto alle traversata atlantiche di ieri, e
dentro geo-corpografie post-coloniali e neo-colonialistiche mediter-
ranee oggi. Per quanto mi riguarda, considero queste testualità come
contro-cartografie che registrano smottamenti tra culture, tra generi,
tra discipline e tra media e così facendo deterritorializzano anche il
concetto di nazione; sono convinta che allentando le separatezze tra
i linguaggi della creatività imposte dai cartografi del canone e delle
discipline, si contribuisca a ridisegnare nuovi no-borderscapes che
aprono passaggi attraversabili, in grado di creare nuove relazioni,
nuove pratiche, nuove politiche, nuove poetiche – cartografie che
abilitano yes-transpassing zones.
Posizionalità critiche innovative lanciano interrogazioni circa
se e come la mobilizzazione modifichi mitologie, geo-grafie, nar-
razioni, linguaggi, poetiche. Nel confronto tra le carte disegnate/
immaginate da Smith e Brand e le cartografie della storia coloniale,
si apre uno spazio di discontinuità rappresentativa che consente al
lettore/spettatore di ripensare le narrazioni retoriche e rapinatrici
delle cartografie cui siamo stati “addestrati” fin dalle scuole prima-
rie, spacciandole come neutre e veritiere – consente cioè di coglie-
re nelle rappresentazioni degli atlanti geo-politici non l’oggettiva
trascrizione dello spazio, ma l’intervento del desiderio di potenza
e dunque l’attivazione dell’immaginazione colonialistica. Tenendo
presente quello che Edward Soja e Barbara Hopper c’insegnano in
The Spaces That Difference Makes: «Tutte le geografie reali sono
immaginate e tutte le geografie immaginate sono reali»18, l’immagi-
nazione geografica è all’opera nelle produzioni artistiche, ma anche
era/è all’opera nella costruzione di bordi e limiti di vecchi e nuovi
colonialismi ed espansionismi.
Disdicendo l’opinione comune circa la scientificità e obiettività
del linguaggio cartografico (per cui la demarcazione dei confini del-
lo spazio occupato dai vari imperi nel Nuovo Mondo o in Africa e
Asia veniva ad essere una marchiatura della spartizione dei territori
18 E. Soja, B. Hooper, Some Notes on Geographical Margins of the New Cultural Po-
litics, in M. Keith, S. Pile (a cura di), Place and the Politics of Identity, Routledge, London
1993, p. 196.mappe dipinte, mappe narrate 235
tra potenze europee) che si spacciava per rappresentazione realistica
dello spazio – oggi, le tecnologiche riprese satellitari dello spazio han-
no inconfutabilmente dimostrato che lo spazio è incessantemente in
trasformazione –, sottacendo che in quello spazio la geografia umana
e la sovranità era stata stravolta dalla colonizzazione ed espropriazio-
ne, le pratiche artistiche e letterarie di Quick-to-see e Brand inscenano
testualità trasudanti gocciolamenti che raccontano dello scorrimento
senza soluzione di continuità tra storia→realtà→immagi(nazione)→vi
sione→visualità. Le loro contro-mappature non solo disegnano nuovi
tracciati, ma offrendo nuovi percorsi performano un altro modello di
occupazione dello spazio, ovvero un’abitabilità in cui ci si riappropria
di tracce di concezioni spaziali native (Quick-to-see)19 e africane pre-
colonialistiche (Brand) e le si immette in spaziature mediali – il dipinto,
nel caso di Quick-to-see; il libro per Brand – che diventano spazi car-
tografici fluttuanti, ariosi, unbounded, slegati dalla dicotomia dentro/
fuori; centro/margini; metropolitano/tribale.
2. Mappe disorientanti
Mi sto avviando in questo territorio d’analisi testando le loro ope-
re, cercando di capire se e come gli icono-testi liquidi di Quick-to-see
Smith e le mappe deterritorializzate dipinte attraverso il linguaggio
ecfrastico fondato sui nuclei della mappa, del mare, del viaggio di
Brand, producano una crepa negli steccati imposti dalle differenti
tecnologie dei generi e codici (letterario e plastico; verbale e visuale;
storico-politico e artistico; etc.) e di/tra i generi sessuali, e così facen-
do disseminano narrazioni/mappature che disdicono il nazionalismo
e pongono sotto i nostri occhi l’ineludibile constatazione che i corpi,
le storie e i segni di soggetti e popoli in movimento si dibattono per
non restare per sempre marchati dalla violenza geopolitica, territo-
riale, sia essa locale o transnazionale.
19 Smith spiega così il concept da cui discende la sua serie di mappe: «Siamo i veri pro-
prietari della nazione. La nostra terra ci fu rubata dagli invasori euro-americani […]. Non
riesco a dire con abbastanza forza che le mie mappe raccontano di terre rubate, il nostro stes-
so patrimonio, le nostre culture, le nostre visioni del mondo, il nostro essere… Ogni mappa
è una mappa politica e racconta una storia – che siamo vivi ovunque in questa nazione» (J.
Sasse, Postmodern Messenger, Tucson Museum of Art, Tucson (AZ) 2004, p. 8).236 paola zaccaria
In Tribal Map 2001 # 2 (2000), per esempio, non solo Quick-to-
see Smith intende ricordare che le terre americane un tempo erano
abitante da innumerevoli popoli nativi, ma che oggi la bandiera ameri-
cana – simbolo della nazione che è divenuta tale espropriando i nativi
– oscura e tacita la relocation, la ricollocazione forzata dei nativi in
riserve. Ecco che i colori degli stati delimitati dal segno colonizzatore
a seguito dell’annessione di territori sottratti ai nativi, gocciolano20,
si sversano, disdicendo confini e confinamenti, oppure, come accade
per State Names (2000), vengono inclusi i nomi di stati che derivano
da parole native americane, come Wyoming, una parola degli indiani
Delaware che significa “montagne e vallate che si alternano”; Kansas,
da una parola Sioux che significa “popolo del vento del Sud”; Ohaio,
dal nome irocchese del fiume che l’attraversa, che significa appunto
“grande fiume”, etc. In Giving Thanks (2000), invece, la mappa del
nuovo mondo esiste come traccia sbiadita sullo sfondo di una cami-
ciola nativa, e non porta i nomi degli stati così come denominati dagli
occupanti, ma lo spazio porta le inscrizioni: “le piante”, “i fiori”, “le
montagne”, “l’acqua”, “la terra”, ovvero gli elementi della geografia
naturale facenti parte del territorio al tempo in cui il territorio era la
sacra terra nutrice – cioè l’artista ri-immette in circolazione, sottopone
allo sguardo dell’osservatore, il lessico attraverso cui la terra era nomi-
nata nella cosmografia sacra indigena.
Si coglie nelle operazioni di Smith un caso di ékphrasis rovescia-
ta: un’opera visuale rimedia dalla nomenclatura verbale le parole
per dire di un altro tempo, un’altra storia, un’altra cultura, un’altra
mappatura e queste parole, trascritte col pennello, sono decorative e
connotative allo stesso tempo: Mary Priestly21 definisce questo tipo di
tecnica: «una miscela di pittografie narrative, forme astratte e colori
cangianti». La pittografia nativa (disegni di figurine e simboli presenti
nell’arte nativa delle origini) viene rimediata nella trascrizione di nomi
pregnantemente simbolici per la cultura nativa, ma trascritti nell’alfa-
beto e lingua della cultura anglo-americana – come si sa, la scrittura
alfabetica non era praticata dai nativi nord-americani –, insieme alla
rimediazione dei petroglifici, ovvero immagini incise sulla roccia: in
20 Cfr. L. Carbonara, Textos vivos, la rappresentazione dell’identità da Jaune Quick To
See Smith a Victor Cartagena (http://www.artsob.it/tag/jaune-quick-to-see-smith).
21 M. Priestly, Grey Canyon and Friends Contemporary American Indian Art, Portland
Art Museum, Portland 1981.mappe dipinte, mappe narrate 237
alto, la tunica è protetta da due volti con fattezze animali. La scrittura
petroglifica era, per la cultura nativa, non tanto espressione artistica,
quanto documentazione di eventi sacri. Le due immaginette a destra
e sinistra della tunica-mappa sembrano segnalare che, all’origine, la
terra che fa da sfondo alla tunica era cartografata in una scrittura pe-
troglifica e pittografica che è ancora lì, nel 2000, a raccontare della
sopravvivenza di radici culturali dentro i territori sottratti ai residenti
e “bonificati” dai colonizzatori. La sopravvivenza di queste segnature
native viene garantita da un particolare humus umido che deriva pro-
prio dallo sgocciolamento: sul fondo della mappa/dipinto si forma una
pozza creata dalle gocce dei colori di mappa e tunica, ed in questa umi-
dità, serra di coltura, si riproducono gli animali sacri di terra e acqua:
lucertole, serpenti, pesci.
Le tuniche o camiciole riportano in presenza – ricordano al pre-
sente e ai presenti – le war-shirt (camicie di guerra; bellissima visiva-
mente quella rappresentata in un dipinto del 1992 intitolato appunto
War shirt) o i regalia (vestiti da cerimonia) o i ghost-dance dresses
(le tuniche usate per la cerimonia sacra nata intorno alla fine dell’Ot-
tocento per invocare la rinascita del mondo nativo)22, oltre che gli
animali, e gli elementi naturali (come il tuono, il vento, la luna e il
sole, etc.). Le pittografie presenti nelle camiciole-mappe, usate come
elementi decorativi, sono simboli che alludono ai poteri posseduti o
alle azioni speciali compiute da chi le indossava, come nel caso delle
camicie di guerra, oppure alla forza delle donne e agli aspetti sacri
dei rituali, nel caso dei vestiti per le ghost-dance (Giving Thanks).
Ma questo re-surfacing di segnature della sua genealogia culturale,
non ancorano l’artista contemporanea alla dedizione a recuperare
l’“autenticità” della tradizione: lei stessa definisce le sue operazioni
“arte nomade” in quanto passa da un medium ad un altro, e fa uso di
svariati materiali. La biografia di Quick-to-see Smith composta per il
National Museum of Women in the Arts, recita:
Profondamente connessa alla sua eredità culturale, Smith crea opere che si
riferiscono ai miti dei suoi antenati nel contetso di questioni che riguardano
gli Indiani di oggi. Lavora con la pittura, con il collage, e con un’immaginario
appropriato, usando una combinazione di immagini rappresentative e astratte,
confrontandosi con argomenti quali la distruzione dell’ambiente, l’oppressio-
22 Cfr. R. D’Aniello, Il dizionario degli indiani d’America, Newton Compton, Roma 1999.238 paola zaccaria
ne governativa delle culture native, e i miti invasivi dell’egemonia culturale
euro-americana. Traendo ispirazione nelle innovazioni di artisti quali Pablo
Picasso, Paul Klee, e Robert Rauschenberg, così come nell’arte tradizionale
nativa, Smith si vede come «un precursore, una mediatrice e una costruttrice
di ponti. La mia arte, la mia esperienza di vita, e i miei legami tribali sono to-
talmente intrecciati. Vado, con dei messaggi, da una comunità all’altra e cerco
di illuminare le persone»23.
Con lei, come per Dionne Brand, siamo in presenza di straordi-
narie traghettatrici di spezzoni di narrazioni culturali antropologiche
visuali e letterarie, o meglio visual-letterarie, nel presente: nel caso di
Smith c’è una rivisitazione della simbologia visuale di antiche conce-
zioni, in parte disperse, circa lo spazio e il sentimento di comunità;
nel caso di Brand, ad esempio, il libro A Map to The Door of No
Return non è suddiviso in capitoli, ma in brevi sezioni i cui titoli
– assecondando un movimento ondivago che ricorda il flusso delle
correnti marine, ma anche il flusso circolare del tempo nella memoria
– riaffiorano più in là per trasportare sempre un po’ oltre contenuti e
sensi che tuttavia restano per sempre incompleti, monchi, mai satu-
rando la rappresentatività e il requisito tradizionale della letteratura
come costruzione di un ordine, ma andando oltre i limiti della rap-
presentazione. Inoltre, la forma delle testualità di queste due autrici
porta indizi, quando addirittura non si presenta come ri-mediazione,
di opere visuali e letterarie cosiddette moderniste, ovvero ideate da
artisti e scrittori che ritenevano concluso il ciclo dell’opera d’arte
come rappresentazione del reale: Picasso e le avanguardie europee
e americane in Jaune Quick-to-see; Virginia Woolf e le avanguardie
euro-americane e di discendenza afro del Nuovo Mondo in Brand.
Le loro scritture portano i segni della traduzione di culture e me-
dia, ovvero della transmediazione e transculturazione, processo che
per Fernando Ortiz (1940) indicava la perdita di parte del bagaglio
culturale originario (deculturazione), l’acquisizione di elementi di una
nuova cultura (acculturazione) e la creazione di un nuovo fenomeno,
definibile come neo-culturazione. Ma non si tratta, nel loro caso, di
adesione alle spinte moderniste, né di post-modernismo, in quanto il
loro tipo di testualità non lavora «all’interno delle opposizioni mo-
23 Cfr. http://www.nmwa.org/explore/artist-profiles/jaune-quick-see-smith.mappe dipinte, mappe narrate 239
derniste tra cultura e arte, o civilizzazione»24, ma anzi si propone di
smontare i binarismi riposizionando, sulle mappe di territori un tempo
periferia di imperi, pitto-grafie e pittogrammi che nel mentre rievocano
la topografia di paesaggi che si riferiscono alla storia del passato trami-
te un collage di materiali vari, tra cui anche, nel caso di Quick-to-see
Smith, frammenti di mappe degli USA, disegnano, come avviene in
Indian, Indio, Indigenous (1992), ad esempio, un paesaggio transcul-
turale e transmediale che impasta immagini astratte con immagini più
apertamente rappresentative; segni fumettistici e satirici, inclusivi di
script, con pittografie di animali e fiori a testimoniare la traccia del
legame alla natura. Proprio l’impastamento di segni, stili, colori, e il
gocciolamento dei tratti che dovrebbero “contornare” spazi e figu-
re, disdice la possibilità di continuare a pensarsi semplicisticamente
come soggetti a cultura unitaria ché, anzi, la dimensione transmediale
e transculturale afferma una posizionalità dinamica, di mobilizzazione
di sensi, di media e culture in costante redifinizione, come riconosce
Smith quando si definisce costruttrice di ponti in quanto «La mia arte,
la mia esperienza di vita, e i miei legami tribali sono inestricabilmente
intrecciati». E tuttavia, sapendosi nativa sul suolo americano, ella può
rivendicare un luogo di provenienza
La posizionalità dei discendenti degli schiavi africani è invece più
complicata: in assenza di una mappa che re-indirizzi verso il buco
nero della porta del non ritorno, Dionne Brand, attraverso un clu-
ster di simboli molto densi (la porta, l’acqua, la mappa, il mare, la
bussola), intermedia il modello della mappa nella scrittura del libro-
mappa fatto di parole-immagini. Smontando i segni netti e a tut-
ti noti del tracciato colonialistico europeo nell’Africa e nel nuovo
mondo, scritturando la fratturazione spaziale, identitaria e psichica,
Brand traduce per noi, ovvero rende consapevoli sia i lettori che di-
scendono dalla diaspora africana sia i lettori in apparenza distanti
da quella storia, che il linguaggio della cartografia fino al Novecento
è stato intriso della pulsione colonialistica a circoscrivere i mari e
le terre, dal Mediterraneo all’Atlantico, per marcare lo spazio come
colonizzato, appartenente a (non a caso il sottotitolo recita: “Notes
to belonging”25).
24 N. Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, trad. it. di F. Fontana, Meltemi,
Roma 2005, p. 198.
25 Il corsivo è mio.240 paola zaccaria
Dal canto suo, Jaune Quick-to-see Smith lavora, si è detto, nel-
le opere visuali concepite come trascrizione “nozionale” e non “na-
zional-americana” del concetto di “mappa”, ovvero compiendo una
destrutturazione della pratica ecfrastica tout court tramite lo scio-
glimento dai vincoli di rappresentazione come conservazione di una
qualche forma di fedeltà all’originale e quindi adesione, da parte di
chi rappresenta, tramite la modalità ecfrastica, ai presupposti ideolo-
gici dell’arte del mappare, verso una progressiva dispersione, disag-
gregazione e diluizione del contorno di terre e stati, riacchiappando
tracce di racconti e segni nativi. Riciclando le tracce che hanno atti-
vato tanto un lavorio mnestico (interessante, a questo proposito, il
dipinto Memory map, 2000), quanto una sollecitazione dell’immagi-
nazione creativa, trasforma e rinnova sia la mappa convenzionale del
Nuovo Mondo sia il concetto ancora colonialistico ed imperialistico-
imperativo di mappa come grafia che consegna territori e popoli al
disegno-controllo dei confini.
Disorientata non per sua scelta, ma perché discendente da popoli
scacciati dal proprio territorio e ri-locati, senza scelta, nelle riserve,
Quick-to-see Smith disorienta lo spettatore per quindi ri-orientare se
stessa e il pubblico, consapevole, in base al sapere che le viene dalla
sua appartenenza genealogica e dalle scelte ideologico-spirituali indi-
viduali, che nessun orientamento, nessun orizzonte è per sempre dato
a chi, come i nativi, sono stati derubati della propria modalità di con-
cepire l’abitare la terra. Così le sue mappe, impossibilitate a tacere la
geo-corpografia della disgiunzione dalla propria terra e la dispersione
e spersonalizzazione dell’habitus/habitat originario dentro le riserve, si
articolano, a partire da una posizionalità che lei stessa dichiara noma-
dica, attraverso l’instabilità di linee di fuga e si pongono come collage
visuali in cui le tracce di forme iconiche delle antiche culture native
(la tartaruga, il serpente, la rana, il fulmine, il vento, etc.) convivono
con tracce occidentali: simboli nativi danzano nello spazio testuale che
si presenta con segnature da arte astratta se non addirittura con la
spavalderia dell’arte pop o i gocciolamenti alla Pollock, producendo,
tramite la mescolanza di segni, di tecnologie, di culture e di media un
rilancio dell’immaginazione circa la confluenza/scontro di segni che
discende dalle tenaglie del colonialismo e della conquista, e s’intreccia
ai mutamenti geopolitici in atto nel presente.mappe dipinte, mappe narrate 241
3. Le mappe ondivaghe del non ritorno
Entro questo lavorio di dispersione della funzione rappresentati-
va di ciascuna forma di scrittura, e conseguente messa in crisi delle
narrazioni del mondo come universali e omogenee; contro la sepa-
ratezza dei linguaggi e dunque l’intoccabilità delle codificazioni, a
partire proprio dalle fratturazioni della panoplia originaria del mon-
do, Smith e Brand riescono a recuperare tracce, impronte appena
percettibili, a dispetto della rimozione e offuscamento della memo-
ria, rilanciando mescidazioni fluttuanti dai crinali, dalle crepe, dalle
secche dell’imbrigliamento.
Per Brand, discendente di schiavi deportati nei Caraibi, si tratta di
costruire percorsi di (impossibili) ritorni: visto che l’Atlante della memo-
ria che credeva custodito dal nonno non è in grado di ritrovare la via del
ritorno – il nonno, discendente dei “neri della diaspora”, non ricorderà
mai a quale popolo apparteneva –, gettando di conseguenza il corpo
senza cinture di salvataggio dell’adolescente Dionne in un movimento
sbilanciato, ondivago, la narratrice-creatrice, in assenza di mappe che
indicano la rotta, a volte si ancora temporaneamente a postazioni mo-
bili che non offrono appigli per attraccarsi a una zolla di terra radicata,
né tanto meno per far casa negli approdi. Non le resta che affidarsi alla
trascritturazione di spazi-immagini mentali, fantasticate, sognate, rico-
noscendo alle immagini visuali e immateriali create dalla mente lo stesso
statuto di quelle reali, come in qualche modo suggerisce Wunenburger
nelle sue definizioni di imago, simulacrum ed eidolon:
L’immagine dunque si sposta su un registro semantico che oscilla tra l’idea di
forma visibile (imago è forma, figura, corpo, come in tedesco Bild e Gestalt, in inglese
picture, figure, pattern, frame, shape) e l’idea di contenuto irreale, fittizio, prodotto
di ciò che non è (in greco eidolon, in tedesco Schattenbild, in inglese phantom)26.
Quel che è visualizzato nella mente, attiva nel cervello la pulsione
ecfrastica: il cervello genera descrizioni testuali di ciò che vede. E le
immagini mentali, dice Mitchell, vengono dai sogni, dalle idee o fan-
tasticherie, ma anche dalle memorie27.
26 J.-J Wunenburger, Philosophie des images, Presses Universitaires de France, Paris
1997; trad. it. di S. Arecco, Filosofia delle immagini, Einaudi, Torino 1999, p. 11.
27 Cfr. W. J. T. Mitchell, Ekphrasis and the Other, cit.242 paola zaccaria
A questo proposito, riporto la narrazione di una concrezione vi-
suale come svolta da Brand, nel momento in cui descrive l’acqua, una
delle immagini che le sovviene più spesso nella mente: «L’acqua è la
prima cosa nella mia immaginazione. Oltre il limite dello sguardo a
Guaya, quando ero una ragazzina, sapevo che c’era ancora più acqua.
Tutto inizia nell’acqua, tutto finisce nell’acqua. Turchese, acquamari-
na, verde scuro, blu intenso, blu inchiostro, acqua cerulea nero-blu»28.
La psicogeografia di Brand è stata segnata, nell’infanzia, dalle ve-
dute marine come accade a chi nasce e vive su un’isola. La incom-
mensurabilità dell’acqua e i suoi colori cangianti entrano per sempre
a far parte della sua esperienza percettiva spaziale, per cui la sua
immaginazione, anche vivendo altrove, è sempre inondata-irrorata
dall’acqua e, come fosse una pittrice, la sua descrizione dell’acqua
racconta le infinite sfumature del mare, dalla più chiara alla più scu-
ra, fino ad arrivare al deep blue, ink blue, blue-black cerulean water
– immagine acquatica in cui le sfumature scure di blu portano tracce
del Black Atlantic, del Middle Passage, del mal di mare, delle morti
per mare, della nostalgia di un altrove, la terra d’origine, mai più
recuperabile, e del blues.
Il primo dei capitoletti intitolati “Water” si offre come una for-
ma-esperienza di immersione psicofisica e sensoriale nell’acqua, qua-
si una traversata: dopo aver ribadito la centralità dell’acqua nella
sua percezione spaziale, affermando che l’acqua costituisce il primo
ricordo («L’acqua è la prima cosa nella mia memoria»), l’autrice pas-
sa a descriverla attraverso quel che coglieva tramite altri sensi e non
la sola vista: «Il mare risuonava come migliaia di segreti, tutti bisbi-
gliati nello stesso momento. Di giorno, non riuscivo a distinguerlo
dall’aria. Sembrava fatto della stessa sostanza. La stessa sostanza che
trasportava voci o profumi, musica o emozioni»29. Il mondo-acqua
senza confini, il mare-aria, il mare-sentire (voci, odori, musica, emo-
zioni) ci si presenta come cartografia dei sensi e dei sentimenti; come
spazio mobile che trasporta suoni, voci, ritmi attraverso l’aria e il
mare, ché anzi aria e mare si fondono proprio attraverso gli spruzzi
e le esalazioni del mare. Nel paragrafo precedente il mare era stato
presentato al lettore come acqua-sguardo:
28 D. Brand, A Map to the Door of No Return. Notes to Belonging, Vintage Canada,
Toronto 2001, p. 6.
29 Ivi, p. 8.mappe dipinte, mappe narrate 243
Il mare dietro la casa in cui ero nata era una agitato paese mare […]. Mi
ricordo che mi svegliavo ogni mattina per scoprire cosa ci avesse portato, e
cosa si era portato via. La parola sguardo si addice solo al mare. Guardare
in quell’acqua era guardare nel mondo, o quel che io pensavo fosse il mondo,
perché il mare trasmetteva immediatamente il senso di quanto grande fosse il
mondo […]. Il mare era nazione a sé, con una propria sovranità…30.
Il mare che mescola, il mare che inonda, il mare che non cono-
sce confini, il mare – definito anche dal diritto internazionale spazio
senza sovranità, “acque internazionali” – si connota in queste pagine
iniziali come spazio immaginativo (la prima cosa immagazzinata nel-
la sua immaginazione, dice la narratrice), immagine della memoria
(la prima cosa allogata nella memoria) e come mappa dell’emozione,
disegnando una geografia aptica31 in cui spazio storico-pubblico e
spazio psichico-privato s’incontrano. Brand sta mappando, oltre che
spazi contro-egemonici, meccanismi intimi, che hanno a che fare con
la memoria e l’immaginazione. Sta adempiendo a quella pulsione che
spinge a cercare nuove traiettorie, ovvero sta, per dirlo con Giulia-
na Bruno, perlustrando «lungo la traiettoria della psico-geografia»,
«il terreno geopsichico», – e geo-ecfrastico ideativo, aggiungerei nel
caso di Brand –, «che le teorie dello sguardo hanno trascurato. Que-
sto terreno – di cui lo spazio “aptico” fa parte – è anche il luogo dove
si formano l’occhio tattile e il tatto visivo, poiché questo modo di
guardare si inscrive nel movimento della geografia emozionale.
Le espressioni “occhio tattile” e “tatto visivo”32 sono ascrivibili,
in questo caso, non a opere plastiche, come la pittura o il cinema di
cui si occupa Bruno nel suo bel libro, ma a un’opera letteraria che
30 Ivi, p. 7. Il corsivo è mio.
31 Per l’etimologia greca, “aptico” significa “venire a contatto”. Si può perciò ritenere
che sia una specie di extra-senso che ha a che fare col tatto, ma in realtà ha anche a che
fare con gli altri sensi in quanto mette in contatto il corpo con l’ambiente circostante. Se-
condo Giuliana Bruno, l’aptico è un vero e proprio senso geografico: «La nostra esperienza
aptica ci dota di un tatto esteso, immaginario, addirittura globale. Ecco perché il contatto,
l’esplorazione e la comunicazione vanno considerate attività aptiche» (G. Bruno, Atlante
delle emozioni, Mondadori, Milano 2006, p. 229). In un saggio precedente ho preso in
considerazione gli archivi di culture pubbliche come mappe delle emozioni (P. Zaccaria,
“Jammings” disonantes: viajando por los archivios poscoloniales y posmulticulturales de
las culturas pùblicas, in Mujeres, Genero y Desarrollo. Saberes Interdisciplinares, Publica-
cions de la Universitat de Vic, Vic 2012, vol. 1, pp. 25-44).
32 Siamo dentro quel paesaggio sensoriale in cui le percezioni derivano da una trasla-
zione dei sensi, cui fanno riferimento anche Anzaldúa e Kahlo.244 paola zaccaria
crea mappe (ambito del visuale) la cui morfologia è guidata da uno
dei sensi, il tatto – il senso primordiale con cui entriamo nel mondo,
sposato alla vista: le visioni geo-corpo-grafiche di Brand nascono dal
sentire e, viceversa, è il sentire che fa nascere visioni.
In realtà l’autrice sta giocando non solo intermedialmente a raffi-
gurare il mare come se lo dipingesse, come se lo ricostruisse tramite
l’immaginazione e la memoria, ma sovrappone al piano spaziale in-
dividuale (il mare come prima percezione del mondo di una bimba
caraibica in epoca post-coloniale), il piano temporale collettivo che
fondò il trauma della diaspora per quasi quattro secoli (l’affacciarsi
degli africani ridotti in schiavitù sulla vista-mare una volta varcata la
porta del non ritorno, partenza che segnò la fuoriuscita definitiva dalla
terra dell’Africa e si compì attraverso la via del mare, la traversata
del black-blue Atlantic). In questo modo, la condizione post-coloniale
della bimba in qualche modo rintraccia e ri-traccia la condizione colo-
niale di ogni africano che fece esperienza della schiavitù: la prima me-
moria di ciascuno di loro, dopo essere stato tagliato per sempre dalla
madreterra, è l’acqua, che molti non avevano mai visto – lo sguardo
dei più non era mai stato bagnato dal mare, non aveva mai toccato-
sentito le sue sfumature di blu e mai toccato-avvertito il sentimento
blu(es)33. L’affermazione della citazione precedente, «La parola sguar-
do si addice solo al mare», esprime in modo pregnante il legame tra
lo sguardo (il termine inglese, gaze, significa osservare con attenzione,
mirare, fissare) e l’acqua, che qui si fa specchio del mondo (Guarda-
re in quell’acqua era guardare nel mondo): guardando nell’acqua la
bambina ha la sensazione di star guardando nel mondo, e del resto
poco prima ha chiamato il mare la sua “nazione turbolenta” e subito
dopo ha precisato che non solo il mondo-mare le sembra immenso, e
pertanto anche terrificante (anche in questo caso le sensazione della
bimba assorbono e ripetono le sensazioni degli schiavi che si affaccia-
33 In At the Full and Change of the Moon, alla piccola Bola, figlia di una schiava
ribelle che organizza un suicidio di gruppo sull’isola di Trinidad nel 1824, si riempiono,
nei momenti in cui invoca il nome della madre, gli occhi d’acqua, e all’acqua-mare sono
associati, nel romanzo, colori e sentimenti blu(es). Bola, messa in salvo per volere della
madre che nei suoi occhi-mare intravede il futuro, da uno schiavo fuggiasco (maroon) in
un punto dell’isola abbandonato, diventa creatura del mare, in grado di «piangere un oce-
ano e amare le balene». Attraverso il mare i suoi figli, generati in una comunità maroon, si
disperderanno in Nordamerica, Europa e Caraibi tracciando le nuove rotte della diaspora
post-schiavismo.Puoi anche leggere