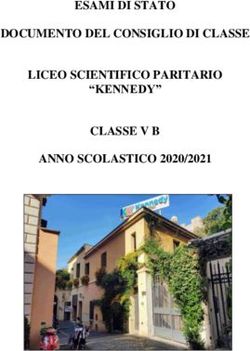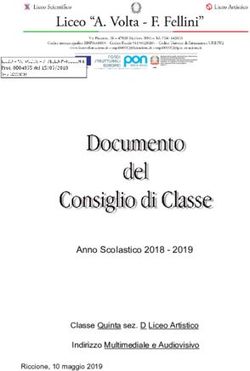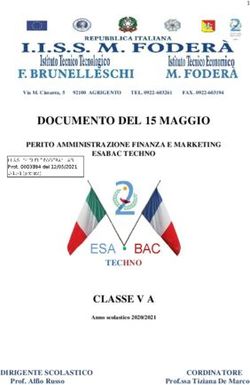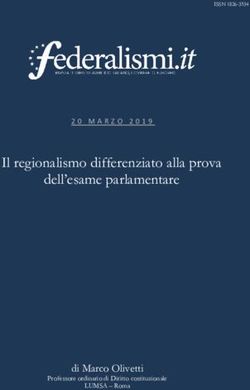DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Classe V sez F - Liceo Classico V ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LICEO CLASSICO STATALE
“Vittorio Emanuele II”
Corso Matteotti 48 , 60035 JESI (AN)
Tel. 0731/57444 - 208151 \ Fax 0731/57444 \ e-mail anpc060007@istruzione.it
Cod. MPI ANPC060007 \ Distretto Scolastico n.8 \ Cod. Fisc. 82001640422
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe V sez F
LICEO delle SCIENZE UMANE
anno scolastico 2018-2019
Jesi, 15 maggio 2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa RagniINDICE pag
PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 3
PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 4
ELENCO ALUNNI 6
DOCENTI E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 7
DESCRIZIONE GENERALE DELLA CLASSE ALLA CONCLUSIONE DEL 8
PERCORSO FORMATIVO
OBIETTIVI PROGRAMMATI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE
OBIETTIVI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI RAGGIUNTI 9
METODOLOGIA SEGUITA 15
CLIL 16
ATTIVITA’ E PROGETTI
DOCIMOLOGIA 17
TIPI DI PROVE OGGETTO DI VALUTAZIONE 18
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
prima prova 19
seconda prova 25
colloquio 26
SIMULAZIONE DELLE PROVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 27
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
PROGRAMMI DISCIPLINARI
Letteratura italiana 28
Lingua e letteratura latina 33
Lingua inglese 36
Scienze umane 38
Filosofia 44
Storia 46
Matematica 48
Fisica 52
Scienze naturali 55
Storia dell’arte 56
Scienze motorie 58
Religione cattolica 59
PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 60
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE ALLEGATO
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
!2IL CONSIGLIO DI CLASSE
ITALIANO VALENTINI MARIANGELA
LATINO TAGLIANINI PATRIZIA
L. INGLESE JANNI ANNAMARIA
FILOSOFIA LUCARELLI ROBERTA
SCIENZE MARINANGELI GIGLIOLA
UMANE
STORIA GAMBADORI ANNACLAUDIA
MATEMATICA CARDINALI ROBERTA
FISICA CARDINALI ROBERTA
SCIENZE SBARBATI MARIA GIUSEPPINA
NATURALI
STORIA BALDONI MARIA
DELL’ARTE
SCIENZE PESARESI ELENA
MOTORIE
RELIGIONE FERETTI MARIA ROSA
!3omissis !4
omissis !5
omissis !6
DOCENTI E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO
classe III classe IV classe V
Italiano Valentini M. Valentini M. Valentini M.
Latino Taglianini Taglianini Taglianini
Inglese Roccheggiani Roccheggiani Janni
Sc. Umane Marinangeli Marinangeli Marinangeli
Filosofia Lucarelli Lucarelli Lucarelli
Storia Gambadori Gambadori Gambadori
Fisica Cardinali Cardinali Cardinali
Matematica Cardinali Cardinali Cardinali
Scienze Naturali Sbarbati Sbarbati Sbarbati
Storia dell’arte Baldoni Baldoni Baldoni
Ed. fisica Pesaresi Pesaresi Pesaresi
Religione Feretti Feretti Feretti
!7DESCRIZIONE GENERALE DELLA CLASSE
ALLA CONCLUSIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Alla conclusione del V anno la classe, in relazione al raggiungimento degli obiettivi disciplinari e
pluridisciplinari presenta il seguente quadro:
OBIETTIVI PLURIDISCIPLINARI
CONOSCENZE
➢ Contestualizzazione storica dei singoli fenomeni.
➢ Connotazione di correnti letterarie, pedagogiche, filosofiche e artistiche.
➢ Definizione dell’identità umana e culturale dei diversi autori e conoscenza degli aspetti significativi
della loro produzione.
➢ Possesso degli elementi basilari per una comprensione interculturale.
➢ Conoscenza di problematiche di varia natura per mezzo di modelli matematici.
➢ Conoscenza dei fenomeni biologici e fisiologici.
COMPETENZE
➢ Inserire autori e testi nel periodo storico di riferimento
➢ Cogliere i diversi sviluppi letterari, filosofici, pedagogici ed artistici.
➢ Comprendere ed interpretare i testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto culturale.
➢ Saper organizzare, produrre e valutare una esperienza didattico – operativa.
➢ Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo.
➢ Comprendere il funzionamento dei complessi sistemi biologici e i loro rapporti con l’ambiente.
CAPACITA’
➢ Utilizzazione ed integrazione di conoscenze e di competenze specifiche.
➢ Analisi: individuare autonomamente i dati richiesti ed i concetti chiave
➢ Sintesi: giungere a definizioni ed interpretazioni critiche.
➢ Valutazione: esprimere giudizi motivati.
➢ Espressione: riconoscere ed utilizzare la terminologia specifica delle singole discipline nella
produzione scritta e orale.
OBIETTIVI PROGRAMMATI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE
• Formare una personalità libera, creativa, consapevole dei propri diritti e doveri
• Sviluppare una comprensione interculturale
• Sviluppare una mentalità logico-scientifica
• Esporre in modo chiaro, personale, lessicalmente appropriato sia le conoscenze acquisite sia le
proprie idee
• Riflettere e ricercare i “perché” nella comprensione ed acquisizione dei contenuti,
argomentando in modo logico
• Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi
• Produrre testi di varie tipologie con adeguate competenze linguistiche
• Ricercare in maniera autonoma la documentazione e la bibliografia necessaria agli
approfondimenti delle tematiche in esame
• Saper cogliere le interrelazioni tra le diverse discipline
• Sviluppare capacità di adattamento a situazioni nuove
!8OBIETTIVI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI RAGGIUNTI
OBIETTIVI GENERALI Disciplina : ITALIANO
CONOSCENZE
• Conoscere le linee generali dello sviluppo della letteratura italiana dalla fine del ‘700 al ‘900;
• Conoscere il Paradiso dantesco attraverso alcuni canti significativi.
• Comprendere il significato di un testo attraverso la lettura.
• Conoscere le tecniche fondamentali della comunicazione linguistica.
COMPETENZE
• Riconoscere la tipologia testuale e gli aspetti formali del testo letterario
• Contestualizzare ossia collegare il testo con il genere letterario a cui appartiene e con la realtà
storico culturale in cui si situa.
• Attuare collegamenti e confronti tra la letteratura italiana e le altre letterature europee.
• Interpretare un testo in modo chiaro e organico utilizzando elementi testuali e contestuali.
• Mettere a confronto interpretazioni critiche e formulare, sulla base di valide argomentazioni, un
giudizio personale.
CAPACITÀ
• Riconoscere le tematiche fondamentali di un periodo storico culturale.
• Cogliere analogie e differenze tra i testi letterari.
• Collegare scelte tematiche e stilistiche del testo al contesto storico culturale.
• Utilizzare le conoscenze possedute in funzione di un apprendimento critico.
OBIETTIVI GENERALI Disciplina : LATINO
CONOSCENZE
Gli alunni possiedono:
• Una conoscenza adeguata delle strutture morfo-sintattiche fondamentali della lingua latina
per la decodifica e la comprensione del testo
• Una conoscenza organica della letteratura latina dalla produzione dell’età
Giulio-Claudia alla tarda età imperiale, con cenni alla letteratura cristiana.
• Una conoscenza specifica di alcuni autori attraverso la lettura e l’analisi dei testi
COMPETENZE
Gli alunni sono in grado di:
• Riconoscere le più importanti strutture morfo-sintattiche
• Tradurre in lingua italiana con proprietà linguistica
• Cogliere nel testo, attraverso l’analisi stilistica e tematica, gli elementi utili per la sua
contestualizzazione
• Collegare il testo con il genere letterario a cui appartiene
• Individuare, attraverso la conoscenza delle linee generali dello sviluppo della storia letteraria,
analogie e differenze fra epoche e autori
CAPACITA’
Gli alunni sono in grado di:
• Utilizzare le conoscenze acquisite per un apprendimento critico
• Sviluppare la consapevolezza del rapporto di continuità/alterità tra passato e presente
!9OBIETTIVI GENERALI Disciplina : LINGUA INGLESE
Conoscenze
- conoscere le tematiche specifiche dell’indirizzo di studi;
- conoscere le tematiche storico-letterarie, gli autori e le opere più significative trattate (‘800 e
prima parte del ‘900);
- conoscere le caratteristiche principali dei generi letterari esaminati.
Competenze
- saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati;
- saper comprendere testi propri dell’indirizzo di studi;
- saper comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto
culturale;
- saper produrre oralmente con sufficiente chiarezza logica, fluidità nell’esposizione e precisione
lessicale;
- saper produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali.
Capacità
- saper rielaborare in modo personale ed autonomo le conoscenze tramite le competenze
acquisite;
- saper collegare le conoscenze sia all’interno della disciplina che in ambito multidisciplinare;
- saper esprimere giudizi motivati e critici.
OBIETTIVI GENERALI Disciplina : SCIENZE UMANE
CONOSCENZE
• Conoscere i principali campi d’indagine delle Scienze Umane mediante gli apporti specifici ed
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica.
• Riconoscere le specificità del lessico delle discipline.
• Conoscere alcuni problemi fondamentali della sociologia e antropologia in relazione al contesto
storico-culturale.
COMPETENZE
• Utilizzare con proprietà il lessico disciplinare.
• Comprendere le dinamiche della realtà sociale, soprattutto i fenomeni educativi e i processi formativi,
i servizi alla persona, il mondo del lavoro, i fenomeni interculturali, i contesti di convivenza e
costruzione della cittadinanza.
• Individuare il nucleo concettuale in alcuni passi delle opere degli autori.
CAPACITÀ
• Verbalizzare ed elaborare adeguatamente i contenuti.
• Progettare brevi percorsi di ricerca
!10OBIETTIVI DISCIPLINARI FILOSOFIA
Conoscenze:
-conoscenza delle principali teorie filosofiche tra l' 800 e il '900
-conoscenza del lessico specifico della disciplina
-conoscenza delle categorie essenziali della tradizione filosofica
Competenze:
-utilizzare il lessico proprio della disciplina
-utilizzare le categorie fondamentali della tradizione filosofica
-individuare il nucleo fondamentale del pensiero di ogni filosofo
-confrontare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema
Capacità:
-saper sintezzare ed eprimere correttamente il contenuto di testi e di argomenti di studio
-saper analizzare e comprendere i testi di autori significativi
-saper ricondurre le tesi individuate al pensiero complessivo dell' autore .
OBIETTIVI DISCIPLINARI STORIA
CONOSCENZE
Vedere programma allegato.
COMPETENZE
Utilizzare con proprietà il lessico disciplinare.
Individuare le coordinate spaziali, temporali, causali degli avvenimenti e delle epoche.
Leggere e interpretare in modo progressivamente autonomo testi e brani di autori.
Riconoscere, analizzare e confrontare interpretazioni diverse dei fatti storici.
CAPACITÀ
Ricostruire i problemi in ambito diacronico e sincronico.
Esprimere un giudizio critico sui diversi avvenimenti/temi affrontati.
Esporre tesi/problemi secondo finalità logico - argomentative.
!11OBIETTIVI GENERALI Disciplina: MATEMATICA
CONOSCENZE
• Si rimanda alla sezione “contenuti”.
COMPETENZE
• Studiare il dominio di una funzione.
• Studiare il segno, la parità o disparità, la crescenza o decrescenza di una funzione.
• Conoscere le definizioni nei diversi casi di limite.
• Saper operare coi limiti.
• Determinare gli asintoti di una funzione.
• Calcolare il limite di alcune forme indeterminate.
• Calcolare le derivate fondamentali.
• Calcolare la derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni.
CAPACITÀ
• Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione.
• Capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.
• Abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori.
• Attitudine a riesaminare a sistemare logicamente le conoscenze man mano acquisite.
• Rielaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo.
• Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiare l’organizzazione complessiva,
soprattutto sotto l’aspetto concettuale.
OBIETTIVI GENERALI Disciplina: FISICA
CONOSCENZE
• Si rimanda alla sezione “contenuti”.
COMPETENZE
• Conoscere e saper interpretare in maniera corretta i fenomeni e le teorie.
• Saper esprimere, pur con diversi livelli di completezza, precisione e chiarezza i concetti fondamentali
dei fenomeni e delle teorie studiate utilizzando uno specifico linguaggio disciplinare.
• Saper descrivere le motivazioni per la scelta di procedimenti risolutivi specifici.
• Saper rielaborare criticamente con diverso livello di approfondimento quanto appreso.
CAPACITÀ
• Saper risolvere semplici problemi applicativi delle teorie apprese.
• Essere in grado di cogliere i concetti nella loro essenzialità, di coordinali e di rafforzarli.
• Essere in grado di giungere ad interpretazioni critiche esprimendo giudizi motivati.
!12OBIETTIVI GENERALI Disciplina : SCIENZE NATURALI
CONOSCENZE
• individuare il ruolo delle biomolecole all'interno dei processi vitali
• comprendere l'importanza delle biotecnologie e le loro applicazioni
• descrivere modelli globali per spiegare la dinamica endogena della Terra
COMPETENZE
• Comprendere la letteratura scientifica del settore
• Conoscere ed utilizzare un linguaggio scientifico corretto ed appropriato
• Comunicare i risultati mediante forme orali, scritte e grafiche, anche utilizzando moderne
tecnologie
CAPACITA’
• Dimostrare di aver acquisito attraverso un processo di assimilazione e rielaborazione personale
i diversi contenuti
• Saper dare unitarietà alle conoscenze operando collegamenti e relazioni
OBIETTIVI GENERALI Disciplina : STORIA DELL’ARTE
CONOSCENZE
Metodologie di analisi e lettura di un prodotto artistico in relazione al suo secolo: visivo-strutturale,
tecnico strutturale, iconografico, iconologico, sociologico.
ILLUMINISMO-NEOCLASSICISMO-ROMANTICISMO- REALISMO-MACCHIAIOLI-IMPRESSIONISMO-
POSTIMPRESSIONISMO-PUNTINISMO-DIVISIONISMO-FAUVES-ESPRESSIONISMO-LIBERTY-
AVANGUARDIE DEL PRIMO E SECONDO NOVECENTO –BAUHAUS- RAZIONALISMO
COMPETENZE
Comprensione
Saper comprendere i concetti chiave e gli aspetti significativi di una determinata tematica.
Esposizione
Saper esporre in modo chiaro e corretto, con adeguato lessico specifico (tecnico-critico) il contenuto e gli
aspetti significativi di una particolare tematica.
Argomentazione
Argomentare, anche in modo pluridisciplinare contenuti e aspetti significativi di una particolare
tematica.
Rielaborazione
Saper rielaborare personalmente e con spirito critico il contenuto e gli aspetti significativi di una
determinata tematica.
CAPACITA’
Analisi
Saper individuare i concetti chiave di una particolare tematica.
Sintesi
Saper essere in grado di rielaborare sinteticamente e criticamente un contenuto di una tematica
proposta.
Valutazione
Saper formulare un giudizio critico personale sulle caratteristiche e qualità formali e sul valore
espressivo ed estetico di un prodotto artistico (opera d’arte).
!13OBIETTIVI GENERALI Disciplina : SCIENZE MOTORIE
La classe ha acquisito le prime cognizioni dell’allenamento specifico delle capacità motorie: forza
velocità mobilità articolare resistenza, in particolare ha sviluppato le qualità motorie coordinative:
equilibrio e coordinazione.
Ha utilizzato correttamente gli schemi motori in correlazione con l’immagine corporea e i processi
motori. Ha attuato movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili.
Conosce ed applica le regole di base nelle discipline sportive praticate e dei giochi sportivi e non
sportivi.
Comprende gli apparati e i sistemi dell’apparato locomotore, ed ha una adeguata conoscenza degli assi
e piani del corpo umano.
La classe inoltre ha appreso i principali traumi sportivi e si confronta sul concetto di sport come parte
integrante di vita.
COMPETENZE
Gli alunni sanno valutare il proprio stato di efficienza fisica; sanno stabilire con il corpo e il movimento
relazioni interpersonali , gestiscono in modo autonomo l’attività motoria in base al contesto ,
realizzano movimenti complessi adeguati alle diverse stazioni spazio temporali , hanno appreso le
attività sportive con ruoli e regole, ed hanno approfondito le norme elementari di comportamento ai fini
della prevenzione degli infortuni.
OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA
La classe ha sviluppato una migliore consapevolezza della propria corporeità , ha raggiunto un
armonico sviluppo psicofisico , ha acquisito una cultura delle attività motorie per raggiungere una
migliore qualità di vita.
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI
Potenziamento fisiologico.
Rielaborazione degli schemi motori e miglioramento delle capacità coordinative e spazio temporali.
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.
Conoscenze e pratiche delle attività sportive.
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.
CAPACITA’
La classe ha sviluppato una buona capacità di lavorare in modo autonomo e originale, ha aumentato il
bagaglio di attività motorie e sportive, ha migliorato la capacità di rielaborazione ed ha potenziato la
capacità di cooperazione di lavorare in gruppo nei giochi sportivi e di squadra raggiungendo un buon
coinvolgimento, interesse e disponibilità.
OBIETTIVI GENERALI Disciplina : RELIGIONE
CONOSCENZE
• Conoscere le linee essenziali dei contenuti proposti
• Definire i caratteri fondamentali del discorso antropologico e teologico
COMPETENZE
• Comprensione. La maggior parte degli alunni mostra di aver compreso le linee essenziali dei
discorsi affrontati
• Esposizione. Gli alunni sono in grado di esporre in modo corretto, chiaro ed appropriato gli
argomenti trattati, nelle loro linee essenziali
• Argomentazione. La maggioranza degli alunni sa argomentare le proprie opinioni e confrontarle
con quelle dei compagni.
• Rielaborazione. Buona parte della classe sa interpretare personalmente i contenuti e formulare
giudizi critici e motivati.
CAPACITA’.
• Analisi. La maggior parte della classe è in grado di individuare i termini fondamentali dei discorsi proposti
evidenziando analogie e differenze.
• Sintesi. Gli alunni sanno cogliere e collegare tra loro i nuclei proposti.
• Valutazione. Molti alunni mostrano autonomia di giudizio e capacità critiche.
!14METODOLOGIA
Gli insegnanti hanno seguito durante l’anno scolastico le indicazioni contenute nel contratto formativo;
per conseguire gli obiettivi sono state usate le seguenti metodologie didattiche
Discipline Lezione Lezione Ricerca Lavoro di Simulazione Pluridi- Esercitaz.
frontale Guidata individuale gruppo sciplina- Metodo-
rietà didattiche
x INVALSI
Italiano x x x x
1°prova scritta
Latino x x x x
L. Inglese x x x x INVALSI x
x
Sc. Umane x x x x
2°prova scritta
Filosofia x x x x
Storia x x x x x
Matematica x x x INVALSI
Fisica x x
Sc. Naturali x x
Storia arte x x x x x
Sc.Motorie x x x
Religione x x x
Strumenti utilizzati dai singoli docenti, in correlazione alla specificità delle discipline
Disciplina Testi Dispense Documenti Laboratori Audiovisivi Fotocopie Biblioteca Palestra
Italiano x x x x x
Latino x x x x x
L. Inglese x x x x x
Sc. Umane x x x x
Filosofia x x x x
Storia x x x x x
Matematica x x x
Fisica x x x x x
Sc. Naturali x x x
Storia arte x x x x
Sc.Motorie x x x
Religione x x x x
!15ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA
STRANIERA CON METODOLOGIA CLIL
MATEMATICA “DISCONTINUITY AND ASYMPTOTES”
obie5vi linguisDOCIMOLOGIA
Sono stati usati tutti i voti da 1 a 10 per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la
seguente scala:
a) Raggiungimento TOTALE, che equivale a una valutazione numerica da 9/10 fino a 10/10
(OTTIMO)
b) Raggiungimento QUASI TOTALE, che equivale a una valutazione numerica da 8/10 compreso fino
al valore più prossimo a 9/10
(BUONO)
c) Raggiungimento PARZIALE, che equivale a una valutazione numerica da 7/10 compreso fino al
valore più prossimo a 8/10
(DISCRETO)
d) Raggiungimento MINIMO, che equivale a una valutazione numerica da 6/10 compreso fino al
valore più prossimo a 7/10
(SUFFICIENTE)
e) Raggiungimento INCOMPLETO , che equivale a una valutazione numerica da 5/10 compreso fino al
valore più prossimo a 6/10
(MEDIOCRE)
f) MANCATO raggiungimento che equivale a una valutazione inferiore a 5/10
(INSUFFICIENTE)
!17TIPI DI PROVE OGGETTO DI VALUTAZIONE
PROVE SCRITTE
Discipline Elaborati Elaborati di Problemi Test Quesiti a
argomentativi comprensione Traduzioni risposta
testuale aperta
Italiano x x x x
Latino x x x x
L. Inglese x x x x
Sc. Umane x x x
Filosofia x x
Storia x x x x
Matematica x x
Fisica x x x
Sc. Naturali x x
Storia arte x x
Ed. fisica x
Religione
PROVE ORALI
Discipline Esposizione di Discussioni Approfondime Analisi dei Esercizi
argomenti nti testi applicativi
Italiano x x x x
Latino x x x
L. Inglese x x x x
Sc. Umane x x x x
Filosofia x x x x
Storia x x x x
Matematica x x
Fisica x x
Sc. Naturali x x
Storia arte x x x
Ed. fisica x x
Religione x x x x
!18Liceo Classico – Scienze Umane - Economico Sociale “Vittorio Emanuele II” di Jesi
Esame di Stato: 1ª PROVA SCRITTA DI ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE –
TIPOLOGIA A
Cognome e Nome del/della candidato/a:__________________________________________ classe: ______
Livelli (L) Punteggio
Indicatori Descrittori /Peso (P)
15 P. Punti (L x P)
% 3 Max.15 punti
(15 punti max)
Mancanza di filo conduttore – assenza o inefficacia di introduzione e conclusione
testo disordinato e incoerente. L.1
IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E Filo conduttore incerto – scarsa funzionalità di introduzione e conclusione –
ORGANIZZAZIONE coesione e coerenza del testo approssimative L.2
DEL TESTO
…….pt
Filo conduttore riconoscibile – introduzione e conclusione abbastanza funzionali
COESIONE E L.3
INDICATORE 1
– testo per lo più coerente e coeso
COERENZA
TESTUALE
Filo conduttore chiaro – introduzione e conclusione funzionali – testo coerente e
coeso L.4
Filo conduttore logico e rigoroso – introduzione e conclusione funzionali ed
efficaci. Testo coerente, coeso e ben articolato. L.5
25 P. Punti (L x P)
% 5 Max.25 punti
Errori numerosi e/o gravi di grammatica e punteggiatura – povertà di lessico e
inadeguatezza di registro – espressione non sempre comprensibile L.1
(25 punti max)
RICCHEZZA E
PADRONANZA
Diverse scorrettezze e improprietà di grammatica e punteggiatura – lessico
LESSICALE approssimativo e/o ripetitivo – registro spesso non appropriato, colloquiale o L.2
trascurato – espressione a tratti involuta
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA, Poche improprietà di grammatica e punteggiatura – lessico semplice e poco vario
ma adeguato alla materia trattata – registro generalmente appropriato – L.3 …….pt
MORFOLOGIA,
INDICATORE 2
espressione abbastanza chiara
SINTASSI), USO
CORRETTO ED
EFFICACE DELLA Occasionali imperfezioni di poco conto di grammatica e punteggiatura – buona
PUNTEGGIATURA
padronanza del lessico e controllo abbastanza sicuro del registro – espressione L.4
chiara e scorrevole
Correttezza e precisione, punteggiatura accurata – lessico ricco e vario, sicuro
controllo del registro – espressione scorrevole, che denota una qualche ricerca L.5
stilistica
20 P. Punti (L x P)
% 4 Max.20 punti
(20 punti max)
Conoscenze molto limitate, rudimentali e/o usate a sproposito, in modo non
AMPIEZZA E appropriato e non pertinente. Assente o inappropriata valutazione personale delle L.1
PRECISIONE DELLE idee.
CONOSCENZA E DEI
RIFERIMENTI Conoscenze limitate, approssimative e/o usate in modo spesso schematico, poco L.2
CULTURALI appropriato e poco pertinente. Valutazioni critiche superficiali.
L.3
INDICATORE 3
ESPRESSIONE DI
Conoscenze adeguate ma non molto approfondite – uso in genere appropriato …....pt
benché talora schematico. Valutazioni critiche sufficienti.
GIUDIZI CRITICI E
VALUTAZIONI Conoscenze abbastanza approfondite e/o sicure, usate in modo appropriato e L.4
PERSONALI pertinente – positiva rielaborazione critica delle idee
Conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei dettagli, usate in modo
pertinente ed efficace– spiccata rielaborazione critica e personale delle idee L.5
!19P. Punti (L x P)
5%
1 Max.5 punti
RISPETTO DEI
VINCOLI POSTI
Rispetto quasi del tutto assente dei vincoli posti nella consegna. L.1
NELLA CONSEGNA
(ad esempio, Scarso rispetto complessivo dei vincoli posti nella consegna. L.2
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo- o Sostanziale rispetto dei vincoli posti nella consegna. L.3 ..…..pt
(40 punti max)
circa la forma
parafrasata o sintetica Accurato rispetto dei vincoli posti nella consegna. L.4
della rielaborazione)
Pieno rispetto dei vincoli posti nella consegna. L.5
15 P. Punti (L x P)
A
% 3 Max.15 punti
INDICATORE SPECIFICO PER LA TIPOLOGIA
Assai limitata e poco articolata comprensione del testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici L.1
CAPACITA’ DI
COMPRENDERE IL
TESTO NEL SUO Parziale e/o superficiale comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici L.2
SENSO COMPLESSIVO
E NEI SUOI SNODI
…....pt
TEMATICI E Comprensione del testo nel suo senso e nei suoi snodi tematici e stilistici limitata L.3
STILISTICI agli aspetti essenziali
Buona comprensione del testo nel suo senso e nei suoi snodi tematici e stilistici L.4
Completa e dettagliata comprensione del testo nel suo senso e nei suoi snodi L.5
tematici e stilistici anche più profondi
10 P. Punti (L x P)
% 2 Max.10 punti
PUNTUALITA’
Mancata o limitata analisi degli aspetti formali. L.1
NELL’ANALISI
LESSICALE,
Parziale analisi degli aspetti formali. L.2
SINTATTICA,
STILISTICA E
RETORICA (SE Essenziale analisi degli aspetti formali L.3
RICHIESTA)
…....pt
Analisi corretta degli aspetti formali L.4
Analisi completa, puntuale e profonda degli aspetti formali L.5
10 P. Punti (L x P)
% 2 Max.10 punti
Interpretazione del testo inadeguata o appena accennata L.1
INTERPRETAZIONE
CORRETTA E
Interpretazione del testo limitata e superficiale L.2
ARTICOLATA DEL
Interpretazione del testo corretta, ma non particolarmente articolata. L.3
TESTO …....pt
Interpretazione del testo adeguata e/o originale in alcune parti L.4
Interpretazione appropriata, ben argomentata e personale L.5
Totale Somma dei Punteggi dei vari indicatori (SP) : ……./ 100
Punteggio in ventesimi: (SP : 5): ……/201
1
Nel caso di risultati in decimali l’arrotondamento verso il punteggio più alto sarà a partire dal valore ,5.
Es: SP= 77/100 Punteggio in ventesimi:77:5=15,4 = 15/20
SP= 78/100 Punteggio in ventesimi: 78:5= 15,6 = 16/20
!20Liceo Classico – Scienze Umane - Economico Sociale “Vittorio Emanuele II” di Jesi
Esame di Stato: 1ª PROVA SCRITTA DI ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE –
TIPOLOGIA B
Cognome e Nome del/della candidato/a:__________________________________________ classe: ______
Livelli (L) Punteggio
Indicatori Descrittori /Peso (P)
15 P. Punti (L x P)
% 3 Max.15 punti
(15 punti max)
Mancanza di filo conduttore – assenza o inefficacia di introduzione e conclusione
testo disordinato e incoerente. L.1
IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E Filo conduttore incerto – scarsa funzionalità di introduzione e conclusione –
ORGANIZZAZIONE DEL coesione e coerenza del testo approssimative L.2
TESTO
…….pt
Filo conduttore riconoscibile – introduzione e conclusione abbastanza funzionali
COESIONE E L.3
INDICATORE 1
– testo per lo più coerente e coeso
COERENZA
TESTUALE
Filo conduttore chiaro – introduzione e conclusione funzionali – testo coerente e
coeso L.4
Filo conduttore logico e rigoroso – introduzione e conclusione funzionali ed
efficaci. Testo coerente, coeso e ben articolato. L.5
25 P. Punti (L x P)
% 5 Max.25 punti
Errori numerosi e/o gravi di grammatica e punteggiatura – povertà di lessico e
inadeguatezza di registro – espressione non sempre comprensibile L.1
(25 punti max)
RICCHEZZA E
PADRONANZA
Diverse scorrettezze e improprietà di grammatica e punteggiatura – lessico
LESSICALE approssimativo e/o ripetitivo – registro spesso non appropriato, colloquiale o L.2
trascurato – espressione a tratti involuta
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA, Poche improprietà di grammatica e punteggiatura – lessico semplice e poco vario
ma adeguato alla materia trattata – registro generalmente appropriato – L.3 …….pt
MORFOLOGIA,
INDICATORE 2
espressione abbastanza chiara
SINTASSI), USO
CORRETTO ED
EFFICACE DELLA Occasionali imperfezioni di poco conto di grammatica e punteggiatura – buona
PUNTEGGIATURA
padronanza del lessico e controllo abbastanza sicuro del registro – espressione L.4
chiara e scorrevole
Correttezza e precisione, punteggiatura accurata – lessico ricco e vario, sicuro
controllo del registro – espressione scorrevole, che denota una qualche ricerca L.5
stilistica
20 P. Punti (L x P)
% 4 Max.20 punti
(20 punti max)
Conoscenze molto limitate, rudimentali. Assente o inappropriata valutazione
AMPIEZZA E personale delle idee. L.1
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZA E DEI
RIFERIMENTI
Conoscenze limitate, approssimative. Valutazioni critiche superficiali. L.2
CULTURALI
Conoscenze adeguate, ma non molto approfondite. Valutazioni critiche sufficienti. L.3 …....pt
INDICATORE 3
ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
Conoscenze abbastanza approfondite e/o sicure. Positiva rielaborazione critica
VALUTAZIONI delle idee L.4
PERSONALI
Conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei dettagli. Spiccata
rielaborazione critica e personale delle idee L.5
!2115 P. Punti (L x P)
% 3 Max.15 punti
Individuazione assente o non esatta di tesi e argomentazioni del testo L.1
Individuazione approssimativa di tesi e argomentazioni del testo oppure
INDIVIDUAZIONE individuazione corretta della tesi, ma non delle argomentazioni L.2
CORRETTA DI TESI E
ARGOMENTAZIONI
Individuazione complessivamente corretta di tesi e di almeno alcune
L.3 ..…..pt
PRESENTI NEL TESTO argomentazioni del testo
PROPOSTO
(40 punti max)
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni del testo L.4
Individuazione puntuale ed approfondita di tesi e argomentazioni del testo L.5
15 P. Punti (L x P)
% 3 Max.15 punti
Scarsa coerenza del percorso ragionativo pieno di contraddizioni e passaggi poco
INDICATORE SPECIFICO PER LA TIPOLOGIA B
logici e/o chiari – scarsi e/o inadeguati connettivi L.1
CAPACITÀ DI
SOSTENERE CON
Parziale coerenza del percorso ragionativo caratterizzato talvolta da passaggi
COERENZA UN
confusi e/o contraddittori – uso dei connettivi logici non sempre adeguato L.2
PERCORSO
RAGIONATIVO
Sufficiente coerenza del percorso ragionativo – uso per lo più adeguato dei
…....pt
ADOPERANDO
connettivi logici L.3
CONNETTIVI
PERTINENTI
Buona coerenza del percorso ragionativo – uso appropriato dei connettivi logici L.4
Buona/ottima coerenza del percorso ragionativo – uso sicuro ed efficace dei
connettivi logici L.5
10 P. Punti (L x P)
% 2 Max.10 punti
Uso inappropriato dei riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione. L.1
CORRETTEZZA E Uso superficiale e/o poco congruo dei riferimenti culturali a sostegno
CONGRUENZA DEI dell’argomentazione. L.2
RIFERIMENTI
CULTURALI
Uso accettabile per correttezza e congruenza dei riferimenti culturali a sostegno …....pt
UTILIZZATI PER dell’argomentazione. L.3
SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE
Uso corretto ed efficace dei riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione. L.4
Uso corretto, efficace e personale dei riferimenti culturali a sostegno
dell’argomentazione. L.5
Totale Somma dei Punteggi dei vari indicatori (SP) : ……./ 100
Punteggio in ventesimi: (SP : 5): ……/201
1
Nel caso di risultati in decimali l’arrotondamento verso il punteggio più alto sarà a partire dal valore ,5.
Es: SP= 77/100 Punteggio in ventesimi:77:5=15,4 = 15/20
SP= 78/100 Punteggio in ventesimi: 78:5= 15,6 = 16/20
!22Liceo Classico – Scienze Umane - Economico Sociale “Vittorio Emanuele II” di Jesi
Esame di Stato: 1ª PROVA SCRITTA DI ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE –
TIPOLOGIA C
Cognome e Nome del/della candidato/a:__________________________________________ classe: ______
Livelli (L) Punteggio
Indicatori Descrittori /Peso (P)
15 P. Punti (L x P)
% 3 Max.15 punti
(15 punti max)
Mancanza di filo conduttore – assenza o inefficacia di introduzione e conclusione
testo disordinato e incoerente. L.1
IDEAZIONE,
PIANIFICAZIONE E Filo conduttore incerto – scarsa funzionalità di introduzione e conclusione –
ORGANIZZAZIONE DEL coesione e coerenza del testo approssimative L.2
TESTO
…….pt
Filo conduttore riconoscibile – introduzione e conclusione abbastanza funzionali
COESIONE E L.3
INDICATORE 1
– testo per lo più coerente e coeso
COERENZA
TESTUALE
Filo conduttore chiaro – introduzione e conclusione funzionali – testo coerente e
coeso L.4
Filo conduttore logico e rigoroso – introduzione e conclusione funzionali ed
efficaci. Testo coerente, coeso e ben articolato. L.5
25 P. Punti (L x P)
% 5 Max.25 punti
Errori numerosi e/o gravi di grammatica e punteggiatura – povertà di lessico e
inadeguatezza di registro – espressione non sempre comprensibile L.1
(25 punti max)
RICCHEZZA E
PADRONANZA
Diverse scorrettezze e improprietà di grammatica e punteggiatura – lessico
LESSICALE approssimativo e/o ripetitivo – registro spesso non appropriato, colloquiale o L.2
trascurato – espressione a tratti involuta
CORRETTEZZA
GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA, Poche improprietà di grammatica e punteggiatura – lessico semplice e poco vario
ma adeguato alla materia trattata – registro generalmente appropriato – L.3 …….pt
MORFOLOGIA,
INDICATORE 2
espressione abbastanza chiara
SINTASSI), USO
CORRETTO ED
EFFICACE DELLA Occasionali imperfezioni di poco conto di grammatica e punteggiatura – buona
PUNTEGGIATURA
padronanza del lessico e controllo abbastanza sicuro del registro – espressione L.4
chiara e scorrevole
Correttezza e precisione, punteggiatura accurata – lessico ricco e vario, sicuro
controllo del registro – espressione scorrevole, che denota una qualche ricerca L.5
stilistica
20 P. Punti (L x P)
% 4 Max.20 punti
(20 punti max)
Conoscenze molto limitate, rudimentali. Assente o inappropriata valutazione
AMPIEZZA E personale delle idee. L.1
PRECISIONE DELLE
CONOSCENZA E DEI
RIFERIMENTI
Conoscenze limitate, approssimative. Valutazioni critiche superficiali. L.2
CULTURALI
Conoscenze adeguate, ma non molto approfondite. Valutazioni critiche sufficienti. L.3 …....pt
INDICATORE 3
ESPRESSIONE DI
GIUDIZI CRITICI E
Conoscenze abbastanza approfondite e/o sicure. Positiva rielaborazione critica
VALUTAZIONI delle idee L.4
PERSONALI
Conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei dettagli. Spiccata
rielaborazione critica e personale delle idee L.5
!2315 P. Punti (L x P)
% 3 Max.15 punti
Scarsa o mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia ;mancata e/o incoerente
formulazione del titolo e della paragrafazione L.1
PERTINENZA DEL
TESTO RISPETTO ALLA
TRACCIA Parziale pertinenza del testo rispetto alla traccia ;formulazione del titolo poco
efficace e paragrafazione non sempre coerente e/o discontinua. L.2
COERENZA NELLA
FORMULAZIONE DEL Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia ;corretta formulazione del
TITOLO E titolo e paragrafazione per lo più corretta e congrua. L.3 ..…..pt
DELL’EVENTUALE
PARAGRAFAZIONE
INDICATORE SPECIFICO PER LA TIPOLOGIA C (40 punti max)
Corretta pertinenza del testo rispetto alla traccia ;corretta formulazione del titolo
e della paragrafazione . L.4
Piena pertinenza del testo rispetto alla traccia ; valida ed convincente
formulazione del titolo; paragrafazione sicura ed efficace.. L.5
15 P. Punti (L x P)
% 3 Max.15 punti
Sviluppo disordinato, confuso e senza chiari nessi logici dell’esposizione L.1
SVILUPPO ORDINATO E Sviluppo a volte ellittico dell’esposizione o in parte confuso L.2
LINEARE
DELL’ESPOSIZIONE
Sviluppo lineare, ma piuttosto semplice dell’esposizione L.3
…....pt
Sviluppo ordinato e logico dell’esposizione L.4
Sviluppo lineare, convincente e articolato dell’esposizione L.5
10 P. Punti (L x P)
% 2 Max.10 punti
Uso inappropriato delle conoscenze, articolate senza adeguata padronanza L.1
Uso superficiale e/o incompleto e /o poco articolato delle conoscenze e dei
riferimenti culturali L.2
CORRETTEZZA E
ARTICOLAZIONE
Uso accettabile delle conoscenze e dei riferimenti culturali, articolati in modo …....pt
DELLE CONOSCENZE
sintetico. L.3
E DEI RIFERIMENTI
CULTURALI
Uso corretto ed efficace delle conoscenze e dei riferimenti culturali, articolati con
una certa dovizia di particolari. L.4
Uso corretto ed efficace delle conoscenze e dei riferimenti culturali, articolati con
una certa complessità e arricchiti di significativi apporti personali. L.5
Totale Somma dei Punteggi dei vari indicatori (SP) : ……./ 100
Punteggio in ventesimi: (SP : 5): ……/201
1
Nel caso di risultati in decimali l’arrotondamento verso il punteggio più alto sarà a partire dal valore ,5.
Es: SP= 77/100 Punteggio in ventesimi:77:5=15,4 = 15/20
SP= 78/100 Punteggio in ventesimi: 78:5= 15,6 = 16/20
!24SCHEDA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
PUNTEGGIO PER LIVELLI
1 2 3 4 5 6 7 CALCOLO
CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE CONOSCENZE
FRAMMENTARIE FRAMMENTARIE E LIMITATE CORRETTE CORRETTE ED COMPLETE ED COMPLETE
PUNTEGGIO MASSIMO LACUNOSE E LACUNOSE MA SUPERFICIALI E ESSENZIALI ORGANICHE ORGANICHE ED
SCORRETTE GENERICHE APPROFONDITE
7
COMPRENSIONE COMPRENSIONE COMPRENSIONE COMPRENSIONE COMPRENSIONE COMPRENSIONE
ERRATA E SCARSI I INESATTA E PARZIALE DI PARZIALE E LIMITATA COMPLETA E DETTAGLIATA
PUNTEGGIO MASSIMO COLLEGAMENTI TRA ALCUNI CONCETTI CHIAVE AD ALCUNI CONCETTI PERTINENTE PERTINENTE E
LE INFORMAZIONI APPROFONDITA
5
INTERPRETAZIONE ANALISI SCORRETTA E ANALISI GENERICA E ANALISI COMPLETA ANALISI COERENTE
SINTESI MANCANTE SINTESI NON SINTESI EFFICACE E E SINTENSI
PUNTEGGIO MASSIMO APPROPRIATA PERSONALE APPROPRIATA
4
ARGOMENTAZIONE ARGOMENTAZIONE MANCANZA ARGOMENTAZIONE ARGOMENTAZIONE
SOSTANZIALMENTE D’AUTONOMIA NELLA CORRETTA E PERSONALE
PUNTEGGIO MASSIMO INESISTENTE – USO SINTETIZZAZIONE E SCORREVOLE - AUTONOMA -
IMPROPRIO DEI NELL’ARGOMENTAZIONE – RIELABORAZIONE SPUNTI INNOVATIVI
4 TERMINI E DEI LEGAMI BAGAGLIO LESSICALE AUTONOMA RISPETTO – USO DI
LOGICI LIMITATO DEI VINCOLI LOGICO- LINGUAGGIO
LINGUISTICI SPECIFICO
NOME: CLASSE: PUNTEGGIO
TOTALE:
!25Liceo Classico – Scienze Umane - Economico Sociale “Vittorio Emanuele II” di Jesi
Esame di Stato
– G R I G L I A D I VA L U TA Z I O N E D E L C O L L O Q U I O –
Cognome e Nome del/della candidato/a:__________________________________________ classe: ______
Fase Indicatore Descrittore Punti Punteggio
attribuito
Limitata e superficiale 1
PRESENTAZIONE DEI
“PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI Essenziale e corretta 2 …….
E PER L’ORIENTAMENTO” PRESENTAZIONE ED
(ex Alternanza Scuola Lavoro). ESPOSIZIONE
(max 4 punti) Articolata e personale 3
Approfondita e originale 4
Non si orienta, anche se guidato 1
Si orienta e crea collegamenti con 2
ORIENTAMENTO E difficoltà
CAPACITA’ DI Si orienta con una certa sicurezza e
COLLEGAMENTO sviluppa collegamenti adeguati 3
Si orienta con piena sicurezza e
sviluppa collegamenti efficaci e 4
approfonditi
Molto limitate e/o usate a sproposito 1
PROPOSTA DEL MATERIALE …….
NELLA BUSTA E COLLOQUIO Superficiali e incomplete 2
MULTIDISCIPLINARE
CONOSCENZE
(max 14 punti) Adeguate ma non molto 3
DISCIPLINARI approfondite
Apprezzabili con qualche 4
approfondimento
Corrette e approfondite 5
Ampie, approfondite e sicure anche 6
nei dettagli
Incerte 1
CAPACITA’
ARGOMENTATIVE ED Semplici 2
ESPOSITIVE Piuttosto efficaci 3
Spiccate e ben articolate 4
Conoscenze sufficienti esposte in
CONOSCENZE E modo semplice ma corretto 1
“CITTADINANZA E CAPACITA’ CRITICO- ……
COSTITUZIONE” ARGOMENTATIVE Conoscenze ricche ed approfondite,
(max 2 punti) esposte in modo fluido e 2
convincente
Totale punteggio: …….. /20
!26SIMULAZIONE DELLE PROVE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
In preparazione al nuovo Esame di Stato sono state svolte due simulazioni di prima prova e
due simulazioni di seconda prova, secondo quanto stabilito dal calendario del Ministero. I
risultati di tali prove sono stati valutati nelle rispettive discipline.
R LA COMPETENZE TRASVERSALI E x alternanza scuola-lavoro)
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(ex Alternanza scuola-lavoro)
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro, ridenominate dalla legge 145 del 30.12.2018 “Percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento” sono state progettate in ottemperanza alla
legge 107/2015. L’obbligo di 200 ore di Alternanza Scuola Lavoro, ha indotto questa
Istituzione e i Consigli di classe, a suddividere il monte ore articolandolo in n. 90 ore di Stage
per gli studenti del terzo anno e n.90 ore per il quarto anno, svolte in ambiti differenti, in
relazione ad un Progetto personalizzato. Ogni esperienza è stata preceduta ed integrata
mediante attività propedeutiche allo Stage: Visite aziendali, formazione in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro(D. lgs 821/2008) incontri con tutor aziendali, informazioni sul mondo del
lavoro, questionari sulle attitudini personali e le preferenze di impiego, esercitazioni per la
redazione del proprio curriculum vitae.
Il periodo di attività presso aziende e/o Enti è stato collocato nell’ultima parte dell’a.s. e
continuato nella seconda metà del mese di giugno, mentre la valutazione delle attività e delle
competenze acquisite, a cura del Consiglio di classe è stata realizzata nel successivo a.s.
Nel corrente anno, alla classe quinta sono state riservate attività culturali e di orientamento
alla scelta universitaria o lavorativa.
In particolare per la classe 5 F la sede dello stage , nella maggior parte dei casi, non è stata la
stessa nei due anni, dando modo ai ragazzi di sperimentare situazioni lavorative diverse.
Considerando l’indirizzo specifico del corso di studi gli alunni si sono orientati verso strutture
scolastiche, asilo nido o scuola dell’infanzia; non sono mancate anche esperienze in ambito
medico-sanitario, culturale (scuole di lingua, redazione di giornale o biblioteche) o legale. Due
alunne infine hanno svolto il loro stage all’estero.
!27LETTERATURA ITALIANA
Testi utilizzati: P.ROCCHI, Fresca Rosa Novella, Loescher , voll. 2 e 3
D. ALIGHIERI . La Divina Commedia, a cura di Zoli e Sbrilli, Bulgarini
Premessa
Il programma di letteratura italiana è stato sviluppato secondo un tradizionale criterio
cronologico. Sono state infatti presentate alla classe le principali correnti letterarie dell’800 e
del ‘900 non solo italiano, inquadrate all’interno di precisi contesti storici, culturali e filosofici.
Tale metodo ha permesso agli studenti di comprendere gli elementi di continuità e di rottura
di ogni periodo e ha favorito lo studio degli autori più significativi della letteratura, sempre
inseriti nei precisi contesti descritti da cui traevano ispirazione. Molta importanza è stata
data a collegamenti con altre discipline (soprattutto la filosofia, la storia , l’arte ed il latino)
per stimolare negli studenti la capacità critica.
Spazio è stato concesso alla lettura dei testi degli autori, perché risultano essere il
mezzo più accattivante e significativo per entrare in contatto col pensiero e la sensibilità di
questi, Purtroppo però tale spazio sarebbe dovuto essere maggiore, ma motivi contingenti
(quali numerose interruzioni dell’attività didattica)hanno costretto l’insegnante a dover ridurre
il tempo concesso alla fruizione diretta dei testi.
Significativa è stata la scelta dei canti del Paradiso di Dante, opera di cui la classe è
riuscita ad apprezzare il grande valore letterario, linguistico e culturale, nonostante la
difficoltà del lessico e il disagio che crea il recupero della civiltà letteraria medievale non affine
al programma dell’ultimo anno.
ARGOMENTI SVOLTI
ILLUMINISMO : lavori di gruppo su Goldoni ( la riforma del teatro) , Parini (la critica alla
società ; l’intellettuale impegnato) , la pena di morte (Cesare Beccaria , Dei delitti e delle pene )
e la stampa periodica ( l’opinione pubblica).
Approfondimento : il genere del romanzo dalle origini al Settecento .
VITTORIO ALFIERI: tra Illuminismo e Romanticismo .
Vita, opere e weltanshaung: il titanismo .
Opere : “Autoritratto “ (fotocopia).
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA
Caratteristiche e contesto storico. V. Monti. J. W. Goethe e “ I dolori del giovane Werther”.
Testo “L’io di fronte all’Infinito”.
UGO FOSCOLO : la vita ; la cultura e le idee ; la produzione letteraria. ULTIME LETTERE DI
JACOPO ORTIS : Al Lettore ; lettere dell’ 11 ottobre e da Ventimiglia.
SONETTI :“Autoritratto” : confronto con i sonetti autoritratti di Alfieri e di Manzoni
(fotocopia);“ A Zacinto”; Alla sera; “In morte del fratello Giovanni” (confronto con carme 101
di Catullo).
I SEPOLCRI.
La prima metà dell’Ottocento
IL ROMANTICISMO
Storia del termine “romantico”.
L. Mittner: “Il concetto di Sehnsucht e il Romanticismo come categoria psicologica e come
categoria storica”
Linee generali del Romanticismo europeo. Differenze con l’Illuminismo
!28Linee generali del Romanticismo italiano: dibattito tra classicisti e romantici dopo l’articolo
di M.me De Stael.
M.me de Stael “Dovrebbero a mio avviso gl’italiani tradurre diligentemente assai delle recenti
poesie inglesi e tedesche”
Approfondimento : Il genere letterario del romanzo .
GIACOMO LEOPARDI
LA VITA : l’infanzia , l’adolescenza e gli studi eruditi; la conversione “dall’erudizione al
bello”; le esperienze fuori da Recanati; l’ultimo soggiorno a Recanati; Firenze e Napoli.
IL PENSIERO: la genesi e le fasi del pessimismo (la natura benigna; il pessimismo storico;
la natura malvagia; il pessimismo cosmico).
Dallo ZIBALDONE : La teoria del piacere; teoria del suono e della visione; la teoria del vago
ed indefinito; teoria del vero.
I CANTI
“Il passero solitario “
“L’infinito”
“A Silvia”
“La quiete dopo la tempesta”
“IL sabato del villaggio”
“La ginestra o fiore del deserto” passim
OPERETTE MORALI
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare.
ALESSANDRO MANZONI
La vita e le opere. La poetica. La questione della lingua. Confronto con Leopardi.
I Promessi Sposi e il romanzo storico.
“ 5 maggio”: analisi e commento.
LA SECONDA META’ DELL’800 IN EUROPA ED IN ITALIA
Lo scenario : storia, società, cultura e idee
La letteratura per l’infanzia : Carlo Collodi e Pinocchio ; Edmondo De Amicis e Cuore .
LA SCAPIGLIATURA: caratteristiche e rapporti con la letteratura francese (cenni a Charles
Baudelaire e ai poeti maledetti)
Emilio Praga, Preludio
IL NATURALISMO FRANCESE:
i fondamenti teorici (il Positivismo; Taine); i precursori; la poetica di Zola da “Il Romanzo
sperimentale” ;il romanzo naturalista .
!29IL VERISMO ITALIANO :
la diffusione del modello naturalista; la poetica di Verga e Capuana; l’assenza di una scuola
verista.
GIOVANNI VERGA
La vita e le opere
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
L’ideologia verghiana
Il verismo di Verga ed il naturalismo zoliano
Da “Vita dei campi “ Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”, La Roba .
Il ciclo dei vinti dai MALAVOGLIA, la prefazione, “I vinti e la fiumana del progresso”, cap. I,
la famiglia Malavoglia ; cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio. Le interpretazioni sulla
conclusione del romanzo
Da MASTRO DON GESUALDO: la morte di Gesualdo .
IL DECADENTISMO
LO SCENARIO : CULTURA E IDEE.
La visione del mondo decadente
La poetica del Decadentismo
Temi e miti della letteratura decadente
Il Decadentismo in Italia
GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita; le opere ; il dannunzianesimo .
L’estetismo e la sua crisi
Il Piacere , libro I , l’attesa; il ritratto di Andrea Sperelli .
Le Laudi: Alcyone, “La pioggia nel pineto”
GIOVANNI PASCOLI
La vita , le opere e la visione del mondo.
La poetica : Il fanciullino, “La poetica pascoliana”
I temi della poesia pascoliana
Le soluzioni formali
Le raccolte poetiche:
Myricae, “ “X Agosto”,
I Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”.
Primi poemetti : Italy.
!30Poesia italiana del primo Novecento
Contesto storico e contesto culturale
La stagione delle avanguardie e le riviste.
Analisi e commento di una poesia a scelta tra i vociani e i crepuscolari.
I futuristi e Filippo Tommaso Marinetti : i manifesti del futurismo e della letteratura
futurista; cenni al Futurismo russo ;Aldo Palazzeschi (“ Chi sono ?”, “ Lasciatemi divertire”),
i crepuscolari (Sergio Corazzini “Desolazione di un povero poeta sentimentale”)
GIUSEPPE UNGARETTI
La vita e le opere. Poetica.
da L’allegria,
In memoria,
Veglia
Fratelli
Mattina
Soldati
da Il dolore,
Gridasti , soffoco (fotocopia)
Non gridate più
EUGENIO MONTALE
La vita ed opere. Poetica del correlativo oggettivo
da Ossi di seppia, I Limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
L’ERMETISMO: origine e definizione .
SALVATORE QUASIMODO
La vita, le opere e la poetica.
Ed è subito sera
Uomo del mio tempo (fotocopia)
LUIGI PIRANDELLO
La vita, la visione del mondo
La poetica : L’umorismo, “Il sentimento del contrario”
Le novelle: Ciaula scopre la luna
I romanzi:
da Il fu Mattia Pascal: la prima premessa ; lo strappo nel cielo di carta
da Uno, nessuno e centomila:Tutto comincia da un naso .
Il teatro
Sei personaggi in cerca di autore
!31ITALO SVEVO
La vita ,la cultura , le opere. Il caso “Svevo”.
Da La coscienza di Zeno: la prefazione; il fumo; lo schiaffo ; il finale .
UMBERTO SABA
La vita , le opere , il pensiero.
La capra
Trieste
Mio padre è stato per me “l’ assassino”
Ulisse
Divina commedia: introduzione alla cantica .
Parafrasi e commento dei canti:
I vv. 1-36: proemio del Paradiso
vv.43-81: Dante e Beatrice cominciano a salire dall’Eden al Paradiso. La
trasumanazione
vv.81-93: il primo dubbio di Dante
II vv.1-18: il monito al lettore
III vv. 34-57: incontro con Piccarda
vv. 58-87: Piccarda spiega a Dante la condizione dei beati
vv.88-108: la vicenda umana di Piccarda
VI vv.1-33: l’imperatore Giustiniano narra la propria vita
vv.97-111: invettiva contro guelfi e ghibellini
XI vv. 43-117: presentazione di San Francesco.
XXXIII vv.1-39: Preghiera di San Bernardo alla Vergine
Gli studenti La docente
prof.ssa MARIANGELA VALENTINI
!32LINGUA E LETTERATURA LATINA
FEDRO E LA FAVOLA : Gli umili alla ribalta letteraria, l’opera e il mondo di Fedro.
I testi : Prologus
Lupus et agnus ( Fabulae I,1)
Vulpes ad personam tragicam (I,7)
Cervus ad fontem (I, 12)
Vulpes et corvus ((I, 13)
Vacca capella ovis et leo (I, 13)
Rana rupta et bos (I, 24)
De vulpe et uva (II 3)
De vitiis hominum (II 10)
Mons parturiens (II 24)
Lupus ad canem (III, 7) ITA
La matrona di Efeso (Appendix Perottina 114) ITA
SENECA : la vita e le opere, il pensiero filosofico e lo stile.
I testi: La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4 )
Riappropriarsi del tempo (Epist.1, 1-5)
La schiavitù (Epist. 47, 1-4 , 10-11)
Il male di vivere (De tranquillitate animi 2, 10-15)
La lotta contro l’ira (De ira 13, 1-3)
PETRONIO: I misteri del Satyricon, Petronio e il problema dell’identificazione, i modelli e la tecnica
narrativa del romanzo, il mondo del Satyricon, la lingua.
I testi: Entra in scena Trimalchione ( 32-33) ITA
Presentazione dei padroni di casa (37) ITA
Trimalchione fa sfoggio della sua cultura (50) ITA
Il lupo mannaro ( 61, 6-14) ITA
La matrona di Efeso ( 111-112 ) ITA
LUCANO, TRA POESIA E POLITICA : Notizie biografiche, il Bellum civile o Pharsalia, la nuova epica di
Lucano, la visione pessimistica, lo stile, Lucano e la negromanzia
I testi: Proemio (I, vv.1-9) ITA
I serpenti del deserto libico (….) ITA
Una funesta profezia (VI, vv. 624-725) ITA
!33LA PEDAGOGIA DI QUINTILIANO: Una vita per la scuola, l’ Institutio oratoria, lo stile.
I testi: Proemium (9-12)
Una professione di fede nella scuola ( Instit. I, 1-3)
I primi attori del processo formativo ( I, 1, 4-9)
Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (I, 1-2, 4-8)
Anche a casa si corrompono i costumi (I 2, 4-8) ITA
Vantaggi della scuola pubblica (I 2, 17-22)
L’importanza della ricreazione (I, 3, 8-14)
Contro le punizioni corporale (I 3 14-17)
Il maestro ideale (II, 2, 5-8)
I doveri dell’allievo (II 9 1-3)
MARZIALE Una vita alla ricerca della stabilità, l’epigramma, la poetica e i modelli, la tecnica
compositiva e lo stile.
I testi: Matrimoni di interesse (10, 8, 43) ITA
Tutto appartiene a Candido (III, 26)
L’epigramma per la morte della piccola Erotion (V, 34) ITA
SVETONIO, BIOGRAFO IMPERIALE: Nerone e Domiziano (dal De viris illustribus) ITA
GIOVENALE, IL POETA DELL’INDIGNAZIONE: La vita e la produzione artistica, il Giovenale delle
prime satire, dallo sdegno alla rassegnazione: le ultime satire. Stile, lingua, tecnica.
I testi: Roma città crudele con i poveri (Sat III, vv.41-48, 190-222) ITA
La metetrix augusta (Sat. VI, vv.114-131) ITA
La padrona crudele ( Sat. VI, vv.206-230) ITA
Responsabilità dei genitori (VII 219-243) ITA
TACITO, STORICO O MORALISTA, la visione della storia e della politica, le opere e lo stile, il mistero
del Codex Aesinas.
I testi: Il discorso di Calgaco (da Agricola 30-31 3) ITA
Purezza razziale e aspetto fisico (Germania, 4)
Risorse naturali e denaro (5)
La fedeltà coniugale (Germania 19)
Nerone e l’incendio di Roma (Annales XV 38-39) ITA
La persecuzione deo cristiani (Annales XV 44) ITA
!34Puoi anche leggere