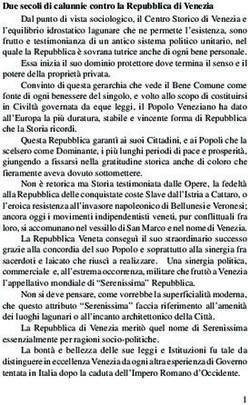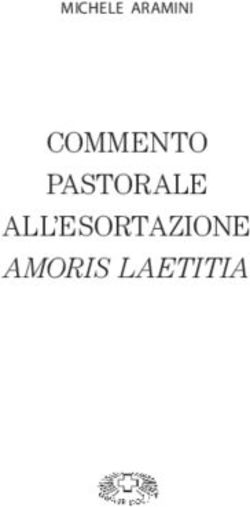Alla scuola di Lourdes senza devozionalismi o pregiudizi
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Alla scuola di Lourdes senza
devozionalismi o pregiudizi
di Stefano Liccioli • Nel mese di
febbraio è uscito nelle sale
cinematografiche italiane il
documentario “Lourdes”.
Si tratta di un’opera che, come
affermano i due registi francesi Thierry
Demaizière e Alban Teurlai, va a colmare
una lacuna: sull’importante santuario
mariano francese erano stati realizzati
finora solo film e reportage televisivi,
ma mai un documentario che raccontasse
la storia dei tanti pellegrini che ogni
anno si recano a Lourdes (nel 2016 sono stati circa
seicentomila). I due registi hanno trascorso un anno presso il
santuario, seguendo dieci pellegrinaggi e girando ben
duecentocinquanta ore di filmati. Il risultato è un racconto
corale, in presa diretta, che assume la prospettiva delle
persone, di qualsiasi fede e cultura, che si sono recate,
magari neanche per la prima volta, alla grotta dove nel 1858
la Madonna apparve alla quattordicenne Bernadette Soubirous.
E’ un intreccio di storie, spesso caratterizzate dal dolore e
dalla sofferenza, con cui ogni pellegrino si presenta ai piedi
della Vergine.
Lo sguardo di Demaizière e Alban Teurlai è quello di due
persone non credenti che proprio per questo però riescono a
testimoniare come la verità di Lourdes sia qualcosa che
travalica la fede per parlare a tutti. Il documentario
presenta uno spaccato sulla condizione umana, soprattutto
quella più fragile e ferita nel corpo e nello spirito, ma
anche sulla fede, l’amore e la speranza.
Per chi, come me, è stato più volte a Lourdes non può cheritrovarsi nelle testimonianze dei pellegrini che si raccontano. Ho trovato particolarmente vera l’affermazione secondo cui «quando sei a Lourdes puoi mostrare te stesso perciò che sei veramente in tutta la tua grandezza e debolezza». La sensazione più diffusa, infatti, è quella di sentirsi pienamente se stessi, in un clima di reciproca fraternità. Guardando scorrere le immagini non si può non pensare a come il pellegrinaggio, in generale, ai santuari sia davvero un’eseperienza di fede e non di folclore, come in alcuni casi viene messo in luce. Soprattutto quando il pellegrinaggio è di gruppo si può sperimentare bene, a mio avviso, la Chiesa come popolo di Dio in cammino: la fede, infatti, non è un percorso in solitaria, ma un itinerario da fare con fratelli e sorelle, condividende le gioie, le cadute e le difficoltà. A tal proposito sono significative le esperienze di tutte quelle associazioni che accompagnano a Lourdes o negli altri santuari le persone ammalate. E’ un modo straordinario per ricordarci che abbiamo una responsabilità nei confronti del nostro prossimo, chiunque esso sia. Ma ci rammenta anche che nessuno è uno scarto, un pezzo venuto male, ma un fratello o una sorella da guardare con gli occhi Dio. Il merito dell’opera dei due registi francesi è di accostarsi al fenomeno di Lourdes senza pregiudizi e senza tesi precostituite o parzialismi come quando si parla del santuario francese limitandosi alle guarigioni o agli aspetti commerciali che vi gravitano intorno e che piaccio tanto, per non dire troppo, a certi media.
Un’annotazione, infine, su alcuni aspetti stilistici del
documentario che si avvale di un montaggio efficace e di una
fotografia capace di evocare i ricordi più belli per chi è
stato a Lourdes, ma anche d’incoraggiare ad andarci per chi
ancora non c’è stato.
Il futuro dei giovani e la
crisi demografica
di Antonio Lovascio • Saper
leggere e scrivere non è più
sufficiente in una società
tecnologica, sempre più
complessa, nella quale i rischi
si moltiplicano. Anche per quanti
come me si occupano di
Comunicazione, è sempre più indispensabile avere almeno una
minima conoscenza della psicologia intuitiva e la capacità di
interpretare le statistiche, che aiutano poi a comprendere
cosa succede attorno a noi, i mutamenti ed i fenomeni più
significativi del mondo, e in particolare dell’Italia. Oltre
ai primi dati sul Coronavirus (su cui si potrà riflettere
quando la sua diffusione sarà più chiara e si sarà placato il
panico che si è sovrapposto ad una giustificata paura) nelle
ultime settimane mi hanno impressionato due Rapporti tra loro
in qualche modo concatenati, purtroppo trascurati dai Media:
il crollo demografico e l’idea che i giovani hanno del loro
futuro. “Fotografie” che purtroppo peggioreranno se l’epidemia
aggraverà la recessione economica.
I giovani rinviano la scelta di avere figli e preferiscono
emigrare in cerca di opportunità all’estero, perché non vedonoprospettive di trovare un buon posto di lavoro e un reddito soddisfacente; ma proprio il declino della popolazione, che è il risultato di miriadi di scelte individuali, riduce la domanda interna, erode la capacità produttiva e, in definitiva, limita quelle stesse prospettive di crescita che servirebbe ai giovani per decidere di procreare o cercare un futuro in Italia. Ormai questa è una spirale che si sta autoalimentando da sola. L’Italia ha già perso 478 mila abitanti fra il 2015, momento di massima estensione della popolazione nella Penisola, alla fine dell’anno scorso, quando le nascite hanno fatto registrare il minimo storico: 116 mila italiani in meno. Il ricambio naturale si ferma. L’ISTAT ci racconta che la crisi demografica italiana si manifesta con due storie diverse: una discreta tenuta al Nord e soprattutto al Nord-Est e un collasso nel Mezzogiorno che minaccia intere aree di una vera e propria desertificazione dei giovani. In altri termini le migrazioni interne e internazionali fanno sì che la popolazione nel Nord Italia – soprattutto a Nord-Est – continui a crescere almeno un po’. Nelle regioni del Centro Italia c’è invece una lieve decrescita dei residenti nell’ultimo anno (-0,22%), anche perché poche persone sono arrivate in Toscana, Lazio, Umbria o Marche dal resto del Paese. Al Sud invece i numeri della popolazione stanno letteralmente collassando. L’intera area ha perso 129 mila persone l’anno scorso – persino più di quante ne abbia perse l’Italia nel complesso – con un saldo netto di migrazioni verso il resto del Paese di 77 mila meridionali che hanno scelto di andarsene Lombardia, Piemonte e Veneto.
Che la scelta relativa ai figli sia in calo lo conferma anche un’indagine condotta da Eurispes, che per la prima volta ha messo a confronto I valori della vita dei giovani tra i 18 e i 30 di Italia, Germania, Polonia e Russia, fortemente orientati verso valori che riguardano la vita sociale e privata (salute, carriera amore, amici), evidenziando, invece, una lontananza rispetto ai valori politici e a quelli spiritualità. Lavoro e casa sono in cima agli incubi dei giovani. Il terrorismo non c’è. La situazione del mercato del lavoro, i problemi abitativi, la mancanza di tutele per la vecchiaia e, in generale, le difficoltà economiche sono tra i principali problemi percepiti dai 18-30enni. Insomma i risultati dello studio EURISPES evidenziano che nel 2019 l’orizzonte sociale della pianificazione della vita dei giovani è progettato solo a medio termine ed è significativamente in ritardo rispetto a quello della pianificazione biologica: Un dato che impoverisce il quadro generale del progresso futuro, ma suggerisce che le nuove generazioni non vivono “giorno per giorno”. I giovani, classificati per coorti statistiche, nel contesto dei cambiamenti globali e delle crisi costanti che li caratterizzano, non vedono la possibilità di costruire piani a lungo termine, che è tipico per le età più mature, e sono alla ricerca di opportunità in varie fonti di risorse. L’attuale generazione giovanile è orientata a creare il proprio futuro prevalentemente in modo autonomo, per conto proprio. Un’ultima considerazione: il fatto che giovani appartenenti a sistemi anche molto diversi tra loro, manifestino elementi di convergenza su alcuni punti fondamentali relativi alla loro idea di futuro, dovrebbe far riflettere sia gli studiosi che la Politica e le Istituzioni sul fatto che il mondo digitale sta creando sempre di più una comunità giovanile europea che, nonostante le stesse radici cristiane, esprime pensieri e sentimenti autonomi al di là dei tradizionali confini degli
Stati. L’interpretazione e la gestione di questo fenomeno è un
problema aperto per tutti: un problema scientifico, politico,
culturale, sociale. Ed anche ecclesiale. Già da tempo Papa
Francesco e la CEI hanno fatto squillare il campanello
d’allarme. Purtroppo finora inascoltati.
Ricordando don Benito
Marconcini
di Stefano Tarocchi • Mons. Benito
Marconcini nasce a Montaione (città
metropolitana di Firenze, diocesi di
Volterra) il 18 aprile 1938. Compie gli
studi classici all’università di Firenze,
dove consegue la laurea in lettere.
Successivamente ottiene la licenza al PIB e
il dottorato all’Angelicum.
Nel 1965 diventa prefetto degli studi presso il Seminario
regionale di Siena, dove già aveva studiato teologia: ha a che
fare con un centinaio di studenti della metropolia con le
diocesi che vi afferivano (Montepulciano, Chiusi e Pienza,
Grosseto, Pitigliano, Sovana e Orbetello) e l’allora
Congregazione dei seminari (poi Congregazione per l’educazione
cattolica).
Don Benito vi svilupperà le sue doti di mediazione, che dovrà
impiegare nel corso del suo ministero e della sua vita
accademica. In quegli anni dà anche il via alla scuola diformazione biblica e teologica per laici presso il centro culturale San Donato di Siena. Viene ordinato presbitero a Volterra nel 1962 (e dal 1980 farà parte dell’Istituto Gesù Sacerdote dei Paolini di don Alberione). Nel 1966 cominciò l’insegnamento a Firenze presso lo Studio Teologico Fiorentino: nelle prime stagioni svolgerà gli insegnamenti di metodologia e di ebraico; in seguito insegnerà Profetismo. Memorabile negli anni ‘70 l’esame di ebraico del direttore della nostra rivista, sulla parabola narrata da Natan a David, con il celebre «tu sei quell’uomo!» (2 Sam 12,7), naturalmente nella lingua originale e davanti al riso irrefrenabile di Marconcini. Non va dimenticato il ruolo di vicepreside, creato poco prima. Sotto questa veste affianca don Valerio Mannucci: don Benito lo accompagna, e di fatto anche lo sostituisce, negli ultimi anni di vita, al tempo della brutta malattia che precede la morte del preside storico dello Studio Teologico Fiorentino (STF). In questi giorni, fra l’altro, ricorre il venticinquesimo anniversario della sua scomparsa repentina. Don Benito era molto attento alle singole persone: mi vidi assegnare il corso di Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli dopo il meritato pensionamento dell’ottantacinquenne P. Lino Randellini. Gli sono grato anche per l’anno sabbatico nel primo anno del mio dottorato, che obbligò a forzare i sacri parametri degli orari. Non posso poi non ricordare la preziosa collaborazione con Marconcini per lo sviluppo della Biblioteca, che al tempo dirigevo, e che portò ad un salto di qualità anche per l’informatizzazione introdotta nel nostro Studio teologico al tempo. Grazie a lui portammo in facoltà il collegamento alla rete internet, nei suoi vari sviluppi. Don Benito vedeva lontano. Se eravamo momentaneamente su posizioni differenti, in lunghe conversazioni al telefono, – non si faceva mai negare, – riuscivamo sempre, grazie a lui a
trovare un punto di incontro. Nel frattempo (1993), era diventato preside dello STF, incarico che rivestì fino al 1997, quando lo STF venne eretto a facoltà. Così don Benito fu il traghettatore dallo STF alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (FTIC) e protagonista attivo del lungo lavoro di preparazione che comportò il superamento di tutti gli ostacoli che si sovrapponevano, soprattutto con la Congregazione per l’educazione Cattolica e in stretta sinergia con il cardinale Silvano Piovanelli, per continuare il lavoro iniziato da tempo. Fu vero fondatore della rinata Facoltà teologica, naturalmente insieme a tanti di noi. Nessuna contiguità con quanti si sono affacciati con ben altri progetti, provvidenzialmente vanificati dai fatti. Quando arrivò l’ormai insperato decreto da Roma, a poca distanza del terremoto di Assisi, quello Studio teologico della città di Francesco che menti poco lungimiranti volevano associare a Firenze in una modalità inappropriata, quando la semplice distanza lo impediva, fu nominato primo Preside della FTIC (1997) e fu confermato tre anni dopo, fino al 2003. Alla scadenza dell’incarico don Benito venne nominato prima canonico onorario, e poi effettivo, della Metropolitana fiorentina. Nel 2008, compiuti i settanta anni, divenne docente emerito.
Nel 2010 la facoltà gli offrì una miscellanea per i suoi 75 anni (in realtà erano 72!): Memoria Verbi. Saggi in onore di Mons. Benito Marconcini. A cura di L. Mazzinghi – B. Rossi – S. Tarocchi, («Vivens Homo» 21, 2010). Vi collaborano colleghi e colleghe ed ex-alunni (gli stessi curatori dell’opera), ed ex alunne – la divisione dell’opera in due parti rispettava le specifiche competenze degli esegeti e dei teologi. Qui vorrei ricordare anche l’uomo sapiente e capace, il ricercatore e docente acuto, ma anche il prete amante e comunicatore della Parola: il saggio uomo di governo, in cui la bonomia non si distaccava mai dalla fermezza – era celebre, e ne sono direttamente testimone, il momento in cui in certe discussioni degli organismi accademici amabilmente aggiungeva: «Ricordate che mi chiamo Benito… e si fa come dico», che portava a risolvere con spirito costruttivo tutte le querelle – soprattutto quelle generate dal principio che Umberto Eco, ne Il pendolo di Foucault ha chiamato la tetrapiloctomia: ovvero l’arte sottile e perversa, erede del bizantinismo, di “spaccare il capello in quattro”, capace di sprecare inutilmente il tempo. Così don Benito, usando l’ironia non lasciava mai con la bocca amara nelle situazioni apparentemente senza via d’uscita. La sua spiccata intelligenza relazionale riusciva sempre a trovare i punti di unione, senza mai mortificare i colleghi, né tantomeno alzare la voce. Nel 2012 festeggiò con diversi dei suoi colleghi il cinquantesimo dell’ordinazione presbiterale. Fu allora che consegnò ai presenti un prezioso libretto (Alla sequela di Gesù. Il discepolo nel Nuovo Testamento, Paoline, Milano 2012) che raccolse nella parte finale la sua sterminata produzione di libri, articoli, voci di dizionario, ecc., che inizialmente era prevista nella miscellanea. Questo libretto fu il suo testamento spirituale: l’acribia dello studioso, con la sua squisita sensibilità e passione
della Parola, ma anche della comunicazione a tutti: agli
specialisti, ma anche agli studenti delle facoltà e degli
studi teologici, e dell’intero popolo di Dio in una serie
senza fine di lezioni e conferenze.
Questo era – ed è – il suo messaggio: dopo
quell’evento in cui don Benito mostrò tutta
la gioia di cinquant’anni al servizio del
Signore, purtroppo cominciò il declino
psicofisico che l’ha portato alla sua
scomparsa.
Per tante volte le persone che, come tanti di noi l’hanno
conosciuto, la sua preziosa ed insostituibile collaboratrice
Nadia, l’intero personale del convitto ecclesiastico, si sono
– ci siamo – interrogati sul misterioso perché un uomo tanto
sapiente fosse stato colpito dal male proprio nell’organo che
guida tutto il nostro vivere, la mente e il cervello, e
l’abbiano reso tabula rasa, da cui ogni tanto, in certi
momenti, riemergevano schegge della sua antica sapienza.
Si invera così quello che dice il vangelo di Matteo: «ogni
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche» (Mt 13.52).
Così il cuore e il sorriso di don Benito ci rimangono accanto,
insieme alle parole di Paolo indirizzate ai cristiani della
chiesa di Filippi: «la vostra amabilità sia nota a tutti. Il
Signore è vicino!» (Fil 4,5).
Che il Signore accolga fra le sue braccia di misericordia don
Benito Marconcini e gli dia il premio promesso ai suoicollaboratori fedeli: «servo buono e fedele, sei stato fedele
nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del
tuo Signore” (Mt 25,21)».
Giorgio La Pira, maestro
anche nel linguaggio:
adattivo, rispettoso, poetico
ed ottimista.
di Carlo Parenti • Assistiamo nel
dibattito politico, nei Talk
show, sui giornali, in incontri
pubblici e privati ad un
linguaggio a dir poco sguaiato,
spesso offensivo verso
l’interlocutore. Dominano sempre
più spesso la mancanza di rispetto, le accuse , una cifra
linguistica degradata e volgare, un attardarsi nell’analizzare
il passato e nell’indicare per il futuro visioni banali, non
documentate e comunque pessimistiche, prive di speranza.
Voglio qui illustrare un esempio magistrale: il linguaggio di
Giogio La Pira, che era adattivo, poetico ed ottimista; mi
spiego.
Nel parlare in pubblico, ricorreva anche a una gestualità di
universale comprensione (del resto, osservo, i recenti studi
etologici e psicologici, danno sempre più rilevanza al
linguaggio gestuale nella relazione tra persone). Dossetti
ebbe già a notare come la mimica di La Pira oltrepassava le
parole e come inoltre la sua personalità era pulita, luminosa,di un colore bianco che emanava da tutto il suo essere. Mi ha sempre colpito questo suo linguaggio, scritto e parlato. A mio modo di vedere aveva un registro comunicativo particolarissimo e “adattivo” nei confronti degli interlocutori del momento. Il saper cambiare modalità espressiva a seconda di chi si ha davanti è sicuramente una capacità che denota grande intelligenza e in un certo senso genialità. Quando si rivolgeva ai meno acculturati, ai semplici, usava un linguaggio piano, scorrevole, semplice, di immediata comprensione. Quando invece il discorso era rivolto agli uomini di cultura, ai politici, agli ecclesiastici, ai potenti, il linguaggio si faceva denso, articolato, ricco di subordinate e incisi, di parentesi, di sottolineature ed evidenziazioni (le virgolette). In entrambi i casi era costruito aristotelicamente, per punti. Era infatti un aristotelico e costruttori di architetture aristoteliche erano due personaggi che ricorrevano spesso anche come tali nei suoi discorsi: il giurista romano Gaio e san Tommaso, il quale partendo dalle Scritture e interpretando sant’Agostino estese l’impianto aristotelico alla teologia. Entrambe le figure accompagnarono le sue riflessioni per tutta la vita. Il professore era quindi capace di mettersi nei panni di chi lo doveva ascoltare o leggere, partiva dal concetto che magari non sapeva niente dell’argomento e aveva solo lui come fonte di informazioni. Cercava di essere chiaro. Per usare concetti del marketing, cercava di mettersi nei panni del cliente. Era, mi pare di poter dire – e se ne può trovare conferma nei filmati giunti fino a noi, reperibili anche su YouTube– una sorta di anticipazione verbale di PowerPoint, cioè il programma di presentazione di Microsoft. I concetti erano spiegati infatti per bullet point (elenco per punti). Concentrava cioè le informazioni principali in punti o titoli, e faceva largo uso di punti chiave, liste numerate e grassetto. Schematizzava il più possibile, isolava i diversi
argomenti e dava loro una sequenza logica. Ma nel linguaggio del professore apparivano spesso immagini poetiche, che trovavano radici nei testi biblici e che si riferivano anche e soprattutto alla natura (il creato): il volo degli uccelli migratori, lo scorrere dei fiumi, la navigazione, i porti, la barca (di Pietro), l’oceano cosmico, la primavera, la fioritura, le messi, la mietitura, l’alba, la lotta tra tenebre e luce, le stelle, il pianeta, ecc. Questa dimensione poetica andrebbe approfondita. Certamente fu influenzato anche dall’amicizia mai interrottasi dagli anni messinesi con Salvatore Quasimodo, cui lo accomunavano l’amore per la poesia, la fede e la ricerca di Dio. Scrivendogli La Pira definiva la poesia come un grimaldello che apre le mistiche case dell’anima e coglie il palpito invisibile delle cose visibili. La sua “poesia” (anche nello sperare un mondo giusto, secondo Isaia) lo facilitò nei rapporti con personaggi come Senghor e addirittura Ho Chi Minh. Sovente sapeva essere anche ironico. Ma non era mai una ironia offensiva o sminuente l’altro, non era derisione, era un sorriso angelico di fraternità. Papa Francesco da Firenze il 10 novembre 2015 ha significativamente detto: «l’umanesimo cristiano […] stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità […] e fornisce ragioni […] per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura». La Pira mai usava espressioni negative verso qualcuno. Con i Proverbi, diceva «benedetto chi benedice, maledetto chi maledice» e con Luca (6,37) «non giudicate e non condannate». E al massimo, se non era convinto della persona, diceva di qualcuno «fasullo». Mai pettegolava.
La Pira non indulgeva al pessimismo e il suo vocabolario
esprimeva speranza, infatti il suo non conosceva il
pessimismo: come detto parlava solo con espressioni positive e
mai negative. La negatività trovava dimora in una sola frase:
«nonostante tutto». Era infatti un consapevole ottimista. E
questo, nel colloquiare, lo faceva appunto trasparire nel suo
sorriso.
Non era mai supponente, era sempre una persona che spiegava
con umiltà il suo punto di vista che non imponeva, ma
suggeriva. Il suo motto, con san Paolo, era: spes contra spem.
«Egli (Abramo) ebbe fede sperando contro ogni speranza e così
divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: Così
sarà la tua discendenza» (san Paolo, Lettera ai Romani, 4,18).
Ciò a significare che anche quando la realtà porta a pensare
che tutto è perduto resta piena la fede in un futuro migliore.
In conclusione: un vero attuale Maestro di linguaggio anche
per tutti i politici e coloro che vogliono essere inclusivi e
fare squadra a servizio di questa nostra umanità sofferente.
Le ragioni di un titolo
Le ragioni di un titolo
di Gaetano Mercuri • Questa nuova rubrica della rivista prendeil nome da un celebre libretto, ancora disponibile in libreria, che raccoglie una serie di scritti dell’allora mons. Giovanni Battista Montini su Azione Fucina, rivista ufficiale della Federazione degli Universitari Cattolici Italiani (F.U.C.I.) nei primi anni ’30 del XX secolo. La coerenza e la passione in questi scritti sono notevoli. Montini, in quelle poche pagine quanto mai limpide e profonde si lancia in una colta quanto adamantina difesa nello stesso tempo della ragione e della trascendenza. I punti salienti della riflessione montiniana si incentrano sull’unità di pensiero che deve contraddistinguere lo studente universitario che si definisca cristiano. Per Montini Fede e Ricerca vanno come si suole dire “a braccetto”. Entrambe hanno un ruolo essenziale nella formazione e nella coscienza del giovane studente universitario. Ad un certo punto l’autore si spinge a dire che quella dell’università è un esperienza essenzialmente religiosa. Ma in che senso? Lo studio per il futuro papa è «materia della più alta moralità» mentre l’esperienza universitaria è momento della «religione del vero». Ciò significa che lo studente cristiano non deve trascurare la grande importanza di una vera e propria etica della coscienza universitaria che contrasti efficacemente il positivismo e l’agnosticismo, se non
addirittura il laicismo ed ateismo che
pervadono gli ambienti scientifici.
Montini in Coscienza Universitaria sostiene fermamente che lo
spirito di ricerca apre lo studente credente alla
sperimentazione pratica di quel volto di Dio redentore e
rivelatore, perché apre alla mente ed al cuore nuovi orizzonti
di senso, una volta giunti ai limiti delle proprie conoscenze
e del proprio ricercare.
Un libricino, Coscienza Universitaria, tutto da riscoprire e
che parla ancora ai giovani studenti di oggi. Un libricino che
farà quindi da sfondo ed ispirazione, nei prossimi numeri, a
questa nuova rubrica della nostra rivista, dove si
affronteranno problemi e sfide dei giovani credenti di oggi,
alle prese con gli studi superiori.Puoi anche leggere