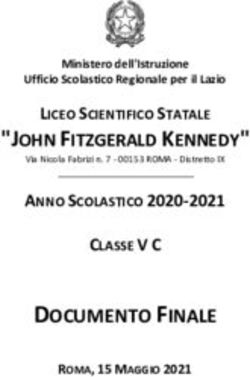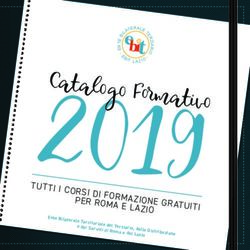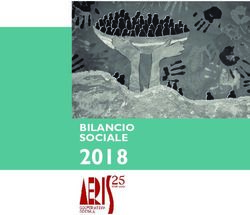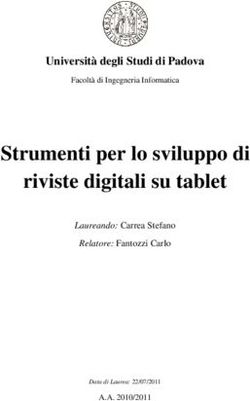Enrico Mattei ESAME DI STATO 2019 - Documento della classe: Istituto Tecnico Industriale Statale - Gruppo Spaggiari Parma
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Istituto Tecnico Industriale Statale
Enrico Mattei
San Donato Milanese, Via Martiri di Cefalonia 46
ESAME DI STATO 2019
Documento della classe:
5BL 15 maggio 2019
Pagina 1 di 28FIRME
MATERIA DOCENTE FIRMA
Lingua e letteratura italiana FLORA MARIA BACCHIONI
Lingua e cultura straniera: Inglese SILVIA FRANCESCA PULITI
Storia FLORA MARIA BACCHIONI
Filosofia SERGIO ALFREDO DAGRADI
Matematica PAOLA MARCATI
Fisica ANNA BAZZOCCHI
Scienze naturali MARIELLA CAPPELLA
Informatica CRISTINA CALAFIORE
Storia dell'arte ANDREA VISCO
Scienze motorie e sportive ANGELO DI BATTISTA
Religione cattolica ANTONIO CRISTINO
1° rappresentante studenti RICCARDO CAPACCIOLI
2° rappresentante studenti AOUANI ZAID
Dirigente Scolastico SUSANNA MUSUMECI
Pagina 2 di 28Indice
1. Presentazione del corso di studi
2. Presentazione della Classe
- 2.1. Storia della classe
- 2.2. Situazione generale della classe e fasce di livello
- 2.3. Interventi di recupero
3. Presentazione del Consiglio di Classe
- 3.1. Continuità didattica
- 3.2. Formazione della Commissione d’Esame
4. Programmazione del Consiglio di Classe
- 4.1. Criteri di verifica e valutazione
- 4.2. Attività progettuali inserite nel Pof e/o deliberate dal CdC
- 4.3. Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
- 4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
- 4.5. Clil
- 4.6. Indicazioni per il colloquio
5. Note metodologiche e contenuti delle singole disciplina
Lingua e Letteratura italiana
Lingua e Cultura inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Informatica
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
ALLEGATI:
Allegato 1: Documentazione sugli alunni con BES
Allegato 2: Griglie di valutazione
Allegato 3: Materiale fornito dai docenti
Pagina 3 di 281. Presentazione del Corso di Studi
La classe 5BL ha seguito il seguente PIANO ORARIO:
MATERIE D’INSEGNAMENTO
del
1° 2° 3° 4° 5°
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3**
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Fisica 2 2 3* 3 3
Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 3 4 5 5 5
Disegno e Storia dell'arte 2 2 2
Informatica 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE SETTIMANALE 27 27 30 30 30
*NOTE: Per Fisica 1 ora alla settimana è stata svolta in copresenza con un docente tecnico-pratico.
**NOTE: Per la lingua straniera 1 ora alla settimana è stata svolta in copresenza con un docente madrelingua.
Pagina 4 di 282. Presentazione della classe
2.1. Storia della classe
Classe Iscritti Promossi Respinti Con Debiti Trasferiti Trasferiti Ritirati
in entrata in uscita
III 27 26 Nessuno 6 Nessuno 1 (cambio Nessuno
sezione ad
inizio anno)
IV 25*+1** 25 Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno
V 26
* Una studentessa ha svolto l’anno scolastico all’estero ai sensi della Normativa ministeriale vigente e linee di
indirizzo sulla mobilità internazionale (nota prot. 843, 10/04/2013), del D.L.vo n. 13 del 16/01/2013 sulla
Valutazione degli apprendimenti non formali e informali e del Regolamento interno approvato dal Collegio dei
docenti in data 16/02/2016 con delibera n. 21.
** Una studentessa straniera è stata presente alle lezioni all’interno di un programma di scambio internazionale
(Intercultura).
2.2. Situazione generale della classe
L’atteggiamento degli studenti non è sempre stato corretto, anche se, fatti salvi alcuni casi particolari, non si sono
segnalati gravi episodi dal punto di vista comportamentale.
Dal punto di vista didattico la classe ha raggiunto un discreto livello di preparazione: nel corso degli anni quasi tutti
gli studenti hanno seguito con impegno non solo il lavoro proposto dai docenti, ma anche i suggerimenti per il
recupero o il potenziamento. All’interno del gruppo è possibile distinguere tre fasce di livello: un certo numero di
allievi ha dimostrato di aver acquisito una buona preparazione e un metodo di studio efficace; la maggior parte è
stata in grado di ottenere buoni risultati soprattutto a fronte di scadenze programmate, mantenendo comunque una
media sufficiente o più che sufficiente; un esiguo numero di alunni ha indirizzato il proprio studio allo svolgimento
di singole verifiche, risultando talora in difficoltà rispetto ad una capacità di programmazione del lavoro e ad una
rielaborazione dei contenuti di più ampio respiro.
Purtroppo, il frequente cambio di docenti in diverse discipline (Lingua e Letteratura italiana, Storia, Informatica) ha
determinato il manifestarsi di alcune fragilità a livello metodologico e contenutistico nelle stesse, fragilità che
comunque la maggior parte della classe è riuscita a compensare grazie allo studio e alla costanza nell’affrontare il
lavoro. 2.3. Attività di recupero Secondo delibera del Collegio dei docenti, è stato previsto per le
2.3. Attività di recupero
Secondo delibera del Collegio dei docenti, è stato previsto per le classi quinte il recupero in itinere e/o
individualizzato.
Pagina 5 di 283. Presentazione del Consiglio di Classe
3.1. Continuità didattica:
MATERIE D’INSEGNAMENTO 3° 4° 5°
Lingua e letteratura italiana Celeste Sebastiani Daniela Fabrizio Flora Maria
Bacchioni
Lingua e Cultura Inglese Silvia Francesca Silvia Francesca Silvia Francesca
Puliti Puliti Puliti
Storia Celeste Sebastiani Daniela Fabrizio Flora Maria
Bacchioni
Filosofia Sergio Alfredo Sergio Alfredo Sergio Alfredo
Dagradi Dagradi Dagradi
Matematica Lucia Bellenzier Paola Marcati Paola Marcati
Fisica Anna Bazzocchi Anna Bazzocchi Anna Bazzocchi
Laboratorio fisica Mariarosa Valentini ——————— ———————
Scienze naturali (Biologia, Chimica e Mariella Cappella Mariella Cappella Mariella Cappella
Scienze della Terra)
Informatica Maria Vincenza Iori/ Fausto Lai Cristina Calafiore
Alessandro Negroni
Disegno e Storia dell'arte Daniele Bricchi Andrea Visco Andrea Visco
Scienze motorie e sportive Angelo Di Battista Angelo Di Battista Angelo Di Battista
Religione cattolica o attività alternativa Cosimo Spinola/ Antonio Cristino Antonio Cristino
Elpidio Santonastaso
Sostegno Chiara Scicolone Pier Paolo Bianco Mariarosa Valentini
La classe ha cambiato diversi docenti nel corso del triennio, sia in corso d’anno (soprattutto in terza) sia tra un anno
scolastico e l’altro. Particolarmente problematica è stata la discontinuità didattica in Lingua e Letteratura italiana,
Storia ed Informatica, discipline che hanno visto il succedersi di almeno tre diversi docenti nel corso del triennio.
3.2. Formazione della Commissione d’Esame
Materie a cura dei docenti esterni:
1. Lingua e Letteratura Italiana
2. Lingua e Cultura Inglese
3. Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra)
Materie a cura dei docenti interni e nomi dei docenti::
1. Matematica - prof.ssa Paola Marcati
2. Fisica - prof.ssa Anna Bazzocchi
3. Filosofia - prof. Sergio A. Dagradi
4. Membro aggregato - Sostegno - prof.ssa Mariarosa Valentini
Pagina 6 di 284. Programmazione del Consiglio di Classe
4.1. Criteri di verifica e valutazione
Il Cdc ha adottato i criteri di verifica e valutazione dell’attività didattica nonché i parametri di valutazione
deliberati dal Collegio dei Docenti ed illustrati nel Documento di valutazione di istituto, reperibile sul sito
istituzionale.
4.2. Attività progettuali realizzate inserite nel Pof e/o decise dal CdC
Classe Quinta
Conferenze con UNIMI e IFOM. Ready4Future: il genoma, l’editing gentico e l’analisi di Big
Data (27/09/2018).
Conferenze scientifiche in lingua inglese. Oscar Wilde (28/01/2019); Moonshot: la tecnologia
utilizzata dagli americani per l’allunaggio
(29/01/2019).
Progetto Lauree Scientifiche in Progetto in collaborazione con UNIMI dipartimento di
collaborazione con il dipartimento di chimica - “Le molecole chirali” (12 febbraio 2019).
chimica e biologia dell’ Università degli
Studi di Milano.
Progetto Educazione alla salute. Interventi informativi e formativi di volontariato associazioni
AVO e AVIS (30/01/2019).
Progetto “A scuola con il geologo”. Intervento con un geologo in data 7 novembre 2018.
Progetto Educazione stradale. Partecipazione a due interventi in data 10/12/2018 e
14/12/2018.
Progetto prevenzione bullismo - “Andiamo in Tre studenti hanno preso parte al progetto "Andiamo in rete",
rete”. sviluppatosi negli ultimi due anni scolastici - 2017/2018 e
2018/2019 - a cura del prof. Mangani e della prof.ssa Tarantino.
Il progetto prevede una serie di incontri nelle classi del biennio
inerenti ai temi del rispetto delle regole giuridiche, del bullismo
e cyberbullismo, dei procedimenti civili e penali che
coinvolgono i minori.
Accademia Viscontea - Sonata di Auschwitz Un incontro per non dimenticare la più grande tragedia del XX
Musica e politica dal Fascismo alla Shoah secolo attraverso l’insolito sguardo della musica. Esecuzioni
(1938-1945). Concerto multimediale. musicali, racconti, immagini e filmati riguardo inediti aspetti
della politica culturale delle dittature nazi-fasciste e degli orrori
dei campi di concentramento (23/01/2019)
Visita al Museo del Novento. Visita guidata alla collezione permanente del Museo
(17/04/2019)
Teatro F. Parenti - Il piacere dell’onestà - L. Spettacolo teatrale tratto dall’opera di L. Pirandello
Pirandello. (07/05/2019).
Inoltre, alcune studentesse e alcuni studenti hanno aderito a proposte di attività facoltative sia presenti nel
PTOF che indicate dal Consiglio di classe, in particolare:
• Sedici studenti e studentesse si sono recati in orario extra-scolastico alla mostra “Ma poi, che cos’è un nome?
Una mostra sul censimento degli ebrei a Milano nel 1938” al Palazzo della Triennale.
• Sedici studenti e studentesse si sono recati in orario extra-scolastico a visitare la collezione permanente della
Pinacoteca di Brera a Milano.
• Quattro studentesse hanno assistito alla presentazione dell’opera lirica “ La Cenerentola” di Gioacchino Rossini
in data 10 febbraio 2019.
Pagina 7 di 28• Nove studenti hanno partecipato in data 13 marzo 2019 alla conferenza “Al di sopra del DNA: ruolo
dell’epigenetica nella regolazione dell’espressione genica e nella nostra salute”.
4.3. Insegnamento di cittadinanza e costituzione
MATERIA CONTENUTI
Lingua e letteratura Partecipazione al progetto “La sonata di Auschwitz”.
italiana
Lingua e cultura Visione e commento del film “In the Name of the Father”. Il film è un lavoro
straniera: Inglese cinematografico prodotto nel Regno Unito nel 1993 per la regia di Jim Sheridan. La
pellicola racconta la storia vera del nord-irlandese Gerry Conlon, vissuto quindici
anni in carcere perché accusato ingiustamente di un’azione terroristica. La scelta
della visione di questo film nasce dall’esigenza di unire conoscenze di
problematiche politiche britanniche legate ai ‘Troubles’ con le tematiche affrontate
in Cittadinanza e Costituzione.
Storia Partecipazione ai progetti “Sulla mia pelle”, “Dead man walking - Contro la
tortura e la pena di morte”, “Cittadinanza e Costituzione”.
Tematiche legate al programma di Storia:
- Statuto Albertino e Costituzione repubblicana.
- Il discorso razzista.
- La nazione e i nazionalisti.
- Il concetto di totalitarismo.
- Istituzioni fasciste e costituzione repubblicana.
- Il gulag.
- L’Olocausto - Auschwitz. Il processo di Norimberga.
- Popoli e confini.
- Il confine orientale e le foibe.
Filosofia Partecipazione ai progetti “Sulla mia pelle”, “Dead man walking - Contro la
tortura e la pena di morte”.
Tematiche legate al programma di Filosofia:
- Il concetto di Stato in Hegel, nel Positivismo e in Marx.
- I diritti civili e i diritti sociali in Marx.
Matematica Partecipazione al progetto “Dead man walking - Contro la tortura e la pena di
morte”.
Scienze naturali Intervento “A scuola con il geologo”: intervento finalizzato alla diffusione della
cultura geologica dell’Italia, quale elemento necessario per la salvaguardia del
Territorio e dell’Ambiente.
Progetto Educazione alla salute e ambiente: la finalità è la promozione ad uno stile
di vita sano, al movimento ed al consumo sostenibile, contrastando patologie
prevalenti della società del benessere (sovrappeso, obesità, tumori, diabete e patologie
dell’apparato cardiocircolatorio). Attraverso il consumo sostenibile si vogliono
diffondere comportamenti virtuosi per la comunità e per l’ambiente in cui si vive. I
progetti “A scuola con il geologo” e “ Educazione ambientale” hanno inoltre lo
scopo di potenziare le competenze degli alunni in ambito della sostenibilità ambientale
e della conoscenza del territorio da un punto di vista geologico.
Partecipazione alla Conferenza“Ready4Future”: sono stati trattati argomenti
relativi all’editing genetico e alle sue possibili applicazioni nella medicina di
precisione e nella prevenzione delle malattie.
Visita alla mostra “Com’eri vestita”: attraverso questo percorso si vuole decostruire
alcuni stereotipi relativi alla violenza sessuale, primo tra tutti l’idea che
l’abbigliamento possa esserne la causa e che l’atteggiamento e il comportamento della
donna possano averla provocata.
Pagina 8 di 28Fisica Collaborazione al progetto “Educazione alla salute e ambiente”.
Informatica Partecipazione al progetto “Cittadinanza e Costituzione”.
Storia dell'arte Approfondimento della conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale: insegnare a ragionare, ad argomentare, a valutare le cose
(pensate), attraverso degli specifici dati conoscitivi (conoscenza). Tale percorso
consiste non solo nel trasmettere nozioni, ma anche nel coraggio di suscitare domande
sul senso delle cose.
Scienze motorie e Rispetto delle regole e fair play.
sportive
Religione cattolica Riflessione sulla dignità dell’uomo: il caso Cucchi.
Riflessione sulla libertà religiosa ed il ruolo della donna: Asia Bibi e la superdiversità
religiosa nelle grandi città.
Temi di bioetica: clonazione ed eutanasia.
Cattolici e politica: Giorgio La Pira.
L’uomo e la guerra.
PROGETTO PTOF/
BREVE DESCRIZIONE CONTENUTI/COMPETENZE
CdC
“Sulla mia pelle” Visione del film “Sulla mia Il progetto è finalizzato ad affrontare alcune tematiche
pelle ” ; d i b a t t i t o e giuridiche inerenti la situazione de facto della vicenda
riflessione sulle tematiche Cucchi, analizzando nello specifico:
affrontate attraverso una - la normativa costituzionale (art. 13 Cost.) e legislativa
serie di domande stimolo. riguardante l’intervento prima della polizia giudiziaria e
poi dell’autorità giudiziaria in merito alla restrizione
della libertà personale.
- l’adozione delle misure pre-cautelari e delle misure
cautelari.
La sonata di Auschwitz - Accademia Viscontea - Un incontro per non dimenticare la più grande tragedia
Musica e politica dal Concerto multimediale. del XX secolo attraverso l’insolito sguardo della musica.
Fascismo alla Shoah Esecuzioni musicali, racconti, immagini e filmati
(1938-1945) riguardo inediti aspetti della politica culturale delle
dittature nazi-fasciste e degli orrori dei campi di
concentramento.
Progetto “Cittadinanza e Il progetto si è sviluppato Il diritto e la norma giuridica.
Costituzione” nell’arco di quattro ore di 1. Definizione di diritto (oggettivo, soggettivo,
approfondimento svolte positivo, naturale) e differenza tra norme non
durante le ore di lezione in giuridiche e norme giuridiche (individuazione e
c ol l ab or a zi on e con i caratteristiche).
docenti Flora M. 2. Le fonti del diritto: Individuazione, classificazione
Bacchioni (Storia), e risoluzione dei conflitti tra norme giuridiche.
Cristina Calafiore 3. L'interpretazione delle norme giuridiche e la loro
(Informatica) e Antonio efficacia nello spazio e nel tempo.
Cristino (Religione). La Costituzione.
1. Origine e nascita della legge fondamentale dello
Stato.
2. Il ruolo dell'Assemblea costituente nel processo di
formazione di regole condivise.
3. Struttura, carat ter istiche e processo di
modificazione della Costituzione.
4. Fondamenti della Costituzione: i principi
fondamentali.
5. I diritti (individuali, collettivi, economici,
sociali) e i doveri dei cittadini: brevi cenni
schematici.
Pagina 9 di 28“Dead man walking - Visione del film “Dead Il progetto mira a stimolare la discussione in classe sul
Contro la tortura e la man walking”; dibattito e tema della pena di morte ed è finalizzato a permettere
pena di morte” riflessione sulle tematiche agli studenti di passare da un ragionamento
affrontate attraverso una esclusivamente “emozionale” ad uno più “razionale”
serie di domande stimolo. attraverso l’intermediazione della norma giuridica
nazionale (costituzionale e legislativa) e la disamina della
“ratio legis” di diversi istituti giuridici legati
direttamente o indirettamente alla pena di morte, quali il
gratuito patrocinio, la legittima difesa, il diritto di
difesa garantito in ogni stato e grado del giudizio, la
finalità rieducativa della pena.
Nello specifico il tema della pena di morte è stato
affrontato cercando altresì una relazione con il concetto
di “empatia” già affrontato nei progetti sul bullismo e
cyberbullismo.
4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Tutta la classe ha ampiamente svolto le 90 ore previste entro il quarto anno:
Anno scolastico Attività Caratteristiche dell’intervento progettuale
Classe TERZA Team Building Lezioni introduttive al Team Building; attività di team
as 2016-17 building gestita in collaborazione con socità esterna (Jungle
Raider Park); lezione di restituzione e certificazione delle
competenze (8 ore).
Sicurezza sul lavoro Corso di sicurezza sul lavoro gestito e certificato da una
società esterna (Randstad); Lavori di gruppo su casi pratici di
analisi delle condizioni di sicurezza e dei comportamenti
idonei sul luogo di lavoro (4 ore).
Orientamento Attività di orientamento in collaborazione con ente esterno
(AFOL SUD Milano); Stesura di vari tipi di curricola;
Gestione dati in lingua inglese (19 ore).
Diritto del Lavoro Lezioni introduttive al diritto del lavoro (Jobs Act); Attività di
gruppo di esame di casi pratici in materia del diritto del
lavoro; Interviste informative sui mutamenti introdotti dal
Jobs Act nel mercato del lavoro.
Progetto Laboratorio Radon Seminario (dott.ssa Groppi):
Radioattività ambientale (2 ore - 21/11/2016).
Progetto in collaborazione
con l'Istituto Nazionale di Seminario (prof.ssa Bazzocchi):
Fisica Nucleare di Milano e Tecniche e strumenti per la rivelazione del Radon (2 ore -
il Dipartimento di Fisica 28/11/2019).
dell'Università degli Studi di Lezioni multimediali ed esercitazioni in classe:
Milano, Piano Lauree Radioattività. Il “caso Radon” (4 ore - dicembre 2016/febbraio
Scientifiche 2017).
Lavori di gruppo
Approfondimento di alcuni temi inerenti la radioattività
ambientale.
Preparazione di poster in lingua inglese (3 ore curricolari;
lavoro domestico - Marzo/aprile 2017).
Discussione
Presentazione dei lavori di gruppo (3 ore - Maggio 2017).
Pagina 10 di 28Stage estivo Attività individuali di tirocinio o stage presso aziende o enti
esterni (40 ore).
Classe QUARTA P r o g e t t o E d u c a z i o n e Svolto durante l’anno scolastico 2017/18. Gli studenti hanno
as 2017-18 ambientale presentato, dopo un intervento informativo e formativo tenuto
dal professor ingegnere P. Casellato, attraverso strumenti
multimediali, possibili soluzioni aderenti a diverse
problematiche ambientali del suolo, dell’acqua e dell’aria.
Progetto ENI - Enrico Mattei Realizzazione di un cortometraggio multimediale (durata min.
e i suoi valori: un ritratto 1) sulla figura ed i valori pregnanti Enrico Mattei (60 ore).
interattivo
Progetto Olimpia@School Il progetto volto ad avvicinare al mondo dello sport gli
adolescenti delle scuole milanesi, non solo con un approccio
tecnico ma anche educativo, con una visione orientata al
mondo del lavoro e a quanto accade intorno ad una società
sportiva (35 ore).
Intercultura Partecipazione ad attività formative introduttive e specifiche al
progetto; partecipazione ad attività di accoglienza di studenti
di studenti provenienti e di ritorno da Paesi comunitari ed
extracomunitari (10).
Attività di Laboratorio
Predisposizione della campagna di misura.
Posizionamento dei rivelatori a tracce (CR39) in un
appartamento di San Giuliano Milanese, MI (1 ora -
27/09/2019).
Attività di potenziamento
Progetto Laboratorio Radon Partecipazione alla Manifestazione “Meet me Tonight –
Faccia a faccia con la ricerca”, presso il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia di Milano, per presentare al
pubblico quanto svolto nell’ambito del Progetto (4 ore - solo
un gruppo di studenti - 29/09/2017).
Attività di Laboratorio
Trattamento chimico dei CR39 (2 ore - 17/04/2018).
Progetto “Andiamo in rete” Progetto sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo (solo
3 alunni - 15 ore).
Classe QUINTA Progetto “A scuola con il Progetto di ASL / 7 ore
as 2018-19 geologo” Intervento con il geologo in data 7 novembre 2018.
Progetto Lauree Scientifiche UNIMI dipartimento di chimica: “Le molecole chirali “
- In collaborazione con il incontro svolto in data 12 febbraio 2019.
dipartimento di chimica e
biologia dell’ Università
degli Studi di Milano
Intercultura Partecipazione ad attività formative relative al progetto (2
ore).
Progetto Laboratorio Radon Attività di potenziamento
Partecipazione alla “RadioLab Summer School”, presso il
Rifugio Zamboni, Macugnaga, VB, per presentare quanto
svolto nell’ambito del Progetto e svolgere attività di
approfondimento in tema di radioattività ambientale (solo 2
studentesse - 48 ore - 9-14/09/2018).
Pagina 11 di 284.5. CLIL
Dal momento che il Consiglio di Classe della VB LSA non ha un professore certificato Clil, per effettuare l’unità
didattica secondo i criteri della materia CLIL si è pensato di compensare con la partecipazione ad una conferenza in
inglese dal titolo Moonshot: la tecnologia utilizzata dagli americani per l’allunaggio. A tale scopo è stata
organizzata una mattinata nella quale a fare lezione è stato un esperto madrelingua, Joseph Quinn. Tale lezione
riguardava la tecnologia impiegata dalla NASA per compiere l’allunaggio, nel contesto storico della competizione
tra Unione Sovietica e USA per la conquista dei cieli e la Guerra Fredda.
La classe, grazie alla collaborazione tra docenti titolari e potenziatori, ha svolto l’unità di apprendimento nel
secondo quadrimestre.
DNL LINGUA STRANIERA DOCENTE
INFORMATICA INGLESE Joseph Quinn/Silvia F. Puliti
4.6. Indicazioni per il colloquio fornite agli alunni:
Il DM 18/1/2019 al COMMA 1 recita: “Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve
relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento; oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze
specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta
di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.”
Agli studenti sono quindi state fornite le seguenti indicazioni, sulla base del fatto che il presente documento
contiene tutte le attività svolte nel triennio:
• è possibile scegliere quale attività trattare, anche una sola (quella più importante o che ha colpito
maggiormente il candidato);
• è possibile parlare di un’esperienza in azienda o di un progetto svolto a scuola;
• il tempo previsto per l’esposizione è di dieci minuti.
Pagina 12 di 285. Note metodologiche e contenuti delle singole discipline
Le attività, gli obiettivi, i tipi di verifica e tempi, sono stati quelli fissati dalla programmazione di materia
consultabile nel sito istituzionale.
Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti, anche se, naturalmente, non per ogni alunno con uguale grado di
sicurezza ed approfondimento.
Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Flora M. Bacchioni
Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della Letteratura, vol. 3 Unico, Paravia -
Pearson.
IL ROMANTICISMO
Giacomo Leopardi
- Cenni biografici. L’evoluzione ideologica e letteraria.
• Dall’Epistolario: Lettera a Giordani;
• dallo Zibaldone: La teoria del piacere;
• dai Canti: L’Infinito, Alla luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso,
La ginestra (lettura in parafrasi di tutta l’opera, analisi e commento solo di alcuni versi);
• dalle Operette morali:Il dialogo della natura e di un Islandese.
L’ETÀ POSTUNITARIA
Quadro storico e temi di riferimento.
La Scapigliatura.
- Camillo Boito.
• Dal Libro dei versi: Dualismo.
Giosuè Carducci.
- Profilo biografico.
- L’evoluzione ideologica e letteraria.
• Dalle Rime nuove: Pianto antico;
• da Odi barbare: Alla stazione un mattino d’autunno.
Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia.
Il romanzo russo - Fedor Dostoevskij - Da Delitto e castigo: La confessione di Raskolnikov.
Il Naturalismo francese - Emile Zola - Da L’assomoir: L’alcool inonda Parigi.
Il verismo italiano
Giovanni Verga.
- Profilo biografico e letterario.
- Tecniche narrative e ideologia verghiana.
• da Vita dei campi: Rosso Malpelo;
• da I Malavoglia: Prefazione (I “vinti” e la “fiumana del progresso”); Il mondo arcaico e l'irruzione
della storia (cap. I); La conclusione del romanzo (cap. XV);
• da Novelle rusticane: La roba;
• da Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo.
Il decadentismo
Quadro storico, temi e poetica di riferimento.
Charles Baudelaire.
• da I fiori del male: L’albatro; Spleen
Paul Verlaine.
• Languore.
Quadro generale del romanzo europeo - Il romanzo decadente europeo.
Gabriele D’Annunzio.
- Profilo biografico e letterario.
- Estetismo e panismo; il superuomo.
• da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (III, cap.II);
• da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.
Giovanni Pascoli
- Profilo biografico e letterario.
- La visione del mondo e la poetica.
Pagina 13 di 28• da Il fanciullino: Una poetica decadente;
• da Myricae: Arano, Lavandare, Novembre, L’assiuolo, Temporale, Il tuono (Allegato 3.1.) e Il lampo;
• da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
IL PRIMO NOVECENTO
Quadro storico, temi e poetica di riferimento.
Il Futurismo.
Filippo Tommaso Marinetti.
• Brevi cenni biografici.
• Manifesto del Futurismo.
I Crepuscolari
Guido Gozzano - dai Colloqui: La Signorina Felicita ovvero la felicità, analisi dei vv. 73-120.
Luigi Pirandello
Profilo biografico e letterario.
Visione del mondo: la crisi dell’io, la trappola e la maschera; l’umorismo.
I romanzi: tecniche narrative e temi principali.
Il teatro e la trilogia metateatrale.
Partecipazione alla rappresentazione teatrale del testo “Il piacere dell’onestà”.
• da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;
• Il fu Mattia Pascal (lettura integrale dell’opera);
• da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome;
• da i Sei personaggi in cerca di autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio.
Italo Svevo
• Profilo biografico e letterario.
• Tecniche narrative e tematiche: l’inetto e la malattia.
• da Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap. I);
• da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III); La morte del padre (cap. IV); La profezia di
un’apocalisse cosmica (VIII).
TRA LE DUE GUERRE
Quadro storico e culturale di riferimento.
La lirica del Novecento e l’Ermetismo.
Giuseppe Ungaretti.
- Profilo biografico e letterario.
- Visione del mondo e poetica: l’analogia.
• da L’allegria: In memoria; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Soldati;
Mattina;
• da Il dolore: Non gridate più.
Salvatore Quasimodo.
- Profilo biografico e letterario.
• da Acque e terre: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici.
Eugenio Montale.
- Profilo biografico e letterario.
- Visione del mondo e poetica: il male di vivere, il correlativo oggettivo, il “varco”; le critiche al mondo
contemporaneo.
• da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho
incontrato; Forse un mattino andando in un’aria di vetro;
• Da da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto.
• Da da La bufera ed altro: Piccolo testamento.
• Da Satura, La storia.
DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI
Quadro storico e culturale di riferimento dal 1946 al 1960.
I movimenti letterari e i generi di maggior diffusione - Il neorealismo.
Beppe Fenoglio.
• da Il partigiano Johnny: Il settore sbagliato della parte giusta.
• Una questione privata - lettura integrale dell’opera.
Primo Levi.
• Se questo è un uomo - lettura integrale dell’opera.
Mario Rigoni Stern.
Pagina 14 di 28• Il sergente nella neve - lettura integrale dell’opera.
Cesare Pavese.
• da La luna e i falò: lettura integrale dell’opera.
Dante Alighieri, Divina commedia.
Lettura integrale, analisi e commento dei canti I, III, XXXIII del Paradiso.
Scrittura - Testi esemplificativi della tipologie A, B e C; caratteristiche del testo: funzione, organizzazione,
connettivi, lessico. Analisi di testi di vario tipo.
Programma svolto di LINGUA E CULTURA INGLESE
Docente: Silvia F. Puliti
Libro di testo: R. Norris, H. Thomson, READY FOR FIRST - ITALY PACK, MACMILLAN.
SPECIFICATION 5
A Two-Faced Reality
- The first half of Queen Victoria’s reign.
- Life in the Victorian town.
- The Victorian compromise.
- The Victorian novel.
Charles Dickens and children
- Oliver Twist.
• Oliver wants some more.
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature
- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde.
• The story of the door.
Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete
- The Picture of Dorian Gray.
• Dorian’s death.
SPECIFICATION 7
The Great Watershed
The Edwardian age.
History World War I.
The War Poets.
- The Soldier by R. Brooke.
- Dulce et Decorum Est by W. Owen (just the final strophe).
The Easter Rising and the Irish War of Independence.
The Irish Question.
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man
- The Waste Land -The Burial of the Dead.
• The Fire Sermon.
- An excerpt from The Love Song of J. Alfred Prufrock (Allegato 3.2.B).
- Edward Morgan Forster and the contact between different cultures -
A Passage to India.
• The Barabar Caves Aziz and Mrs Moore.
- A Passage to India.
James Joyce and Dublin
- Dubliners.
• From 'The Dead’, 'She Was Fast Asleep’ (material given by the teacher - Allegato 3.2.A.).
SPECIFICATION 8
A New World Order: The Culture of Wealth and Materialism
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age
- The Great Gatsby.
• Nick meets Gatsby.
Pagina 15 di 28Programma svolto di STORIA
Docente: Flora M. Bacchioni
Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanetti, L’esperienza della Storia, vol 3, Bruno Mondadori.
L’ITALIA UNITA
- L’età della Destra storica. 1861-1876.
- L’età della Sinistra storica. 1876-1896.
INDUSTRIA, MASSE, IMPERI
- La seconda rivoluzione industriale.
- L’età delle masse.
- L’imperialismo.
VERSO IL NOVECENTO
- Conflitti e consenso. La vita politica in Europa e Negli Stati Uniti.
- Il caso italiano. Decollo industriale e crisi di fine secolo.
L’EUROPA DELLA BELLA ÉPOQUE
- Inizio secolo. Le inquietudini della modernità.
- Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto.
GUERRA E RIVOLUZIONE
- Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano.
- Il conflitto e la vittoria dell’Intesa.
- La Russia: rivoluzioni e guerra civile.
LE EREDITÀ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI
- Il quadro politico del dopoguerra.
Pagina 16 di 28- Le radici del problema mediorientale.
- Il quadro economico del dopoguerra.
L’ETÀ DEI TOTALITARSMI
- Il fascismo
• Le tensioni del dopoguerra italiano.
• Il crollo dello Stato liberale.
• Il regime fascista.
- Il nazismo.
• La repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler.
• Il regime nazista.
- Lo stalinismo.
• Dopo la Rivoluzione. L’URSS degli anni Venti e l’ascesa di Stalin.
• Il regime staliniano.
GUERRA, SHOA, RESISTENZA.
- La II guerra mondiale.
- L’Europa nazista e la shoà.
- La resistenza in Europa e in Italia.
IL LUNGO DOPOGUERRA E LA GLOBALIZZAZIONE
- Pace impossibile, guerra improbabile. La guerra fredda.
L’ITALIA REPUBBLICANA
- La ricostruzione. Dalla liberazione all’età del centrismo.
Programma svolto di FILOSOFIA
Docente: Sergio A. Dagradi
Libro di testo: F. Bertini, Io penso, vol. 3, Da Schopenhauer ad oggi, Zanichelli.
IDEALISMO TEDESCO: IL PENSIERO DI GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
Il pensiero di Hegel nelle sue linee fondamentali:
- Il metodo dialettico triadico di Hegel (tesi – antitesi – sintesi) e il concetto di Aufheben.
- Idea in Sé, Idea per Sé e Idea in Sé e per Sé: Logica, Natura, Spirito.
- Significato e scopi della Fenomenologia dello Spirito.
- Le figura più rilevanti della riflessione hegeliana:
• La realtà come Spirito Assoluto.
• La figura servo-signore.
• La filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (cenni).
• L’eticità: famiglia, società civile (sistema dei bisogni – amministrazione della giustizia – polizia e
corporazioni) e Stato (cenni).
• La Storia e l’Astuzia della Ragione.
- La filosofia dello Spirito Assoluto: Arte, Religione e Filosofia (cenni).
IL DIBATTITO POST-HEGELIANO: SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD E IL POSITIVISMO
- Il pensiero di Schopenhauer: La ripresa del pensiero kantiano: fenomeno e noumeno. – Il mondo come
volontà e come rappresentazione. – La noia e il dolore. – La liberazione attraverso l’arte e la redenzione
morale. – Il rifiuto del suicidio.
- Il pensiero di Kierkegaard: Caratteri personali dell’esistenzialismo di Kierkegaard. – L’opposizione ad
Hegel e la vita come scelta. – L’aut-aut e i tre stadi sul cammino della vita. – Il Don Giovanni e la scelta di
vita estetica. – Il marito e la scelta di vita etica. – Scelta e angoscia. Abramo e la scelta di vita religiosa:
caratteri della fede per Kierkegaard.
- Caratteri generali del Positivismo: Il contesto storico, economico e socio-politico; l’origine del termine
positivismo; il metodo scientifico come modello di ogni conoscenza; descrizione e previsione del reale;
Positivismo sociale e Positivismo evoluzionistico (cenni).
Pagina 17 di 28IL PENSIERO DI KARL MARX
Il pensiero di Karl Marx nel suo sviluppo storico:
- Destra e sinistra hegeliana;
- La critica di Feuerbach alla religione;
- Il pensiero di Karl Marx:
• la critica alla filosofia hegeliana del diritto;
• dal politico al sociale: la Questione ebraica;
• la scoperta dell’economico ed i Manoscritti economico-filosofici: la critica dell’economia politica; il lavoro
alienato e la proprietà privata; il comunismo come emancipazione umana: falso comunismo e vero
comunismo;
• la collaborazione con Engels e l’elaborazione della concezione materialistica della storia; il materialismo
storico e la critica all’ideologia; forze produttive e rapporti di produzione; struttura e sovrastruttura; la lotta
di classe e il programma comunista;
• Il Manifesto del Partito Comunista;
• Il Capitale; il capitalismo e le merci; valore d’uso e valor di scambio; produzione e valorizzazione; il
processo di valorizzazione del capitale; il plusvalore come pluslavoro; plusvalore relativo ed assoluto; la
caduta tendenziale del saggio di profitto e la fine del capitalismo.
NIETZSCHE E IL NICHILISMO
Il pensiero di Friedrich Nietzsche:
- Il problema Nietzsche: denazificazione e interpretazione della follia;
- la periodizzazione della riflessione di Nietzsche;
- la fase giovanile: l’analisi della tragedia greca; i concetti di apollineo e dionisiaco;
- la critica della decadenza della cultura occidentale e la malattia storica nella seconda Considerazione
inattuale;
- la fase illuministica: lo spirito libero come spirito non fanatico; scienza e arte; la critica alla morale, alla
verità e alla metafisica; il superamento del soggettivismo;
- la filosofia del meriggio: meriggio e ombra; l’annuncio della morte di dio; il peso più grande;
- la fase dello Zarathustra: l’Oltreuomo, la trasvalutazione dei valori e l’eterno ritorno dell’uguale;
- l’ultima fase della riflessione di Nietzsche: la volontà di potenza.
FREUD E LA PSICOLOGIA DEL PROFONDO
Il pensiero di Sigmund Freud:
- Gli studi con Jean-Martin Charcot sull’ipnosi e gli studi con J. Breuer sull’isteria; il metodo catartico;
- il concetto di psicoanalisi;
- il metodo della psicoanalisi; il concetto di inconscio e la prima topica;
- L’interpretazione dei sogni, il lavoro onirico e la sua interpretazione;
- Psicopatologia della vita quotidiana (lapsus, atti mancanti e libere associazioni);
- i Tre saggi sulla teoria sessuale (il concetto di libido, la teoria della sessualità infantile, il complesso di
Edipo);
- le tre istanze della psiche (Es, Io e Super io) e la seconda topica;
- i meccanismi della rimozione e della sublimazione;
- il Disagio della civiltà (Eros e Thanatos)
Testo
Sigmund Freud, voce «Psicoanalisi» da Due voci di Enciclopedia (1922).
Programma svolto di MATEMATICA
Docente: Paola Marcati
Libro di testo: L. Sasso, MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE BLU per il quinto anno, Volume 5 + Ebook,
Editrice PETRINI.
TEMA M LIMITI E CONTINUITÀ
Unità 1 INTRODUZIONE ALL’ANALISI
- Che cos’è l’analisi?, L’insieme R, Funzioni a variabile reale: dominio, segno e proprietà.
Pagina 18 di 28Unità 2 LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
- Introduzione al concetto di limite. Definizioni dei vari limiti.
- Teorema di esistenza e unicità sui limiti, le funzioni continue e l’algebra dei limiti.
- Forme di indecisione e limiti notevoli.
Unità 4 CONTINUITÀ
- Funzioni continue, punti di di discontiuità e loro classificazioni, proprietà delle funzioni continue e metodo
di bisezione. Asintoti e grafico probabile di una funzione.
TEMA M CALCOLO DIFFERENZIALE
Unità 5 LA DERIVATA
- Il concetto di derivata, le derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, derivata delle funzioni
composte della funzione inversa. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni del
concetto di derivata.
Unità 6 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
- Il teorema di Fermat, di Rolle e di Lagrange. Funzioni crescenti e decrescenti, criteri per l’analisi dei punti
stazionari. Problemi di massimo e minimo. Funzioni concave e convesse, punti di flesso. I teoremi di
Cauchy e de L’Hôpital.
Unità 7 LO STUDIO DI FUNZIONE
- Studio di funzione e realizzazione del grafico di funzioni algebriche, trascendenti e con valori assoluti.
Grafico deducibile. Applicazione dello studio di funzioni per la soluzione di equazioni.
TEMA O CALCOLO INTEGRALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Unità 8 L’INTEGRALE INDEFINITO
- Primitive e integrale indefinito: integrali immediati, integrali per scomposizione, di funzioni composte e
per sostituzione. Integrazione per parti e di funzioni razionali frazionarie.
Unità 9 L’INTEGRALE DEFINITO
- Dall’area al concetto di integrale definito, Primo teorema fondamentale del calcolo Integrale. Calcolo di un
integrale definito e delle aree. Applicazioni geometriche del concetto di integrale definito. Valor medio di
una funzione. Integrali impropri e funzioni integrabili. La funzione integrale, Secondo teorema
fondamentale del calcolo integrale.
Unità 10 LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI
- Introduzione alle equazioni differenziali. Equazioni differenziali del primo ordine.
- Soluzione di equazioni differenziali lineari ed a variabili separabili. Problemi che hanno come modello le
equazioni elementari. Definizione di soluzione di equazione differenziale di ordine n. Problemi che hanno
come modello equazioni differenziali.
TEMA P DATI E PREVISIONI
Unità 11 DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ
- Variabili aleatorie e distribuzioni discrete. Giochi equi. Distribuzione di Poisson.
- Distribuzione binomiale.
Programma svolto di FISICA
Docente: Anna Bazzocchi
Libro di testo: U.Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.Blu”, vol.3, Zanichelli.
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
- Il flusso del campo magnetico e la legge di Faraday-Neumann-Lenz.
- Autoinduzione e induttanza.
- Energia immagazzinata in un campo magnetico.
- Analisi di circuiti RL.
Pagina 19 di 28LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
- Corrente di spostamento e corrente di conduzione.
- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.
- Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce.
- Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche.
- Lo spettro elettromagnetico.
INTRODUZIONE ALLA TEORIA DELLA RELATIVITÀ
- I postulati di Einstein.
- Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
- Le trasformazioni di Lorentz e l’intervallo invariante.
- Legge relativistica di composizione delle velocità.
- Equivalenza tra massa ed energia.
- Quantità di moto ed energia cinetica relativistiche.
INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA
- Radiazione di corpo nero e ipotesi di Planck.
- Fotoni ed effetto fotoelettrico.
- Quantità di moto del fotone.
- Diffusione dei fotoni ed effetto Compton.
LA STRUTTURA DELL’ATOMO
- Gli spettri a righe.
- I raggi X.
- L’esperimento di Thomson e la scoperta dell’elettrone.
- L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica.
- L’esperimento di Rutherford e la scoperta del nucleo.
- I primi modelli dell’atomo.
- Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno.
- Ipotesi di de Broglie e dualismo onda-particella.
IL NUCLEO E LA RADIAZIONE NUCLEARE
- I costituenti e la natura del nucleo.
- L’energia di legame e le reazioni nucleari.
- I decadimenti radioattivi.
- Radioattività ambientale.
- Il problema del Radon e la normativa vigente.
Programma svolto di SCIENZE NATURALI
Docente: Mariella Cappella
SCIENZE DELLA TERRA
Libro di testo: E. L. Palmieri e M. Parotto, Il GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE, Edizioni Zanichelli.
La storia della Terra:
- Geocronologia e geocronometria. I fossili e il processo di fossilizzazione. La storia della Terra in eòni, ère,
periodi. Da una nube di polvere nasce il Sistema solare. Eone Adeano e la roccia più antica, eone archeano
e le stromatoliti, Eone proterozoico e i giacimenti di ferro a bande. Il Paleozoico inferiore e superiore.Il
supercontinente Pangea. Il Mesozoico e il dominio dei rettili. Era cenozoica e la formazione delle grandi
catene montuose. I periodi glaciali e interglaciali del Quaternario e le anomalie magnetiche associate.
Elementi di stratigrafia:
- I principi della stratigrafia. Le trasgressioni e le regressioni marine. Le lacune di sedimentazione.la
deformazione delle rocce: pieghe e faglie.
Pagina 20 di 28La tettonica delle placche:
- La struttura interna della Terra e le superfici di discontinuità. La crosta, il mantello e il nucleo– il calore
interno della Terra: la geoterma. Il magnetismo terrestre e il paleomagnetismo. La crosta oceanica e
continentale a confronto: differenze di spessore, età e composizione rocciosa. L’Isostasia. – La deriva dei
continenti di Wegener e le prove a suo favore - Le dorsali oceaniche: struttura, faglie e vulcanismo presente
–le fosse abissali: struttura di un arco magmatico. Espansione e subduzione. Le anomalie magnetiche sui
fondali oceanici. Le placche litosferiche e i loro margini. L’orogenesi: collisione tra margine continentale e
crosta oceanica ( piano di Benioff) - collisione continentale (le “ofioliti”) - accrescimento crostale – crosta
oceanica sotto crosta oceanica. Il ciclo di Wilson. I moti convettivi del mantello e i punti caldi ( Hawaii).
BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE
Libro di testo: G. Valitutti, N. Taddei e altri, Dal carbonio agli OGM plus, Biochimica e biotecnologie, SCIENZE
ZANICHELLI.
Introduzione alle Biotech
- Importanza e ruolo delle biotecnologie. - Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.
- Tecnologie delle colture cellulari vegetali e animali.
- Le cellule staminali: caratteristiche e diverse tipologie.
Tecnologia del DNA ricombinante
- Enzimi e frammenti di restrizione -L’elettroforesi su agarosio e su gel di poliacrilammide. Lettura dei
frammenti di DNA - Ruolo della DNA ligasi- individuazione di sequenze specifiche di basi: ibridazione
del DNA e tecnica Southern Blotting. - amplificazione del DNA con la DNA polimerasi (PCR) -
sequenziamento del DNA (metodo Sanger).
Il clonaggio e la clonazione
- Clonaggio del DNA - vettori di clonaggio. - biblioteche di DNA - clonare organismi complessi.
Analisi del DNA e delle proteine
- La tecnologia microarray ndi DNA - Western blotting.
Ingegneria genetica e OGM
- Cosa sono gli OGM - ingegneria genetica applicata agli animali: Microiniezione di uova fecondate,
Sostituzione di geni nelle cellule staminali embrionali e topi Knockout.
Ruolo dell’RNA
- Tecnologia antisenso per silenziare un gene – RNAinterfering.
Applicazioni delle biotecnologie
- Le biotecnologie mediche , la diagnostica e i trattamenti terapeutici – utilizzo di anticorpi monoclonali
MAb per diagnostica e terapia.
Biomolecole
- Carboidrati: mono/di/polisaccaridi – Condensazione aldolica di due molecole di gliceraldeide con
formazione del glucosio- Dalla forma aperta del glucosio alla forma chiusa attraverso reazione emiacetalica
tra gruppo aldeidicodel carbonio 1 e gruppo ossidrilico del carbonio 5 : anomero dell’alfa e del beta
glucosio. Strutture di Fischer e di Haworth. Le quattro proprietà degli zuccheri. I legami alfa 1,4 e beta 1,4
glicosidici e i polimeri dell’amido e della cellulosa.
- La fermentazione degli zuccheri e la produzione di etanolo e/o acido lattico.
- Lipidi: Reazione di esterificazione tra tre molecole di acido grasso e il glicerolo e formazione di una
molecola di triacilglicerolo o grasso. Struttura e caratteristiche chimiche e fisiche degli grassi saturi e
insaturi– I fofolipidi: struttura e ruolo – I Lipidi saponificabili e non.
- Proteine: Struttura di un aminoacido, i legami peptidici formano le proteine, i livelli strutturali delle
proteine - la funzione delle proteine, Enzimi: struttura e funzione classificazione–capacità catalitica –
complesso enzima/substrato – inibitori competitivi e non.
- Acidi nucleici: richiami sulla struttura del DNA ed RNA, duplicazione del DNA e sintesi proteica( parte
svolta durante il terzo anno).
Pagina 21 di 28Metabolismo ed energia
- Definizione di metabolismo – anabolismo e catabolismo – le vie metaboliche convergenti, divergenti e
cicliche - ATP e coenzimi CoA, NADH e FADH– i mitocondri: struttura e funzione – importanza della
rigenerazione del NAD e del FAD.
Metabolismo dei carboidrati
- Glicolisi: l’ossidazione del glucosio: introduzione, la glicolisi, la via anaerobica: fermentazione lattica e
alcolica, la via aerobica: la respirazione cellulare e l’ossidazione dell’acido piruvico in acetil CoA, Il ciclo
di Krebs, il trasporto finale di elettroni, meccanismo di fosforilazione ossidativa : accoppiamento
chemiosmotico, il bilancio energetico totale.
CHIMICA ORGANICA
Libro di testo: F. Ranaldi, Chimica organica, SCIENZE ZANICHELLI.
Chimica del Carbonio
- L’atomo di carbonio–Ibridazione sp3, sp2, sp – modalità di rottura del legame covalente: scissione
omolitica ed eterolitica.
Idrocarburi alifatici
- Classificazione – Alcani: nomenclatura IUPAC – proprietà fisiche – Isomeria degli alcani: di struttura e
conformazionale ( conformazione eclissata e sfalsata) - reazioni di combustione e di sostituzione radicalica-
meccanismo radicalico dell'alogenazione – Cicloalcani: struttura e reattività – Alcheni: nomenclatura
IUPAC - isomeria strutturale e isomeria geometrica cis e trans – addizione elettrofila e formazione di un
carbocatione – Addizione con acidi alogenidrici , con acqua, con cloro, con idrogeno, meccanismo
dell'addizione elettrofila – regola di Markovnikov – Alchini e la loro debole acidità –reazione di addizione
elettrofila co acqua e formazione di enoli e tautomeria cheto – enolica.- I dieni: coniugati e cumulati. I dieni
cumulati e l’addizione elettrofila 1,2 e 1,4.
Idrocarburi aromatici
- Caratteristiche del benzene – struttura del benzene –nomenclatura degli idrocarburi aromatici principali e
con due gruppi sostituenti – sostituzione elettrofila ed effetto dei gruppi sostituenti sull'anello benzenico
( Attivanti orto para orientanti e disattivanti meta orientanti)– fenolo: caratteristiche fisiche e chimiche.
Stereoisomeria ottica
- Chiralità – elementi di simmetria – centri stereogenici – attività ottica – convenzione relativa D,L
convenzione Fischer – Rosanoff – convenzione assoluta R,S – convenzione D,L in amminoacidi e
monosaccaridi – enantiomeri, diastereoisomeri, forma meso.
Alogeno derivati (alogenuri alchilici)
- Caratteristiche generali – nomenclatura – preparazione degli alogenuri alchilici: addizione degli alcheni con
acido alogenidrico o con alogeno– sostituzione nucleofila – SN1 – SN2 esempio di SN1 e SN2 tra
alogenuro primario, secondario, terziario con ione OH-.
Alcoli
- Struttura e classificazione degli alcoli( nullario, primario, secondario, terziario)– nomenclatura IUPAC –
proprietà fisiche – acidità e basicità – reazioni di sintesi degli alcoli a partire da alogenuro alchilico o da
alchene - reazioni: salificazione - ossidazione – eliminazione di acqua – reazioni con HCl o saggio di
Lucas- esterificazione e produzione di trigliceridi o lipidi. La fermentazione dell’acido piruvico e la
produzione di etanolo e/o acido lattico.
Aldeidi e chetoni
- Struttura del carbonile e polarità: comportamento simile agli alcheni– nomenclatura IUPAC degli aldeidi e
chetoni – proprietà fisiche e comportamento acido del carbonio alfa dell’aldeide acetica – reattività del
gruppo carbonilico: ossidazione e riduzione – reazioni di addizione nucleofila con OH- e formazione di
emiacetale ( struttura chiusa del glucosio alfa ) e acetale - condensazione aldolica di due molecole di
gliceraldeide e formazione del glucosio.
Acidi carbossilici
- Struttura del carbossile – nomenclatura – proprietà fisiche – acidità – gli acidi grassi – reazioni: formazione
di sali- esterificazione e saponificazione degli esteri – saponi e detergenti. Sostituzione nucleofila:
Pagina 22 di 28formazione di ammidi (il legame ammidico degli aminoacidi). Cenni sugli acidi bicarbossilici, gli
idrossiacidi (acido lattico) e i chetoacidi (acido piruvico).
Ammine
- Struttura di una ammina , le ammine primerie, secondarie e terziarie, le proprietà chimico fisiche delle
ammine– proprietà chimico- fisiche, Il pirrolo e la struttura porfirica del gruppo eme dell’emoglobina.
PROGRAMMA DI LABORATORIO
BIOTECNOLOGIE
Lettura e interpretazione dei frammenti di DNA in un gel di agarosio.
Risorse Multimediali Zanichelli:
- Trasformazione batterica con il gene dell’insulina.
- Analisi genetica per l’anemia falciforme.
- Identificare proteine con il Western Blotting.
- Coltura batterica su piastra Petri.
- Come si fa il DNA fingerprinting.
- Le cellule staminali.
Attraverso i video si sono analizzate le tecniche: PCR, elettroforesi, estrazione di DNA, semina batterica su piastra
Petri, Creazione di un plasmide ricombinante e trasformazione batterica.
SCIENZE DELLA TERRA
- Produzione individuale di un PPT sulla storia della Terra.
- Conferenza sulla storia geologica dell’Italia da parte del geologo esperto: professor Gelati.
CHIMICA ORGANICA
- La saponificazione: produzione del sapone con olio di oliva.
- Il saggio di Lucas : riconoscimento degli alcoli primari, secondari e terziari.
- Individuazione di composti e molecole chirali e studio della specularità di oggetti comuni presenti nel
quotidiano.
Programma svolto di INFORMATICA
Docente: Cristina Calafiore
Libro di testo: A. Lorenzi, M. Govoni, Informatica Applicazioni Scientifiche, Atlas.
Reti di computer:
- Definizione di Reti di computer.
- Classificazione in funzione estensione.
- Classificazione in funzione topologia.
- Classificazione in funzione architettura.
- Definizione di servizio e tipologie di erogazione.
- Collegamento Point to Point, Multipoint, Broadcast.
- Linea Simplex, Half-duplex, Full-duplex.
- Tecniche di commutazione.
- Concetto di affidabilità, latenza.
Modelli standard di riferimento per le reti:
- Definizione di protocollo.
- Struttura a livelli.
- Definizione di Architettura di rete: livelli + protocolli.
- Il modello ISO/OSI.
- Livello Physical.
- Livello Data Link.
- Livello Network.
- Livello Transport.
Pagina 23 di 28- Livello Session.
- Livello Presentation.
- Livello Application.
- Il modello TCP/IP.
- I mezzi trasmessivi.
- Codifica dei dati.
- Apparati di rete.
- Metodi di accesso al canale condiviso.
- Indirizzi IP.
Programma svolto di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente: Andrea Visco
Libro di testo: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Cricco Di Teodoro - Itinerario nell’arte. Dall’Art Noveau ai giorni
nostri, Zanichelli.
L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA E LE SISTEMAZIONI URBANISTICHE
- Caratteri generali, nuovi materiali, la scienza delle costruzioni.
- I cantieri per le Esposizioni Universali: Londra 1851 e il Crystal Palace di Paxton, Parigi 1889 con la
Galleria delle Macchine e la Tour Eiffel.
- L’architettura del ferro in Italia: le coperture delle gallerie urbane, Galleria Vittorio Emanuele II di Milano,
Galleria Umberto I di Napoli.
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO
- Caratteri generali, la fotografia.
- E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.
- C. Monet: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, lo stagno delle ninfee; P. A. Renoir: Moulin
de la Galette. Colazione dei canottieri, le bagnanti.
- Opere a confronto: La Grenouillère di Monet e di Renoir.
- A. Degas: Lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in blu.
- Altri impressionisti: C. Pissarro con Tetti rossi, A.Sisley con Neve a Louveciennes, J.F. Bazille con
Riunione di famiglia, G. Caillebotte con I rasieratori di parquet.
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE
- Caratteri generali.
- P. Cézanne: La casa dell'impiccato, la geometria, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-
Victoire vista dai Lauves.
- G. Seurat: Divisionismo, Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi, il circo; P. Gauguin: L'onda,
il cloisonnisme, Il Cristo giallo, Aha oe feii?Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
- V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo
di corvi.
ART NOUVEAU ED ESPRESSIONISMO
- Caratteri generali, Arts and Crafts, W. Morris ed i presupposti dell’Art Nouveau.
- Art Nouveau: caratteri generali, i diversi nomi, arti applicate.
- I Fauves: caratteri generali.
- Henri Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa; L’Espressionismo: caratteri generali.
- E. Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà, Modella con sedia di vimini.
IL CUBISMO
- Caratteri generali, cubismo analitico e sintetico, papiers collès e collages.
- P. Picasso: dal periodo blu al cubismo, Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di
saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, natura morta con sedia impagliata,
I tre musici, Guernica.
- G. Braque: Case all'Estaque, Violino e brocca, le Quotidien violino e pipa, Natura morta con uva e
clarinetto.
Pagina 24 di 28Puoi anche leggere