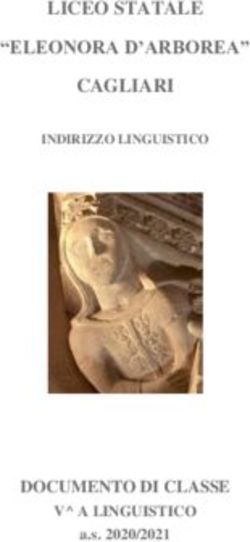Underwater: recensione del monster-movie di William Eubank con Kristen Stewart - Il Discorso
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Underwater: recensione del monster-movie di William Eubank con Kristen Stewart L’ingegnere meccanico Norah Price (Kristen Steward) lavora nella stazione di trivellazione Kepler 822, della Tian Inustries, una gigantesca struttura adagiata nella Fossa delle Marianne, a circa 7 miglia di profondità. All’improvviso si scatena l’inferno, a causa di quello che all’inizio sembra essere un terremoto sottomarino. Norah riesce a cavarsela, assieme a un manipolo di sopravvissuti, che include il capitano Lucien (Vincent Kassel). La situazione è disperata: il nocciolo del reattore nucleare che alimenta la stazione è in procinto di esplodere, le capsule di salvataggio non sono raggiungibili, anche il sottomarino della base è inservibile, la struttura è in procinto di collassare. A mali estremi, stremi rimedi: l’unica possibilità per cavarsela è scendere sulla superficie oceanica e raggiungere a piedi la stazione Roebuck 641. Ma già nella discesa verso il fondo dell’abisso su un malfermo elevatore, i superstiti capiscono che c’è qualcosa che non va. Qualcuno, o qualcosa, sembra aggirarsi nell’oscurità. Ma il vero orrore li attende sul fondale oceanico.
Underwater: un b-movie che riprende tutti gli stereotipi del genere La trama non è per niente originale, la situazione è simile a quella descritta in Creatura degli Abissi, e il film sembra rendere omaggio a innumerevoli pellicole analoghe che lo hanno preceduto. L’atmosfera che si respira all’inizio è quella di Alien, con i lunghi corridoi vuoti e male illuminati e i superstiti che si muovono in oscuri cunicoli. Anche la plancia di comando e la voce sintetica che risuona nell’aria, preannunciando sventure, avvicinano l’atmosfera del film a quella che si respirava sull’astronave Nostromo. I mostri umanoidi sono simili a quelli di Cloverfield, mentre le creatura più grande deve molto anche a Deep Rising. Altre pellicole la cui storia è legata alla fuga da basi sottomarine messe in crisi da creature più o meno ostili, che vengono in mente guardando Underwater, sono Leviathan e The Abyss. Insomma, niente di nuovo. I personaggi sono molto piatti e inconsistenti, con l’eccezione della protagonista, un’androgina Kristen Steward, che tuttavia all’inizio del film William Eubank si diverte a fare girare a piedi nudi nella base in disfacimento, concedendo una piccola dose di feticismo a questa pellicola. Guardando la Noah Price di Underwater viene spontaneo pensare alla leggendaria Ellen Ripley di Alien. In realtà i due personaggi sono molto diversi. Mentre Noah è una persona in crisi che deve fare i conti con il suo passato, ritrovando sé stessa durante il film, Ripley è una autentica guerriera, capace di fronteggiare e sconfiggere mostri e androidi.
I componenti maschili del manipolo di sopravvissuti sono personaggi inconsistenti, a cominciare dal capitano Lucien, interpretato da uno sprecato Vincent Cassel. In Underwater l’iniziativa appartiene alle due donne del gruppo, Norah in testa, che da vera eroina giunge a sacrificare sé stessa per gli altri. Underwater: una onesta pellicola per intrattenere il pubblico Va detto che la mancanza di spessore dei personaggi non è un problema per questa pellicola, che è concepita per intrattenere il pubblico amante di questo genere, e non certo per riflettere sulla natura umana o ragionare sul nostro ruolo nell’universo. Ovviamente c’è anche l’immancabile messaggio ecologista e l’attimo di riflessione sui limiti che l’umanità non dovrebbe violare, ma tutto questo rimane sullo sfondo di una storia che è basata non certo sui dialoghi, spesso avvilenti, quanto sull’ambiente nel quale la storia si srotola. In questo film, la tradizionale dicotomia tra natura e cultura si traduce nella differenza tra il buio carico di inquietante mistero, che caratterizza i minacciosi fondali oceanici, dove si muovono sagome inquietanti, e la luce proveniente dalle strutture della piattaforma di trivellazione, e dagli scafandri degli uomini del suo equipaggio. I protagonisti si muovono tra questi due mondi contrastanti, cercando di sopravvivere. Pochi ci riusciranno, mentre la Tian Industries riuscirà a insabbiare quanto successo, come spesso accade in questo genere di pellicole, continuando a macinare utili, fregandosene di quanti ci hanno lasciato la pelle. Si tratta di un altro cliché di questo genere cinematografico. Basti pensare alla Weyland-Yutani di Alien o alla Umbrella Corporation di Resident Evil. Metafore del nostro mondo globalizzato, dove spesso il potere economico delle grandi compagnie riesce a schiacciare gli individui e i loro diritti. Ma, ancora una volta, tutto questo rimane sullo sfondo.
Lo spettatore viene invece trascinato nella storia dall’incalzare degli eventi. Il dramma esplode subito, nel primo minuto della pellicola, e poi cresce, continuamente. Il film, che comincia come un disaster-movie, diventa un monster- movie. I personaggi devono sopravvivere, superare situazioni che richiedono azione, non dialoghi pensosi. Agire o perire. Quanto allo spettatore che ha pagato il biglietto, se è venuto a vedere un monster-movie non rimarrà deluso, specie se ama il genere e apprezza le citazioni. E poi il buon ritmo, in continuo crescendo, la curata ambientazione sottomarina, gli ambienti claustrofobici e la splendida fotografia possono regalare emozioni forti. Underwater non è certo un capolavoro, ma è un onesto b-movie che fa il suo lavoro: intrattenere il pubblico che apprezza questo genere. 1917: la recensione del film di guerra di Sam Mendes 6 aprile 1917. A due soldati britannici viene affidata una missione suicida: attraversare le linee nemiche, che si suppone essere state abbandonate dai tedeschi, e consegnare una missiva urgente che potrebbe salvare 1600 vite umane. Per uno dei due militari la missione è particolarmente importante, perché nel reggimento che potrebbe cadere in una trappola mortale combatte il proprio fratello. Il film è liberamente tratto da una storia vera, in quanto basato sul racconto del nonno del regista, Alfred Mendes, che realmente combatté nella Prima guerra mondiale, e al quale il film è dedicato.
Un racconto di per sé molto asciutto, che non sembra essere
molto interessato a mostrare le inimmaginabili atrocità della
Grande Guerra, o ad approfondire dettagli storici, ma che
regala un’esperienza immersiva allo spettatore, che grazie a
una eccellente fotografia e all’uso sistematico del piano
sequenza viene letteralmente trasportato nel racconto.
1917: un film tecnicamente
eccezionale
La povertà della storia narrata è però ampiamente compensata
dal livello tecnico stellare della pellicola. Mendes tuttavia
non ha utilizzato ritmi forsennati o fatto uso di effetti
speciali mozzafiato, come attualmente sembra essere molto di
moda nei blockbuster. Al contrario, la narrazione scorre
lentamente, per un film di guerra, e le scene splatter o
truculente vengono utilizzate con parsimonia, tenendo conto
che stiamo parlando degli orrori della Prima guerra mondiale.
In pratica, il film è un unico piano sequenza, in quanto è
molto difficile distinguere le diverse riprese. Inoltre la
telecamera è per la maggior parte del tempo all’altezza dei
due protagonisti. Lo spettatore trascorre virtualmente tutto
il film di fianco ai due soldati inglesi, ed è molto arduo non
rimanere rapiti da quanto viene narrato.
Anche perché la fotografia è di altissima qualità. In
particolare i combattimenti notturni nella cittadina francese
di Ecoust hanno una resa eccezionale, conferendo a quellaparte del film una dimensione quasi metafisica. L’effetto è quindi immersivo, e sottolinea la dimensione umana dei protagonisti, piuttosto che gli accadimenti bellici, e la stessa ricostruzione storica degli eventi narrati, peraltro ineccepibile, passa in secondo piano. 1917: un film semplice che funziona Questa pellicola ha una sceneggiatura molto semplice e lineare, non sembra volere veicolare nessun messaggio particolare, e sicuramente non può essere paragonata a capolavori del cinema che con essa condividono l’ambientazione storica, come Orizzonti di Gloria, di Stanley Kubrick, del 1957. Mendes non sembra neanche interessato a porsi domande metafisiche sul significato della guerra, o su come questa alteri il rapporto dell’uomo con la natura, come ha fatto Malik con il suo complesso La Sottile Linea Rossa, del 1998. Il regista non indugia neanche sulla sete di gloria e l’imbecillità degli alti comandi, come il già citato Orizzonti di Gloria, né perde tempo a sottolineare le deviazioni umane e le perversioni che la guerra inevitabilmente alimenta
nell’animo umano, come accade in Full Metal Jacket, sempre di Stanley Kubrick, del 1987. Semmai questo film può essere concettualmente accostato a Salvate il Soldato Rayan, di Steven Spielberg, del 1998. In entrambe le pellicole quello che mette in moto la storia è la necessità di salvare vite umane al fronte, e il loro scopo sembra essere semplicemente quello di coinvolgere emotivamente nella narrazione, piuttosto che veicolare messaggi complessi. Certo, in 1917 non c’è niente di neanche lontanamente paragonabile alla sequenza iniziale di Salvate il Soldato Rayan, dove l’orrore di quanto accade sulla spiaggia di Omaha Beach, durante lo sbarco in Normandia, viene buttato in faccia allo spettatore con spietata crudezza. Sam Mendes non sembra essere interessato neanche a fare vedere fino in fondo la crudeltà della guerra e le sofferenze inumane che infligge a combattenti e civili. In compenso riesce a coinvolgere lo spettatore in una storia molto semplice, utilizzando inquadrature accuratamente studiate, una fotografia di alto livello, musiche efficaci e utilizzando in maniera magistrale il piano sequenza. 1917: un film da vedere Lo spettatore vien rapito dalla narrazione, quasi sospeso nell’eterno presente della storia che scorre sullo schermo, e non può che immedesimarsi nei due protagonisti (efficacemente interpretati da Dean-Charles Chapman e George MacKay), due ragazzi che la guerra ha strappato dalle loro famiglie e scaraventato al fronte. Due persone molto differenti caratterialmente ma accomunate da una visione molto semplice della vita, lontana da ogni intellettualismo, concentrati sull’unica cosa che può interessare un uomo al fronte: sopravvivere. E i due protagonisti sembrano condividere con il regista la
lontananza da ogni sovrastruttura ideologica. Tanto che nel film, per una volta, il nemico non è una figura ambigua, di difficile lettura, moralmente oscillante in una indistinta zona grigia, ma è semplicemente il cattivo da combattere. Per non essere uccisi. Mentre gli inglesi sono i buoni. Una visione manichea che forse farà torcere il naso a qualche fine intellettuale, ma che è senz’altro funzionale allo scopo di questa pellicola, che è coinvolgere lo spettatore in una storia molto semplice, utilizzando con maestria la tecnica cinematografica. Tra l’altro questa scelta finisce per sottolineare l’assoluta imbecillità della guerra, dove l’unica possibilità è di uccidere per non essere uccisi. Una visione del mondo ristretta, è vero, ma che forse bene rispecchia la drammatica realtà di chi, in quegli anni terribili, si ritrovava al fronte, dove tra un assalto frontale e l’altro sicuramente non c’era molto spazio per fini intellettualismi. 1917 è candidato a 10 Oscar. Forse troppo per questa pellicola, che comunque vale tutti i soldi del biglietto d’ingresso. Per una volta, viva la tecnica e chissenefrega della storia raccontata. Il cinema è anche questo. Richard Jewell: recensione del film di Clint Eastwood Con questa sua ottima pellicola, il quasi novantenne Clint Eastwood mette in scena con grande efficacia un altro dei suoi antieroi, ispirandosi a fatti accaduti veramente. Dimostrando ancora una volta il suo spessore come regista.
Richard Jewell, il protagonista che dà il nome alla pellicola, è una guardia di sicurezza che, durante le Olimpiadi estive del 1996 ad Atlanta, in Georgia, scopre uno zaino contenente un ordigno esplosivo in un parco. Il suo intervento evita una strage, e gli fa guadagnare gli onori della cronaca. I media prima lo osannano come un eroe, poi lo accusano di essere il probabile autore dell’attentato, precipitando la sua vita nell’abisso. L’intervento di un avvocato gli permetterà di riabilitarsi. Il film narra quanto accaduto dall’attentato fino al 2007, quando viene scoperto e condannato il vero autore dell’atto criminale. Richard Jewell: un vero antieroe Richard Jewell è un ragazzone sovrappeso, con problemi di salute, ossessionato dall’ambizione di diventare un poliziotto. Sebbene abbia più di trent’anni, vive ancora con
l’anziana madre, alla quale è molto legato. Per alcuni versi incarna molti stereotipi statunitensi: si ingozza di junk food, fatto che è alla base dei suoi problemi fisici, possiede un arsenale e ama le armi, non paga le tasse, è atterrito dall’idea di venire considerato un omosessuale. In evidente sovrappeso, sgraziato nei movimenti e intellettualmente non superdotato, tanto che viene spesso dileggiato dai colleghi, è tuttavia una persona intimamente buona, caratterizzata da un alto senso della giustizia e sempre pronta a mettersi al servizio degli altri. Il suo maniacale senso del dovere e la perfetta conoscenza delle procedure sono i fattori che gli permettono di scoprire la bomba e di salvare molte vite umane. Con un fisico sgraziato e le fattezze di un bambinone, preso in giro da tutti, Richard è nella sua essenza una persona con un cuore d’oro, con un alto senso delle istituzioni e pronto ad affrontare ogni pericolo per proteggere gli altri. Ha pochi amici. Solo l’anziana madre e un avvocato sul viale del tramonto, Watson Bryant, lo stimano veramente. Richard Jewell: un film contro l’abuso di potere delle istituzioni È proprio Bryant che lo mette in guardia, all’inizio del film, dal pericolo di diventare uno stronzo non appena si acquisisce un minimo di potere. Le persone che cercheranno di annientare il protagonista sono il suo opposto: belli fisicamente, brillanti intellettualmente, ma bacati dentro. Kathy Scruggs è una reporter avvenente e spregiudicata, che fiuta subito la ghiotta occasione di creare un caso giornalistico sulle indagini, appena avviate dall’FBI, sul conto di Richard Jewell. In effetti il profilo psicologico del probabile bombarolo di Atlanta coincide con le caratteristiche di Richard: un maschio frustrato, amante delle armi, in cerca di notorietà per
evadere da una vita buia, ai margini della società. Kathy comincia quindi il linciaggio mediatico del protagonista, mettendo in moto un meccanismo perverso che, auto- alimentandosi, rischia di distruggerlo. In questo è aiutata da un agente in carriera, Tom Show, che, in cambio di una prestazione sessuale, spiffera lo stato dell’arte delle indagini dell’FBI alla giornalista, trovandosi subito dopo nell’impellenza di chiudere il caso. Richard sembra essere un capro espiatorio perfetto. Tom tenta quindi di strappargli una confessione falsa, utilizzando mezzi surrettizi. Tom rappresenta infatti un’istituzione, l’FBI, per la quale il protagonista ha una fiducia cieca e quasi disarmante. Il consapevole tentativo di abusare della creduloneria di Richard è vomitevole, ma fallisce, perché in realtà il protagonista è meno sprovveduto di quanto spossa sembrare. L’intervento dell’avvocato Bryant è risolutivo per riabilitare Richard, salvandolo sia dal linciaggio mediatico che dalla sedia elettrica. Le scene finali, ambientate nel 2007, vedono l’avvocato raggiungere il protagonista nella stazione di polizia dove è finalmente riuscito a diventare un agente, per comunicargli che il vero colpevole ha confessato. Richard muore nello stesso anno, per le complicazioni legate al diabete, a solo 44 anni. Richard Jewell: un film da vedere Clint Eastwood ha realizzato una pellicola semplice ma efficace, centrata su pochi personaggi, molto ben tratteggiati. Un plauso va alla splendida interpretazione di Paul Walter Hauser, che ha ci ha regalato un Richard Jewell molto credibile, diviso tra le sue ambiguità interiori e sballottato in un mondo spregiudicato, dove domina l’apparenza, nel quale i fatti possono essere fatti sparire dalla narrazione mediatica.
Il film critica due istituzioni, l’FBI e il mondo dei media, che diventano il simbolo del potere distorto, capace di distruggere cittadini indifesi per soddisfare le becere ambizioni dello stronzo di turno. E lo fa tenendosi alla larga dal politically correct tanto abusato in Italia (basti pensare a due recentissime pellicole nostrane, Tolo Tolo di Checco Zalone e Hammamet di Gianni Amelio). Il risultato è un prodotto altamente godibile, che intrattiene e fa riflettere. Tra l’altro Clint Eastwood si è divertito a mescolare finzione e realtà, utilizzando filmati originali dell’epoca, che vengono trasmessi dalle televisioni in scena. Il vero Richard Jewell convive quindi con quello della finzione cinematografica, sia pure per pochi istanti. Una chicca cinematografica e un omaggio per quello che è stato un vero eroe, purtroppo dimenticato. Perchè Clint Eastwood ha ancora una volta messo al centro l’uomo, con tutte le sue contraddizioni e le sue ambiguità. Un uomo che, nonostante tutto, può trovare dentro di sé risorse impensabili per tirarsi fuori da situazioni apparentemente senza uscita. Diventando un eroe. Senza ricorrere agli effetti speciali dei film della Marvel Cinematic Universe. Bravo Clint. Aspettando il tuo prossimo film… Lunedì 20 gennaio al cinema Centrale RICHARD JEWELL,in versione originale! EU-CIAK LA FASE FINALE DEL
PROGETTO CHE EDUCA I RAGAZZI AL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO AL TRIESTE FILM FESTIVAL EU Ciak, è il progetto di educazione all’audiovisivo promosso dall’associazione culturale Alpe Adria Cinema e dal PAG (Progetto Area Giovani) delComune di Trieste con il sostegno della Fondazione Pietro Pittini. Alpe Adria Cinema è il motore della principale vetrina internazionale espressamente dedicata alle cinematografie dell’Europa centro-orientale degli ultimi 30 anni e osservando i cambiamenti nella società, si è palesata sempre di più l’esigenza didattica ed educativa di far conoscere ed amare il cinema anche alle giovani generazioni, che grazie al web, usufruiscono del prodotto audiovisivo in maniera più individuale che collettiva. Tra le varie attività organizzate da Alpe Adria Cinema all’interno del TSFF, stanno così assumendo sempre più rilevanza e attenzione quelle dedicate ai bambini e ai ragazzi. Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi progetti e attività volti al coinvolgimento di un pubblico giovane, nell’ottica di sviluppare interesse per il settore dell’audiovisivo e del cinema, con un focus particolare sulle aree del centro-est Europa. A queste attività si è affiancata l’iniziativa EU Ciak, un progetto che coinvolge tre classi, terze e quarte, di tre scuole superiori della città di Trieste: l’International School of Trieste, l’Istituto Deledda – M. Fabiani e l’Istituto Nordio. In ciascuna classe è stato proposto un percorso di 6 laboratori per la realizzazione di un cortometraggio sul tema dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Ai ragazzi verrà dato ampio spazio di confronto e discussione sul tema scelto grazie a ai materiali informativi
messi a disposizione delle classi e alle suggestioni e agli stimoli forniti durante le lezioni. Ad accompagnare gli studenti in questo percorso ci sono stati tre giovani video maker triestini: Giulio Ladini, Fulvio Bullo e Hari Bertoja. «L’esperienza è stata molto stimolante per gli studenti perché a partire dalla formazione iniziale i ragazzi hanno deciso di sviluppare la sceneggiatura dei loro cortometraggi» racconta la referente Carolina Stera di Alpe Adria Cinema «I temi scelti sono stati la libertà di espressione, la discriminazione per motivi di genere e la libera circolazione dei cittadini europei in Europa. Tutti gli studenti hanno poi scelto dei ruoli all interno della troupe cinematografica, chi ha fatto l aiuto regista, chi il fonico, chi l’attore… Ognuno ha quindi potuto immedesimarsi e sperimentare una professione. » Nel corso dei sei giorni di laboratorio, gli studenti sono stati accompagnati nella scrittura di una sceneggiatura e nella creazione e organizzazione di una vera e propria troupe cinematografica in cui ognuno svolge un ruolo preciso, come accade nei set reali. Il risultato sarà un cortometraggio collettivo, in cui l’apporto di ognuno sarà rilevante, riconosciuto e condiviso. Il progetto ha inteso innanzitutto rendere i ragazzi protagonisti di un percorso partecipato e dinamico, in cui loro stessi potessero esprimere idee che poi, grazie al linguaggio audiovisivo e cinematografico, venissero rappresentate nel cortometraggio; il video diviene quindi uno strumento per una sintesi efficace e coinvolgente delle loro idee e del messaggio veicolato. «È stato importante e utile far loro conoscere chi si occupa di questo settore:hanno partecipato ai laboratori in qualità di relatori anche la FVG Film Commission e il regista Thanos Anastopoulos. È stata un’ esperienza che speriamo possa aver suscitato interesse e curiosità negli studenti e siamo sicuri
che la scelta di proiettare i loro cortometraggi sul grande schermo del teatro Miela durante un festival prestigioso come il Trieste Film Festival li renderà orgogliosi e felici di aver partecipato a questa prima edizione di EU Ciak.» Le classi dell’International School of Trieste, Liceo artistico Enrico e Umberto Nordio e Istituto Tecnico G. Deledda – M. Fabiani presenteranno al pubblico i cortometraggi realizzati sabato 18 alle ore 11:00. Il pubblico in sala sarà chiamato a votare il miglior cortometraggio. Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Pietro Pittini e la collaborazione del PAG-Progetto Area Giovani del Comune di Trieste. VR DAYS LA REALTÀ VIRTUALE DELLE DONNE AL TSFF di TRIESTE Da tre anni a questa parte il Trieste Film Festival è impegnato ad esplorare le nuove tecnologie in ambito cinematografico e anche in questa trentesima edizione Alpe Adria Cinema promuove il progetto TSFF goes Virtual – VR Days. «La tecnologia ha sempre visto nomi maschili tra le file degli inventori, dei creatori e successivamente dei CEO e amministratori delle grandi aziende tecnologiche» ci racconta il responsabile della sezione VR del TSFF Antonio Giacomin «Poi arrivano i nuovi media immersivi che mettono lo spettatore in un ruolo diverso, lo immergono in un ambiente nel quale entra e diventa il centro dell’attenzione/azione. E con il nuovo medium espressivo della realtà virtuale tutto ciò
viene sperimentato con nuovi contenuti e con nuove modalità di interazione tra storia e spettatore. La narrazione è ancora alla ricerca di un protocollo, di una serie di regole e sensibilità per un nuovo modo di raccontare il mondo e molte donne si sono cimentate in questo nuovo metodo, non solo per immagini, ma soprattutto per esperienze.» In questa terza edizione dei VR Days, promossa da Alpe Adria Cinema e sostenuta da proESOF 2020,vogliamo discutere e capire il ruolo delle donne nei media immersivi, esplorare nuove tecnologie e nuove modalità di storytelling in un panel con Stefania Casini, regista e produttrice, Sara Tirelli, artista visiva e filmmaker e Alessia Sonaglioni dell’European Women’s Audiovisual Network. L’incontro a ingresso libero dal titolo “Donne E Storytelling Nella Realtà Virtuale” si tiene sabato 18 alle ore 17:00 al Cafè Rossetti ed è moderato da Agnese Pietrobon, psicologa e ricercatrice delle tecnologie immersive. Mentre per un’esperienza “fisica”, da sabato 18 a martedì 21 dalle 11:00 alle 19:00 nel foyer del Politeama Rossetti sarà possibile ‘immergersi’ in tre esperienze in VR. La prima è Mare Nostrum. The Nightmare (Stefania Casini, I, 2019, col., 11’), in cui coraggio, speranza, nostalgia, paura, sofferenza, spaesamento scandiscono il viaggio di un giovane migrante di 13 anni. Una live action, un’esperienza a 360° in realtà virtuale che farà provare un turbinio di emozioni, accompagnati da un sound 3D che consentirà di vivere la tragedia in modo molto emotivo. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria www.marenostrum.eventbrite.it. La seconda s’intitola Medusa Act Ii (Sara Tirelli, I – S, 2018, col., 9’) ed è un cortometraggio a 360° sulla crisi contemporanea dell’identità europea e sulle conseguenze che hanno i grandi flussi di migranti sulla fortezza Europa. Mette in discussione il regresso e la perdita di memoria di una
cultura. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria www.medusavrexperience.eventbrite.it La terza è parte del progetto Esterno / Giorno di Casa del Cinema di Trieste e si intitola Set Reali E Visite Virtuali e porta lo spettatore ad immergersi nei set dei più celebri film e serie TV girati in Friuli Venezia Giulia senza doversi muovere. Accompagnati dalla voce dei protagonisti si potrà vivere un’esperienza completamente nuova grazie alla realtà virtuale. L’esperienza è stata realizzata da Antonio Giacomin, immersive video & VR specialist e si potrà fare da sabato 18 a martedì 21 dalle 11:00 alle 19:00 al costo di €15,00 con prenotazione obbligatoria su www.set-reali-visite-virtuali.eventbrite.it Ma ci sarà anche una quarta importante esperienza la cui postazione viene allestita da sabato 18 a martedì 21 dalle 11:00 alle 19:00 presso l’Hotel DoubleTree by Hilton Trieste e si intitola The Key (Céline Tricart, USA, 2019, col., 20’, v.o inglese), un’esperienza interattiva che mescola teatro immersivo e realtà virtuale. Il partecipante prende parte a un viaggio, esplorando dei sogni nei quali deve affrontare sfide e decisioni difficili, compresa l’esperienza della perdita. Il pubblico sperimenterà un viaggio metaforico dal pericolo alla salvezza. The Key è il vincitore del Gran Premio della Giuria per la migliore opera VR immersiva all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. A ingresso libero con prenotazione obbligatoriawww.thekeyvrexperience.eventbrite.it. dal corrispondente
Presentato il 31. TRIESTE FILM FESTIVAL, 17-23 GENNAIO TRIESTE 30+1: dopo i festeggiamenti – speriamo non troppo autocelebrativi – del trentennale dell’anno scorso, il Trieste Film Festival, diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, si tuffa in un nuovo decennio, facendo tesoro della propria storia (iniziata alla vigilia della caduta del Muro di Berlino) ma allo stesso tempo rimettendosi in gioco con la freschezza di una nuova prima volta. Il giro di boa è compiuto, adesso si continua a nuotare “sincronizzando” – proprio come fanno le campionesse della Triestina Nuoto nella sigla firmata da Thanos Anastopoulos – le anime del festival, tra omaggi e scommesse, azzardo e memoria. Mai così numerosi come quest’anno, i “maestri” si affacciano sin dall’apertura, affidata all’anteprima italiana del nuovo film di un autentico mito della storia del cinema, Terrence Malick: girato interamente in Europa, LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE (presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes, e nelle nostre sale dal 9 aprile distribuito da The Walt Disney Company Italia) racconta la storia vera di Franz Jägerstätter, un contadino austriaco che – richiamato alle armi durante la Seconda guerra mondiale – rifiutò di giurare fedeltà a Hitler, e per questo fu condannato a morte nell’agosto del 1943. “Un film – spiegano i direttori
artistici del TsFF – che ci riguarda da vicino, non solo in senso geografico, e che dopo alcune opere molto intime riporta l’autore di La sottile linea rossa a misurarsi con la Storia del Novecento”. A chiudere il festival sarà invece Corneliu Porumboiu, uno dei nomi più eccentrici emersi dalle file del cosiddetto “nuovo cinema rumeno”: ambientato tra Bucarest e le Canarie – più precisamente La Gomera, l’isola che in originale dà il titolo al film – il suo FISCHIA! (prossimamente nelle sale italiane con Valmyn) è un noir insolito e sorprendente, che reinventa tutti gli archetipi del genere (il poliziotto corrotto, la femme fatale irresistibile) con un gusto e un umorismo personalissimi. Non deve stupire, quindi, il calore con cui il film è stato accolto dalla critica internazionale l’anno scorso a Cannes, e l’attesa per la masterclass aperta al pubblico che Porumboiu terrà a Trieste. Nucleo centrale del programma si confermano i tre concorsi internazionali dedicati a lungometraggi, cortometraggi e documentari: a decretare i vincitori, ancora una volta, sarà il pubblico del festival. Undici i film, tutti in anteprima italiana, che compongono il Concorso internazionale lungometraggi. La (im)mobilità sociale dell’Europa di oggi, fatta di migranti economici che attraversano il continente, è tra i temi centrali: dalla Brexit vissuta sulla propria pelle dai protagonisti bulgari di KOT W SCIANIE (Un gatto nel muro / Cat in the Wall) di Mina Mileva e Vesela Kazakova, già in concorso a Locarno, a NECH JE SVETLO (Che sia fatta luce / Let There Be Light) di Marko Škop, dove un muratore slovacco di ritorno a casa dalla Germania scopre l’affiliazione del figlio ad un gruppo
paramilitare; e ancora l’OLEG di Juris Kursietis, macellaio lettone che a Bruxelles cerca un buon salario e trova la criminalità polacca; altrove la prospettiva è più intima, persino “spietatamente” intima, come dimostra IVANA CEA GROAZNICĂ (Ivana la Terribile / Ivana the Terrible) in cui la regista e attrice Ivana Mladenović mette in scena – e in gioco – le proprie vere fragilità, e i sentimenti sono al centro anche dell’emozionante trittico amoroso del serbo ASIMETRIJA (Asimmetria / Asymmetry) di Maša Nešković, del viaggio di un padre e un figlio in lutto nel bulgaro BASHTATA (Il padre / The Father) di Kristina Grozeva e Petar Valchanov, del matrimonio giunto (forse) al capolinea in MONȘTRI. (Mostri. / Monsters.) del rumeno Marius Olteanu, dell’amore clandestino raccontato dalla russa Larisa Sadilova in ODNAŽDY V TRUBČEVSKE (C’era una volta a Trubčevsk / Once in Trubchevsk), del dolore vissuto da un intero villaggio per la scomparsa di OROSLAN, girato dallo sloveno Matjaž Ivanišin. Per finire, due grandi ritratti femminili: LILLIAN dell’austriaco Andreas Horvath, il lungo viaggio di un’emigrante bloccata a New York per tornare in Russia, un road movie – liberamente ispirato alla straordinaria storia vera di Lillian Alling – che si fa cronaca di una lenta sparizione; e ZANA di Antoneta Kastrati, che nel Kosovo di oggi riflette sui traumi della guerra e su una società patriarcale che ancora condiziona pesantemente la libertà delle donne. Molte anche le proposte Fuori concorso, spesso all’insegna del genere: due “polar”, il crepuscolare HEIDI di Cătălin Mitulescu, l’ultimo caso di un agente alla vigilia della pensione che nella periferia di Bucarest deve trovare due prostitute disposte a testimoniare in un caso di mafia, e il corale V KRAG (La ronda / Rounds) di Stephan Komandarev, che intreccia le storie di tre squadre di polizia di pattuglia
nella notte di Sofia. Due commedie: l’italiano PARADISE UNA NUOVA VITA di Davide Del Degan (presto nelle sale distribuito da Fandango), dove un errore burocratico riunisce tra le nevi del Friuli, con esiti inattesi e paradossali, un testimone di giustizia sotto protezione e il killer di mafia contro cui ha testimoniato; e la prima “commedia zombie” balcanica, POSLJEDNJI SRBIN U HRVATSKOJ (L’ultimo serbo in Croazia / The Last Serb in Croatia) di Predrag Ličina; infine, due opere prime: ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV (Storie dai boschi di castagne / Stories from the Chestnut Woods) di Gregor Božič, che mescola suggestioni letterarie (Cechov e le fiabe della Slavia veneta) e fascinazione per luoghi dimenticati (le Valli del Natisone, al confine tra l’Italia e l’odierna Slovenia), e MOI DUMKI TICHI (I miei pensieri sono silenziosi / My Thoughts Are Silent) dell’ucraino Antonio Lukič, che si muove tra dramma e commedia per raccontare l’ultima chance del giovane Vadym di lasciarsi alle spalle tutto e trasferirsi in Canada. E.L. Hammamet: la recensione del film di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino
Questo film mette in scena la parabola discendente di Craxi, tristemente consumatasi nel suo rifugio ad Hammamet, in Tunisia. La storia comincia con un bambino che rompe delle vetrate con una fionda. Scopriremo che si tratta del giovane Craxi, che nella scena successiva viene rappresentato al massimo del suo fulgore, sul palco del 45° Congresso del Partito Socialista Italiano, dove viene eletto segretario con una maggioranza bulgara, e osannato da una plaudente folla in delirio. Viene avvertito da quello che presumibilmente è un tesoriere del partito che sono in corso delle perquisizioni, ma Craxi, con supponenza e arroganza, lo invita ad andare in vacanza e di stare tranquillo. Nella scena seguente vediamo l’ex segretario, ormai ridotto a un dolorante relitto umano, che si trascina zoppicando, appoggiato a un bastone, nella sua villa ad Hammamet, in compagnia della moglie, della figlia, del nipotino e della sua fedele scorta armata. Il resto del film è una lenta discesa verso l’oblio di quello che una volta era uno degli uomini più potenti d’Italia. Ecce homo.
Hammet: un film nella quale la finzione prevale sul dato storico Nel film non vengono mai usati i nomi reali dei personaggi storici. Lo stesso Craxi viene chiamato presidente, e sua figlia, che nella realtà si chiama Stefania, è Anita, come la figlia di Garibaldi. Non viene mai fatto il nome di un magistrato di Mani Pulite, né di un politico, neanche di quello che viene a trovarlo nella sua villa, in un incontro colmo di tristezza, rimpianti e qualche rancore. Nella storia entra in scena anche un personaggio inventato, Fausto, figlio di un collaboratore morto suicida in seguito alle inchieste giudiziarie. Tutte scelte che sembrano sottolineare la volontà del regista di prendere le distanze dalla realtà storica dei fatti, che pure costituisce il substrato su cui si basa il film, per concentrarsi sul punto di vista dell’assoluto dominatore della scena, Craxi, assurto quasi a metafora dell’uomo potente caduto nella polvere. A Fausto l’ex segretario del PSI affida una sorta di testamento spirituale, una discorso ripreso con una telecamera a mano nel deserto tunisino, vicino al rottame di un vecchio carro armato inglese, nel quale gli dice cose che non ha mai detto a nessuno. E con quel prezioso tesoro multimediale, del quale allo spettatore non è dato conoscere i contenuti, Fausto sparisce nel nulla. Lo ritroveremo alla fine del film, in un manicomio, dove consegnerà ad Anita il prezioso nastro, esortandola a non farlo vedere a nessuno, perché altrimenti qualcuno potrebbe fare del male all’Italia. Una neanche tanto velata allusione a un possibile complotto internazionale che avrebbe decretato la fine di Craxi. Che, peraltro, in tutto il film non fa altro che auto- giustificarsi e auto-assolversi, perché le tangenti le prendevano tutti, perché la democrazia ha un costo, perché il politico deve soddisfare tutti, perché la magistratura non può comandare il parlamento, perché lui è veramente malato, perché
non c’è nessun tesoro nascosto ad Hammamet. Sarà, ma visto lo stile di vita esibito e la quantità di guardie armate schierate a sua difesa, lo spettatore può lecitamente chiedersi chi ha pagato il suo esilio dorato. Un altra domanda sorge spontanea: un giovane spettatore che non ha vissuto i tempi di mani pulite, che idea si può fare di quel tormentato periodo storico, guardando questa pellicola? Anche perché è facile immedesimarsi in un vecchio malato, Craxi, peraltro magistralmente interpretato da un Pierfrancesco Savino in stato di grazia. Hammamet: un film del quale verrà ricordato solo la recitazione stellare di Pierfrancesco Favino Gianni Amelio ha scelto di rappresentare l’esilio ad Hammamet presentando solo il punto di vista di Craxi, dei suoi familiari e della sua amante. Una decisione legittima, per carità, ma di comodo, che toglie spessore al film, costretto nel perimetro delle nostalgiche, e spesso rancorose, riflessioni di un uomo ormai finito, debilitato da una malattia terribile e ormai abbandonato da (quasi) tutti. Una scelta analoga a quella fatta da Checco Zalone, con il suo mediocre Tolo Tolo: mettere in scena un tema sul quale si può avere un’ampia risonanza mediatica senza troppi sforzi, ma senza avere il coraggio di andare fino in fondo, rifugiandosi nel tradizionale buonismo italico. Se Checco Zalone sembra strizzare l’occhio ai migranti, ma non troppo, perché poi magari qualcuno può prenderla male, Gianni Amelio sembra dare una pacca sulla spalla a un Craxi ormai finito, ma non troppo vigorosa, mi raccomando, non si sa mai che qualcuno si offenda. E poi ci si può sempre rifugiare dietro al fatto che viene messa in scena una fiction, e quindi tutto è lecito o comunque interpretabile. Scelte analoghe che portano a risultati simili: pellicole di scarso spessore, che magari ottengono successo al botteghino
ma che vengono dimenticate rapidamente. Tuttavia bisogna ammettere che Hammamet ha una marcia in più: la performance stellare di Pierfrancesco Favino. Anche grazie a un trucco che ha richiesto ore di lavoro ogni giorno di recitazione, la sua interpretazione di Bettino Craxi è eccezionale. Una luce sfavillante in un film per il resto alquanto opaco. Perché la narrazione è molto lenta e ondivaga, schiacciata sulla figura di Craxi e sui suoi monologhi spesso contraddittori, che verso la fine della pellicola, quando la malattia inesorabilmente prende il sopravvento, deborda in una dimensione onirica e quasi metafisica, dove orientarsi non è facile. E che lascia molto poco allo spettatore che ha pagato il biglietto. A dimostrazione che forse in Italia i tempi non sono ancora maturi per affrontare certi argomenti con serenità. Metropolis, il capolavoro di Fritz Lang che nel 1929 creò un nuovo immaginario nel cinema di fantascienza
Pochi film hanno lasciato un impronta così profonda nell’immaginario collettivo come Metropolis, del 1927, di Fritz Lang. Una pellicola costata una cifra iperbolica in quegli anni, che alla sua uscita costituì un fiasco commerciale che mise a rischio bancarotta la UFA, compagnia di produzione tedesca, destinata a diventare un organo della propaganda nazista. Ma il tempo ha reso onore a questo capolavoro del cinema. La storia narrata è una distopia, che vede gli abitanti di Metropolis suddivisi in due categorie: i ricchi, che vivono una vita idilliaca rinchiusi nei loro maestosi palazzi, e i poveri, destinati a spaccarsi la schiena nei sotterranei della città, trascinandosi lungo un’esistenza miserevole. Ma la stratificazione verticale della città del futuro è ancora più articolata: il creatore di Metropolis, Joh Fredersen, vive nell’edificio più alto e imponente dell’area urbana, l’immaginifica New Tower of Babel, mentre, nelle catacombe che si celano sotto la città dei lavoratori, avvengono delle riunioni segrete, nelle quali una giovane
donna, Maria, esorta gli operai ad avere fede nella venuta di un mediatore, destinato a porre rimedio alle differenze di classe inumane esistenti nella città. La città dei ricchi (a destra), sulla quale svetta la New Tower of Babel, e la città dei lavoratori (a sinistra) Il figlio di Joh, Freder, rimane affascinato dalla figura di Maria, che ha l’ardire di fargli vedere le miserevoli condizioni dei bambini poveri, da lei portati negli immaginifici Eternal Gardens, dove il rampollo del creatore di Metropolis vive una vita dorata, in una sorta di harem ipertecnologico. Ma Joh Fredersen sorveglia suo figlio, e quando si rende conto che esiste un pericolo per l’ordine costituito, non esita a rivolgersi a Rotwang, figura e metà strada tra l’alchimista e lo scienziato, chiedendogli di dare le sembianze di Maria e un robot da lui costruito, per incitare i lavoratori alla rivolta e giustificare in tal modo la loro repressione. Le cose vanno in modo diverso da quanto calcolato dal padre, perché i lavoratori, distruggendo le macchine che li rendevano schiavi, provocano l’inondazione dei sotterranei e la distruzione della principale centrale energetica della città, mettendo a repentaglio l’esistenza della stessa Metropolis. Alla fine ci sarà una riconciliazione tra Joh e i lavoratori, nella cattedrale della città, che vede suo figlio Freder nel ruolo di mediatore. Nel film vengono mescolate simbologie religiose e esoteriche, che convivono in un’ambientazione futuristica. Rotwang: un nuovo immaginario per la scienza e lo scienziato Il personaggio di Rotwang è particolarmente interessante,
perché portatore di una nuova iconografia della scienza,
destinata ad avere un duraturo impatto nel cinema di
fantascienza successivo al capolavoro di Lang. Al di là
dell’acconciatura scapigliata, destinata a caratterizzare la
figura di innumerevoli scienziati nei decenni successivi, esso
personifica il prototipo del mad doctor, che mette il suo
sapere al servizio del potere e dei propri capricci personali.
Lo scienziato Rotwang
La sua casa-laboratorio è l’unica in Metropolis a non essere
in stile moderno o futuribile. Sembra quasi un relitto di un
passato ormai dimenticato. Si tratta di un piccolo edificio
isolato, dal tetto spiovente, privo di finestre, la cui porta
di ingresso è marchiata con la stella a cinque punte. Nel
laboratorio, pieno di macchine dal funzionamento misterioso,
c’è il robot creato dal genio di Rotwang, inizialmente
progettato per dare una nuova vita a Hem, avvenente donna di
cui lo scienziato è innamorato, ma che è morta nel dare alla
luce il figlio di Joh.
Ma nei sotterranei della casa si nasconde anche un accesso
segreto alle catacombe della città. In pratica la casa di
Rotwang è una sorta di elemento di congiunzione tra il mondo
ipertecnologico di Metropolis e la religiosità che ancora è
ben viva nel sottosuolo, sia pure in modo non percepibile dai
palazzi dei ricchi.La casa-laboratorio di
Rotwang
Rotwang stesso è una figura ambigua, nella quale la convivenza
tra scienza ed esoterismo trova la sua massima espressione nel
film. È capace di costruire un robot utilizzando macchinari
dal funzionamento incomprensibile, ma la sua dimora è piena di
simboli esoterici. Non indossa un camice bianco, segno
distintivo degli scienziati dagli anni trenta in poi, ma, come
il successivo dott. Frankeinstein, ha un aiutante deforme.
Lo scienziato ha una mano finta, e si vanta di averla persa
nel tentativo di creare l’uomo artificiale, il lavoratore del
futuro. Quella della disabilità dello scienziato è un tema che
ritornerà spesso nel cinema. Basta pensare a Serizawa nel
primo Godzilla, del 1954, al dottor Stranamore del capolavoro
di Kubrick, del 1964, o al Dr. Everett Scott in The Rocky
Horror Picture Show, del 1975.
Disabilità che può essere vista come un problema nel gestire
la conoscenza, e la responsabilità che da essa deriva. Ma è
forse la separazione della scienza dal corpo sociale nel quale
dovrebbe operare che costituisce l’origine del male. La casa-
laboratorio di Rotwang è infatti senza finestre, e lo stesso
inventore intima a Joh di lasciarlo solo, quando deve dare al
suo robot le sembianze di Maria.
Il mad doctor realizza le sue creazioni mostruose chiuso nella
solitudine del suo laboratorio, lontano dalle istituzioni chedovrebbero porre un freno alla sua attività. Lo stesso schema
verrà ripetuto in innumerevoli film successivi a questa
pellicola. Basta pensare a quanto accede in Frankenstein, di
James Whale, del 1931, o al molto più recente Dr. Brenner,
della serie Stranger Things, ormai diventata un cult. La
scienza è positiva quando è al servizio della società, ma
quando si isola, o lavora nell’ombra, genera mostri, che in
genere si rivoltano contro il loro creatore.
Uno dei robot più famosi nella storia del cinema
Anche se molti sostengono che quello presente in Metropolis
sia il primo robot nella storia del cinema, in realtà ci sono
dei precedenti. Il primo è nel cortometraggio Gugusse et
l’Automaton, purtroppo andato perduto, prodotto e diretto nel
lontano 1897 da Gergoes Méliès, da molti ritenuto essere il
vero padre della fantascienza cinematografica.
Il robot tra Joh Fredersen
(a destra) e Rotwang, il suo
creatore (a sinistra)
Nel 1921 viene poi girato L’uomo Meccanico, scritto, diretto e
interpretato dal comico francese André Deed, meglio noto come
Cretinetti. Oltre a essere uno dei primi film di fantascienza
a essere stato girato in Italia, è il primo conosciuto dove si
scontrano un robot buono e uno cattivo. Di questa pellicola
esiste solo una versione di 26 minuti, restaurata nel 1992
dalla Cineteca di Bologna.Mentre questi due precedenti hanno lasciato poche tracce di
sé, molto più duratura è l’impronta lasciata dalla creatura di
Rotwang nel cinema di fantascienza contemporaneo. Basti
pensare che la struttura fisica del celebre robot C-3PO (D-3BO
nella versione italiana), personaggio dell’universo
fantascientifico di Star Wars, è chiaramente ispirata alla
creatura di Metropolis. Un robot che è stato presente in tutti
gli episodi della saga di Guerre Stellari, dal primo fino
all’ultimo, mediocre, Star Wars: l’ascesa si Skywalker,
mantenendo viva nell’immaginario collettivo un’immagine che
proviene dagli anni Venti. Potere del cinema.
C-3PO di Star Wars e il
robot di Metropolis
In generale, nella fantascienza, esistono due strade tramite
le quali l’uomo cerca di duplicare sé stesso o di creare nuova
vita: quella meccanica e quella biologica. Il robot di
Metropolis è l’antesignano più famoso della prima via, mentre
quello più celebre della seconda è la creatura del dott.
Frankenstein. Entrambe le strade portano al baratro, quando
vengono percorse in solitudine dallo scienziato, che si isola
dalla società al cui servizio dovrebbe invece operare.
Qualunque sia la via scelta, bisogna sottolineare come la
fantascienza sia di fatto un espediente narrativo per renderegiustificabile l’accadimento di fatti che la scienza ufficiale considera impossibili. Da questo punto di vista la fantascienza è alla fin fine un tipo di magia, tollerabile dall’uomo moderno. Un trucco che rende possibile la sospensione dell’incredulità da parte dello spettatore, che, davanti all’esposizione di qualche oscuro macchinario, decide di credere, almeno per la durata del film, che quanto sta vedendo sia verosimile. In Metropolis, Rotwang conserva dei caratteri riconducibili al mondo magico-esoterico. Gli scienziati che lo seguiranno tenderanno a perdere questa componente, come accade solo quattro anni dopo nell’ormai mitico Frankeinstein di James Whale, del 1931, dove lo studioso indossa un impeccabile camice bianco, muovendosi in un laboratorio che molto deve all’immaginario creato da Metropolis. Ma, in fondo, gli scienziati del cinema di fantascienza rimarranno sempre degli apprendisti stregoni e, se il film è fatto bene, rimarrà sempre un piacere perdersi nella narrazione, non importa quanto inverosimile possa sembrare la storia al di fuori della sala cinematografica. Magie del cinema! Tolo Tolo: recensione del film di Checco Zalone Tolo Tolo, di Checco Zalone, poco o niente ha a che fare con la canzone Immigrato, creata per il trailer della pellicola, che aveva suscitato accese polemiche prima della sua uscita. Il contestato brano non fa neanche parte della colonna sonora. Il film in ogni caso non risparmia battute per nessuno e non
può certo essere tacciato di essere razzista. Il trailer è stato di fatto una riuscita mossa pubblicitaria, in quanto ha contribuito ad aumentare l’interesse per questa pellicola, stuzzicando la pancia degli italiani su temi molto sentiti e controversi, come quelli dell’immigrazione e dell’accoglienza, che in ogni caso accomunano trailer e film. Probabilmente non ci sarebbe stato nessun bisogno di questo escamotage, visto l’enorme successo commerciale dell’ultimo lavoro di Checco Zalone, Quo Vado?, campione di incassi in Italia, e la grande popolarità del suo protagonista, per la prima volta impegnato anche nel ruolo di regista. Questo suo quinto film sarà senz’altro un successo commerciale. Tolo Tolo: l’obiettivo dell’ironia è l’italiano medio Il bersaglio principale della comicità di Checco Zalone rimane l’italiano medio, non più nella forma di amante del posto fisso e dell’eterna permanenza nella casa dei genitori, come era nel precedente Quo Vado?, ma nella veste dell’improvvisato imprenditore in cerca di facile successo. Ovviamente il fallimento dell’impresa è assicurato, vista anche l’assurdità dell’idea di aprire un sushi bar in un paesino pugliese. Di qui la necessità di scappare dai creditori e dai parenti, che hanno ipotecato i propri averi per finanziare l’apertura del locale, che ben volentieri vorrebbero lo scalpo del protagonista. Questi fugge in Africa, a lavorare in un villaggio turistico, ma si trova ben presto costretto a scappare di nuovo, viste le devastazioni portate da bande di guerriglieri che spargono morte e distruzione. La nuova terra promessa è il piccolo ma ricco Liechtenstein, dove il segreto bancario dovrebbe garantire il silenzio sul suo passato di imprenditore fallito. La via di accesso all’Europa è ovviamente l’Italia, tramite un viaggio su una precaria imbarcazione in partenza dalla Libia.
Anche in questo caso i suoi progetti falliranno, in quanto si ritroverà costretto ad affrontare i suoi parenti e a rimanere in Italia, contro la sua volontà. Il protagonista incarna l’italiano medio, avido di successo ma restio nell’impegnarsi seriamente per raggiungerlo, amante dei suoi piccoli agi e pronto a difendere il suo orticello a tutti i costi, indifferente alle sofferenze altrui e incapace di comprendere i punti di vista diversi dai suoi. Un individuo meschinamente egoista, cafone, ipocrita e amante dei soldi facili. Una persona intrinsecamente fragile, che nei momenti di stress subisce degli attacchi di fascismo che, come gli viene spiegato da un migrante suo compagno di viaggio, è dentro tutte le persone ed è pronto a emergere nei momenti di crisi, come la Candida. Ma il protagonista irride anche gli stereotipi di certa sinistra, incarnati dal giornalista francese di successo, che ha visto i poveri di tutto il mondo, ma che biasima i veri poveri, che a suo dire sono quelli che hanno solo i soldi. E che non esiterà ad abbandonare al loro destino i suoi compagni di viaggio, versando una ipocrita lacrimuccia di circostanza. Anche il cameo di Nichi Vendola è una aperta presa per i fondelli dell’incomprensibile linguaggio usato da certi personaggi pubblici. Checco Zalone infatti irride la classe politica nostrana, dipinta come fondamentalmente inetta ma capace di carriere incredibili, con le quali il merito ha poco a che fare. Da questo punto di vista il suo atteggiamento è bipartisan. La prima regia di Checco Zalone Con Tolo Tolo, Checco Zalone affronta per la prima volta la regia. E si vede. La storia è molto fragile, di fatto è una successione di siparietti comici, con un ritmo mutevole e contaminazioni del genere musical e utilizza anche cartoni animati, che formano un insieme alquanto disomogeneo. Checco
Zalone dal punto di vista attoriale primeggia, anche perché è circondato da personaggi di scarso spessore e spesso stereotipati. L’immagine che viene data dell’Africa è quella dei quadri delle cartoline, nella quale anche i terroristi, tutto sommato, sembrano fare parte del paesaggio e non fanno poi così paura. Nel film il mito italiani brava gente sembra essere sostituito dall’omologo, e altrettanto opinabile, africani brava gente. Gli autoctoni sono sempre felici e sorridenti, al massimo si accigliano quando il loro villaggio sta per essere raso al suolo dal gruppo armato di turno o esplode una bomba nella casa del vicino. Forse alcune situazioni andavano trattate con maggiore cautela e tatto. Certo stiamo parlando di una commedia, ma i temi trattati sono molto impegnativi e il registro del film è mutevole, per cui in alcuni momenti il regista sembra strizzare l’occhio alle sofferenze della gente, mentre in altri se ne fa beffe, rischiando di urtare la sensibilità di qualcuno. Il pericolo maggiore è di lasciare lo spettatore disorientato, perso in una narrazione ondivaga e scarsamente leggibile. Dove spesso si sorride, è vero, ma si fa fatica a ridere di gusto. Checco Zalone per larga parte del film si muove nel campo minato di temi molto dibattuti e divisivi, come le migrazioni, l’accoglienza, le missioni di pace internazionali e il terrorismo. Temi sui quali il dibattito politico è incandescente. Una scelta che, se da un lato garantisce alla pellicola una grande visibilità, come dimostrato dalla risonanza mediatica ottenuta dal trailer, dall’altro rischia di creare aspettative divergenti nel pubblico. Contrariamente a quanto avrebbe lasciato supporre la canzone Immigrato, lo sforzo del regista di rimanere equidistante è percepibile lungo buona parte del film, e, anche se alla fine il piatto della bilancia sembra pendere verso i migranti, il
tentativo di rifugiarsi dietro a una satira generica per non colpire nessuno rischia di scontentare tutti. Una scelta che ha comunque fatto perdere mordente alla comicità del prodotto. Chissà, forse Checco Zalone avrebbe fatto meglio a tenersi alla larga da certi temi. Perché parlare di problemi carichi di implicazioni politiche cercando di rimanere equidistanti è da ingenui. O forse da furbi, pronti a cavalcare il tema più controverso per ottenere il massimo dell’esposizione mediatica, senza però poi prendere una posizione netta. Ma in fin dei conti anche questo è un tipico atteggiamento dell’italiano medio, tanto preso per i fondelli da Checco Zalone nelle sue pellicole, strizzando l’occhio ad Alberto Sordi. In ogni caso questa pellicola sarà un clamoroso successo al botteghino, visto che il suo protagonista è attualmente sulla cresta dell’onda. Ci rimarrà a lungo? Staremo a vedere, in attesa del suo sesto, inevitabile, film. Star Wars: l’ascesa di Skywalker – recensione con spoiler dell’ultimo episodio di una saga ormai avvolta dal mito Che dire. Fare meglio del precedente, meno che mediocre, Gli Ultimi Jedi non sarebbe stato difficile, ma J. J. Abrams doveva chiudere l’intera saga di Star Wars. Confrontarsi con un mito è un compito improbo. Tra l’altro, vista la quantità
Puoi anche leggere