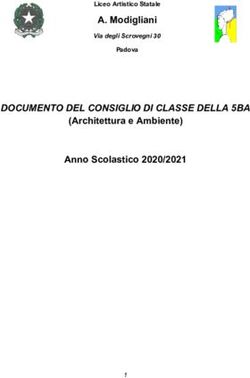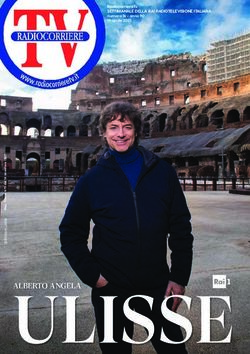Un #metoo calabrese? La voce delle ragazze e il rischio di essere invisibili 2
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Un #metoo calabrese? La voce delle ragazze e il rischio di essere invisibili 2 written by Francesca Pignataro Leggi la prima parte qui Proseguiamo la conversazione con Roberta Attanasio del Centro antiviolenza Roberta Lazino sulla vicenda delle molestie subite da alcune studentesse dell’Istituto di istruzione superiore Valentini-Majorana di Castrolibero, alle porte di Cosenza da un docente. «Il centro è stato vicino fin da subito ai ragazzi e alle ragazze. Abbiamo offerto uno spazio d’ascolto presso la nostra sede e ci siamo resi sempre disponibili. L’abbiamo fatto perché ci siamo rese conto che questo era un fenomeno tanto antico nelle scuole, ma era diversa questa reazione di massa, tra l’altro anche da parte dei ragazzi. Era un’intera scuola che si stava ribellando contro questa situazione e contro questo professore. Ci hanno chiesto di intervenire in assemblea in apertura. Una volta presa la
parola, è scesa la preside per comunicare che la cosa sarebbe andata avanti per vie ufficiali, nonostante fino a quel momento non si fosse svolto nessun consiglio dei docenti e non ci fosse stata nessuna ispezione del consiglio scolastico regionale. Dopodiché se n’è andata.». Ci si potrebbe aspettare che, a questo punto, che le studentesse abbiano iniziato a rivolgersi al centro sia per sé stesse sia per organizzare delle attività durante l’occupazione eppure, anche in questo caso, la realtà tradisce le nostre aspettative. «Non si è presentata assolutamente nessuna. Noi abbiamo dato un tempo fisiologico perché al momento erano impegnate con l’occupazione. Non lo so perché non lo abbiano fatto, noi siamo abituate alle donne che hanno subito una violenza e te ne parlano, poi possono tornare anche dopo tre o quattro anni perché non sempre una donna è pronta a parlare della violenza subita. Anche a distanza di tanto tempo, può uscire la vera consapevolezza. Quindi, secondo me, le ragazze si sono sentite minacciate da questo atteggiamento del professore, ma non so fino a che punto siano consapevoli di essere state delle vittime e non delle complici, perché l’atteggiamento di queste persone tende a far sentire la vittima una complice. La mia preoccupazione è questa: non so fino a che punto sia arrivato questo processo di consapevolezza.». Ha senso preoccuparsi del percorso di consapevolezza tra le studentesse? Questa storia è stata presentata come una grande lezione di democrazia che i ragazzi hanno dato agli adulti, per il fatto che i ragazzi di oggi sono sensibili a certi temi sociali. Quindi che cosa non mi quadrava? Ho chiesto perché, nonostante la denuncia di Dalia risalisse al 2018, la scuola avesse reagito quattro anni dopo: «Quando questa ragazza era a scuola c’era un pregiudizio su di lei e molte persone avevano difficoltà a credere che potesse aver subito una violenza fisica e verbale. Su questo abbiamo sbagliato tutti». L’occupazione dovrebbe essere la prova che quell’ambiente tossico, cui si fa riferimento, non trova più spazio tra i ragazzi e ragazze, grazie a Dalia che per prima ha abbattuto il muro del silenzio. L’inizio di questa storia sembrava pieno di promesse, finalmente il tema degli abusi sessuali nelle scuole avrebbe potuto essere il centro del dibattito pubblico e le ragazze avrebbero potuto costruire assieme ai propri compagni e col corpo docente un ambiente sicuro e capace di ascoltare le loro voci. Muovendosi tra gli studenti l’entusiasmo si è ridimensionato.
A diventare leader dell’occupazione e della protesta è stato un ragazzo, Fausto, e non può che renderci felici sapere che anche i giovani uomini sono sensibili ai temi delle molestie subite dalle donne; tuttavia, è innegabile il senso di amarezza. Sembra che si riproponga un cliché davanti ai nostri occhi: le donne raccontano le loro storie private intrise di disagio, mentre gli uomini le rappresentano pubblicamente diventandone i portavoce e i protagonisti del momento di contestazione politica. Durante la manifestazione di venerdì 18 ottobre la sensazione sul protagonismo maschile è diventata addirittura più insistente: i primi a prendere la parola durante il corteo sono stati dei ragazzi che si scagliavano contro gli abusi subiti dagli studenti. Gli studenti, rigorosamente al maschile. Quando qualcuno fa notare che esistono anche le ragazze, ricordiamo che delle molestie di cui si parla nella scuola hanno coinvolto in prima persona solo delle studentesse, e allora ci si sveglia per un attimo e si includono nel discorso anche le ragazze, almeno per un po’. A questo si somma l’ampliamento della lotta. Ci raccontano infatti che dalle molestie ci si è spostati verso qualcosa di più grande che riguarda i problemi strutturali della scuola. Si parla di alternanza scuola lavoro, di deriva manageriale delle scuole. Ma qual è il rischio? Essendo la prima volta che si occupa di molestie e abusi sessuali, il pericolo è quello di lasciarsi sfuggire l’opportunità di affrontare a pieno questo tema. Scegliere di manifestare venerdì, giorno in cui è stato indetto uno sciopero studntesco nazionale contro l’alternativa scuola-lavoro, ha innegabilmente contribuito a ridurre l’attenzione verso il grande tema delle molestie. Che cos’è una molestia sessuale? Certo, come spiega qualcuno vivere una molestia è un’esperienza dolorosa che fa male e crea disagio, ma qual è la differenza tra bullismo e molestie? Entrambi i fenomeni generano dolore, ma non sono la stessa cosa. Come si riconosce una molestia? Come si interviene? Cosa possono fare le studentesse, gli studenti, il corpo docente e la dirigenza? Quali sono le differenze tra subire una molestia in strada ed essere molestata da un proprio docente, magari una figura carismatica in una posizione di potere gerarchicamente superiore alla nostra? Quali sono gli effetti che questo ambiente tossico ha sulle ragazze e quali effetti ha sui ragazzi? A chi rivolgersi in caso di molestie a scuola? E perché rivolgersi direttamente alla preside e non cercare prima un contatto con le professoresse o i professori più vicini e, magari, più disponibili all’ascolto?
Questi temi avrebbero potuto essere sviscerati durante le due settimane di occupazione, si sarebbe potuto pensare a dei gruppi autogestiti o a degli incontri. La sensazione è che sia mancato il tempo per riflettere su cosa fare, su come organizzarsi, oltre il gesto di protesta. Facciamo un esempio concreto: durante il corteo studentesco una parte dei presenti invitava le vittime a denunciare le molestie e gli abusi, mentre un’altra parte contestava la polizia e lo strumento della denuncia. Che fare? Denunciare o no? Come decidere a chi rivolgersi per capire come muoversi? Ci aiuta a riflettere la delegata del centro antiviolenza Roberta Lanzino: «Puoi andare dalla psicologa a parlare, però se hai bisogno di una consulenza devi chiedere il permesso ai genitori e quindi, per forza, devi dire in famiglia quello che succede. Magari vorresti parlare con qualcuno senza coinvolgere immediatamente la famiglia. Com’è che questi ragazzi ne possono parlare? Quando interveniamo nelle scuole ci rendiamo conto che raccontiamo molte più cose di quelle previste: relazione tra i generi, il rispetto e la cura. Cerchiamo inoltre di non fare una lezione, perché le ragazze e i ragazzi hanno una voglia di parlare pazzesca. Comunicano, esprimono il loro disagio e se hanno dall’altra parte una persona pronta, parlano tantissimo e vorrebbero ripetere l’esperienza perché sentono come un vuoto. Da una parte una scuola che spinge solo a finire i programmi, dall’altro una famiglia che non parla ai ragazzi di sesso. Abbiamo bisogno di corsi di educazione sessuale a scuola». Nella scorsa settimana Fausto prometteva che non si sarebbe tornati in aula finché il patto educativo tra studenti e docenti e tra scuola e genitori non fosse stato sanato, ma lunedì si è ufficialmente rientrati in classe. Cosa è cambiato rispetto al 3 febbraio? Il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, ha inviato degli ispettori per chiarire la situazione; la preside Maletta alla fine ha fatto un passo indietro e si è in attesa di un preside o una preside reggente per arrivare alla fine dell’anno scolastico; il professore accusato è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Cosenza. Si è in attesa che la verità giudiziaria sia ricostruita, ma cosa è cambiato per le studentesse che lunedì’ sono rientrate in aula? Cosa è cambiato in termini di consapevolezza per le ragazze e cosa in termini di sicurezza? E cosa è cambiato per i ragazzi che in quell’ambiente tossico hanno rischiato di normalizzare l’atteggiamento abusivo di un uomo in una posizione di potere? Una parte degli studenti ha giustificato il professore, altri deridevano le ragazze impegnate a
parlare di femminismo e lotta al patriarcato durante la manifestazione, buona parte degli studenti del biennio non ha preso parte all’occupazione. La sostituzione di una preside delegittimata e sulla quale gravano delle accuse e delle responsabilità grandissime è stata indispensabile, ma basta cambiare la persona al vertice di una scuola per purificare un ambiente tossico? Leggi qui la prima parte La guerra è anche guerra alle donne written by Francesca Pignataro Gli stereotipi sono parte di noi, sono uno strumento cognitivo che ci aiuta a semplificare la complessità del reale per provare a capire qualcosa di distante da noi e che non sperimentiamo direttamente. Per chi vive in Europa anche la guerra si è trasformata in uno stereotipo: la si studia a scuola, magari anche in università; si sente parlare delle sue atrocità durante gli anniversari o le giornate della memoria; si sentono le notizie di guerre combattute in qualche paese di cui forse si ignora la precisa collocazione geografica. Siamo cresciuti percependo alla guerra come a qualcosa di temporalmente o fisicamente lontano e abbiamo imparato a conoscerla attraverso i libri di storia o i giornali e i telegiornali.
Ma chi racconta la storia
dimentica spesso una parte
della popolazione, le donne.
Come ricorda Simone de
Beauvoir ne “Il secondo
sesso”, le donne sono state
una presenza-assenza: sono
una presenza reale assente
nella storia scritta dagli
uomini tenendo conto solo del
genere maschile. Il racconto
della storia è influenzato da
un bias di genere, che investe anche il modo in cui si immagina la guerra. Nello
stereotipo condiviso, la guerra è combattuta dagli uomini e sono loro a morire al
fronte mentre il resto della popolazione civile è al sicuro.
Ma ora che sentiamo la guerra vicina, ora che torniamo ad aver paura per noi
stessi, ricordiamo quanto la guerra possa essere sporca e quanto la devastazione
che porta con sé non risparmi i civili.
Il lavoro di Amnesty International testimonia come nelle zone di conflitto e di
guerra aumentino le violazioni del diritto umanitario internazionale e ad esser
maggiormente colpite sono le fasce più vulnerabili della popolazione: donne,
minori, persone disabili e persone azione. In particolare, le donne durante i
conflitti sono state sistematicamente sottoposte a violenze e abusi sessuali e lo
stupro di massa è stato utilizzato come arma di guerra e strumento di terrore
verso la popolazione.
La giornalista Susan Brownmiller, nel saggio “Against Our Will: Men, Women and
Rape”, illustra come lo stupro sia usato come strumento di offesa sistematico sia a
livello che individuale che collettivo. Nel caso dei singoli stupri, gli uomini
ricorrono alla violenza sessuale per punire le donne che trasgrediscono l’ordine
maschile e quindi è un mezzo attraverso il quale far vivere le donne in uno stato
di paura perenne e sottometterle. Con gli stupri di massa, durante le guerre, la
violenza sessuale contro le donne diventa un’arma per intimidire l’intera
popolazione e diminuirne la capacità di reazione. Lo stupro, in questi casi, celebra
la conquista di un territorio da parte di una forza militare: l’abuso della donna,
l’invasione del suo corpo, diventano simboli della conquista militare di unterritorio e della sottomissione della popolazione civile. Gli effetti di uno stupro sono sempre devastanti per la vittima che lo subisce, passando dai danni fisici ai traumi psicologici. Lo stupro come strumento di guerra, tuttavia, presenta delle peculiarità: in seguito ad uno stupro, la vittima può contrarre delle malattie sessualmente trasmissibili o restare incinta, ma in zone di conflitto è quasi impossibile riuscire ad accedere a delle cure mediche adeguate o ricorrere ad un aborto sicuro, inoltre le vittime di stupro di guerra rischiano di essere stigmatizzate e allontanate dalla famiglia. Restare incinte a causa di un saldato nemico significa, nell’ottica di guerra, partorire un nemico. Gli stupri di guerra, inoltre, sono spesso stupri di gruppo e la vittima spesso viene abusata anche mediante oggetti come, per esempio, le canne dei fucili. Gli esempi sono molteplici, basta guardare alla storia recente: lo stupro delle donne di Bengali negli anni ’70 da parte dei soldati pakistani; lo stupro delle donne vietnamite da parte dei militari americani durante la guerra in Vietnam; negli anni ’90 in in El Salvador, Guatemala, Liberia, Kuwait, ma anche in Afganistan, in Somalia, in Palestina, come in Libano, Haiti, Sudan, Zambia nonché a Timor fino ad arrivare alle atrocità commesse nel corso dei conflitti che hanno interessato l’area balcanica il Ruanda. Particolarmente importante fu la Risoluzione 780 del Consiglio di Sicurezza ONU, per indagare le violazioni dei diritti umani durante le guerre jugoslave e, in special modo, durante la guerra in Bosnia-Erzegovina. Dal lavoro della commissione emerse che erano avvenute gravi violazioni e si pose all’attenzione come i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio siano strutturalmente collegati alle violenze contro le donne. La Commissione condusse un’indagine senza precedenti sugli stupri e le violenze sessuali subite dalla popolazione civile e raccolse i dati intervistando 223 donne bosniache rifugiate in Croazia, Slovenia e Austria. Da questo lavoro emersero diverse tipologie di violenza sessuale compiute durante i conflitti: le violenze sessuali compiute prima dello scoppio del conflitto, durante lo scontro, nei campi prigionia, presso i rape- camps – ossia campi costruiti durante la guerra in Bosnia in cui si portavano soggetti per essere ripetutamente stuprati – e, infine, violenze dopo la fine del conflitto per l’intrattenimento dei soldati. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, dopo l’invasione del paese da parte della Russia di Putin, a preoccuparci sono le donne ucraine. Già sul finire del 2020 Amnesty International denunciava un aumento dei casi di violenza sulle donne
nelle zone di Donetsk e Luhansk. L’ONG iniziò a rilevare tale incremento fin dal periodo 2017-2018, anni in cui il territorio caratterizzato dalla presenza di separatisti russi fu travolto da una grave crisi economica. Le tensioni tra filoucraini e filorussi favorirono, inoltre, la possibilità di reperire armi e il conflitto fra le parti continuò a crescere. Questo, per le donne, si tradusse in un aumento dei casi di violenza sessuale e domestica da parte degli uomini ucraini di entrambi gli schieramenti. Gli abusi si consumavano sia tra le mura di casa, laddove crescono le tensioni economiche e sociali il rischio è che gli uomini le riversioni sulle donne della propria famiglia, che fuori ai danni delle civili da parte dei militari. Oggi la situazione sembra precipitare e a denunciare l’escalation di violenza è il governo ucraino, che invocando l’intervento e l’aiuto della NATO. Anche i gruppi di femministe russe, però, sono intervenute fermamente chiedendo al governo del proprio paese di fermarsi. Il messaggio delle femministe, accompagnato dagli hashtag #FeministAntiWarResistance e #FeministsAgainstWar, è chiaro: “guerra significa violenza, povertà, sfollamenti forzati, vite spezzate, insicurezza e mancanza di futuro. È inconciliabile con i valori e gli obiettivi essenziali del movimento femminista. La guerra esacerba la disuguaglianza di genere e ritarda di molti anni le conquiste per i diritti umani. La guerra porta con sé non solo la violenza delle bombe e dei proiettili, ma anche la violenza sessuale: come dimostra la storia, durante la guerra il rischio di essere violentata aumenta più volte per qualsiasi donna. Per questi e molti altri motivi, le femministe russe e coloro che condividono i valori femministi devono prendere una posizione forte contro questa guerra scatenata dalla leadership del nostro Paese”. Un #metoo calabrese? La voce
delle ragazze e il rischio di essere invisibili 1 written by Francesca Pignataro Parte I «A Cosenza avevo un fidanzatino che io trovavo veramente troppo carino e me ne innamorai subito. Lui mi chiese “Riprendiamoci” e io dissi di si. Perché no? Ma poi gli dissi “Cancella questo video” e lui disse che lo avrebbe fatto, ma non lo fece mai e nel giro di due anni sono finita sui telefoni di tutta Cosenza, di tutta la Calabria ed è diventato un caso internazionale finendo su un gruppo Telegram di revenge porn con 77mila iscritti. Sapete cosa mi disse la Maletta quando andai a denunciare la questione, quando le andrai a dire che sarebbero arrivati i poliziotti a scuola per poter interrogare le persone? Che me l’ero cercata, che era colpa mia, era tutta colpa mia, che mia nonna – che io non ho mai conosciuto – si sarebbe vergognata di me. Quando poi iniziai a fare attivismo, iniziai a raccontare quello che lei mi aveva detto e che mi aveva detto di fronte a mio padre e lei iniziò a dire che erano illazioni e che sparavo cazzate. Allora, in quel momento, nel gennaio del 2022 mi sono tornate in testa tutte le cose che lei ha sempre nascosto: tutte le volte che le ho raccontato del bullismo, tutte le volte che le ho raccontato degli abusi che vivevamo in classe, soprattutto noi ragazze, e di quanto lei minimizzava, di quanto lei diceva che non sapevamo prendere gli scherzi perché eravamo piccole, che il professore in questione non avrebbe mai fatto niente del genere. Cara Maletta, io mi ricordo tutto. Mi ricordo le mani su di me, me lo ricordo che mi chiamava panterona e polpettina. Mi ricordo tutte le battute sul mio culo e sulle mie tette, mi ricordo tutto perché gli abusi non si lavano via. È dai nostri ricordi che è nato la pagina Instagram Call.out Noi non finiamo fino a quando non ci sarà riconosciuto che ci sono delle realtà così tristemente radicate che è anche difficile riconoscerle. Io le violenze le ho riconosciute dopo quattro anni, perché pensavo fosse normale che un professore mi toccasse, che mi dicesse che voleva farsi due botte con me, eppure non è normale e siamo qui a gridarlo a gran voce». In queste righe risuona la voce di Dalia, un’ex studentessa dell’Istituto di istruzione superiore Valentini-Majorana di Castrolibero, alle porte di Cosenza. Dalia, attivista femminista e creatrice del podcast Fai la signorina, è stata la prima a denunciare pubblicamente le molestie di uno dei professori del suo liceo e, grazie alla sua testimonianza, si è innescato un effetto domino che ha reso la
scuola protagonista di una vera e propria vicenda mediatica. Questa storia, però, inizia nel 2018, quando il video intimo condiviso senza il consenso di Dalia iniziò a circolare anche all’interno del Valentini-Majorana. La reazione generale degli studenti, dei professori e della presidenza non fu quella di garantire supporto a Dalia, vittima a tutti gli effetti di una violenza, ma la ragazza fu colpevolizzata per l’accaduto e fu vittima di battute sessiste e accuse per via del suo comportamento sessuale. Dalia in quell’anno sporse denuncia, ma non esisteva ancora il Codice Rosso che nel 2019 introdusse nell’ordinamento italiano il reato di revenge porn, e l’iter legale fu lento proprio perché quando lei denunciò non esisteva un reato specifico cui far riferimento. Il tempo passa, Dalia cresce e prosegue il suo percorso da attivista femminista fino a quando, nel dicembre del 2021, decide di condividere la sua storia in uno degli episodi del suo podcast e da quel giorno la storia accelera. La storia di Dalia comincia ad esser raccontata da varie testate giornalistiche e da allora inizia a ricevere messaggi da altre studentesse del suo ex liceo, che le scrivono per condividere con lei le loro storie di molestie subite tra i banchi di scuola. Dall’insieme di tutte quelle storie nasce l’esigenza di creare la pagina Instagram @call.out.valentini.majorana, un posto sicuro in cui poter condividere le proprie esperienze di molestia all’interno della scuola. Chi dice che il virtuale non sia reale, come se il web rappresentasse una realtà parallela e alternativa rispetto al mondo offline, mente e questa storia ne è la prova: la pagina Instagram, che pubblica il suo primo post il 29 gennaio chiedendo di liberare la scuola dai pedofili, nasce per lasciar spazio alle testimonianze delle ragazze che offline non se la sentivano di esporsi, magari per vergogna o per paura del giudizio altrui; dalle testimonianze social fiorisce la consapevolezza collettiva di star vivendo un’ingiustizia e una violenza e da qui un movimento attraversa la scuola e gli sfoghi su una pagina Instagram si trasformano nell’occupazione di un istituto. Il 3 febbraio le studentesse e gli studenti hanno dato il via a un’occupazione con delle finalità precise: allontanare il professore accusato di molestie e fare in modo che la scuola potesse tornare ad essere un luogo sicuro.
È il primo caso in Italia di
un’occupazione studentesca
portata avanti in segno di
denuncia e protesta verso delle
molestie subite da alcune
studentessa per mano di un
docente. Lo scenario ideale
sarebbe stato uno e uno
soltanto: la preside della
scuola, Iolanda Maletta,
avrebbe potuto accogliere le
testimonianze delle sue studentesse e richiedere alle autorità competenti di far
chiarezza e, nel frattempo, allontanare il docente. La realtà, tuttavia, contraddice
spesso i nostri desideri e la faccenda è proseguita con sviluppi ben diversi:
Maletta ha sporto denuncia contro la pagina Instagram, e di riflesso contro la sua
creatrice Dalia, per diffamazione negando di fatto la possibilità che il professore
abbia perpetuato gli abusi di cui si parla. Da qui gli attacchi verso la dirigente
scolastica, accusata di essere a conoscenza del comportamento del professore e di
aver deliberatamente insabbiato la storia per tutelare il buon nome della scuola.
Le studentesse spiegano di aver parlato con la preside, di averle raccontato le
loro storie e di aver avuto sempre riscontri negativi, il professore in questione al
massimo era spostato da una sezione all’altra ma restava comunque a scuola. Nei
giorni dell’occupazione anche una seconda ragazza, Jennifer, trova il coraggio di
denunciare quella volta in cui il professore le chiese una foto del seno per arrivare
alla sufficienza e racconta di averne parlato con la preside, la quale avrebbe
garantito di denunciare e licenziare il docente in questione ma ciò non accadde
mai. Alle accuse di omertà rivolte a Maletta si aggiunge quella di Adele
Sammarro, professoressa della scuola e madre di uno studente. Nel mese di
ottobre il figlio di Sammarro, Samuele, fu selvaggiamente pestato davanti i
cancelli della scuola e la madre accusa la dirigenza di non aver chiamato le forze
dell’ordine per intervenire e fare chiarezza sull’atto di bullismo, ancora una volta.
Prima di andare oltre, è interessante soffermarsi su questa indifferenza verso il
dolore delle studentesse e degli studenti. Nelle scuole, Valentini-Majorana
compreso, esistono progetti in cui si parla di violenza, bullismo, discriminazione
di genere ed esistono giornate dedicate a temi degli abusi e delle violenze contro
le donne, ma come è possibile allora che sia così difficile intervenire quando queifenomeni si manifestano tra le mura della propria scuola? Ne abbiamo discusso con Roberta Attanasio, delegata del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino di Cosenza. «Se la preside avesse dato la giusta attenzione a quello che le veniva detto, non saremmo stati qui. Lei avrebbe dovuto fermare molto prima questa situazione, che non lo volesse fare lo abbiamo capito molto prima, da quel ragazzo malmenato violentemente davanti scuola. È inutile fare corsi contro il bullismo o contro la violenza di genere se poi non vuoi vedere. A che ti servono? A procacciare questa missione aziendalista della scuola che prende fondi e fa progetti, ma poi nella qualità della vita dell’istituto non cambia niente. Dopo qualche giorno, noi abbiamo ricevuto una richiesta di ascolto da parte di alcune docenti, venivano per nome e per conto della preside facendo parte dello staff della direzione, e per loro tramite la direzione ci stava chiedendo di interessarci per un corso di formazione. Anche loro erano consapevoli che noi non avremmo mai fatto un corso per i ragazzi, ma era necessario partire dalla classe docente e, devo dire la verità, anche loro erano abbastanza convinte perché dicevano che, nonostante la scuola sia una delle prime scuole a Cosenza ad aver fatto progetti contro il bullismo, contro la violenza di genere e sulle pari opportunità, è successo quello che è successo e loro non se ne erano accorti e ora sono innegabilmente dalla parte dei ragazzi. Noi siamo felici che avessero individuato nel centro una risorsa che in questo momento potesse dare una mano per la formazione, ma abbiamo detto che aspettavamo che questa situazione, in qualche modo, trovasse una conclusione perché come discuti con una preside che è completamente delegittimata? A parte una considerazione personale che posso fare, su come la scuola diventi sempre più manageriale nell’accaparramento di fondi e nella realizzazione di progetti. Questo conferma l’idea che abbiamo, ossia che la violenza di genere è quasi invisibile, nel senso che non è percepita dagli occhi. In questo caso, anzi, oltre a non essere stata percepita i ragazzi se la sono comunicata questa cosa però non ne hanno parlato con le insegnanti». Ma è possibile che tra i docenti nessuno abbia capito prima la situazione? «Stiamo parlando di una scuola grandissima dove, se non erro, ci sono tra i 120 e i 130 docenti e quindi non è facilissimo avere tutto sotto controllo. Quello che abbiamo capito è che, in qualche modo, ci fosse un inquinamento ambientale: se il professore faceva delle battute sessiste, questo atteggiamento veniva recepito dai
compagni maschi come un’autorizzazione o un lasciapassare a fare delle battute sessiste. Siamo in una situazione in cui c’era un inquinamento ambientale, quindi come potevi distinguere questa cosa? Sono solo battute, no? Anche la preside difende questo comportamento del professore e dice “sei proprio sicura? Ma lui scherza, lui ride, lui vuole fare lo spiritoso. Sei proprio sicura di aver capito bene?” mettendo in discussione il fatto che, se uno ti incita ad andare in bagno e farti una foto al seno per avere la sufficienza non è una molestia ma una battuta. Questa situazione è tossica perché, se già hai difficoltà a riconoscere una molestia, nel momento in cui legittimi certi comportamenti autorizzi anche i ragazzi a fare queste battute verso le loro compagne». Disabili ma non mascotte: note a margine di Sanremo 2022 written by Francesca Pignataro Prima di tutto una premessa: per anni non ho visto Sanremo, non mi interessava e preferivo utilizzare il mio tempo per fare altro, ma negli ultimi tre anni ho iniziato a seguirlo con una certa costanza. Mi incuriosiva capire i meccanismi di un programma nazional popolare e mi sono approcciata con curiosità, non per giudicare in modo troppo serio o agguerrito. Qualcosa mi fa storcere il naso e qualcosa di diverte, ma lo guardo come programma di intrattenimento e con una certa leggerezza. Non mi aspetto le esibizioni musicali del secolo e neppure grossa filosofia, ma se la Rai decide di voler affrontare temi sociali pretendo la faccia con criterio. E veniamo alla quarta sera: la co-conduttrice è stata l’attrice Maria Chiara Giannetta e a lei è toccato il monologo della serata. L’attrice ha interpretato il ruolo di Blanca, una carabiniera cieca. Capisco avrebbero parlato di persone disabili e quindi smetto di commentare in modo scemo il festival con le mie amiche e inizio ad ascoltare con serietà.
Maria Chiara Giannetta spiega che si è impegnata per entrare nel personaggio di
Blanca e spesso stava a casa senza luce per provare a capire le sensazioni che
vive una persona cieca e per restituire la stessa sensazione al pubblico, sia in sala
che a casa, ha chiesto a tutti di chiudere gli occhi e ascoltare perché avrebbero
sentito la sensazione che lei ha provato.
A quel punto la mia fronte inizia a
corrucciarsi perché temevo veramente la
piega che il monologo avrebbe potuto
prendere, mi sembrava tutto molto
retorico: se non ci vedi allora senti cose
che gli altri non riescono a sentire? Se non
ci vedi impari a ottimizzare al meglio gli
altri tuoi sensi, non diventi un guru
spirituale. Ma ero ancora pronta a dar
fiducia al monologo perché è pur vero che io sono una criticona e, magari, a volte
esagero. Da qui, però, il tracollo.
L’attrice spiega di essere stata affiancata da cinque persone per entrare a pieno
nel ruolo, lei li definisce i suoi guardiani. E chi sono questi guardiani? Sul palco
Giannetta, effettivamente, non è sola e con le ci sono tre donne e un uomo. A quel
punto penso: “ok, ora parleranno loro e spiegheranno qualcosa”. No.
Sono persone senza cognome, sono persone senza un’identità, diventano solo
lezioni di vita per Giannetta.
Abbiamo Michela, senza cognome, che le ha inviato dei video di come fa il caffè a
casa da sola o di come rifà il letto. Azioni quotidiane descritte quasi come
eccezionali e perché questo è disturbante? Perché sono le persone abile a
decidere qual è il modo “normale” di svolgere azioni quotidiane, ma quelle azioni
si possono fare in modo diversi e ogni persona sviluppa un modo personale di fare
al meglio quel qualcosa. E da qui arriva la lezione di vita: Michela, senza
cognome, ha insegnato all’attrice come vivere seguendo il proprio tempo e non
affannandosi e correndo. Sul problema delle lezioni di vita torniamo dopo, per ora
soffermiamoci sulla storia del seguire i propri tempi. Michela segue i suoi temi,
ottimo, tutti dovremmo farli e dove sta il MA? Nel discorso si crea uno strano
parallelismo in cui sembra che le persone disabili vivano una vita più semplice,
lontani dalla frenesia del presente, ma no. Magari Michela sì, ma in generale no.
Poter decidere di seguire solo i propri tempi, senza affannarsi, è un privilegio chenon tutti possono godersi per il modo nel nostro sistema sociale è costruito. Noi persone disabili non viviamo in un mondo bucolico, viviamo nella vostra stessa società con le stesse regole del gioco con la sostanziale differenza che le regole del gioco non sono state pensate per includere anche noi e spesso dobbiamo affannarci pure di più. Poi arrivano Marco e Sara, anche loro senza cognome, che si muovono in luoghi assurdi senza difficoltà e la loro lezione di vita a Giannetta è stata quella di farle capire che non c’è nulla di male nel chiedere aiuto. Cosa sono i luoghi assurdi? Dei teatri con corridoi stretti e senza linee di orientamento, guida e sicurezza in grado di rendere lo spazio accessibile anche per le persone non vedenti. Ma torniamo alle parole di Giannetta: è vero, non è una vergogna per nessuno chiedere aiuto, ma qui ho sentito un altro colpo al cuore perché mi è quasi sembrato si stessero normalizzando le barriere architettoniche. Doversi muovere in luoghi assurdi per le esigenze specifiche di una persona non è giusto. Le persone disabili spesso devono adattarsi a situazioni non ottimali, ma adattarsi non rende questa cosa meno ingiusta. Poi arriva Maria, senza cognome anche lei, atleta paraolimpica, di cui c’è dato sapere che è testarda e che a 19 anni è salita su un treno verso Roma senza bastone e senza cane guida. Poi arriva Veronica, che non era sul palco, e anche lei senza cognome anche se è una campionessa nazionale di scherma e di lei conosciamo il rapporto col suo cane guida e il modo in cui la aiuta nella sua quotidianità. Perché mi sto appesantendo? Perché il problema non è tanto Sanremo, ma il modo in cui in Italia si continua a parlare delle persone disabili. Nessuno delle persone presenti ha parlato, a farlo per loro è stata una donna abile. Queste persone cieche erano sul palco in quanto simboli, in quanto lezioni di vita per gli altri. Non si parlava di loro in quanto persone con una vita e una personalità, ma persone a cui manca qualcosa e che nonostante questa mancanza vivono. L’attenzione non era verso queste persone cieche, ma verso la loro cecità. Erano mascotte che servivano a ricordare alle persone vedenti quanto fortunate siano nella vita. Nota bene: il problema non è Maria Chiara Giannetta, il problema è la Rai e il
problema siamo tutti ogni volta che alimentiamo questa costruzione della realtà sia con le nostre parole che con le nostre azioni sia con le politiche che si sceglie di implementare. Non siamo mascotte. Abbiamo una voce. Abbiamo una vita. Non siamo la nostra disabilità, ma viviamo in un mondo che ci disabilita e ci lascia credere non sia normale vivere a pieno. Non solo numeri: per una rappresentanza sostanziale delle donne in politica written by Francesca Pignataro L’avvicinarsi di momenti istituzionali importanti, come le votazioni o la composizione di un nuovo Governo, porta con sé il ripetersi di un mantra: abbiamo bisogno di più donne in politica, dovremmo eleggere una donna. Con la scadenza del mandato di Sergio Mattarella e l’esigenza di eleggere una nuova figura come Presidente della Repubblica, siamo tornati a sentire questo ritornello. Effettivamente la politica italiana – e non solo – ed i partiti che la animano hanno uno storico problema con le donne e la rappresentanza femminile, ma l’affermazione generica del “c’è bisogno di più donne” è tanto insidiosa quanto controproducente. Se quando si parla di uomini da proporre per ricoprire un certo ruolo politico, si individuano dei personaggi maschili precisi e si spiegano le motivazioni per cui scegliere proprio lui; quando si parla di donne si fa riferimento a delle entità astratte e interscambiabili senza un’identità.
Riflettiamo sul fraintendimento della
richiesta di rappresentanza e sul problema di
una politica che continua a mettere al proprio
centro gli uomini. Le donne sono
sottorappresentate nella politica italiana? Sì,
secondo il Global Gender Gap Report 2021
del Word Economic Forum, la diseguaglianza
tra uomini e donne in Italia raggiunge il suo
picco proprio nella distribuzione del potere
politico e si stima ci vorranno 145 anni (!) per
colmare questo divario. Quindi c’è bisogno di
più donne in politica? Sì, le donne in politica
sono ancora una minoranza e la loro assenza è il riflesso di un problema
strutturale della nostra società, in cui più ci si avvicina a ruoli di potere e più le
donne sembrano scomparire: laddove il potere è distribuito in modo gerarchico,
l’apice della piramide è occupato dagli uomini mentre le donne restano
schiacciata sotto il cosiddetto soffitto di cristallo, un confine invisibile che divide
uomini e donne e ostacola quest’ultime a raggiungere posizioni di potere.
Il problema della sotto rappresentanza delle donne in politica non è solo
numerico, legato alla rappresentanza descrittiva, ma è una questione di
rappresentanza sostanziale, che sia capace di offrire una possibilità di cambiare il
modo in cui il potere è gestito e di proporre delle politiche in grado di rispondere
agli interessi e ai bisogni delle donne.
Sono molte le studiose e gli studiosi che si sono occupati del tema, qui faremo un
rapido riferimento al testo Genere e partecipazione politica di Sveva Magaraggia
e Giovanna Vingelli: «L’individuazione degli interessi delle donne è una questione
complessa. […] Se “interessi delle donne” è un termine ambiguo, è possibile
tuttavia descrivere le caratteristiche di una società non favorevole alle cittadine.
Alcune autrici delineano il seguente quadro: una società in cui c’è una netta
differenziazione fra privato e pubblico; una società in cui i più deboli ‒ i malati, i
bambini, gli anziani ‒ sono oggetto di cura, una cura che viene erogata nel
privato, non retribuita; una società in cui non è messo a tema il fatto che questa
divisione coincide con la differenza fra uomini e donne; una società nella quale la
violenza è considerata una questione privata, in cui persiste una situazione di
dipendenza delle donne nella sfera privata e un’inadeguatezza della loropartecipazione nella sfera pubblica, in cui l’oppressione delle donne è ancora mantenuta attraverso la limitazione della loro autonomia (e autodeterminazione). Il quadro che emerge somiglia molto a un circolo vizioso: se il sistema politico non fa i conti con la realtà delle donne, le donne non faranno i conti con la realtà di questa politica e il sistema non cambierà». Ripetere che “c’è bisogno di più donne”, insomma, non risolve il problema della sotto rappresentanza politica delle donne e non presuppone che si voglia operare in virtù di un cambiamento nella direzione della parità. Soprattutto se è un discorso portato avanti da esponenti politici uomini, rappresentati di partiti composti prevalentemente da uomini: il messaggio sottostante alla loro narrazione è che la conquista dello spazio pubblico e politico delle donne avviene grazie a uomini tanto progressisti da lasciar loro spazio. “C’è bisogno di più donne” usata come espressione generica, che non fa riferimento a una visione politica ben definita e a delle donne che portano avanti un preciso programma politico, diventa un artificio retorico col quale rendere invisibili le donne e le loro proposte, e lasciar la voce agli uomini. Un passo per abbattere la retorica maschile è ricordare le donne che hanno fatto la storia politica dell’Italia e tornando indietro agli albori della Repubblica affiora il nome di Rita Pisano. Il 15 agosto del 1926 nasceva a Pedace, un piccolo comune del cosentino che si inserisce in un territorio – la Presila – con una forte subcultura politica rossa. Pisano cresce in una famiglia di estrazione popolare e a diciotto anni, nel ’44, si unisce al Partito Comunista Italiano e da lì inizia la sua fervente attività politica. In quello stesso anno il PCI la manda a Milano per prendere parte alla scuola di partiti dedicata alle giovani dirigenti e da lì a poco sarebbe diventata la responsabile della Commissione femminile provinciale, ruolo conquistato grazie alle sue doti pragmatiche e al suo stile politico semplice e diretto. Grazie alle sue abilità è nominata anche segretaria provinciale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. La sua formazione comunista è ben chiara: Pisano porta avanti una lotta di classe per assicurare condizione di lavoro migliori, ma non è cieca di fronte all’esistenza delle diseguaglianze di
genere perpetuate anche nella classe operaia. Nel 1948 subì il suo primo arresto a Milano per aver organizzato uno sciopero non autorizzato per i diritti delle lavoratrici, che si occupavano della raccolta delle castagne nella zona del Savuto in Calabria: le raccoglitrici erano pagate in natura ricevendo un terzo del raccolto, grazie a Pisano si stabilì che avrebbero dovuto ricevere metà del prodotto del loro lavoro. A questo si aggiungeva l’impegno pacifista: nel 1949 fu nominata come componente della delegazione calabrese al Congresso Mondiale della Pace a Parigi, evento durante il quale illustrò la condizione delle contadine calabresi; mentre nel 1951 fu arrestata nuovamente perché distribuiva manifesti per la pace mentre a Cosenza arrivava un battaglione di soldati di leva. L’impegno politico dimostrato fino a quel momento la portò a d essere eletta consigliera comunale a Cosenza nel 1960 e sei anni dopo ad essere eletta sindaca del suo paese, Pedace. La sua gestione politica si incentrò su politiche di ammodernamento delle infrastrutture locali e culturali e i cittadini riconfermarono la sua buona gestione riconfermandola sindaca nelle successive elezioni del 1970, tuttavia, con l’avvicinarsi delle elezioni del ’75 qualcosa iniziò a cambiare. Il PCI iniziò a emarginarla dal partito senza un apparente motivo e finì con espellerla quando Pisano manifestò la volontà di candidarsi nuovamente alle elezioni comunali, alla fine fondò la lista “Sveglia” e vinse ancora una volta le elezioni battendo addirittura il suo vecchio partito. I suoi cittadini la riconfermarono sindaca sia nel ’75 che nel 1980, carica che ricopri fino al giorno della sua morte il trentuno gennaio 1984. Rita Pisano incarna la figura di una politica di estrazione contadina capace di individuare e rappresentare gli interessi di un preciso gruppo di donne, le lavoratrici. Nell’Italia divisa in mille comuni, queste piccole storie restituiscono il quadro di un paese costruito anche dalle donne che hanno conquistato il loro spazio portando avanti una precisa visione politica, anche in barba ai loro partiti di appartenenza. Alla retorica maschile si oppone la concreta azione femminile.
Da migranti a rivoluzionari: storie
di desaparecidos italiani
written by Francesca Pignataro
«Il colpo di Stato lascia una strana sensazione, un aroma che ritrovi addosso alle
cose. Tutto è pervaso da un senso di vuoto, come in una grande storia d’amore
finita per una cosa da niente». Il nostro viaggio attraverso storie di lotte e
resistenza inizia da un libro, Joca. Il “Che” dimenticato, scritto da giornalista
Alfredo Sprovieri ed edito da Mimesis con l’introduzione di Goffredo Fofi.
La nostra nuova avventura sembra iniziare in modo quasi banale: è il 1955 e la
famiglia Castiglia lascia San Lucido, cittadina della provincia cosentina in
Calabria, ed emigra verso il Brasile. Questa, però, non è solo una storia di
emigrazione simile a quella di mille altre famiglie pronte ad abbandonare il
proprio paese e a adottare una nuova cittadinanza pur di trovare un lavoro e delle
condizioni di vita migliori.
Sono passati quasi dieci anni da quando la
famiglia Castiglia è arrivata a Rio de
Janeiro. È la mattina del primo aprile 1964
e Libero Giancarlo, figlio di mamma Elena
e papà Luigi Castiglia, è già uscito per
andare a lavorare in fabbrica. In casa i
suoi genitori fremono, sono preoccupati
per la sua incolumità e Walter Mario, suo
fratello, si affretta a cercare tutti i libri e gli appunti ed i giornali di Libero
Giancarlo. Ogni copia di A Classe Operaia, il giornale che era stato fondato dal
partito comunista brasiliano e che si proponeva di essere “Giornale dei lavoratori,
fatto dai lavoratori, per i lavoratori” e che aveva lo scopo di diffondere il
marxismo anche in Brasile, era un pericolo. Come pericolosa era la copia del
Capitale e ogni traccia che potesse testimoniare un legame tra Libero Giancarlo
ed il Partito Comunista. Walter Mario doveva far sparire tutto.
Ma perché? Cosa stava succedendo?
Le Forze armate brasiliane avevano destituito il Presidente João Goulart: quella
mattina il Brasile si era svegliato sotto la morsa di un colpo di Stato. Iniziarono lepersecuzioni politiche, nessuna forma di opposizione e dissenso sarebbe stato più
tollerata. Quella mattina Walter Mario vide il corpo di un suo amico giacere in
una pozza di sangue, era il segretario del sindacato degli studenti. Nulla sarebbe
stato più come prima, era iniziata la dittatura militare dei Gorillaz.
Nulla sarebbe stato più come prima
neppure per Libero Giancarlo, che quella
mattina scelse la via delle armi per opporsi
alla dittatura. Dopo l’addestramento in
Cina, Libero Giancarlo e le compagne ed i
compagni del Partito Comunista
costituirono un piccolo esercito partigiano
pronto a sfidare la dittatura. Libero Giancarlo, soprannominato Joca, era tra i
leader della resistenza. L’esercito partigiano resiste, ma la lotta fu dura e la
sproporzione numerica rispetto all’esercito militare era importante. Lentamente
le compagne ed i compagni di Joca iniziano a cadere: donne e uomini iniziano a
scomparire, ad essere torturati e uccisi. Alla fine, la stessa sorte toccò a Joca. Il
suo corpo sparì e non bastò la fine della dittatura nel 1985 per garantire giustizia
a Libero Giancarlo e per restituire le sue spoglie alla famiglia.
Questa, però, non è solo la tragica storia
umana e politica che ha visto Libero
Giancarlo come uno dei protagonisti,
questa è anche la storia del giornalista
Alfredo Sporiveri. Era il 2009 e Alfredo
lavorava come cronista nella redazione di
Calabria Ora ed il giornale sta per andare
in stampa quando arriva una notizia
diversa e interessante: era stato ritrovato
il corpo di un ragazzo calabrese scomparso in Brasile trent’anni prima. Alfredo, ai
tempi, non conosceva la storia di Libero Giancarlo, ma si pose immediatamente
una domanda: «come è possibile che una storia così, diremmo, giornalisticamente
“appetibile” sia passata sotto traccia in questo modo, addormentata in un take di
agenzia di nemmeno cinque righe? Come posso riuscire a lavorarci e a ottenere
l’attenzione di un mondo che ormai non va al di là del titolo?».
Alfredo è un giornalista d’inchiesta, ha naso e si mette sulle tracce di una storia
ingiustamente dimenticata. Ma come raccontare una storia così lontana nel tempoe ancora più lontana nello spazio? Inizia da vicino ritornando alle origini: va a San Lucido, cerca la famiglia di Libero Giancarlo e inizia a parlare con loro, a ripercorrere la vicenda umana dietro questa storia. Ma il lavoro di Alfredo non si ferma, per ben dieci anni inizia a cercare, leggere e studiare documenti in portoghese per cercare di ricostruire oggettivamente una storia dolorosa e complessa. Da quello sforzo di ricostruzione giornalistica non nasce solo un libro, ma un intero progetto. La storia di Libero Giancarlo, infatti, non si inserisce solo nella storia della lotta al regime dei Gorillaz, ma nella più ampia tragedia dei desaparecidos dell’America Latina. Libero Giancarlo sparì come tante altre compagne e tanti altri compagni, perseguitati per motivi politici, per mano dei regimi militari non solo del Brasile, ma di altri Paesi come in Argentina o in Cile o in Uruguay. Quante sono le persone italiane scompare come Libero Giancarlo? Quali sono le loro storie? Per rispondere a queste domande e ripercorrere lo sterminio condotto dalle dittature militari sudamericane nasce l’Archivio Desaparecido, un serbatoio di storie frutto del lavoro del “Centro di Giornalismo permanente”, «un collettivo di giornalisti che collaborano per costruire un modello alternativo di creazione e sostentamento per lavori di inchiesta, analisi e reportage», tra i cui primi soci ritroviamo Alfredo. Mai più orfani di madre: un viaggio attraverso la discriminazione di genere nel mondo accademico written by Francesca Pignataro Con quale criterio si scelgono gli autori da inserire nei libri da studiare tra scuola e università? Ufficialmente si selezionano i pensatori fondamentali per la
formulazione teorica di quel preciso campo di studi. Il processo di selezione, se lo
si guarda da questa prospettiva, potrebbe sembrare neutrale: gli studiosi più acuti
e che per primi hanno studiato alcuni fenomeni hanno buone possibilità di
diventare classici, e gli studenti hanno buone possibilità di doverli studiare per
forza.
Questo processo, che potremmo definire di inclusione-esclusione, diventa
interessante analiticamente se non lo si osserva da un punto di vista individuale e
si presta attenzione ai gruppi sociali inclusi ed esclusi dalla categoria dei classici.
In questo caso l’esclusione non si fonda sulla validità o l’innovatività del pensiero
o della proposta scientifica, a farsi avanti è un principio discriminatorio.
Quanto frequentemente si sente parlare dei “padri fondatori” di una certa
disciplina o di un certo filone di pensiero? Ma è possibile che tutta la storia del
pensiero sia orfana di madre? Questo è un chiaro esempio di esclusione su base
discriminatoria. Si potrebbe contestare la mia affermazione dicendo che gli
uomini -in particolare gli uomini delle classi sociali più ricche- storicamente
abbiano avuto più liberamente accesso all’istruzione; dunque, siano stati più
istruiti e liberi di dedicarsi alla attività intellettuale. Le donne, al contrario, sono
state relegate in una dimensione domestica e privata vedendo negato il
riconoscimento delle proprie capacità cognitive. Il che è vero, ma questa
spiegazione è sufficiente o è viziata dal senso comune?
Cerchiamo di rispondere partendo da un esempio
concreto, il caso di Marianne Weber. Nei corsi di
sociologia è un evento più unico che raro sentir
parlare di lei, al massimo la si cita in quanto moglie
di Max Weber, tra “i padri fondatori” della
sociologia. Ma prima di essere moglie di qualcuno,
Marianne Weber è stata una sociologa, una politica
ed una femminista. Nacque in Vestfalia nel 1870 in
una famiglia della medio-alta borghesia tedesca: il
padre era un medico e la madre era figlia di un
importante uomo d’affari, Karl Weber. Dopo la
morte dei suoi genitori, Marianne si trasferì e iniziò
a studiare in un collegio ad Hannover, grazie al sostegno economico del nonno
Karl che pagava la sua retta. In seguito, si trasferì da una zia, Alwine Weber, e lì
incontrò Max.Dopo il loro matrimonio Marianne continuò a studiare, seguì soprattutto corsi di filosofia, sostenuta dallo stesso Max. Iniziò a militare in movimenti femministi liberal-borghesi, iniziò a pubblicare i suoi primi libri, nel 1919 entrò nel Partito Democratico Tedesco diventando la prima donna eletta nella Repubblica di Baden e fu anche presidente dell’Unione delle organizzazioni femministe tedesche. In seguito, anche dopo la morte del marito, continuò a dedicarsi alle sue attività di ricerca e scrittura e nel 1924 le fu concessa una laurea honoris causa in giurisprudenza. Marianne era una parte attiva della socialità accademica tedesca, eppure tutti ricordano il marito dimenticando lei. Questa non vuole essere una battaglia tra i sessi, tra chi è più meritevole e chi non lo è, ma è interessante constatare quanto fin da allora le studiose fossero delegittimate rispetto ai propri colleghi. Non erano percepite come sociologhe, per esempio, ma viste primariamente come mogli-figlie-compagne di qualcuno, come se vivessero all’ombra degli uomini della loro vita, e al massimo percepite come attiviste più che come accademiche. È facile intuire perché, da un punto di vista femminista, dimenticare l’esistenza di queste donne e le idee portate avanti da loro sia discriminatorio, ma questo non è l’unico aspetto problematico della vicenda. Riprendiamo il caso di Marianne Weber: dimenticare lei, i suoi libri e la sua produzione intellettuale significa ridurre gli strumenti analitici a propria disposizione per studiare la realtà ed i suoi processi sociali. Smettere di ignorare le studiose che si sono susseguite nei secoli non è solo un atto politico, permette anche di superare uno stato di ignoranza recuperando delle conoscenze andate perse. In questo caso il concetto di “ignoranza” non è usato per descrivere un semplice stato di non conoscenza, ma assume delle caratteristiche filosofiche peculiari: l’ignoranza sul sapere prodotto dalle donne è un prodotto culturale, in quanto deriva da un sistema sociale fondato su rapporti di genere diseguali in cui la voce delle donne è silenziata in virtù del dominio maschile sulla scena pubblica. Non è un’ignoranza inconsapevole, ma un’ignoranza colpevole. Le accademiche sono state vittime, per riprendere un concetto teorizzato dalla filosofa Miranda Fricker, di un’ingiustizia epistemica: le donne
anche nel mondo accademico sono state oggetto di un deficit di credibilità a causa
dei pregiudizi legati alla femminilità e agli stereotipi di genere: dipingerle come
meno razionali rispetto agli uomini, e per natura meno inclini al pensiero logico e
astratto, ha generato lo stereotipo per cui le loro idee sono da considerarsi meno
valide. Cosa aspetta il mondo accademico a riscattarsi da un’arretratezza
culturale che condiziona la formazione di studenti e studentesse?
Francesca Pignataro
La Mala fimmina di Instagram:
prospettive di un femminismo
siculo
written by Francesca Pignataro
Il nostro cammino attraverso storie di lotta prosegue cavalcando la quarta ondata
femminista e la nostra compagna d’avventura sarà Claudia, alias La Mala fimmina
su Instagram. Claudia è un’economista siciliana esperta in studi di genere, e La
Mala fimmina è il suo progetto online attraverso il quale, utilizzando lo spazio
virtuale di Instagram, fa divulgazione su tematiche femministe.
Sul profilo di La Mala fimmina si approfondiscono i temi delle disuguaglianze di
genere e si parla di sessualità e delle discriminazioni legate alla propria identità
di genere o al proprio orientamento sessuale, ma la prospettiva che Claudia
adotta è particolare perché alla prospettiva di genere affianca un’attenzione
particolare alla questione meridionale. Claudia non è solo una femminista, ma è
anche una donna siciliana e sono le sue origini, assieme alla sua storia personale,
a rendere unico il suo punto di vista sul movimento femminista italiano.Foto di Francesca Pignataro Il movimento femminista ha una storia lunga due secoli ed è stato caratterizzato da una pluralità di voci e prospettive. Potremmo parlare di un movimento ondivago e ogni ondata ha portato con sé delle questioni nuove e ha fatto spazio a soggettività fino ad allora silenziate nel dibattito pubblico. Questa graduale apertura a diverse soggettività ha consentito al movimento di diventare intersezionale riconoscendo l’esistenza di discriminazioni multiple, le quali attraversano la vita degli individui e si intersecano aumentano le discriminazioni vissute da chi appartiene contemporaneamente a più gruppi sociali marginalizzati e/o vittime di violenze. Ma oggi il movimento femminista italiano quali voci dimentica? Lasciamo che a raccontarlo sia la nostra mala fimmina Claudia. «Per me il movimento femminista è il movimento politico su cui ripongo la mia totale fiducia, per me è l’unico movimento che oggi può cambiare il mondo (gli altri movimenti non lo so), ma solo nel momento in cui il femminismo sa mettersi in discussione cercando di includere altre prospettive. Io mi sono unita ai movimenti femministi in Spagna, quando facevo l’Erasmus, e poi ho intrapreso la magistrale in studi di genere e delle donne a Bologna. Studiavamo in una prospettiva di Italia unitaria e quindi studiavamo le femministe italiane degli anni ’60, tutti i movimenti che c’erano stati anche prima, ma comunque li studiavamo come se l’Itala fosse un territorio unitario, come se si potesse parlare del femminismo italiano con una sola voce. Io non avevo ancora coscienza delle mie origini, non solo come persona ma anche come femminista. Succede che torno in Sicilia, dopo aver finito la magistrale, e mi rendo conto che la mia prospettiva è peculiare perché ho una storia ben precisa di appartenenza territoriale e di genealogia. Molte delle donne e delle persone all’interno dei movimenti che mi
Puoi anche leggere