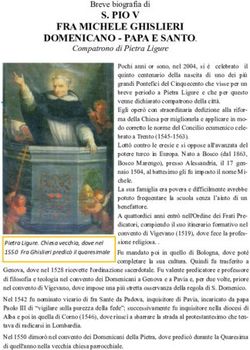Introduzione al romanzo del Novecento - Gino Tellini (dopo Verga e D'Annunzio: Svevo, Pirandello, Tozzi) - Formazione Loescher
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Introduzione
al romanzo
del Novecento
(dopo Verga e D’Annunzio:
→ Svevo, Pirandello, Tozzi)
Gino TelliniPunto di partenza: ● cos’è il verismo? (anni Settanta e Ottanta) ● crisi del cosiddetto verismo (fine anni Ottanta) ● il dopo-Verga, il dopo gli anni Ottanta: 1889 Mastro- don Gesualdo e Il piacere ● L’Italia cambia: da carducciana (anni Settanta e Ottanta) diviene dannunziana (fine anni Ottanta dell’800 – anni Trenta del 900): non c’è mai stata un’Italia verghiana, né sveviana, né pirandelliana…
Giovanni Verga
siciliano,
1840-1922
Giosue
Carducci,
toscano, Gabriele D’Annunzio,
1835-1907 abruzzese,
1863-1938QUALE ROMANZO?
Alla crisi postunitaria
● Verga risponde con
Giovanni
un’indagine disincantata Verga
della caduta dei valori siciliano,
ideali risorgimentali. 1840-1922
● D’Annunzio con
proposta di nuovi valori:
energico vitalismo
estetizzante e
superomistico. Gabriele
Due posizioni antitetiche D’Annunzio,
abruzzese, 1863-1938
(Verga isolato nella
cultura ufficiale)QUALE ROMANZO?
Italo
Svevo,
La strada più autentica triestino,
verso il 900 è aperta da 1861-1928
nuovi narratori come
Svevo, Pirandello, Tozzi:
essi indagano nelle ombre Luigi Pirandello,
siciliano, 1867-
della coscienza comune, 1936
senza avere in tasca ricette
risolutive;
ascoltano la voce della
propria solitudine
interiore.
Federigo Tozzi,
toscano, 1883-1920QUALE ROMANZO?
Il fatto è che questi autori
avvertono la necessità di
andare oltre la denuncia
storico-sociale (di Verga), per
andare in profondità, e di
rifiutare la poetica
estetizzante (di
D’Annunzio), perché la
sentono come risposta
suggestiva ma artefatta e
inautentica ai problemi della
nuova Italia, come forma
seducente di edonismo
evasivo, di incantato Una vita,
1892, con data 1893
abbellimento della realtà.QUALE ROMANZO? Questi autori (Svevo, Pirandello, Tozzi) si sono proposti una prospettiva disincantata (come Verga) e introspettiva (condotta all’interno dell’io). Si sono imposti una scrittura antiesornativa, L’esclusa di Pirandello, senza badare al consenso in «La Tribuna», del pubblico che difatti (per Roma, 29 giugno-16 agosto 1901 lo più) li ha ignorati.
PROTAGONISTI NELL’OMBRA Di Svevo, che pubblica Una vita nel 1892, ci si avvede a fatica intorno al 1925 (l’anno dell’Omaggio montaliano e degli Ossi di seppia), ma il ventenne Guido Piovene è liquidatorio nell’articolo Narratori apparso in «La Parola e il Libro» del settembre-ottobre 1927, salvo Eugenio Montale poi ricredersi con il pezzo (1896-1981) Italo Svevo in «La Fiera Letteraria» del 18 luglio 1946.
PROTAGONISTI NELL’OMBRA
Pirandello è ancora
valutato nel 1914, nel
bilancio tracciato da Le
lettere di Renato Serra,
non altro che un
bozzettista curioso.
Renato Serra, 1884-
1915PROTAGONISTI NELL’OMBRA
Tozzi muore trentasettenne
nel 1920 nell’indifferenza
generale, quando
l’imminente marcia su
Roma annuncia i fasti del
Duce e delle sue parate.
Non splende, né nell’Italia di
fine secolo né in quella tra le
due guerre, una stagione
propizia alle diagnosi
lucide, critiche,
Con gli occhi chiusi,
disincantate.. Milano, Treves, 1919AREE MARGINALI Con questi scrittori continua, come già in ambito postunitario, e anzi si accentua, il primato delle aree marginali. Sono inascoltati e periferici: Trieste, la Sicilia, la Toscana arcaica e antipuristica delle crete senesi. Luoghi decentrati di bilinguismo da cui meglio è consentito affrancarsi dagli istituti espressivi codificati, o più agevole tentare di aggirarne gli ostacoli.
CENTRI NAZIONALI I centri nazionali (la Roma dannunziana, poi la Milano futurista e la Firenze vociana) sono o cassa di risonanza dell’ufficialità estetizzante o tribuna di un’avanguardia costituzionalmente antinarrativa.
INTERESSE PER VERGA
Polemici verso D’Annunzio, i
romanzieri nuovi hanno
considerato con rispetto
quanto di meglio potevano
offrire i modelli del realismo
ottocentesco, specie Verga. Busto di Verga
nel Giardino Bellini
a CataniaINTERESSE PER VERGA Lo sconosciuto Svevo ventottenne è stato tra i primi a segnalare con ammirazione, il 17 dicembre 1889, dalle colonne del quotidiano triestino «L’Indipendente», l’uscita del Mastro-don Gesualdo. E ne ha apprezzato non il fascino esotico della patinatura arcaica (secondo i canoni dell’utilizzazione verghiana del primo D’Annunzio), ma la forza Mastro-don Gesualdo, dello straniamento critico. 1889, con data 1890
INTERESSE PER VERGA
Pirandello ha festeggiato nel
1920 l’ottantesimo
compleanno di Verga, con
pagine memorabili che sono
un attestato di solidarietà
per il «tormentato» maestro
dell’antiretorica, della
«naturalezza [...]
prodigiosa», dello stile
«necessario», modernamente
attualizzato al di là
dell’etichetta convenuta e Verga, ritratto a penna
fasulla di cronista del vero. dal catanese Antonino Gandolfo
(1841-1910)INTERESSE PER VERGA
Il vociano Renato
Serra nel 1914
riconosce all’autore dei
Malavoglia, in anni di
frammentismo
antinarrativo, la
rispettosa dignità del
classico da museo
(per effetto
carducciano). Le lettere (1914),
ristampa vociana, 1920cit. da Renato Serra «Qualcuno è lontano, in luogo glorioso da cui non lo vorremo disturbare: Verga», il quale «nessuno osa disprezzare, ma nessuno più cerca, perché la sua arte e la sua forza schietta non hanno niente di comune con la nostra accidia» (Le lettere, «La Voce», Firenze, 1914). (1908-1916)
INTERESSE PER VERGA La replica a Serra viene da Federigo Tozzi, con l’articolo Giovanni Verga e noi, nel «Messaggero della Domenica» del Federigo Tozzi, 1883-1920 17 novembre 1918:
cit. da Federigo Tozzi
«Non contentiamoci di
sapere che Giovanni
Verga esiste e che è
grande: procuriamoci le
occasioni di ritrovarlo in
mezzo a noi» (Giovanni
Verga e noi, nel
«Messaggero della
Domenica» del 17
novembre 1918).
Copertina della princeps
di Con gli occhi chiusi (1919)VERSO NUOVE CONOSCENZE
Il recupero della
lezione verghiana è in
funzione di una svolta
(che non significa
approfondimento).
Serve da antefatto
Luigi Pirandello,
necessario, da base 1867-1936
giusta di partenza per
sondaggi
introspettivi.VERSO NUOVE
CONOSCENZE
Il nuovo personaggio
del romanzo moderno
è spaesato e
malsicuro, incerto di
sé, delle sue relazioni
con gli altri e con il
mondo che gli sta Italo Svevo,
intorno: l’antieroe 1861-1928
della normalità
quotidiana.Rispetto al romanzo classico ottocentesco cambiano molte cose: ● lo spazio perde la determinatezza geografica e ambientale, per diventare luogo elettivo ed emblematico, riflesso esterno di privati moti affettivi. ● il tempo del racconto non segue la scansione del calendario, ma asseconda i ritmi soggettivi del personaggio, le accelerazioni e i rallentamenti della sua vita interiore. ● al rapporto di causa ed effetto, che lega la serie degli accadimenti Albert Einstein secondo una progressione 1879-1955 logicamente consequenziaria, subentra un meccanismo di associazioni alogiche, inattese e repentine.
VERSO NUOVE CONOSCENZE
L’obiettivo del nuovo
romanzo non tende alla
panoramica globale del
mondo, bensì si concentra
sul primo piano dell’io,
per metterne a nudo le
ansie, le inquietudini, i
sogni inconfessati, i Giorgio de Chirico, Piazza Italia, 1913,
Art Gallery of Ontario,
trasalimenti, i Toronto, Canada
soprassalti
dell’inconscio.VERSO NUOVE CONOSCENZE
Si vuole indagare
nell’«imo del proprio
essere» (Svevo, Pagine di
diario, 1899), si vuole
perlustrare nella «nudità
arida» della vita
(Pirandello, L’umorismo, Giorgio Morandi, Vasi e
bottiglia, 1948,
1908). Il terreno d’analisi Ca’ Pesaro, Galleria d’Arte
si restringe e ciò che si Moderna, Venezia
perde in estensione si
acquista in profondità.STRUTTURA APERTA
Dalla struttura chiusa
del racconto, che sigilla
con compiutezza la storia
rappresentata, si passa a
una struttura aperta che
può lasciare inconclusa
la vicenda, disponibile a
una pluralità di
soluzioni possibili
(esemplare Con gli occhi
chiusi di Tozzi, 1919) Giorgio Morandi, Autoritratto, 1925,
Galleria degli Uffizi, FirenzeRomanzo che pone
domande
Di un romanzo, si tratta, non
destinato a quietare il lettore,
a soddisfare le sue domande,
a prospettargli canoni certi di
giudizio, a confezionargli
trame avvincenti, a
suggerirgli modelli esemplari o
evasioni o miraggi, ma ad
accrescere, con lo strumento Vincent van Gogh, Ramo di
riflessivo del dubbio, la sua mandorlo in fiore, 1890,
Amsterdam, Van Gogh Museum
«comprensione della vita»
(Montale, Italo Svevo nel
centenario della nascita, 1963).Giudizio di Montale
su Svevo
«Leggete tutto Svevo [...],
non rimpiangerete il
tempo perduto; vi rimarrà
il sentimento di aver
compiuto un’esperienza
necessaria, di aver
accresciuto la vostra
comprensione della vita».NUOVA PERCEZIONE DELLA
REALTÀ
Questo nuovo io che si guarda
allo specchio, in Svevo,
Pirandello, Tozzi, è figlio della
nuova cultura europea di fine
secolo, che non solo ha messo in
forse il princìpio di oggettività
della conoscenza
naturalistica, ma ha modificato
la percezione stessa della
realtà, naturale e umana. Vincent van Gogh,
Autoritratto, 1888,
Amsterdam, Van Gogh
MuseumNuova cultura.
NUOVA CULTURA
Occorre distinguere tra
anti-positivismo e post-
positivismo.
Il romanzo di D’Annunzio
si basa sulla critica della
scienza come anti-
positivismo, come mistica
dell’ineffabile e
dell’irrazionale, come
militanza vitalistica e
Mussolini e D’Annunzio
primato dell’azione.NUOVA CULTURA
Invece il nuovo romanzo di
Svevo, Pirandello, Tozzi
muove dal rinnovamento dei
tradizionali parametri
razionalistici che si viene
attuando tra i due secoli con la
crisi che travolge la nozione
David Hilbert (1862-1943),
stessa di una razionalità matematico tedesco,
sistematica e totalizzante e professore
ottimistica. all’Università di GottingaNUOVA CULTURA
Il pensiero negativo, la
«morte di Dio», il
relativismo gnoseologico di
Nietzsche (che sono altra
cosa dal superomismo filtrato
da D’Annunzio), la rilettura
del pessimismo antidealistico
di Schopenhauer,
l’intuizionismo di Bergson… Henri Bergson
(1859-1941)NUOVA CULTURA
… l’indagine dell’inconscio aperta
dalle nuove frontiere della
psicologia e della psichiatria
(da Bénédict Augustin Morel a
Jean-Martin Charchot a Alfred
Binet, dal flusso di coscienza di
William James a Freud),
come gli analoghi progressi
raggiunti dalle scienze
matematiche, fisiche e storico-
sociali, elaborano l’idea di un
mondo che ha perduto il suo William James (1842-1910),
fratello maggiore di Henry
centro di riferimento. James
Una sorta di nuova rivoluzione (1843-1916)
copernicana.NUOVA CULTURA
Si dissolve l’unità della
persona, se ne mette in
dubbio la possibilità stessa
di padroneggiare le
proprie pulsioni.
Emerge dall’ombra un
magma di tensioni, di
progetti, di bisogni che
costituiscono l’essenza
Carlo Carrà, Antigrazioso, 1916,
profonda Milano, Museo del Novecento
dell’esperienza umana.NUOVA CULTURA
Dal regno delle
certezze verificabili,
si è passati nel
labirinto delle
ipotesi, della
provvisorietà, del Pablo Picasso (1881-1973),
Autoritratto,
dubbio. Collocazione ignotaNUOVA CULTURA
Si spalanca un orizzonte
inquietante, che i nuovi
romanzieri vogliono non
evocare con le suggestioni
del mistero, ma percorrere
razionalmente, con il
ricorso alla psicologia
scientifica, con l’ausilio di
una ragione più duttile di
quella positiva, non
deterministica ma Pablo Picasso,
analitica, nonché Ritratto di Dora Maar (1937),
Museo Picasso, Parigi
consapevole dei propri
limiti.CONSAPEVOLEZZA DEI LIMITI Bellissimo articolo di Montale, Stile e tradizione, in «Il Baretti», TO, II, 1, 15 gennaio 1925: «Lo stile, il famoso stile totale che non ci hanno dato i poeti dell’ultima illustre triade [Carducci, Pascoli, D’Annunzio], malati di furori giacobini, superomismo, messianismo ed altre bacature, ci potrà forse venire da disincantati savi e avveduti, coscienti dei limiti e amanti in umiltà dell’arte loro più che del rifar la gente. In tempi che sembrano contrassegnati dall’immediata utilizzazione della cultura, […] lo stile ci verrà dal buon costume». (E. Montale, Stile e tradizione (1925), in Auto da fé. Cronache in due tempi, Milano, Il Saggiatore, 1966, pp. 16-19).
NUOVA CULTURA
Di qui l’importanza
dell’apprendistato
naturalistico di Svevo,
Pirandello, Tozzi e il loro
rispetto verso la lezione di
Verga, di contro alla linea
Fogazzaro, Bourget, Il parigino Joris Karl
Huysmans, D’Annunzio. Huysmans
(1848-1907)NUOVA CULTURA
Il nuovo io romanzesco
è sgomentato dinanzi
all’indecifrabilità del
reale e di se stesso. Sente
labile e sfuggente la sua
presenza nel mondo.
Vede sgretolarsi il tessuto
delle sue relazioni private e
pubbliche.
Carlo Carrà, Il pino sul mare, 1921
Milano, Collezione privataSONDAGGIO CRITICO
L’autore non assume (non può
assumere) la prospettiva del
narratore onnisciente che
mette a posto le cose, bensì si
riserva il ruolo
dell’interrogazione
investigativa, del sondaggio
critico o ironico o sarcastico.
Segue da vicino il personaggio di
cui condivide i timori e le
angosce, ma di cui non
asseconda e anzi denuncia gli
alibi psicologici, gli autoinganni, Carlo Carrà, Manichino, 1917,
Roma, Collezione privata
le mistificazioni, le velleità.SONDAGGIO CRITICO
Il rapporto tra voce narrante e
protagonista è serrato,
dialogico, inquisitorio, fino a
disvelare il volto segreto e più
vulnerabile del personaggio:
per fargli cadere la
«maschera» (Pirandello),
per mettere a nudo l’intricata
matassa della sua vita
interiore, per osservarlo
Carlo Carrà,
camminare «col teschio Gentiluomo ubriaco, 1916,
scoperchiato» (Svevo). Milano, Museo del
NovecentoSONDAGGIO CRITICO
Ecco allora che il nuovo
romanzo si presenta come
autobiografia mediata e
trasposta: scavo pertinace
entro la stessa dimensione
sociale e umana dello
scrittore, autentico e
spietato viaggio
autoanalitico (vale per
Svevo e per Tozzi, ma
anche Il fu Mattia Pascal è
Amedeo Modigliani, Pierrot, 1915,
in prima persona). Milano, Museo del NovecentoSONDAGGIO CRITICO I personaggi più noti che il lettore incontra in questa perlustrazione del moderno sono gli inetti velleitari di Svevo, piccoli borghesi dalla coscienza sporca; sono le creature dissociate di Pirandello, spesso corrotte, irretite nella solitudine, protese alla vana ricerca di un’impossibile felicità; sono gli allucinati e visionari personaggi di Tozzi, pronti a sprigionare una feroce carica distruttiva e autodistruttiva.
Freud
LO SCOPRITORE
DELL’INCONSCIO?
Nella cerimonia per il suo 70°
compleanno (1926), salutato da
un oratore come «lo
scopritore dell’inconscio»,
Freud rifiuta questa qualifica:
«Poeti e filosofi hanno scoperto
l’inconscio prima di me. Quel
che io ho scoperto è il metodo
scientifico con cui poterlo
analizzare» (cit. in LIONEL
TRILLING, La letteratura e le
idee, 1940, trad it. Torino, Sigmund Freud
Einaudi, 1962, p. 5). (1856-1939)INTERESSE DI FREUD PER LA POESIA Lo psichiatra austriaco, che di poesia si è sempre nutrito («[i poeti] sono soliti sapere una quantità di cose tra cielo e terra che la nostra filosofia neppure sospetta», scrive in Delirio e sogni nella «Gradiva» di W. Jensen, 1907), ha fornito agli scrittori un formidabile strumento d’esplorazione e d’analisi: «Letterariamente Freud è certo più interessante [che clinicamente]. Magari avessi fatto io una cura con lui. Il mio romanzo [la Coscienza di Zeno] sarebbe risultato più intero» (Italo Svevo a Valerio Jahier, Trieste, 27 Sigmund Freud dicembre 1927, in Epistolario, Milano, (1856-1939) dall’Oglio, 1966, p. 859).
IN CRISI L’IDENTITÀ DELL’IO Prima della psicanalisi, il romanziere sapeva d’avventurarsi in un territorio inesplorato: hic sunt leones. Dopo la psicanalisi, sa di entrare in una riserva di caccia, ma sempre imprevedibile come un campo minato. L’allargamento dei confini conoscitivi, entro questa zona sconosciuta sottratta al mistero, non è una rivoluzione di poco conto: mette in crisi l’identità dell’io così come è stata codificata dalla razionalità Sigmund Freud classica e spezza le fondamentali (1856-1939) certezze che la riflessione filosofica ha elaborato dall’epoca di Cartesio.
IL TARLO DEL DUBBIO
Il tarlo del dubbio investe non più
soltanto le cose, ma la coscienza che le
percepisce.
L’io si scopre in balìa di forze che non
può dominare: deve prendere atto di
essere un gomitolo di impulsi oscuri, tra
loro in conflitto.
Siamo alla terza «mortificazione»
inflitta alla «megalomania dell’uomo»,
dopo la prima che è associata al nome di
Copernico («Copernico, Copernico […]
ha rovinato l’umanità,
irrimediabilmente», esclama il
pirandelliano Mattia Pascal,
Premessa [seconda] filosofica) e la
seconda introdotta da Darwin: Luigi Pirandello
(1867-1936)Terza mortificazione cit. di Freud: «la terza e più scottante, mortificazione, la megalomania dell’uomo è destinata a subirla da parte dell’odierna indagine psicologica, la quale tende a dimostrare all’Io che non solo egli non è padrone in casa propria, ma deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo a quello che avviene inconsciamente nella sua vita psichica» (SIGMUND FREUD, Lezione 18, in Introduzione Sigmund Freud alla psicoanalisi, Torino, (1856-1939) Boringhieri, 1969, p. 258).
ROMANZO DEL NOVECENTO I narratori nuovi pongono al centro delle loro opere proprio un «Io» che «non è padrone in casa propria»: da Pirandello a Svevo, da Tozzi a Palazzeschi da Landolfi a Savinio, da Moravia a Gadda.
ROMANZO DEL NOVECENTO
Siano o non siano lettori
appassionati di Freud, questi autori,
pur nella tenace ostilità della
nostra cultura idealistica e
cattolica verso la cosiddetta
«pseudoscienza» psicanalitica
(«repugnante alla chiarezza, alla
purezza, alla eleganza, al decoro
dell’anima e della mente latina»:
CARLO EMILIO GADDA, Psicanalisi e
letteratura, 1946, in I viaggi la
morte, Milano, Garzanti, 1958, p.
35), popolano le loro opere di
I viaggi la morte,
protagonisti che testimoniano per Milano, Garzanti,
segni evidenti il freudiano ritorno 1958
del rimosso e del represso.MOMENTO GIUSTO
La psicanalisi certo non
ha scoperto l’«immenso
reame dell’inconscio»
(Saba, Scorciatoia 150)
né i suoi conflitti, è
però nata nel momento
storicamente giusto per
prendere atto dei Alberto Savinio,
L’isola dei giocattoli, 1930
meccanismi della Collezione privata
rimozione e delle sue
cause;MOMENTO GIUSTO
è nata nel momento
storicamente giusto per
studiare sul lettino
dell’analista una tipologia
psicologica che tra i due
secoli s’incontra sempre più
frequente nelle pagine di
romanzo, con personaggi
privi d’identità e
d’integrazione: soggetti con
Giorgio De Chirico,
debolissime difese dinanzi Bagnante, 1930,
ai dissidi e alle sofferenze di Museo Casa Siviero, Firenze
un’interiorità sconvolta.CONFLITTO DENTRO L’IO Se nel romanzo ottocentesco l’io (specie in zona scapigliata e verista) è in conflitto con la solida realtà del conformismo borghese, agli esordi del Novecento il conflitto si trasferisce all’interno dell’io, con l’affioramento del rimosso alle soglie della coscienza, che diventa un terremotato campo di scontro o di battaglia. Felice Casorati, Maschere, 1921
ACQUAI E GABINETTI Alberto Savinio ha osservato che, nella «Casa, la Vita», Freud «si occupò dei servizi (cucina, lavanderia, acquai, dispense, gabinetti, caldaia e apparecchi di riscaldamento, aspirapolvere, ecc.), cioè a dire delle parti che l’ospite, soprattutto se di riguardo, non vede; e ignorò la parte di rappresentanza, salotti, sala da pranzo, ingresso padronale, ecc.» (ALBERTO SAVINIO, Contro il fanatismo, in Felice Casorati, «La Lettura», 24 agosto 1946). Mela spaccata, 1938
NARRATIVA DA GIORNO FERIALE
Sembrerebbe un
riconoscimento limitativo, in
linea con le tante polemiche
idealistiche contro il
materialismo «sudicio»
dell’indagine psicanalitica.
Ma non è così. In effetti, nel
nuovo secolo (come già talvolta
nell’800), quella più autentica Alberto Savinio,
non è la narrativa «di Il tempio maledetto,
rappresentanza», ma la 1931,
Collezione privata
narrativa da giorno feriale,
addetta «ai servizi», alle
cantine, al dietroscena
dell’esistenza.«LO STAGNARO DELLA VITA» Non per esaltare i cunicoli del sottosuolo, ma per conoscerli e (se possibile) saperli amministrare. «Ottimo operaio, Freud. Lo stagnaro della vita. Laborioso e paziente [...], lo scienziato atteso, lo scienziato necessario di un’epoca che ha scoperto che l’uomo non è creazione di Dio ma creazione di se stesso. [...] Freud è l’antropologo di un’epoca che ha rotto i ponti tra sé e il beau idéal» (ALBERTO SAVINIO, Contro il Alberto Savinio, L’oratore, 1932, fanatismo, in «La Lettura», 24 Collezione privata agosto 1946).
NON DESTINO, MA PULSIONI
Dai processi della vita
psichica il caso è abolito e la
terribile ineluttabilità del
destino classico ha assunto
le più terrene sembianze di
istinti e pulsioni, non resi
però meno angoscianti e
temibili dal fatto di essere
Casa «La vita», Milano,
razionalmente Bompiani, 1943,
inventariabili. poi Milano, Adelphi,
1988OTTIMISMO E SGOMENTO
L’ottimismo conoscitivo
di Freud, la sua
positivistica fiducia nel
potere del progresso
scientifico, il suo
impegno di medico
dedito a curare
efficacemente i propri
pazienti non attenuano
lo sgomento di fronte alla Alberto Savinio,
L'Annunciazione, 1932,
violenza cieca Milano, Civiche Raccolte d'Arte,
dell’irrazionale. Collezione Boschi Di StefanoFine
Puoi anche leggere