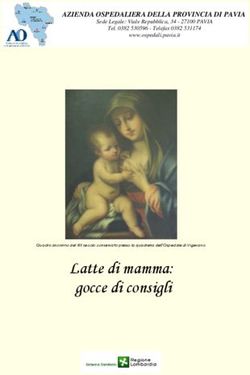Cambiamenti Climatici e Protocollo di Kyoto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Cambiamenti
Climatici e
Protocollo di Kyoto
Alcuni Dati sul Clima
La temperatura media del pianeta è in crescita
(0,3°-0,6°C dal 1860)
Il livello dei mari è aumentato (10-25 cm)
Il 20° secolo è il più caldo del millennio
Gli anni ‘90 rappresentano la decade più calda
dal 1850. Il 1998 e il 1997 sono stati
gli anni più caldi (e il 2007 sarà il più caldo in assoluto)
L’IPCC prevede, entro il 2100, un incremento
della temperatura tra 1° e 6°
“the balance of evidence suggests a discernible
human influence on the climate system” (fonte: IPCC 2001, “Third Assessment Report, WG I, Summary for Policy Makers”
1(fonte: IPCC 2001, “Third Assessment Report, WG I, Summary for Policy Makers”
I principali gas-serra
Gas-serra Formula Concentrazione Concentrazione Vita media Sorgenti Potenziale di
chimica pre-industriale nel 1994 atmosferica antropogeniche riscaldamento
(anni) globale
Anidride CO2 278000 ppbv 358000 ppbv Variabile Uso combustibili 1
carbonica fossili
Deforestazione
Produzione cemento
CAUSE Metano CH4 700 ppbv 1721 ppbv 12,2 ± 3 Uso combustibili 21
fossili
Risaie
Discariche
Bestiame
Protossido di N2O 275 ppbv 311 ppbv 120 Fertilizzanti 310
azoto Processi industriali
Combustione
CFC - 12 CCl2F2 0 0,503 ppbv 102 Liquidi refrigeranti 6200 - 7100
Schiume isolanti
HCFC - 22 CHClF2 0 0,105 ppbv 12,1 Liquidi refrigeranti 1300 - 1400
Perfluorometano CF4 0 0,070 ppbv 50000 Produzione di 6500
alluminio
Esafluoruro di SF6 0 0,032 ppbv 3200 Fluido dielettrico 23900
zolfo
2(fonte: IPCC 2001, “Third Assessment Report, WG I, Summary for Policy Makers” (fonte: IEA 2002, “Key World Energy Statistics from the IEA”
IL FUTURO
(fonte: IPCC 2001, “Third Assessment Report, WG I, Summary for Policy Makers”
3(fonte: IPCC 2001, “Third Assessment Report, WG I, Summary for Policy Makers”
(fonte: IPCC 2001, “Third Assessment Report, WG I, Summary for Policy Makers”
IL PROTOCOLLO
DI KYOTO
(fonte: IPCC 2001, “Third Assessment Report, WG I, Summary for Policy Makers”
4Protocollo di Kyoto (dic. 1997 COP3 UNFCCC) Paesi soggetti a vincolo di emissione:
•per la prima volta, un obiettivo di riduzione 39 Paesi indicati nell’Annex A, ovvero i paesi OCSE e quelli con economie in
transizione
delle emissioni dei principali gas serra (GHGs)
• per la prima volta, un accordo vincolante sul piano legale
Tempi dell’accordo:
Gas oggetto dell’accordo (basket): Intervallo 2008-2012, utilizzando come anno base il 1990 per i primi tre gas o, per i
anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossido di azoto (N2O), restanti tre e a discrezione della Parte, il 1995
esafluoruro di zolfo (SF6), idrofluorocarburi (HFCs),
perfluorocarburi (PFCs).
Entrata in vigore:
Obiettivo dell’accordo: 90 giorni dopo la ratifica del Protocollo effettuata da almeno 55 Parti aderenti alla
riduzione delle emissioni del basket dei sei gas (misurate in CO2 Convenzione (UNFCCC), le cui emissioni rappresentino almeno il 55% del totale di
equivalenti) di un tasso differenziato per Paese, il cui valore medio complessivo CO2 al 1990 dei paesi appartenenti all’Annex I (16 FEBBRAIO 2005)
è pari al 5.2% rispetto alle emissioni dell’anno di riferimento (base year) 1990 (o 1995)
Alcuni significativi tassi di riduzione sono: Europa -8%, USA -7%, Italia -6,5%
Principi guida:
Canada, Ungheria, Polonia e Giappone -6%, Russia, Ucraina e
“precauzione”, “responsabilità comune ma differenziata”
Nuova Zelanda 0%, Norvegia +1%, Australia +8%, Islanda +10%.
Il Protocollo prevede 3 meccanismi di flessibilità:
Il Protocollo come compromesso
Emission Trading (ET):
i Paesi dell’Annex A che riducono le emissioni in misura maggiore Sconfitta la posizione USA (0%) e quella
rispetto al target loro imposto, possono “vendere” tale surplus ad giapponese (- 2.5%). L’Europa aveva come
altri Paesi soggetti a vincolo di emissione (Art. 3 e 17) obiettivo il - 15%
Joint Implementation (JI): I Paesi in Via di Sviluppo sono riusciti a far
i Paesi dell’Annex A possono collaborare per raggiungere i loro
rispettare gli accordi del Berlin Mandate e,
obiettivi. Le Parti possono trasferire o acquisire “emission reduction units” (ERUs)
realizzate attraverso specifici progetti realizzati in altri paesi dell’Annex A (Articolo 6) pertanto, non sono obbligati a rispettare
alcun vincolo
Clean Development Mechanism (CDM), dal 2000: “Vittoria” USA sui meccanismi di flessibilità
governi o privati dei Paesi industrializzati possono realizzare progetti di riduzione
delle emissioni in Paesi in via di sviluppo ottenendo “certified emission reductions”
(CERs) il cui ammontare contribuisce al rispetto del loro target (Articolo 12)
“Vittoria” UE sull’idea della “ bolla”
5Posizioni delle Parti L’Umbrella Group
(USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda,
L’Unione Europea ha sostenuto: Giappone, Norvegia, Islanda, Russia e Ucraina):
la necessità di definire scadenze per gli
“unfinished business” Ha sostenuto la necessità di un’attivazione rapida
la priorità delle azioni domestiche sui Meccanismi di Kyoto
dei meccanismi di flessibilità (ET, CDM e JI)
la necessità di garantire, per l’ET, prima degli scambi: Si è opposto a un “cap” all’ET
trasparenza del mercato, regole di rischio e responsabilità,
meccanismi di verifica, di compliance e di idoneità, Teme (in particolare gli USA), le ripercussioni
necessità di reporting. economiche del Protocollo (stima DOE: aumenti
l’importanza di una rapida firma del Protocollo del prezzo della benzina in USA da $1.39 a $1.91
la fattibilità tecnica ed economica del al gallone, aumenti del prezzo dell’elettricità
raggiungimento del target in USA tra il 20% e l’86%).
G77 e Cina (gruppo fondato nel 1967 che cerca Valutazione sintetica del Protocollo di Kyoto
di armonizzare le posizioni di 132 PVS):
In positivo:
Evidenzia l’urgenza dell’adattamento
Sottolinea la necessità di cautela e attenzione rappresenta un esempio virtuoso di dialogo tra i paesi,
sull’ET: definizione di regole chiare prima degli un meta-accordo di sostenibilità globale e partecipata
scambi ha spostato la battaglia sul climate change dal piano
delle idee a quello delle politiche
Teme che l’ET sostituisca le azioni nazionali
(“hot air” e bassi prezzi dei permessi) In negativo:
Sottolinea la necessità di precise regole metodologiche
le regole del gioco, sui FLEXMECHS e sulla compliance,
e tecniche per il CDM non sono state ancora definite del tutto
Teme che il CDM spiazzi altri progetti di sviluppo
AOSIS (Alliance of Small Island States: 42 piccole isole): L’esclusione dei PVS indebolisce il Protocollo. L’IEA
particolarmente esposte al problema dell’innalzamento stima che circa 3/4 dell’incremento delle emissioni di CO2
delle acque marine. Stimolano il dibattito, soprattutto sull’adattamento previsto tra il 1995 ed il 2010 verrà dalla Cina e dai PVS
6QUALE E’ LA
SITUAZIONE DEI PAESI
INDUSTRIALIZZATI?
7PREVISIONI DEL
WORLD ENERGY
OUTLOOK 2000
DELL’IEA
8Previsioni IEA (WEO 2000):
CO2 al 2010 e target (Mil tonn di CO2)
In aggregato (Annex B): + 15.8%
Andamento delle emissioni
di gas-serra nell’UE (1)
Paese Variazione 1990- Obiettivo di
2002 limitazione delle
EUROPA E ITALIA DOPO emissioni nel
periodo 2008-2012
KYOTO: SITUAZIONE E Austria + 8,8 % - 13 %
PROSPETTIVE Belgio + 2,9 % - 7,5 %
Danimarca - 0,4 % - 21 %
Finlandia + 6,8 % 0%
Francia - 1,9 % 0%
Germania - 18,6 % - 21 %
Grecia + 26,0 % + 25 %
Irlanda + 28,9 % + 13 %
9Andamento delle emissioni
LA DIRETTIVA EUROPEA EMISSIONS TRADING
di gas-serra nell’UE (2) “EU ET”
Paese Variazione 1990-2002 Obiettivo di
limitazione delle •Direttiva 2003/87/EC: ha per oggetto l’istituzione di un
emissioni nel periodo
2008-2012 sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto
Italia + 8,8 % - 6,5 %
serra nella Comunità ai fini di promuovere la riduzione di tali
emissioni secondo criteri di efficienza sistemica e di
Lussemburgo - 19,5 % -8%
efficienza economica (art.1)
Paesi Bassi + 1,1 % -6%
Portogallo + 40,5 % + 27 % •La direttiva si inquadra nell’impegno strategico dell’Europa
all’applicazione del Protocollo di Kyoto
Regno Unito - 14,5 % - 12,5 %
Spagna + 40,5 % + 15 %
Svezia - 3,5 % +4%
Totale UE - 2,5 % -8%
LA DIRETTIVA EUROPEA EMISSIONS TRADING “EU ET”
LA DIRETTIVA EUROPEA EMISSIONS TRADING
La direttiva si applica per i 6 gas indicati a Kyoto e relativamente ad alcuni “EU ET”
settori soltanto. Precisamente:
•Attività energetiche: impianti di combustione con una potenza calorifica
di combustione di oltre 20 MW, esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o Ciascun Paese membro (art.9) è tenuto ad elaborare un
urbani Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di
•Raffinerie di petrolio, cokerie emissione (PNA) nel quale devono essere determinate le
•Produzione o trasformazione di metalli ferrosi; impianti di produzione di quote di emissioni che il Paese intende assegnare al
ghisa e acciaio complesso dei comparti oggetto della Direttiva e le
•Industria dei prodotti minerali modalità di tale assegnazione a ciascun soggetto avente
•Impianti destinati alla produzione di cemento e di calce in forni rotativi diritto. Il libero commercio dei permessi potrà nel seguito
•Impianti per la fabbricazione del vetro e fibre consentire a ciascun soggetto industriale di realizzare
•Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura,
l’obiettivo assegnato. Il piano deve essere elaborato sulla
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane base di criteri obiettivi e trasparenti tenendo nella dovuta
•Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire dal considerazione le osservazioni del pubblico.
legno
10IL PIANO NAZIONALE ITALIANO PER L’ASSEGNAZIONE LE CRITICITÀ DEL VECCHIO PNA
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA
Le proposte del vecchio PNA preparate dal
•Pochi giorni prima della scadenza prevista (3 Ministero dell’Ambiente sono fondate su un
giugno 2005), Il Piano delle Assegnazioni Italiano quadro di rinuncia agli obiettivi di
è stato approvato dalla Commissione Europea, contenimento delle emissioni nel settore
dopo le due bocciature ricevute il 21 luglio 2004 e regolato dalla Direttiva, pianificando una
il 25 febbraio 2005 (la seconda pochi giorni dopo crescita del livello di Mt CO2 del settore
l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto) elettrico giustificata attraverso 2 argomenti:
• Questo Piano, relativo agli anni 2005-2007 e - l’Italia è un Paese virtuoso in fatto di usi energetici
messo a punto dal precedente governo, - La crescita della domanda interna e il deficit di
prevedeva un’assegnazione complessiva di circa produzione elettrica non consentono ulteriori
restrizioni della produzione elettrica nazionale
223,11 milioni di tonnellate a titolo gratuito.
IL NUOVO PNA
LE CRITICITÀ DEL VECCHIO PNA
Il Piano dà grande spazio alla crescita dell’offerta elettrica
e apre la strada all’uso di carbone e orimulsion,
combustibili sporchi e a bassa efficienza carbonica. Esso
prefigura un modello di produzione-consumo di energia
del tutto insostenibile
La Direttiva Europea viene recepita dall’ordinamento
italiano in aperto contrasto con le sue finalità (coerenti con
l’obiettivo di Kyoto)
Nella sostanza, si tratta di un tentativo di denuncia e
rottura esplicita della linea di impegno dell’Italia per la lotta
ai cambiamenti climatici su scala globale
11PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE
CRITICHE AMBIENTALISTE AL NUOVO PNA
Wwf, Greenpeace e Legambiente rilevano che il
piano predisposto da Pecoraro Scanio e Bersani
«presenta un tetto di 209 milioni di tonnellate (Mt), 15
in più rispetto a quello previsto dallo schema del
piano nazionale di allocazione (Pna) predisposta dal
solo ministero dell’ambiente nel luglio scorso». A
questo punto gli ambientalisti «auspicano un
intervento della Commissione europea per riportare il
tetto delle quote assegnate a livelli in linea con
l’obiettivo di Kyoto, ovvero a 186 Mt»
12Puoi anche leggere