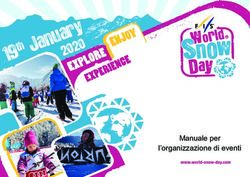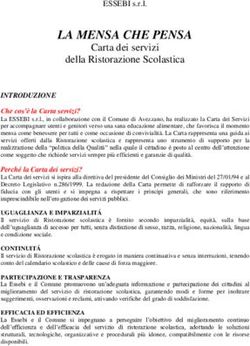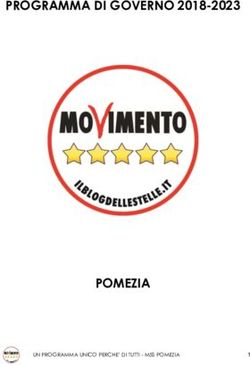Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
14 novembre 2011 – Seminario di approfondimento: Testamento biologico ed etica del fine vita
Presso Centro Servizi VSSP – Via Giolitti 21 Torino
Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici
Prof. Andrea Porcarelli
Docente di Pedagogia generale e sociale all’Università di Padova - Direttore scientifico del Portale di bioetica
(www.portaledibioetica.it) - Docente di Etica generale presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna – Presidente
del Centro di Iniziativa Culturale di Bologna - Membro della Commissione Ministeriale su Cittadinanza e Costituzione
Mai come in questi anni il dibattito sulle questioni attinenti il fine-vita è stato così
vivo ed intenso. Alcuni casi drammatici balzati agli onori della cronaca, come quello di
Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro hanno portato il tema all’attenzione di molti e ci si
interroga anche sull’opportunità di intervenire per via legislativa su un tema di tale
delicatezza. Le opinioni appaiono schematicamente contrapposte, ma se si va a guardare in
termini più sottili le ragioni che possono fondare eventuali differenze ci si accorge che il
panorama è molto più sfaccettato e complesso di come lo si vorrebbe dipingere. Riteniamo
di portare un contributo al dibattito mettendo in luce alcune di tali ragioni che, a nostro
avviso, ci portano a ritenere che l’ipotesi di attivare il meccanismo delle D.A.T. (Direttive
Anticipate di Trattamento) sia portatrice di gravi problemi da un punto di vista etico e
culturale, mentre lasciamo ad altri argomentare sul piano giuridico.
Il problema filosofico e culturale: qualità della vita e dignità della persona
Premettiamo subito quella che – a nostro avviso – è la posta in gioco sul piano
filosofico e culturale, ovvero il fatto che nella nostra cultura tenda ad affermarsi la
mentalità di quanti pensano che la vita meriti di essere vissuta solo “a determinate
condizioni”, ovvero che il suo valore sarebbe subordinato alla valutazione della sua qualità.
Questo problema non riguarda solo le problematiche di fine vita, ma anche – ad esempio –
la sempre maggiore diffusione di quello che viene impropriamente chiamato aborto
terapeutico1, in cui una diagnosi prenatale di malattia o malformazione del nascituro
diviene facile premessa alla sua soppressione “per il suo bene”, dietro l’alibi che una vita
menomata non meriterebbe di essere vissuta.
1
Si tratta di una evidente mistificazione linguistica (potremmo dire anti-linguistica), perché nessuno può
seriamente pensare che la soppressione del paziente (il bambino non ancora nato) si possa qualificare come una
“terapia”. Purtroppo i termini, una volta divenuti familiari, tendono ad essere accolti in modo acritico, anche da
coloro che non avrebbero ragione di utilizzarli perché – ad esempio – non condividono i presupposti di una
cultura di morte che vi sono implicati.
Prof. Andrea Porcarelli Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici 114 novembre 2011 – Seminario di approfondimento: Testamento biologico ed etica del fine vita
Presso Centro Servizi VSSP – Via Giolitti 21 Torino
Lo stesso sentire diffuso si affaccia in modo ancora più evidente sull’altro capo della
vita, quando le persone imboccano l’ultimo tratto di strada che li porterà a spegnersi, per
lo più in condizioni di salute gravemente problematiche, a cui si può aggiungere la
sofferenza per la solitudine, il fatto di sentirsi “di peso” per le persone che ci sono care, un
atteggiamento freddo e spersonalizzante di molte strutture sanitarie. Accompagnare le
persone in questo tratto di strada è indubbiamente difficile e, nella mente di chi vive in
modo particolarmente acuto tale difficoltà, può anche prendere forma l’idea che la morte
della persona cara potrebbe essere per lei (o piuttosto per noi?) una liberazione. Un conto,
però, è rendersi conto che prendono forma pensieri di questo tipo, un conto è sentenziare,
come spesso avviene, che la vita di una persona che vive un’esperienza di menomazione,
handicap grave (come nel caso di chi si trova in stato vegetativo) o sofferenza non è degna
di essere vissuta, non merita di essere vissuta o – peggio ancora – non è più la vita di una
persona. Tali affermazioni si spingono decisamente oltre i confini di una comprensibile
fatica che può sperimentare chi sta accompagnando una persona alle soglie dell’ultimo
viaggio: si tratta di affermazioni che, ancora una volta, sottendono una subordinazione del
valore della vita alla valutazione della sua qualità2.
Dichiarazioni anticipate di “velleità”?
Affrontiamo ora la questione fondamentale sul piano etico, visto che i fautori delle
D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento) tendono a proporre una capziosa analogia
tra il documento che ne emergerebbe e quello – già previsto e necessario – relativo al
consenso informato del paziente, in ordine a terapie alle quali debba essere sottoposto da
parte del personale sanitario. L’art. 32 della nostra Costituzione, infatti, al comma 2, recita
che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana”. Questo naturalmente riguarda la persona cosciente, capace di
2
Non è questa la sede per esplorare in modo analitico le “ragioni” che – nel dibattito bioetico – animano le
posizioni di quanti da un lato sostengono che la dignità della vita dipenda dalla “valutazione” della sua qualità, o,
dall’altro lato, affermano che la vita di una persona ha una dignità che le appartiene in forza di quello che è e,
per questo, è intangibile dal momento del concepimento, fino al suo termine naturale. Ciò che ci preme qui
sottolineare è che dietro a queste due posizioni vi è un ampio dibattito e si nascondono due “modelli culturali”
distinti e distanti, che si traducono anche in prospettive bioetiche profondamente diverse. Chi desidera
approfondire tali “ragioni” (anche per saper “rendere ragione” a sua volta delle proprie convinzioni) può
consultare i numerosi contributi che trova sul Portale di bioetica (www.portaledibioetica.it), a partire da un testo
di chi scrive: A. Porcarelli, Bioetica si dice in molti sensi, che potete trovare in “Temi trattati”\ “Orizzonti della
bioetica” (l’URL preciso è: http://www.portaledibioetica.it/documenti/000011/000011.htm ). Suggeriamo
anche la lettura, nella stessa sezione del Portale, dell’interessante articolo della prof.ssa Mariella
Lombardi Ricci, I fondamenti antropologici delle questioni bioetiche, (l’URL preciso è:
http://www.portaledibioetica.it/documenti/003423/003423.htm ).
Prof. Andrea Porcarelli Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici 214 novembre 2011 – Seminario di approfondimento: Testamento biologico ed etica del fine vita
Presso Centro Servizi VSSP – Via Giolitti 21 Torino
intendere e di volere, che non ponga in essere richieste contrarie alla sua stessa dignità: se
per esempio una persona chiedesse di essere uccisa (con qualsiasi modalità) quella
richiesta sarebbe “irricevibile” sul piano etico, ma anche su quello giuridico (visto che la
legge italiana vieta il suicidio assistito). Con le D.A.T. viene di fatto avanzata
un’interpretazione estensiva e indebita dell’art. 32 della Costituzione, proponendo una
costante analogia tra queste ed il Consenso informato, la cui acquisizione è necessaria.
Tale analogia è impropria e capziosa3, crea confusione concettuale equiparando fattispecie
di atti profondamente diversi e si traduce in una mistificazione per due motivi: la
responsabilità dell’informazione (e della verifica dell’avvenuta presa di coscienza) è interna
al dialogo fiduciario tra medico e paziente; il consenso è tale se è contestuale a tale
comunicazione che lo rende autenticamente “informato”. Tra l’altro l’informazione non
riguarda solo le terapie a cui il paziente dovrebbe essere sottoposto, ma concerne
soprattutto il rapporto tra le specifiche condizioni di salute in cui (secondo la diagnosi che
è possibile compiere) il paziente si trova effettivamente e gli effetti che – in quelle precise
e specifiche condizioni – potrebbero avere alcune terapie invece di altre.
Una precisazione merita il tema della cosiddetta alimentazione e idratazione
artificiale, che preferiremmo chiamare alimentazione e idratazione assistita. Nella
consapevolezza della delicatezza del dibattito attualmente in corso, si può ritenere una
indebita forzatura la posizione di quei soggetti (anche autorevoli) che le hanno definite
come “terapie”, mentre riteniamo ben più solidi gli argomenti (supportati anche dai
documenti del Comitato Nazionale di Bioetica4) per cui alimentazione e idratazione sono
un supporto vitale doveroso. Il fatto di inserirle tra i trattamenti “sanitari” apre la strada
alla possibilità di esprimere su di essi una sorta di “diniego preventivo” aprioristico e quindi
di vanificare eventuali limitazioni che una legge sulle DAT ponesse in tal senso.
Non si può quindi pensare ad una “disposizione” anticipata che possa in qualche
misura risultare vincolante per i medici, ma nemmeno autenticamente significativa in
ordine all’espressione effettiva della volontà della persona. L’atto volontario è veramente
libero solo se viene emesso con “piena capacità di intendere e volere” riferita non solo alle
condizioni soggettive di chi esprime le proprie intenzioni, ma anche alla situazione
3
Il tema, che qui ci limitiamo ad accennare, può essere approfondito grazie ad un interessante articolo di
Lucio Sesta, Il vero nodo del dibattito sul testamento biologico, che si trova nel Portale di bioetica, in
“Temi caldi” \ “Testamento di vita” (URL: http://www.portaledibioetica.it/documenti/005113/005113.htm );
sempre nella medesima sezione del Portale, si può trovare un ulteriore approfondimento grazie all’articolo
di Francesco Viola, La volontà del paziente, il consenso informato e le direttive anticipate,
(http://www.portaledibioetica.it/documenti/002019/002019.htm ).
4
Ci riferiamo, in particolare, ad un Parere del Comitato Nazionale di Bioetica, del 30 settembre 2005, su:
L’alimentazione e l’idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente, reperibile sul Portale di bioetica,
nell’ampia sezione dedicata ai documenti – e-teca (http://www.portaledibioetica.it/cgi-bin/eteca.cgi ) -, all’URL
specifico: http://www.portaledibioetica.it/documenti/003374/003374.zip .
Prof. Andrea Porcarelli Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici 314 novembre 2011 – Seminario di approfondimento: Testamento biologico ed etica del fine vita
Presso Centro Servizi VSSP – Via Giolitti 21 Torino
oggettiva in cui vengono espresse. In altre parole una persona può essere perfettamente
capace di intendere e di volere (come soggetto), ma non emettere un atto libero in una
determinata situazione perché viene privato della conoscenza di tutto ciò che sarebbe
necessario sapere perché la sua mente possa “intendere” le condizioni dell’atto qui ed ora.
Quando si parla di consenso informato si mira proprio a superare questo gap in merito alle
cure sanitarie fornendo “qui ed ora” alla persona le informazioni necessarie in ordine a
quel trattamento, con quella diagnosi, quella prognosi ecc. Le intenzioni “non contestuali”
non possono assolutamente venire equiparate ad un atto volontario espresso qui ed ora,
ma - semmai - a quelle che potremmo chiamare in termini antropologicamente più corretti
“Dichiarazioni Anticipate di Velleità”, ovvero - per utilizzare l’espressione presente nella
Dichiarazione di Oviedo - legittimi desideri di cui è necessario tenere conto, ma senza
applicarli in modo meccanico ad un contesto che è sempre diverso da come potrebbe
essere stato immaginato dal soggetto quando si trovava in tutt’altra situazione.
Il “pendio scivoloso” e la deriva eutanasica
Chi si occupa di bioetica da qualche tempo e conosce gli argomenti e le strategie di
quanti partecipano da anni al dibattito sulle questioni di fine vita, sa che in genere le varie
forme di Testamento biologico rappresentano una strategia di “avvicinamento” 5 alla
legalizzazione dell’eutanasia ad opera di gruppi e movimenti favorevoli alla cosiddetta
dolce morte6. Per la precisione è nel 1967 che Luis Kutner conia l’espressione “Living will”
per designare il rifiuto di alcune forme di terapie, da allora inizia una forte campagna di
diffusione di questi “testamenti biologici” (così viene abitualmente tradotta l’espressione
in lingua italiana) che in molti casi si configurano come vere e proprie richieste di
“eutanasia passiva”. Nel 1976 lo Stato della California approva il cosiddetto Natural Death
Act, che prevede la possibilità – per i soggetti maggiorenni – di esprimere le proprie
volontà circa l’impiego (o l’interruzione) di “terapie per il sostegno vitale”.
5
Per un’approfondita disamina della storia delle DAT / Testamento biologico rimandiamo al saggio di Filippo
Bergonzoni, Il dibattito etico-giuridico sul testamento biologico, reperibile sul Portale all’URL:
http://www.portaledibioetica.it/documenti/004602/004602.pdf .
6
Non è questa la sede per affrontare il tema – articolato e complesso – dell’eutanasia, ma ci preme segnalare il
forte collegamento culturale tra la questione che stiamo trattando (testamento biologico / DAT) e l’eutanasia;
rimandiamo per questo all’amplissima documentazione che si può trovare – sul Portale di Bioetica – nel “tema
caldo” dedicato a questo argomento (URL: http://www.portaledibioetica.it/documenti/000632/000632.htm ),
suggerendo in particolare la lettura del testo di Filippo Bergonzoni, Il dibattito bioetico sull’eutanasia:
distinzioni concettuali e posizioni a confronto (http://www.portaledibioetica.it/documenti/003723/003723.htm),
quello di Etienne Montero, Il dibattito sulla legalizzazione dell'eutanasia volontaria
(http://www.portaledibioetica.it/documenti/000671/000671.htm ) e quello di Denis Gallino, Eutanasia: qualità o
dignità? (http://www.portaledibioetica.it/documenti/002450/002450.htm ).
Prof. Andrea Porcarelli Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici 414 novembre 2011 – Seminario di approfondimento: Testamento biologico ed etica del fine vita
Presso Centro Servizi VSSP – Via Giolitti 21 Torino
Anche in Italia associazioni che promuovono l’eutanasia – come Exit – hanno da
molto tempo un loro modello di testamento biologico, in cui – in sostanza – ci si esprime
per la sospensione di qualsiasi tipo di terapia e di sostegno vitale, qualora ci si venisse a
trovare in determinate condizioni. Resta – come si è detto sopra – molto problematico,
anche per chi assume questa posizione, consentire ad un interlocutore esterno di
identificare con chiarezza a partire da quali condizioni effettive (perdita di coscienza, coma
vigile, stato di minima coscienza … ?) rendere operative le disposizioni eventualmente
lasciate a chi dovesse accogliere il paziente privo di coscienza. Una volta che fosse passata
l’idea che è legalmente possibile consentire alla persona di porre in essere delle azioni e
delle omissioni che abbiano come unico scopo effettivo quello di abbreviare
deliberatamente la durata della propria vita, diventerebbe – nel tempo – sempre più
difficile resistere alla tendenza di consentire (sempre a chi lo richiede) di ottenere lo stesso
risultato anche per via “attiva”. Passo dopo passo il cammino verso l’eutanasia attiva si
farebbe sempre più rapido. Per questo è importante vigilare.
L’uomo di fronte al mistero della morte
Riflettere sull’esperienza della morte in se stessa, prendendola sul serio e senza
“censure interiori”, ci aiuta a rischiarare in modo più profondo le dimensioni di splendore
dell’esistenza della persona umana. In primo luogo la definizione della morte, anche solo a
livello biologico, ci “costringe” a rendere più raffinata la nostra idea della vita. Si tende
infatti a definire la morte come perdita totale e irreversibile dell’unitarietà funzionale
dell’organismo ed è in rapporto a tale definizione che si individuano i criteri diagnostici per
l’accertamento di morte. A tal riguardo è bene essere consapevoli di un gap concettuale
fisiologico e - in parte - insuperabile: l’evento “metafisico” del morire è in sé invisibile agli
occhi e non può essere oggetto di una verifica empirica diretta; tutto ciò che possiamo fare
con i nostri strumenti conoscitivi è verificare indirettamente, a partire dagli effetti sensibili,
l’avvenuto decesso. Per far questo - in ogni modo - abbiamo bisogno di un concetto di
morte, di cui dovremo andare a cercare gli effetti visibili. La definizione che abbiamo
riportato è quella che ci consente di usare - come indicatori per l’accertamento di morte - i
fenomeni che ci attestano la morte di tutto l’encefalo (compreso il tronco encefalico):
quando tutte le funzioni dell’encefalo sono scomparse totalmente e irreversibilmente è
impossibile assicurare l’unitarietà funzionale dell’organismo, quindi si deve dire che
l’individuo è certamente deceduto. Il soggetto non perde la propria identità finché non
viene distrutto quel principium unitatis che possiamo considerare in sé piuttosto
misterioso, ma il cui effetto è quell’unitarietà funzionale di cui si è detto.
A differenza di quanto avviene per la sofferenza, non si può dire che noi abbiamo
modo di reiterare l’esperienza della morte e trarre vantaggio dal nostro vissuto, in ogni
caso è l’esperienza della morte delle altre persone, soprattutto di quelle che ci sono care,
ad offrirci gli elementi maggiormente rivelativi anche per riflettere sull’attesa della propria
morte. Questa si presenta come un “segno di contraddizione”, particolarmente fecondo
che ci costringe ad andare - con la nostra riflessione - ai fondamenti stessi della condizione
Prof. Andrea Porcarelli Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici 514 novembre 2011 – Seminario di approfondimento: Testamento biologico ed etica del fine vita
Presso Centro Servizi VSSP – Via Giolitti 21 Torino
umana. Vi è una legittima aspirazione all’immortalità che si radica nella natura spirituale
dell’uomo: l’intelligenza e la volontà dell’uomo sono - in qualche misura - “aperte
all’infinito”. L’apertura all’infinito dell’intelligenza e della volontà da un lato
rappresentano il fondamento del nostro desiderio di immortalità 7 e dall’altro offrono
argomenti significativi per argomentare in favore dell’immortalità dell’anima.
Paradigmatiche sono le riflessioni di Platone e di quanti - sulla sua scia - hanno
argomentato l’immortalità dell’anima umana a partire dall’immaterialità delle sue
operazioni spirituali: se l’anima umana è in grado di compiere azioni che vanno oltre i limiti
della materialità degli organi di cui si servono, allora essa è anche in grado di esistere8 oltre
i limiti della vita del corpo fisico.
La morte, in ogni caso, può essere intesa anche - e soprattutto - come “momento
supremo” in cui si trae il bilancio di un’esistenza e si giunge al compimento di quello che
può essere il suo significato. Tale modo di intendere la morte può essere vissuto sia in una
prospettiva religiosa che in termini laici9, a seconda di quello che per ciascuno di noi è il
criterio in base al quale si possono trarre i propri bilanci: in rapporto ai valori umani per i
quali si ritiene che la vita abbia un senso e un valore e/o in rapporto al modo in cui si
confronta la propria esistenza con le esigenze dell’amore di Dio. In entrambi i casi
possiamo ripercorrere il triplice consiglio che Ignazio di Loyola dava a colui che dovesse
assumere una decisione importante, cioè quello di porsi tre domande: che cosa
consiglieresti al tuo migliore amico? che cosa vorresti aver fatto se ti trovassi in punto di
morte? che cosa vorresti aver fatto se ti trovassi al cospetto del Tribunale di Dio? Ci
sembra un interessane “esperimento mentale” che ci aiuta a vedere il rapporto tra
l’evento della morte ed il significato della vita, in una pluralità di prospettive.
Per una “cultura del volontariato” profonda e consapevole
Vogliamo concludere la nostra riflessione dedicando un pensiero specifico a coloro
che svolgono attività di volontariato a contatto diretto con persone anziane, malate, o
anche che si occupano di promuovere – sul piano culturale – un’autentica cultura della
vita.
7
Solo la persona intelligente, libera, consapevolmente proiettata verso un futuro da progettare e costruire,
sente nativamente orrore della morte, intesa come “fine” di tali attività (almeno in questa vita).
8
Tale argomentazione - che esponiamo sostanzialmente nella forma in cui è stata ripresa da Tommaso D’Aquino
- si basa sul principio per cui il modo di agire di un determinato ente consegue al suo modo di essere (agere
sequitur esse), ovvero - in altri termini - non è possibile che un ente compia azioni di un certo tipo, di un certo
livello e di una certa dignità, se non ha anche un atto di essere (e quindi una natura) di pari livello e pari dignità.
9
Il bellissimo carme di Ugo Foscolo, I sepolcri, esprime con parole di rara levatura un visione nobile del
significato di una vita che continua nel ricordo che ciascuno lascia dopo di sé, nella mente e nel cuore dei propri
cari e in qualche modo anche nell’intera umana famiglia.
Prof. Andrea Porcarelli Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici 614 novembre 2011 – Seminario di approfondimento: Testamento biologico ed etica del fine vita
Presso Centro Servizi VSSP – Via Giolitti 21 Torino
Un famoso psicologo dell’educazione contemporaneo, Jerome Bruner, sostiene che
in tutti coloro che operano in ambito educativo è possibile rintracciare una Psicologia
implicita (o psicologia popolare) ed una Pedagogia implicita: senza una visione della
persona, dei suoi dinamismi affettivi e cognitivi e senza una visione dell’educazione è
impossibile educare. Tanto il citato Bruner, quanto – più modestamente – chi scrive10 sono
convinti che è importante, specialmente per chi opera come professionista nel campo
dell’educazione, che tale psicologia e tale pedagogia divengano “consapevoli”, in modo da
poterne controllare – con acume e spirito critico – i contorni e i confini ed evitare di
metabolizzare inconsapevolmente modelli pedagogici o antropologici che di fatto
contrastino con le proprie convinzioni profonde.
Ampliando il discorso dalla sfera educativa a quella del volontariato riteniamo che si
possa affermare qualcosa di simile: chi opera, come volontario, nel campo della vita, della
salute, dell’ambiente ha – di fatto – una sua Bioetica implicita, che racchiude le
consapevolezze profonde in forza delle quali ha maturato la scelta di dedicare tempo ed
energie ad una causa che ritiene nobile e meritevole di impegno. Ciascuno ha maturato tali
convinzioni attraverso un proprio percorso personale, le proprie esperienze di vita,
l’incontro con persone significative, alcune letture che ha giudicato “illuminanti”.
Il problema che vogliamo porre, proprio prendendo ad esempio il tema che
abbiamo affrontato (quello delle DAT / Testamento biologico), è che il dibattito
contemporaneo su questi temi è complesso e insidioso. Spesso sotto le parvenze di un
lessico apparentemente innocuo si nascondono insidie culturali e attentati ad una cultura
della vita che non è facile riconoscere. Potrebbe persino accadere che persone che hanno
una cultura di base saldamente attenta al valore della vita si trovino ad assorbire,
inconsapevolmente, concetti e parole che appartengono ad una prospettiva culturale
diametralmente opposta. Per questo riteniamo che vi sia un collegamento profondo tra
bioetica e volontariato11 e pensiamo che tale collegamento si possa leggere in due
direzioni.
La prima direzione è quella della formazione culturale dei volontari, in modo tale
che la loro “bioetica implicita” divenga, progressivamente, esplicita e consapevole. A
questo scopo è destinato il Portale di Bioetica nel suo complesso, inteso come una “riserva
10
Il testo di Bruner a cui ci riferiamo è: J. Bruner, La cultura dell’educazione, tr. It. Feltrinelli, Milano 1997; per le
nostre considerazioni in merito si può vedere: A. Porcarelli, Cammini del conoscere, Giunti, Firenze 2008 e A.
Porcarelli, Lineamenti di pedagogia sociale, Armando, Roma 2009.
11
Per chi volesse approfondire questo specifico aspetto suggeriamo di esplorare con attenzione l’area
denominata “bio-volontariato” nel Portale di bioetica e di leggere anche il nostro testo: A. Porcarelli,
Bioetica e volontariato, all’URL: http://www.portaledibioetica.it/documenti/003158/003158.htm . Sul rapporto
con le questioni educative si può vedere: A. Porcarelli, Identità della persona tra bioetica ed educazione,
all’URL: http://www.portaledibioetica.it/documenti/004500/004500.htm .
Prof. Andrea Porcarelli Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici 714 novembre 2011 – Seminario di approfondimento: Testamento biologico ed etica del fine vita
Presso Centro Servizi VSSP – Via Giolitti 21 Torino
strategica” di documentazione (completa e attendibile), con numerose piste di
approfondimento, schede informative, approfondimenti legati alle notizie di “attualità
bioetica”. Le Associazioni di volontariato lo possono considerare come un grandissimo
“scrigno” a cui liberamente attingere per i propri incontri formativi, ma anche per le
proprie attività in cui è importante – quando si vuole sostenere una tesi – farlo con
proprietà concettuale e nella consapevolezza delle “obiezioni” che si potranno incontrare,
rispetto alle quali è opportuno prepararsi coscienziosamente.
La seconda direzione è quella della valorizzazione delle attività realizzate dalle
Associazioni, che sono portatrici sane e – soprattutto – testimoni credibili delle idee che
professano. Si suol dire che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.
L’attività di chi, silenziosamente e umilmente, opera al servizio della vita e della salute,
specialmente delle persone in difficoltà, delle persone sole e dimenticate, di coloro che
non possono far sentire la propria voce, assomiglia al suono silenzioso della foresta che
cresce. Ma è importante che la cultura contemporanea si accorga di questo suono
silenzioso e che le stesse associazioni, oltre a comunicare al loro interno, si abituino a
pensarsi “in rete” tra di loro e con quanti condividono un tratto del loro cammino. A
questo scopo è stata creata la sezione “Biovolontariato”, che caratterizza il nostro Portale.
Prof. Andrea Porcarelli Testamento biologico ed etica del fine vita. Problemi etici 8Puoi anche leggere