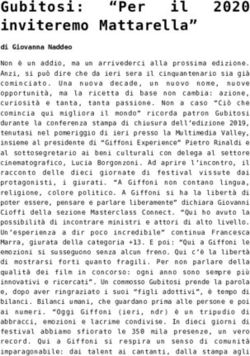Marco Paolini Laurea ad honorem Lectio Magistralis Università degli Studi di Padova Palazzo del Bo, 10 gennaio 2013
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Marco Paolini
Laurea ad honorem
Lectio Magistralis
Università degli Studi di Padova
Palazzo del Bo, 10 gennaio 2013
PADOVA UNIVERSITY PRESS©2013 Padova University Press Università degli Studi di Padova via VIII Febbraio, 2 - Padova www.padovauniversitypress.it Fotografie Massimo Pistore ISBN 978-88-97385-67-7 Tutti i diritti riservati.
Marco Paolini
Laurea ad honorem
Lectio Magistralis
Università degli Studi di Padova
Palazzo del Bo, 10 gennaio 2013
PADOVA UNIVERSITY PRESSIntroduzione Oggi siamo riuniti in questa nostra splendida Aula Ma- gna carica di storia, luogo solenne in cui sono mirabil- mente riassunti gli otto secoli di vita della nostra Universi- tà, per una delle cerimonie più significative e importanti della nostra vita accademica: la laurea ad honorem. È a tutti noto che l’Università di Padova, in coerenza all’equilibrio cui cerca sempre di attenersi nella sua azio- ne, è tradizionalmente molto parsimoniosa nell’attribu- zione di questo prestigioso riconoscimento a personalità illustri della vita scientifica, professionale o sociale.
10
È in questa luce che va visto il significato della gior-
nata di oggi e il conferimento della laurea in Scienze
dello spettacolo e della produzione multimediale a
Marco Paolini; potremmo dire un riconoscimento raro e
prezioso per un personaggio raro e prezioso. Le motiva-
zioni di carattere più propriamente accademico di tale
conferimento sono contenute nella delibera che verrà
letta tra poco dal professor Cortelazzo e di tali motiva-
zioni possiamo sottolineare in particolare la straordinaria
ecletticità di Marco Paolini e la sua non comune capa-
cità di praticare con eguale eccellenza di risultati diversi
luoghi espressivi dal teatro, alla televisione, al cinema,
per recuperare le radici e l’identità e per fondere nell’in-
venzione linguistica e scenica i contenuti di una storia
collettiva che si alimenta di piccole storie particolari.
Qui mi preme soprattutto ribadire come questo lega-
me strutturale e fondante di Paolini con la cultura del no-
stro territorio ripeta, per apertura universalistica e altezza
di risonanze, la lezione di tre grandi scrittori veneti: Mario
Rigoni Stern, Luigi Meneghello e Andrea Zanzotto, cui lo
stesso Paolini ha dedicato con Carlo Mazzacurati uno11 degli splendidi Ritratti, che furono presentati proprio in questa Aula Magna; e come con tali scrittori egli condi- vida un recupero ed una rivisitazione critica delle radici del territorio, che egli intende tenere lontane da tenta- zioni localistiche e da quelle che proprio Zanzotto bollò come “false difese”. Il nostro riconoscimento a Marco Paolini vuole espri- mere l’alto apprezzamento ad un percorso individuale complesso e originale nel quale le forme del mestiere si compenetrano tra loro: attore, regista, creatore di testi, anche produttore; ed è anche un omaggio a un’idea di teatro articolata, mobile, inventiva, un’idea che ama gli incroci, che mantiene una salutare dose di sfida in un periodo come il nostro nel quale le ombre lunghe del di- simpegno o del conformismo si fanno pericolosamente consistenti. Sono, quelli di Paolini, incroci di teatralità e altri lin- guaggi di realtà e di finzione, di storia e di presente, di italiano e di dialetto, di parole mate e di forme dell’in- vettiva civile, di album di ricordi e di ritratti di compor-
12
tamenti diffusi, di commedia e di dramma. E la sfida è
nelle proposte fatte, nella dimostrazione che memoria e
attualità si posso accompagnare all’invenzione scenica,
che a teatro si può portare qualsiasi testo, che ci sono
carte sicuramente vincenti nei confronti di un’offerta
televisiva votata alla piattezza e al piano inclinato del-
la banalità. In particolare l’Università di Padova si sente
partecipe e vicina all’intento di Paolini di impegnarsi in
una divulgazione alta e accessibile, rigorosa e ineccepi-
bile della cultura scientifica, ma insieme legata al piace-
re del racconto.
Questa nostra Aula Magna che anche oggi ci ospita
e che non cessa, nella sua solennità, di intimorire è de-
dicata a Galileo Galilei. A Galilei, che a Padova fece
scoperte destinate a mutare il corso della storia, della
scienza, della filosofia e della cultura moderne, Paolini
ha dedicato uno dei suoi spettacoli più recenti, tra i mi-
gliori e i più seguiti della sua produzione. Egli ha avuto
anche in quell’occasione la capacità non comune di
renderlo leggero, di rendere leggero, quasi realizzando
l’intento del grande Italo Calvino, il peso di un grande13
pensiero come quello di Galilei. Per questa tua capaci-
tà di muoverti nello spazio dell’originalità, intrecciando
concretezza della storia del reale e forza della finzione,
l’Università di Padova è molto lieta caro Marco, di poter-
ti annoverare da oggi tra i propri laureati onorari.
Giuseppe Zaccaria
Rettore dell’Università di Padova14 Il professor Michele Cortelazzo, già Preside della facoltà di Lettere e filosofia, dà lettura del testo di conferimento della laurea ad honorem in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale a Marco Paolini, basata sulle motivazioni espresse dall’allora facoltà di Lettere e filo- sofia, nel marzo del 2010.
Il Rettore consegna il diploma di laurea a Marco Paolini
Il quaderno degli appunti di Marco Paolini
Lezione magistrale
Marco Paolini
La nota sul registro della maestra del 1962 recitava
«L’alunno Paolini Marco risulta spesso disattento, quasi
assente». Non era vero, ero solo distratto da un altro tipo
di attenzione più forte: io stavo attento al treno.
«Attenti al treno» la frase l’ho imparata prima di saper
leggere, forse perché il macchinista era mio papà! E si
sarebbe arrabbiato se per distrazione fossi andato sotto
al treno. Coparse sotto al treno non era permesso. Anche
in classe alle elementari si stava attenti al treno: quando
le sbarre del passaggio a livello avvisavano nessuno più
si faceva distrarre dalla maestra, che a quel punto era20
l’unica in classe a non stare attenta al treno; noi invece
trepidavamo aspettando papa Giovanni XXIII.
Le locomotive a vapore erano nere, hanno fatto tre-
ni ordinari trainando l’Italia fin oltre il boom economico,
dall’800 fino a tutto il secolo breve, fino al ’79, quando le
ultime caldaie a carbone per vapore sono state spente
ad Alessandria, Avellino, Siena, Torino, Treviso.
Il treno, per me, è parente oltre che dell’uguaglianza
anche della democrazia (anche il teatro, a dire il vero,
e mi piace immaginare l’antica Grecia con i suoi teatri
e la ferrovia che gli passa vicino; ecco la democrazia
me la immagino così!). Da noi la democrazia era cristia-
na, per questo al Vaticano era concesso un occhio di
riguardo. A papa Giovanni avevano regalato una lo-
comotiva a vapore tutta bianca e lui ci andava in giro
e benediva: tutta la classe, tranne la maestra, sapeva
e aspettava quella benedizione, le orecchie fuori dal-
la testa a cogliere un fischio, un soffio, poi una pompa,
uno scappamento e alla fine ferro su ferro, con le ruote.
Allora in quel momento, pianissimo, bisognava levitare
alzandosi sul banco, ma restando seduti, cioè mante-
nendo la piega delle gambe perché la maestra non si21 accorgesse. La classe non era acqua, era un durissimo esercizio! Il davanzale della finestra a scuola scendeva e si vedeva sfilare il sopra della locomotiva che però era sempre nera. Peccato! La prossima volta… Pare che a papa Giovanni la locomotiva bianca piacesse guidarla di persona e intanto ovunque anda- va benediva i bambini lungo la ferrovia. È qualcosa che ho imparato a scuola cercando di non distrarmi. Ero di- stratto – diceva la maestra –, distratto, distratto. Lei era impegnata a piegare i nostri giovani corpi ribelli alla di- sciplina del banco, poareta, e noi scampavamo dalla finestra con la fantasia inseguendo una balena bianca. Ecco, per evitare equivoci nostalgici ripeto che la nostra balena era a vapore. Sono partito da un ricordo delle elementari per un ringraziamento a questa Università che mi ha chiamato oggi a ricevere una laurea che corona un percorso sco- lastico piuttosto irregolare. Dopo la scuola dell’obbligo e le superiori mi sono iscritto in questo Ateneo alla facoltà di Agraria, dove ho iniziato a frequentare, e frequentare,
22
e frequentare sia i corsi, sia le mense, sia le assemblee,
sia le studentesse di Psicologia. Sia Piazza delle Erbe, sia
le Case dello studente di via De Cristoforis alla Stanga,
proprio di fianco a quelli che allora erano i nuovissimi,
lussuosi condomini di via Anelli.
È inutile cercare nei registri dell’Opera universitaria
l’assegnazione di un posto letto a uno studente di nome
Paolini M., ero abusivo regolare! Pagavo un letto ag-
giunto in un appartamento a uso esclusivo di un gruppo
di solidi contadini dell’Alto Vicentino che già frequenta-
vano Agraria da dodici anni
Oggi loro insegnano!
Probabilmente sono l’ultimo del mio corso e del no-
stro appartamento a essermi laureato…
E di questo ringrazio l’Università per la pazienza avuta
con la pecorella smarrita.
È vero che c’è una leggera discrepanza tra l’indirizzo
iniziale dei miei studi e il titolo universitario che mi è stato
riconosciuto, ma anche di questo mi assumo l’intera re-
sponsabilità, perché, con incoscienza giovanile o belle
speranze, ho rubato tempo ad Agraria per fare teatro.23 Ho cominciato a far teatro perché era un modo di- vertente per far politica, ho cominciato prima di sapere come si fa, e all’inizio questo si può anche sopportare, ma a un certo punto è diventato un problema: ero di- stratto. Non ho fatto l’Accademia teatrale perché ero contro ogni tipo di Accademia; se fosse vivo Luigi Meneghello, oggi sarebbe qua a guardarmi con la toga addosso, a pochi metri dalla cattedra di Galileo e mi direbbe «Ben- venuto caro, parli un po’ troppo sai caro, stringi caro, stringi». Lasciando un malizioso sottinteso su cosa dovrei stringere… Io nel ’79 frequentavo i seminari a Sant’arcangelo di Romagna. La “a” di arcangelo di Romagna è minuscola perché in Romagna sono comunisti fin dal ’500. Io però venivo da Treviso, dove alle ultime politiche i comunisti erano arrivati a quota 500 grazie anche al mio voto gio- vanile… Ho avuto il raro privilegio di diventare adulto e votare prima di conoscere l’amore carnale e siccome in quegli anni in Italia i governi duravano poco e si votava spesso, tra le due per me a Treviso la prima continuava a essere l’attività prevalente.
24
Ecco, per cambiare orizzonte facevo i seminari, lo so,
può sembrare un controsenso, ma non è così. I seminari
teatrali per un giovane teatrante erano luoghi pieni di
promesse, in tutti i sensi. A Sant’arcangelo di Romagna
ho conosciuto Gabriele Vacis, Eugenio Barba, Jerzy Gro-
towski e Dario Fo, oltre a un paio di fidanzatine; era molto
promettente il futuro ma contestavo. Mi era rimasta ad-
dosso un’abitudine nata a Treviso e coltivata a Padova,
in anni per niente memorabili; contestavo in base al prin-
cipio che se uno è famoso va contestato, semplice, no?
Aver provato a contestare Carmelo Bene mi era già
costato una lezione indimenticabile di cui oggi non par-
lo, ma che ho narrato già varie volte a teatro.
Un giorno però a Sant’arcangelo, durante un semi-
nario, attaccai Dario Fo, con l’accusa di fare vecchio
teatro politico, con testi non proprio belli. Non avevo la
minima idea del fatto che stavo accusando il dramma-
turgo italiano più rappresentato al mondo, futuro Nobel
per la letteratura. La risposta sua me la ricordo ancora:
è una delle lezioni di vita che ho avuto. Mi ha detto «il
Teatro non si scrive per i posteri, non è letteratura, non
aspira all’immortalità».Il ricordo sul libro dell’Università
26
A me, nonostante tutto, sembrava noioso imparare
a memoria i dialoghi scritti, mi piaceva improvvisare, an-
dare sui trampoli, mi piaceva fare il clown, imparare a
comporre frasi col corpo, piegandolo in esercizi lunghi
e ripetuti. Tutto questo, però, senza mai sapere a cosa
sarebbe servito.
Da questo disordine è nata una disciplina, un corpo
di attore a cui poi nel tempo si è aggiunto un mestiere;
la commedia dell’arte e la maschera di cuoio ne sono
state la palestra.
La gente mi conosce come uno che racconta storie
sul palco, da solo, ma per arrivarci, la strada che ho fat-
to, non era solitaria. È una strada di incontri con uomini
straordinari e luoghi non teatrali. L’idea che il teatro sia
un territorio e non un edificio, per me non è mai stata
astratta. Io vengo da fuori e a me non spaventa un futu-
ro in cui bisogna ricominciare da fuori dei teatri.
Un futuro.
Secondo me per riassumere il futuro, basterebbe una
citazione teatrale, da Aspettando Godot, ma fatta in
maniera un po’ impropria. Mi ero chiesto una volta «Si27 possono fare i classici in dialetto?» Farebbe più o meno così: «E se se copassimo?» «No se pol» «Parché?» «Spetemo go-Pod». Il prossimo. Ecco, una ragion di vita sufficiente a non coparse, il prossimo go-Pod della Apple. Parliamo del futuro. Lo sapete che Kathmandu è tutta cablata? Nel sen- so che c’è un palo della luce in mezzo, tutti si attaccano abusivamente e non si sa chi paga la bolletta. The Economist il 1° dicembre 2012, ha racconta- to come uno scenario di guerra tra imperi ai tempi di Galileo, il futuro di Apple, Amazon, Facebook, Google. Ecco, quel futuro, quello scenario, mi riguarda da vicino, perché quello che faccio io riguarda il mercato della cultura. Io ogni tanto passo dal teatro alla televisione, la Jole- film S.R.L, che insieme a quattro soci e compagni realizza il mio lavoro, produce qui, da Padova, oltre al mio tea-
28
tro anche documentari, musica e film. Sono 12 anni che
facciamo tutto questo come una factory indipenden-
te e direi che ne sono piuttosto orgoglioso, ma come
ogni impresa culturale abbiamo da tempo raccolto dei
segnali sulla fine di un ciclo. Il sostegno pubblico come
lo conosciamo, sta finendo il che non significa che c’è
solo meno denaro in circolazione, non è questo il proble-
ma, è diverso. Sta finendo per la conservazione dei beni
ambientali, per l’istruzione, per la sanità, per l’assistenza
alle fasce più deboli, così come per l’amministrazione
dei Comuni. Ma ciò che rende difficile il presente non è
la riduzione della spesa, è il disordine conseguente all’in-
certezza sulle regole.
Come mi ha efficacemente riassunto un sindaco di
un ricco comune del Veneto: «È come portar la macchi-
na a riparare in una officina nel caos». Se prima di fare il
lavoro bisogna ancora rimettere a posto gli attrezzi vuol
dire che non siamo ancora pronti a intervenire.
Ecco io credo che sia questa la differenza tra una
società povera e una che ha appena incominciato a
impoverirsi, ma non ha ancora cambiato abitudini: gli
attrezzi fuori posto. La metafora credo racconti il cam-29 biamento abbastanza bene. Anche il sistema dell’informazione e dell’editoria si regge in parte su finanziamenti pubblici, il resto dipende dalla pubblicità che tiene a galla un sistema, quello dei giornali e delle televisioni, che oggi è in difficoltà. Fino a quando gli editori azionisti di giornali e televisioni potran- no reggere un sistema che perde ogni anno? Lo faranno fin quando l’importanza del loro settore sarà strategica, oppure fin quando potranno permetterselo. Ma quello che ci propongono diventa ogni giorno un po’ più ob- soleto; fino a quando, voglio dire, accetteremo di com- prare un quotidiano che parla di ieri quando tutti sap- piamo le notizie di oggi? E da chi le sappiamo le notizie di oggi? Dal telefono. Quand’ero bambino mi ricordo che il futuro sem- brava venire dall’orologio. L’orologio di James Bond. Neanche gli autori di fantascienza immaginavano che sarebbe stato il telefono a essere usato come arma. Ma quello che oggi noi usiamo come telefono non è più un telefono, è un’eucarestia. Un sacramento. Che sotto le spoglie di telefono nasconde un mistero. Ogni volta che Apple lancia un prodotto si genera un proces-
30
so che somiglia di più alla comunione che alla vendita,
perché i fedeli lo sanno che dentro a quello che rice-
vono c’è un mistero gaudioso da scoprire un poco alla
volta. Ecco. Non basta. Ogni tanto il mistero si aggiorna
da solo. Ti cambia i colori, trasfigura, annuncia cambia-
menti: come fai a restare miscredente davanti a questo
miracolo tecnologico? È chiaro a tutti che siamo solo
all’inizio?
Prima di Natale papa Benedetto ha «cinguettato»
per la prima volta. Per farlo hanno invitato le televisioni,
che saranno vecchie ma servono ancora. Il Papa, devo
dire, sembrava più imbarazzato che emozionato. Con
un aiutino ha premuto invio e il messaggio è partito …
cip … anzi tweet.
Io in quei giorni ero andato a parlare di teatro all’Isti-
tuto Italiano di Cultura a Parigi, intervistato in pubblico
dalla direttrice che è una brava giornalista che stimo,
lei durante l’incontro scattava delle foto … Dopo scrive-
va dei messaggi per far partecipi dell’incontro certi altri
non presenti tra cui uno che era in treno. Io ho dovuto
concentrarmi tantissimo per rispondere a lei e non guar-31 dare quello che scriveva sul telefono. Lei era bravissima, attenta a non distrarsi, distratta attentamente. Torno in Nepal per una risposta ancora mancante. Perché Kathmandu è tutta cablata? Perché decine di migliaia di alpinisti, o presunti tali, evoluti, vanno in Ne- pal a condizione di poter restare connessi a qualcuno di lontano, a casa o nel mondo. Per molti vagabondi del trekking è importante prima di partire, sapere di restare cablati. Prenotano via internet il loro rifugio lungo il sen- tiero, e sanno che una volta arrivati in quel rifugio use- ranno l’altro terminale di internet per parlare a casa e dirghe «so in Nepal», «go caro… go caro», «come va?», «piove», «go caro»… E in California l’industria cinematografica ha un pro- blema: la durata classica del film comincia a essere troppo lunga per alcune fasce di pubblico. Dopo aver rimosso i fumatori dai cinema, adesso bisogna creare sale o aree riservate per un nuovo tipo di dipendenza: spettatori che non possono restare disconnessi per due ore. La durata di un film. «No se sa mai cosa pol succe- dere in due ore». Credetemi in due ore, in un cinema, in America, può succedere di tutto, ed è bene avere un
32
telefono per scampare al pericolo.
Da alcuni anni a teatro, a partire dall’avvento della
telefonia mobile è cominciata una guerra tra palco e
platea. Non sono l’unico attore che potrebbe parlarvi
di cosa gli è successo: ho minacciato, improvvisato e a
volte interrotto, perché mi ero rotto. Alle matinée per le
scuole negli ultimi anni i telefoni non suonano più, brilla-
no e basta. Alcuni spettatori a turno sembrano Avatar,
hanno una luce blu in faccia. Ogni tanto uno si accen-
de e un attimo dopo un altro si spegne. Non parlano
mica con altri sul treno, parlano fra loro, dal palco si
vede tutto… Come mi regolo?
Gli spettatori affermano il loro diritto a essere distrat-
ti. Fino a 100 anni fa nei palchi e in platea durante gli
spettacoli si mangiava, c’erano tavole e camerieri per i
signori nei palchetti di proprietà o in affitto. Come face-
vano i cantanti e gli attori? Come si regolavano? È stato
Toscanini a far rimettere a posto gli attrezzi, a pulire le
sale, a mettere a dieta il pubblico, ma non è stato faci-
le: gli spettatori volevano restare connessi con il proprio
stomaco.33 Io mi regolo così con gli studenti: a volte all’inizio dò messaggi poco rassicuranti, altre volte accetto la sfida e faccio il virtuoso, accentuo il mestiere, cambio ritmo… Sentendo gli altri che ridono, tirano su la testa e finalmen- te mi guardano, alcuni perdono interesse a messaggia- re e dopo la prima mezzora così, li ho presi e di solito mi seguono fino alla fine. Con la maggior parte funziona. Quelli che restano sono così bravi a messaggiare che non vale la pena interromperli. A ogni attore ogni tanto capita di trovare spettatori più bravi di lui. Mi resta una curiosità: se io impegnandomi come un matto riesco a spegnere due telefoni su tre per un’ora e mezza su due, cosa deve fare in 18 ore su 24 settimana- li (un po’ meno vivaci) un normale insegnante per farsi ascoltare? Deve fare gli straordinari. Non voglio negare gli indiscutibili pregi dell’era dell’accesso che Jeremy Rifkin ha paragonato alla rivo- luzione dei caratteri di stampa, rifletto solo sul fatto che la tecnologia appare sempre più un effetto separato dalla ricerca scientifica che l’ha resa possibile. Quegli algoritmi sono difficili da costruire, ma semplici da usare.
34
L’abitudine di regalare tecnologie da adulti ai bambini
se da un lato offre loro possibilità di impararne l’uso più
rapidamente degli adulti, di fatto costituisce un’abolizio-
ne di una fascia che nel ’900 si è cercato di proteggere
con l’educazione obbligatoria: l’infanzia e l’adolescen-
za. A volte per apprendere, educare, bisogna creare
un luogo separato, un seminario. Non voglio fare affer-
mazioni ideologiche, né sostenere il proibizionismo, mi
sembra però che quanto viviamo assomigli alla rappre-
sentazione di un mondo descritto da Collodi: Pinocchio,
Lucignolo e gli altri arrivano in un parco pieno di distra-
zioni. Se in fondo la tecnologia non è altro che il pae-
se dei balocchi allora non ha senso negarne l’accesso
ai piccini. Da adulti continueranno a frequentarlo con
sempre nuova meraviglia traendo nuove distrazioni. Se
solo chi sceglie di vivere così accettasse, come piccola
contropartita, di portare le orecchie da somaro, sareb-
be davvero tutto più chiaro. Il prezzo per tutto questo è
che non si sceglie più per attenzione, ma per distrazione.
Nel frattempo dovendo scegliere tra mali minori de-
cido di non frequentare social network e di continuare
a fumare. Ho paura che se smettessi mi metterei a cin-35 guettare e a vivere attaccato al telefono, felicemente distratto. Ma per fare il mio mestiere ho imparato che tra un’uscita pubblica e un’altra è necessario creare dei vuoti, un distacco, un silenzio. Ammetto di avere un atteggiamento passatista, di preferire Pompeo Molmenti a Tommaso Marinetti, di col- tivare interesse per isole solide nella società liquida. Io sono antico, le radici del mio lavoro sono più vec- chie di me, io vengo dalla tradizione che non è solo quella della commedia dell’arte, ma anche da quella più scomoda, ma utile, della tragedia dell’arte. Non ho un solo maestro, ho imparato da tanti, ma negli ultimi tempi quelli cui penso di più sono Brecht, Verdi, Galilei. Secondo me sono vitali in un paese come il nostro e per giustificare questa affermazione dovrei fare un esempio. Quanto pesa un metro cubo d’acqua? 1.000 chili, 10 quintali, una tonnellata? Quant’è una tonnellata? Quant’è grande un metro cubo d’acqua? Così comin- ciava Vajont: quanto pesa un metro cubo d’acqua. E poi giù una serie di confronti tra frane: Val di Stava, Val-
36
tellina. Perché le frane bisogna misurarle a metri cubi:
dentro può esserci la roccia, l’acqua, la terra morbida,
la sabbia, ma quel che non cambia sono i metri cubi.
E poi via, cambio, un bambino che va in seconda
elementare: io.
E poi via cambio, i titoli dei giornali, nomi famosi, gior-
nali famosi tutti si erano sbagliati, tranne una: Tina Merlin.
Geologi e ingegneri si erano sbagliati, l’Enel e la Mon-
tedison avevano giocato con l’acqua in un bicchiere
ma il sasso ci era caduto dentro e pluff, 2.000 vittime.
Nessuno nel ‘97 aveva ancora chiesto scusa a nessu-
no, speravano fosse stata dimenticata. Il processo civile
si trascinava ancora verso gli ultimi gradi di giudizio, non
c’era nessuna ragione di attualità per proporre Vajont in
diretta televisiva il 9 ottobre ’97, anzi, quel giorno era ca-
duto il governo Prodi e l’attualità modificava i palinsesti
per commentare uno scenario nuovo.
In piedi, sulla diga, mezzora prima della diretta, ho
fatto una promessa a me stesso, ai morti senza sepoltu-
ra, alle luci di Longarone in fondo alla valle: la promessa
di non perdere il filo del discorso, che avrei cominciato e
finito come avevo già fatto 270 volte a teatro.37 Ho giurato a me stesso e a loro che gliela avrei fatta vedere e sentire. Carlo Freccero aveva scommesso su un attore sco- nosciuto con una storia potente, il risultato lo ricordate, è una pagina di storia della televisione, una pagina im- portante come quella recente in cui Roberto Benigni ha prestato il suo corpo e il suo slancio per ridare forza e bellezza alla Costituzione. La lezione di Benigni resta ad- dosso alle persone, dura almeno per un po’. Un po’, ma quanto? La lezione raccontata il 9 ottobre ’97 sul Vajont dura ancora, me lo testimoniano ogni anno vecchi e nuovi spettatori. Sarebbe un atto di servizio pubblico da parte della Rai riproporla il 9 ottobre 2013 a 50 anni di distan- za, lo dico ovviamente non senza imbarazzo, ma con la consapevolezza che quella storia ormai non appartiene più a qualcuno, non è mia, è demanio, bene comune o almeno servizio pubblico. Cosa c’entra Vajont con Galileo, con Brecht e con Verdi? Non è facile stare dalla parte di Galileo, troppo comodo fare lo scienziato e illudersi di essere tra quelli. Troppo facile a volte accusare chi mette sotto accusa
38
gli scienziati di essere un oscurantista, troppo amici tra
loro i professori per riuscire a vedere e dissociarsi dalle al-
trui responsabilità. Raramente i corsi di geologia in Italia
si occupavano del Vajont in modo critico, l’argomento
veniva trattato con un’astrattezza sconcertante.
Per mesi ho letto con attenzione manuali tecnici con
descrizioni marziane della frana del Toc che omettevano
del tutto il trattamento delle conseguenze funeste, della
sottovalutazione dei tempi e dei modi dello slittamento.
Qualcosa è cambiato? Sì, io lo credo, una generazione
di geologi più vigili si è formata riflettendo sul racconto
del Vajont. Ne ho decine di testimonianze.
Mi illudo? Forse. Se dovessi giudicare sulla base della
scomposta reazione della comunità scientifica naziona-
le, e di una parte di quella internazionale, davanti alle
pesanti accuse rivolte da un giudice de L’Aquila alla
Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile dovrei
concludere che mi ero illuso. Entro pochi giorni saranno
depositate le motivazioni della sentenza. Voglio leggerle
con attenzione e spero che la stessa attenzione vi sia
prestata da tutti quelli che ne hanno già parlato, da tutti
coloro che per ragioni professionali occupano un posto39 importante nella comunità scientifica. Essere in tanti a pensare una cosa non fa di quella cosa l’essenza reale, l’autorità accademica e scientifi- ca non rende immuni da errori o pratiche approssima- tive. Far parte della comunità scientifica non significa automaticamente essere dalla parte di Galileo. Con Brecht il racconto del Vajont ha in comune l’uso appassionato del teatro come strumento di indagine, l’intento pedagogico di far pensare. Con Rigoni Stern ho condiviso l’appartenenza fiera a gente di montagna, la passione per le storie degli ultimi e di scrivere di ciò che si conosce meglio, di cui si è fatta esperienza con i piedi e con le mani. È stato il Vajont che ci ha fatto conoscere e incontrare, anche se di questo non parlo mai. Ma cosa c’entra il Vajont con Verdi, con Apple, con Google e con tutto il paese dei balocchi? Io per anni ho lasciato che si definisse Vajont orazione civile, evitando ogni altra parola che ricordasse il teatro politico di Ber- tolt Brecht o di Dario Fo. Era importante ed era anche giusto perché ciascuno doveva sentirlo proprio, suo, a
40
un livello pre-politico. Vajont colpiva lì perché secondo
me questo substrato esiste, andrebbe coltivato, è lo stes-
so strato su cui agisce, dovrebbe agire, il corpus delle
leggi che derivano dalla Costituzione, l’ambitus dell’e-
ducazione, la tutela dei deboli, il processo dell’inclusio-
ne sociale, degli immigrati, degli emarginati. La cultura
può fare molto di più di quanto ha fatto per tutto questo
sfidando un po’ il mercato e le sue regole e se lo fa può
trovare degli alleati, dei complici insospettabili che in
una missione di questo tipo si riconoscono.
La definizione di orazione civile per me, lo dico ades-
so, è stata un po’ un paravento, una maschera per na-
scondere e proteggere l’essenza di quell’opera.
Che cos’è Vajont? Vajont è una tragedia popolare,
è come Rigoletto, La traviata, anche se non ha la musi-
ca, non ha i personaggi. Vajont è diventato familiare da
subito a tutti quelli che ascoltano. Ho scritto e descritto
altre storie tragiche ma non ho difficoltà a riconoscere
che nessuna ha la forza popolare di Vajont.
Nessuno studente continua a digitare dopo mezzo-
ra di visione del Vajont. Siamo il paese che si racconta
con la commedia all’italiana, ma quando gli eroi della41 commedia Gassman e Sordi si fanno fucilare nel finale del film La grande guerra ognuno si tace ed è come se si sentisse Verdi in sottofondo. La grande lezione di Verdi è aver inventato la tra- gedia dell’arte e gli italiani l’hanno adottata da subito, anche quelli che non andavano all’opera. Poche cose sono identitarie come quelle tragedie nella nostra sto- ria. Senza la crisi economica saremmo più compromessi con il mondo di Collodi. La commedia ci aiuta a cam- pare, la tragedia ci serve a capire. La lezione del Vajont si comprende perché accom- pagna un forte dolore a un pensiero critico pieno di do- mande. È molto difficile immaginare di produrre un simile ef- fetto tra uno spot pubblicitario e l’altro. La sfida del 9 ottobre ’97, e anche quelle successive che ho fatto in televisione si sono sempre svolte senza interruzioni pub- blicitarie, con la complicità dell’editore nel sopportare il sacrificio di una mancata entrata in cambio di una maggior attenzione. Tutto questo è già solo un ricordo? La riduzione di entrate pubblicitarie, l’impoverimento del valore del sistema televisivo e la crescita rapida delle
42
potenze mondiali dei nuovi media cambiano lo scena-
rio. Si ricorre al mecenatismo di grandi aziende, giusto …
ma l’Enel avrebbe potuto essere lo sponsor della serata
del Vajont?
Il teatro, il cinema, la canzone d’autore, la musica
classica non possono immaginarsi come contenuti di
una flebo di sistemi moribondi. A essi compete di riorga-
nizzare l’offerta culturale costruendo un nuovo territorio
attorno a sé; come concretamente ha fatto Mario Bru-
nello con Antiruggine a Castelfranco Veneto proponen-
do agli spettatori un’alleanza produttore-consumatore.
Come quella proposta da Carlin Petrini tra contadini e
consumatori per una rivoluzione del consumo alimen-
tare. La rivoluzione digitale ha mandato in soffitta tutto
ciò che è analogico, ma ciò che era manuale è rimasto
manuale. Spalare la neve è manuale, tagliare l’erba o
pulire un fosso sono manuali e competono agli attori, e
anche nel paese dei balocchi ogni tanto nevica. Ma se
tutti sono distratti nessuno se ne accorge finché non va
via la luce.
È troppo fragile un mondo così deconcentrato.43 Occorre ridare valore alla sapienza delle mani e dei piedi. Morale: «E se se copassimo?» «No se pol». «Parché?» «Spetemo go-Pod». La laurea ad honorem è un po’ come un Oscar alla carriera, ti accorgi che il tempo è passato e farai sem- pre più fatica a superarti, un po’ te la metti via e un po’ ci provi ancora, bisogna esser un po’ ambiziosi e un po’ grati. Grato a mio papà ferroviere e a mia mamma casalinga che dopo avermi fatto studiare beh, hanno avuto fiducia. Grato ai miei cari, ai miei compagni di viaggio, all’Università di Padova che mi ha spiegato pri- ma che per ritirare la laurea ad honorem ci sarebbe da regolare un conticino: tra l’ultimo anno che ho frequen- tato e questo ci sono 30 anni di tasse universitarie come fuori corso da pagare … ho dato un’occhiata alla som- ma, una cifra mostruosa, ma posso pagarla a rate. Un’ultima cosa. Proprio il giorno che ho fatto Vajont
44
avevano dato a Dario Fo il Nobel per la letteratura, na-
turalmente ero molto contento, ma anche un po’ invi-
dioso e preoccupato perché adesso per un bel po’ a un
italiano teatrante non lo davano più…
Comunque quella sera, alle otto, prima di andare a
concentrarmi sulla diga ho chiamato gli accademici del
Nobel a Stoccolma e gli ho chiesto: «Ma voi Rai2, in Sve-
zia, la vedete vero?»
Marco Paolini, 10 gennaio 201346
47
Puoi anche leggere