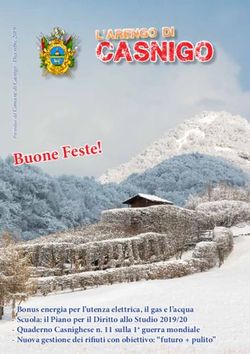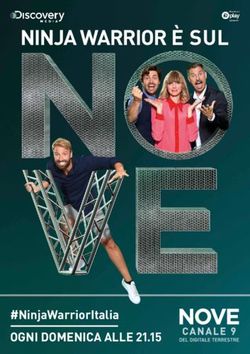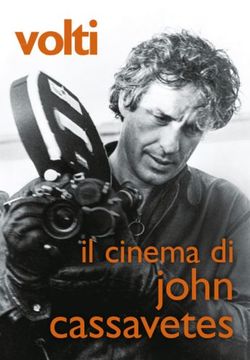Giacomo Puccini TOSCA - Stagione Lirica 25 26 ottobre 2020 - Teatro Stabile del Veneto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
OGNI PROSECCO DOC Teatro Mario Del Monaco
Autunno Musicale 2020
È UN VIAGGIO NELL’ECCELLENZA ITALIANA.
MA SOLO SE HA ORIGINE QUI. Stagione Lirica 2020
Domenica 25 ottobre 2020 – ore 18.45 anteprima
Lunedì 26 ottobre 2020 – ore 20.00 Prima di Stagione
TOSCA
Melodramma in tre atti – libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giocosa
Bevi responsabilmente
Musica di
Giacomo Puccini
Edizioni Musicali Thompson, Kalmus.Com – U.S.A
Prima rappresentazione
Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900
Floria Tosca Chiara Isotton
Mario Cavaradossi Fabio Sartori
Il barone Scarpia Claudio Sgura
Il sagrestano Alex Martini
Cesare Angelotti Andrea Pellegrini
Spoletta Francesco Tuppo
Sciarrone Hazar Mürşitpınar
Un carceriere Luca Scapin
Un pastore Anna Cesca, Sophia Marino
Francesco Lanzillotta
Maestro Concertatore e Direttore
Coro di Voci Bianche dell’Associazione Musicale Francesco Manzato
Maestro del coro Livia Rado
Insieme Corale Ecclesia Nova
Maestro del coro Matteo Valbusa
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
SOLO PROSECCO DOC ORIGINALE HA IL CONTRASSEGNO.
Quando brindate, siate originali: scegliete il vero Prosecco DOC, solo quello in
bottiglia, proveniente dal territorio unico delle nove province di Veneto e Friuli
Venezia Giulia, la Dreamland. Lo riconoscete dalla bottiglia col contrassegno sul
collarino. E dal suo gusto inconfondibile.Guida all’opera
Direttore di produzione Edoardo Bottacin Il soggetto p. 07
Direttore di palcoscenico Federico Brunello
Maestro di sala e di palcoscenico Gianni Cappelletto Il libretto p. 11
Altro maestro di palcoscenico Jacopo Cacco
Maestro ai sopratitoli Alessandro Argentini La Tosca di Giacomo Puccini: una sapiente mistura di passione,
sesso, patriottismo, devozione. E con un pizzico di sadismo.
Responsabile di palcoscenico Andrea Gritti di Gilberto Mion p. 12
Macchinista Paolo Minuto
Elettricista Davide Daniotti
L’orchestra
Fonico Davide Dall’acqua
di Michele Girardi p. 22
Truccatrice Susy Zancanaro
Coproduzione tra Comune di Treviso - Teatro Mario Del Monaco Le voci
e A.P.S. Musincantus – Autunno Musicale d Michele Girardi p. 24
In collaborazione con Rappresentazioni di Tosca al Teatro Mario Del Monaco
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta di Iorio Zennaro p. 26
Associazione Corale Ecclesia Nova
Associazione Musicale Francesco Manzato Gli interpreti p. 31
Calendario Ott - Dic 2020 p. 37
Partners p. 38p. 07
Il soggetto
L’azione si svolge a Roma, il 14 giugno 1800, data della battaglia di Marengo. La
Repubblica Romana è caduta e feroci rappresaglie sono in corso verso gli ex
repubblicani simpatizzanti di Napoleone Bonaparte.
ATTO I
Angelotti, già console della Repubblica e per questo prigioniero politico, riesce a
evadere da Castel Sant’Angelo e trova rifugio nella Chiesa di Sant’Andrea Della
Valle. Sua sorella, la Marchesa Attavanti, gli ha lasciato la chiave della cappella di
famiglia, ove egli trova nascondiglio.
Arriva il sagrestano per ripulire i pennelli del pittore Mario Cavaradossi,
impegnato nella realizzazione di un affresco raffigurante la Madonna. Il pittore
entra poco dopo per rimettersi al lavoro. Quando toglie il telo dal suo affresco,
il sagrestano ha un sobbalzo: nell’effige della Madonna riconosce un volto già
visto. Cavaradossi confessa di essersi ispirato ad una devota della chiesa, non
sapendo che si tratta proprio della Marchesa Attavanti. Continua a dipingere il
quadro guardando, di tanto in tanto, un ritratto della sua amata Floria Tosca.
Pur se inquieto, il sagrestano fa per uscire, quando nota che il paniere con il pranzo
di Cavaradossi è ancora intatto; pensa ad un digiuno di penitenza, ma il pittore lo
rassicura dicendo di non aver appetito. Angelotti, pensando di esser rimasto solo,
esce dal nascondiglio. Incontra però Cavaradossi, suo vecchio amico e anch’egli
simpatizzante per Napoleone Bonaparte. I due vengono interrotti bruscamente
dall’arrivo di Tosca; Angelotti è costretto a nascondersi frettolosamente, non
prima di aver preso il paniere di Cavaradossi.
Floria Tosca, cantante e amante di Cavaradossi è per sua indole molto gelosa. Ha
sentito il suo amato parlare con qualcuno e teme la presenza di un’altra donna.
Dopo essere stata rassicurata dal Cavaradossi di essere l’unica donna da lui
amata, lo invita a passare la serata insieme nella villa del pittore. Prima di uscire,
però, riconosce nello sguardo della Madonna gli occhi della Marchesa Attavanti;
di nuovo viene presa da un impeto di gelosia, e di nuovo Cavaradossi le proclama
il suo unico e incondizionato amore.
Allontanatasi Tosca, Angelotti può uscire di nuovo dal suo nascondiglio. Racconta
che la sorella ha nascosto nella cappella per lui delle vesti femminili; aspetterà
il tramonto per fuggire dalla caccia del barone Scarpia. Cavaradossi consiglia
all’amico di recarsi subito alla sua villa e, in caso di pericolo, nascondersi nel
pozzo. Un colpo di cannone sparato da Castel Sant’Angelo annuncia che la fuga
di Angelotti è stata scoperta. Questi è dunque costretto alla fuga.
Entra il sagrestano circondato da una folla di chierici e confratelli, tutti festosi
per la notizia dell’imminente (e presunta) sconfitta di Napoleone da parte degli
austriaci. Li interrompe bruscamente Scarpia, accompagnato da Spoletta,
giunto nella chiesa per ricercar il fuggitivo. Trova il paniere vuoto e un ventagliop. 08 p. 09
femminile con lo stemma Attavanti. Riconoscendo infine il volto della Marchesa finta fucilazione di Cavaradossi: in questo modo il pittore avrebbe salva la vita e il
nell’effige della Madonna, capisce che il piano di fuga di Angelotti è stato ordito barone manterrebbe il suo ruolo di capo della polizia.
con la complicità di Cavaradossi. Tosca, non capendo l’inganno del barone, chiede inoltre un salvacondotto per
Tosca torna in chiesa per annunciare al suo amato un cambio di programma: poter fuggire da Roma con il suo amato. Scarpia le consegna il documento e
dovrà presenziare ad un concerto a Palazzo Farnese quella sera stessa, quindi chiede a Tosca di rispettare il patto; in tutta risposta lei prende un coltello dalla
non potrà recarsi alla sua villa. Il barone Scarpia utilizza il ventaglio per instillare tavola imbandita e lo pugnala, uccidendolo.
il dubbio nella mente di Tosca. Ella riconosce lo stemma sul ventaglio e crede
che Cavaradossi abbia una relazione con la Marchesa; corre quindi alla villa del
pittore per poter cogliere i due sul fatto. ATTO III
Scarpia la fa seguire da Spoletta e da alcuni poliziotti. Il suo scopo è duplice:
avere per sé Floria Tosca e catturare Angelotti. Dalla sua cella di reclusione, Mario Cavaradossi chiede al suo carceriere di poter
scrivere un’ultima lettera alla sua amata Tosca. Mentre si strugge per trovare le
parole adatte, Tosca fa il suo ingresso nella cella accompagnata da Spoletta (il
ATTO II quale ancora non è a conoscenza della morte di Scarpia). Quando i due amanti
restano soli, Tosca confessa il suo crimine e mostra a Cavaradossi il salvacondotto
Interno di Palazzo Farnese, camera di Scarpia al piano superiore; dalla finestra firmato da Scarpia prima di morire. Tutto ciò che dovrà fare Cavaradossi è
provengono le note del concerto e, di lì a poco, la voce inconfondibile di Tosca. Il cadere quando i soldati spareranno con i loro fucili caricati a salve. Tosca infatti
capo della polizia è in compagnia del gendarme Sciarrone. non immagina che la messa in scena della finta fucilazione sia in realtà un inganno
Spoletta entra trascinando con sé Cavaradossi. Nella villa infatti vi era solo perpetrato da Scarpia per approfittare di lei.
quest’ultimo, nessuna traccia del fuggitivo Angelotti. Scarpia cerca di fargli Cavaradossi viene portato sul ponte di Castel Sant’Angelo per essere fucilato;
confessare l’ubicazione del suo amico, senza però riuscirvi. quando i soldati sparano lui cade a terra.
Tosca entra nella stanza; vedendo Cavaradossi gli fa un cenno per fargli intendere Tosca attende che i soldati se ne siano andati, prima di accorrere verso il suo
d’aver capito tutta la situazione. Lui la implora di non dire nulla. amato e aiutarlo a rialzarsi; solo allora capisce che, quella che avrebbe dovuto
Cavaradossi viene portato nella camera di tortura mentre Scarpia, rimasto solo essere una simulazione, in realtà è stata una vera fucilazione.
con Tosca, cerca di farle rivelare il nascondiglio di Angelotti. Per convincerla a Dalle stanze di Castel Sant’Angelo si odono le urla di Spoletta e dei soldati che
parlare le fa sentire le urla di dolore di Cavaradossi, provenienti dalla stanza hanno trovato il corpo di Scarpia. Si recano in fretta sul ponte per arrestare
attigua. Solo allora Tosca capisce cosa sta succedendo al suo amato. Cerca Tosca. Lei sale sul parapetto del ponte e si getta nel vuoto, non prima di aver
di resistere, sopportando le urla strazianti del pittore, finché non cede: urla a lanciato un’ultima maledizione a Scarpia.
Scarpia che Angelotti è nascosto nel pozzo del giardino.
Cavaradossi, sanguinante e fisicamente provato, viene condotto da Tosca, mentre
Spoletta va a catturare Angelotti. Irrompe nella stanza Sciarrone con una notizia
preoccupante dal fronte: quella che sembrava essere una sconfitta pesante per
Napoleone, in realtà si è trasformata in una vittoria decisiva. L’esercito austriaco
è stato sconfitto a Marengo. Cavaradossi ritrova le forze e urla alla vittoria,
facendosi beffe di Scarpia. Quest’ultimo non tollera l’affronto del rivale e lo
condanna a morte.
Rimasto di nuovo solo con Tosca, Scarpia le dice che potrebbe esserci un modo
per salvare Cavaradossi: ella dovrà concedersi a lui. Tosca rifiuta sdegnata
la proposta, ma il barone alfine la convince, complice anche l’imminenza
dell’esecuzione capitale.
Spoletta ritorna con la notizia della morte di Angelotti: il fuggiasco, pur di non
farsi catturare, si è tolto la vita.
Sugellato il patto con Tosca, il barone finge di accordarsi con Spoletta per unap. 11
TOSCA
Melodramma in tre atti
libretto di
Luigi Illica e Giuseppe Giocosa
dal dramma La Tosca di Victorien Sardou
Musica di
Giacomo Puccini
PERSONAGGI
Floria Tosca, celebre cantante Soprano
Mario Cavaradossi, pittore Tenore
Il barone Scarpia, Capo della Polizia Baritono
Cesare Angelotti, un prigioniero politico evaso Basso
Sagrestano Baritono
Spoletta, Agente di Polizia Tenore
Sciarrone, Gendarme Basso
Un carceriere Basso
Un pastore Bambino
Un Cardinale; il Giudice del Fisco;
Roberti, esecutore di Giustizia; uno Scrivano;
un Ufficiale; un Sergente
Soldati, Sbirri, Dame, Nobili, Borghesi, Popolo, ecc.
Roma: Giugno 1800
Prima rappresentazione assoluta:
Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900p. 12 p. 13
La Tosca di Giacomo Puccini: una sapiente mistura di
passione, sesso, patriottismo, devozione. ***
E con un pizzico di sadismo
di Gilberto Mion Secondo la testimonianza di Arnaldo Fraccaroli, il primo biografo
di Puccini1, il compositore lucchese aveva fatto conoscenza con i
Nel biennio che va dal marzo 1851 al marzo 1853, Giuseppe Verdi personaggi di quello che sarebbe divenuto il suo quinto melodramma
riuscì a consegnare al suo pubblico ben tre opere nuove. Tre autentici una sera del febbraio 1889, nella sala del Teatro dei Filodrammatici
capolavori, si badi, tre titoli tuttora popolarissimi, mica cosucce di di Milano. Qui andava in scena La Tosca di Victorien Sardou (1831-
routine. Con Giacomo Puccini suona tutt’altra musica. È noto infatti 1908), dramma in cinque atti apparso a Parigi nel novembre del 1887
come il compositore lucchese fosse allo stesso tempo pignolo e e nel quale lo scrittore francese (all’epoca all’apice della sua fama)
insicuro, incline agli entusiasmi come agli improvvisi scoraggiamenti, mescolava una storia di fosco libertinismo e di morte sullo sfondo di
pronto a fare e disfare, sempre esigente e perfezionista sino una tenebrosa Roma papalina dell’anno di grazia 1800. A Milano, tra
all’inverosimile. Persino la moglie Elvira pare lo rampognasse delle l’altro, Puccini vide La Tosca in lingua originale, ed il francese non era
sue incertezze e quindi della sua scarsa prolificità, con tono di aspro certo il suo forte. Ma grazie anche alla straordinaria recitazione di
rimprovero: «Tre anni per trovare un libretto? Ma in tre anni Verdi ha Sarah Bernhardt, in tournée italiana con la sua compagnia, il lavoro
composto Rigoletto, Trovatore e Traviata!». ebbe un forte impatto sul musicista, sedotto sia dalla potenza della
Tuttavia Puccini non era fatto così. Fra un’opera e l’altra, aveva protagonista sia dalla forte presa scenica del soggetto. Non a caso
bisogno di lunghi tempi di riflessione e di maturazione. Basta guardare Sardou, drammaturgo all’epoca presente e celebrato sulle scene di
le date dei suoi lavori: Le Villi apparve nel 1884, Edgar nel 1889; Manon tutta Europa, era un consumato manipolatore dei linguaggi e delle
Lescaut nel 1893, La bohéme nel 1896. Dopo Madama Butterfly (1904) tecniche teatrali, assai abile tanto nella costruzione degli intrecci
bisognò attendere il 1910 per La fanciulla del West, mentre La rondine quanto nel conferire notevole spessore psicologico ai suoi personaggi.
venne ultimata nel 1915. Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi, i tre Le sue piéces teatrali avvincevano lo spettatore conquistandone
pannelli del Trittico videro la luce tra il 1913 ed il 1918. E sei anni dopo la continua attenzione, anche se a prezzo di qualche espediente un
Turandot era ancora incompiuta, allorché il compositore mancava a po’ truculento. In Puccini si era fatta strada insomma la convinzione
Bruxelles, a fine novembre del 1924. E venne rappresentata alla Scala, d’avere tra le mani un soggetto validissimo per la sua ispirazione,
completata nel finale da Franco Alfano, solamente nell’aprile 1926. tanto che scrisse al suo editore e protettore Giulio Ricordi il 7 maggio
Lo stesso vale per Tosca. Quando la sera del 14 gennaio 1900 il sipario del 1889 (dunque appena quindici giorni dopo la delusione per la
del Teatro Costanzi (l’attuale Teatro dell’Opera di Roma) finalmente si mezza riuscita della premiére dell’Edgar) affinché si adoperasse per
levava sulla sua quinta opera, scoprendo al pubblico la ricostruzione ottenere l’esclusiva dei diritti di musicarla: «Carissimo signor Giulio…
un po’ fantasiosa dell’interno della chiesa di Sant’Andrea della Valle, penso alla Tosca! La scongiuro di fare le pratiche necessarie per
e quando risuonavano i tre violenti accordi che l’aprivano eseguiti ottenere il permesso da Sardou, prima di abbandonare l’idea, cosa
“fortissimo, a tutta forza” dall’orchestra capitolina diretta da che mi dorrebbe moltissimo. Poiché in questa Tosca vedo l’opera che
Leopoldo Mugnone, veniva a concludersi un lungo cammino iniziato ci vuole per me…». 2
molti, molti anni prima. Addirittura undici, per la precisione. Tanto il
tempo che si era reso necessario affinché, dopo un lunghissimo e L’editore milanese aveva una palese predilezione per il più giovane
tormentato iter, tra subitanee infatuazioni e improvvisi abbandoni, degli autori della sua scuderia, e nutriva un incrollabile affidamento
tra certezze passeggere ed inattese perplessità, tra continui rimpalli nel suo talento nonostante la procellosa navigazione dell’Edgar, che
con i librettisti e l’editore, la vena compositiva di Giacomo Puccini incontrava accoglienze alterne; e cercò subito quindi d’accontentarlo.
prendesse un indirizzo definitivo, e desse infine concretizza a questa Si rivolse pertanto al direttore Emanuele Muzio, in quel periodo
opera che chiudeva un secolo ed inaugurava quello nuovo, fra impegnato a Parigi, pregandolo di mettersi in contatto con il
l’enorme aspettativa del pubblico e l’attesa al varco della critica non
solo italiana ma anche europea, data la fama mondiale del suo autore,
1
In A. Fraccaroli, La vita di Giacomo Puccini, Milano 1925.
ottenuta con i travolgenti successi di Manon Lescaut e La bohéme.
2
Carteggi pucciniani, a cura di E. Gara, Milano 1958.p. 14 p. 15
drammaturgo. Il quale, da parte sua, era un artista di successo, ma dal famoso, Franchetti aveva nel frattempo ottenuto già il beneplacito
carattere non facile e senz’altro alquanto venale, visto quanto si trovò del drammaturgo francese nel 1893, pagandogli profumatamente di
a riferirgli Muzio: «Sardou non si sente molto disposto a permettere tasca propria i diritti relativi alla Tosca, firmando poi con l’editore
che della sua Tosca si faccia un libretto italiano, però vorrebbe Ricordi un contratto concernente la stesura e le rappresentazioni del
sapere quale compenso proporrebbe Puccini»3. Allora il costo dei melodramma relativo. Nonostante ciò, Franchetti non pareva più preso
libretti, per consuetudine, ricadeva quasi sempre sui compositori; è da questo soggetto, ed infatti il libretto realizzato per lui da Luigi Illica
probabile inoltre che lo scrittore temporeggiasse un poco, dato che gli girava e rigirava tra le mani senza convincerlo appieno. In due anni
allora il compositore lucchese era ancora un ‘signor nessuno’ in terra aveva infatti steso appena qualche abbozzo. A questo punto interviene
di Francia. Ad ogni modo Puccini (facile ad infiammarsi, altrettanto un noto racconto di Giuseppe Adami4, da accogliere con le dovute
veloce nel farsi passare l’entusiasmo iniziale) mutò improvvisamente riserve. Secondo quanto narrato molti anni dopo dal futuro librettista
di parere, e lasciò cadere i vagheggiati progetti sulla Tosca. E passò di Turandot, infatti, Illica e Giulio Ricordi decisero di muoversi con
ad esercitare la sua arte sulle trine ed i merletti della Histoire du scaltra diplomazia, convincendo il compositore torinese nel corso di
Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, romanzo scritto un secolo un serrato colloquio che l’intreccio di Tosca non era assolutamente
e mezzo prima dall’abate Prévost. adatto alla sua vena, col risultato di fargli perdere ogni fiducia in esso
E quindi fu solo dopo l’apparizione della Manon Lescaut, e un po’ prima e a rinunciarvi a favore di Puccini. Sempre secondo l’Adami, pare anzi
di quella de La bohéme, che si tornò finalmente a parlare nell’entourage che l’accordo preliminare tra Casa Ricordi e Puccini per la stesura
pucciniano del dramma di Sardou, non prima d’aver scartato varie della «sua» Tosca venisse steso e firmato (senza porre altri indugi)
altre ipotesi letterarie. Cosa dunque mosse Puccini a riaccostarsi lo stesso giorno, o al massimo il giorno seguente a quell’incontro.
al dramma del tragediografo francese? Molto probabilmente contò Sta di fatto che in una lettera del 9 agosto 1895 indirizzata all’amico
anche la nuova sensibilità imposta dal Verismo teatrale, con la sua Clausetti, responsabile di Casa Ricordi in Napoli, il musicista lucchese
ricerca di immediati effetti visivi e di un forte impatto emotivo, che poteva perentoriamente comunicare la sua vittoria: «Tosca la farò io,
avevano una grande presa nei confronti di un pubblico che oramai libretto straordinario di Illica, in 3 atti, Sardou entusiasta del libretto»5.
aveva messo in soffitta le ultime nostalgie per il vecchio Romanticismo.
Un interesse reso palpabile dai successi teatrali di Cavalleria rusticana Al di là del vittorioso proclama di Puccini (che peraltro in quel
di Mascagni (1890), di Mala vita di Giordano (1892) e dei Pagliacci periodo doveva ancora condurre in porto la lunga composizione de
di Leoncavallo (1893), oltre che d’altri lavori di autori minori presto La bohème)per giungere alla stesura del libretto finale di Tosca servì
postisi sulla loro scia. Una miriade di titoli che avevano creato di fatto ancora molto lavoro. Ricordi decise infatti di associare nell’impresa
una nuova moda ed un nuovo tipo di spettatore incline alle emozioni letteraria anche Giuseppe Giocosa, l’altro scrittore di punta della casa
forti ed immediate. E l’Andrea Chénier di Giordano, apparso nel marzo editrice milanese, affidandogli nel dicembre 1895 la versificazione del
1896, aveva attestato la possibilità di applicare il lessico verista, con libretto. Dopo qualche tempo però (siamo nel frattempo arrivati a
validi risultati, non solo a vicende ‘popolari’, ma anche ad un soggetto metà del 1896) Giocosa comunicava con franca schiettezza all’editore
d’ambientazione storica. Insomma, anche a Puccini venne voglia di alcune osservazioni e dubbi sulla struttura generale della Tosca di
tentare la carta del Verismo, e proprio con i personaggi di Tosca: Sardou. Pur apprezzando il lavoro di lima sinora svolto dal collega,
anche se in verità, diciamolo subito, la sua particolare indole, incline ci trovava troppa carne al fuoco, e pure troppi duetti: un problema
più alle mezze tinte, ai ‘piccoli affetti’, non gli permise di trasformarsi peraltro già evidenziato da Illica stesso, e rimasto comunque irrisolto.
in un musicista di impronta verista. E poi evidenziava un meccanismo farraginoso, talune forzature nel
Con l’unica eccezione del tardo Tabarro, apparso peraltro quando truce personaggio di Scarpia, l’intreccio dei fatti che andava a scapito
tale tendenza poteva dirsi ormai passata di moda. della poesia. Espresse queste non piccole riserve, si dichiarava infine
C’era però a questo punto un ostacolo sul cammino della Tosca disponibile a rinunciare all’incarico. Ma la collaborazione con Illica,
pucciniana, e portava il nome di Alberto Franchetti. Compositore per forte insistenza di Ricordi, proseguì lo stesso, anche se il comune
torinese di famiglia aristocratica e benestante, allora abbastanza lavoro procedette con lentezza, per i difficili contatti epistolari con
3
Carteggi pucciniani, op. cit. 4
In Giulio Ricordi e i suoi musicisti, Milano 1933.
5
Carteggi pucciniani, op. cit.p. 16 p. 17
Puccini impegnato a seguire e promuovere per mezza Europa i vari principali prescelti furono la bella soprano romena Ericlea Darclée
allestimenti de La bohéme, che stava intanto conoscendo grande (già prima interprete della Wally di Catalani e dell’Iris di Mascagni)
fortuna. Si dovette arrivare insomma agli inizi del 1898, perché il come Floria Tosca; il famoso tenore Emilio de Marchi per la parte
musicista avesse sul leggio del pianoforte i versi definitivi del primo di Mario Cavaradossi (che era stata invano ambita dal più giovane
atto della sua nuova opera, e potesse dare avvio al lavoro di stesura ma meno noto Enrico Caruso, ingaggiato nella medesima stagione
dello spartito. romana); ed infine per quella del Barone Scarpia il valente baritono
*** Eugenio Giraldoni, figlio del celebre Leone che aveva inaugurato Il
trovatore e Un ballo in maschera di Verdi. Va detto che la creazione di
L’iter compositivo di Tosca (portato avanti per lo più nella casa di Tosca era poco a poco diventata un avvenimento musicale e mondano
Torre del Lago, e in parte a Milano e in una casa di Boscolungo sulle di portata sovranazionale, la cui risonanza era stata sollecitata ed
montagne lucchesi) non durò comunque più di tanto, tenendo conto orchestrata con abili mosse pubblicitarie dall’editore Ricordi. La sera
della sua lentezza d’autore, e dei numerosi viaggi che lo distraevano della prima, il 14 gennaio del 1900, sedevano in sala celebri colleghi
dal lavoro. Puccini (incontentabile perfezionista) chiedeva sempre come Mascagni, Sgambati, Cilea, Franchetti, Marchetti; molte erano
qualche aggiustamento e qualche aggiunta: la serenata del pastorello le autorità politiche presenti (tra cui il generale Pelloux, da poco
che apre il terzo atto, per dire, fu sviluppata tutta da lui, senza ricorrere dimessosi dalla carica di Presidente del Consiglio) mentre la Casa
a Illica e Giacosa. Da Roma l’amico don Pietro Pannichelli (il «pretino Reale era presente con la Regina Margherita che giunse, secondo
di Pietrasanta» conosciuto tempo prima, suo fervente ammiratore e prescrizioni d’etichetta, solo al secondo atto.
poi un po’ ingenuo biografo6) gli faceva da consulente musicale per i Puccini e Ricordi nutrivano rosee aspettative sul successo di Tosca:
passaggi per così dire “liturgici” del primo atto: «so già che non usasi ma non andò proprio tutto liscio come si sperava. Il lavoro nel suo
dire né cantare niente prima di intonare il solenne “Te Deum”, ma… complesso piacque alla critica, che nondimeno si mostrò alquanto
io vorrei trovare «qualcosa da brontolare» quando dalla sagrestia prudente nei giudizi, in qualche misura disorientata dall’intreccio che
vanno all’altare», gli scriveva Puccini7 chiedendogli un suggerimento; venne giudicato (proprio come aveva lamentato Giocosa) poco adatto
ma i versi mormorati dalla folla prima del Te Deum se li scrisse poi ad essere posto in musica. Ma nel complesso essa seppe rendere
praticamente da sé, in un approssimativo latinorum. Sempre don giusto omaggio all’originalità del suo autore, pur senza mostrare
Panichelli provvide a metterlo in contatto con il maestro Meluzzi, per eccessivi entusiasmi, ammirandone in particolare il sontuoso e
identificare la nota profondissima emessa dalla campana maggiore di duttile tessuto orchestrale. L’opera passò indenne pure il vaglio del
San Pietro (un mi, per inciso), e poi con il poeta dialettale Luigi (Giggi) pubblico, che applaudì in particolare alcuni momenti (ottenendo i
Zanazzo, che gli fornì una graziosa quartina in vernacolo romano da bis delle due arie tenorili, del Te Deum, della ‘preghiera’ di Tosca, del
sovrapporre alla breve musica già composta per la serenata che apre duetto sugli spalti di Castel Sant’Angelo) senza però entusiasmarsi
la scena sull’alba a Castel Sant’Angelo. Il primo atto di Tosca, iniziato per altri. Anch’esso si trovò senza dubbio un po’ spiazzato dal fosco
alla fine del ‘gennajo 98’, come sta scritto nell’autografo, fu finito prima soggetto dell’ultimo lavoro pucciniano, pur gradendone la immediata
dell’inverno; il secondo fu composto tra febbraio e luglio del 1899; e coinvolgente musicalità. Le ulteriori repliche registrarono sempre
la parola fine venne messa sotto al terzo atto il 29 settembre dello generosi applausi, come pure le edizioni che portarono subito dopo il
stesso anno, a Torre del Lago. A conti fatti, dunque, dopo all’incirca un lavoro in giro per il mondo. Il 17 marzo dello stesso anno Tosca arrivò
anno e mezzo di lavoro compositivo. sul palcoscenico della Scala (direttore stavolta Toscanini), il 12 luglio
I primi giorni del 1900 videro la nuova opera di Puccini già in prova al Covent Garden di Londra, il 4 febbraio 1901 al Teatro Metropolitan
al Teatro Costanzi di Roma, lo stesso luogo dove dieci anni prima di New York. Accolta ovunque dal favore del pubblico ( un po’ meno dei
s’era tenuto il varo di Cavalleria rusticana. Non c’era Arturo Toscanini critici, a volte un po’ aspri) innescando un crescendo inesorabile che
a dirigere l’orchestra, come auspicato in un primo momento; al suo l’ha portata ad essere nel tempo una colonna portante dei cartelloni
posto però celebrava l’altrettanto bravo Leopoldo Mugnone. La messa lirici.
in scena era tutta nelle mani di Tito Ricordi, figlio di Giulio; gli interpreti
6
Suo l’agiografico Il “pretino” di Giacomo Puccini racconta, Pisa 1940.
7
Carteggi pucciniani, op. cit.p. 18 p. 19
*** Eppure innegabile è il fascino che i personaggi di Tosca hanno da
sempre sullo spettatore; sia che siano positivi, sia che siano negativi.
Come ha commentato Mosco Carner, «Gli ingredienti adoperati da Forse perché qui, più che una semplice storia di passione, si tratta di
Sardou per la Tosca furono sesso, religione e arte, mescolati dalla contrasto tra Bene e Male: un Male incarnato dalla figura di Scarpia,
mano di un cuoco di classe e serviti sul piatto di un importante che si avverte come entità autonoma, possente, invincibile, ma che
avvenimento storico»8. La trama de La Tosca di Sardou si inserisce suscita un fascino sinistro. Gli amori di Mario Cavaradossi e Floria
infatti sullo sfondo della discesa in Italia delle truppe rivoluzionarie Tosca sono poi ben diversi da quelli di una coppia di Donizetti, di Verdi
francesi: nel 1798, dopo le vittorie di Napoleone Bonaparte, i suoi soldati o di Wagner: il loro rapporto non è altrettanto semplice e lineare,
avevano occupato la Città Eterna ed annullato il potere temporale del l’aspetto erotico spunta ovunque, la loro sensualità è bruciante,
papa Pio VI che si spense in Francia il 29 agosto 1799, prigioniero compulsiva, divorante. La gelosia della donna è irragionevole ed
del Direttorio. Ma dopo la partenza di Napoleone per la campagna eccessiva, e scaturisce alla fine un effetto devastante; e se il vorace
d’Egitto, e dopo alterne vicende sul campo, l’esercito napoletano di erotismo della coppia appare diverso da quello rapinoso e furioso
Ferdinando IV di Borbone sostenuto da forze austro-russe scacciava di Scarpia, è solo perché in quest’ultimo prevale una componente
il 30 settembre 1799 il presidio francese, decretando così la fine sadica, deviante, eppure in qualche modo morbosamente attraente.
dell’effimera Repubblica Romana proclamata il 15 febbraio dell’anno Il che spiega perché la musica che Puccini dedica a questo fosco
precedente. Infine, il 21 marzo 1800 il nuovo papa Pio VII poteva salire personaggio possegga «un torbido sex-appeal che nessun ‘cattivo’
al soglio di San Pietro. Tutti fatti richiamati nei dialoghi di La Tosca, la dell’opera romantica… si sognò mai di possedere. Tra i cattivi e i
cui trama si dipana in Roma qualche tempo dopo, esattamente tra il 16 buoni, nell’opera romantica, l’abisso è invalicabile; e noi spettatori
e il 17 giugno dell’anno 1800; in concomitanza dunque della battaglia di stiamo fatalmente dalla parte dei buoni… Non così in Puccini, non così
Marengo in cui il Napoleone divenuto Primo Console, si scontrò con le nella Tosca dove, svanita una tavola di valori certa, i sedicenti buoni
truppe filopapali guidate dal maresciallo austriaco Michael von Melas. e il sedicente cattivo si riflettono in qualche modo reciprocamente,
Scontro epico, le cui sorti iniziali sembrarono dapprima decisamente lasciando intravedere un fondo comune; e mentre gli slanci più felici
favorevoli alle soverchianti forze asburgiche, ma che si concluse a sera dei primi sono percorsi da brividi e sospetti, quelli biechi del secondo
con la clamorosa vittoria delle truppe francesi. Il disastroso rovescio scatenano in noi un’inquietante dialettica di attrazione-repulsione»10.
costrinse infine gli austriaci alla richiesta di un armistizio. Insomma, a veder bene i ‘buoni’ e i ‘cattivi’ hanno in fondo molte
«Con Tosca Puccini si confronta per la prima volta con un’opera di ambiguità in comune. Nessun personaggio agisce limpidamente, non
azione. Perciò il passo è più veloce, i motivi ricorrenti più brevi, più certo il torbido barone siciliano, crudo oltreché scellerato sessuomane;
taglienti e più numerosi che nelle opere precedenti, e non hanno sempre ma neppure i due protagonisti (Floria e Mario) si salvano, in fondo: le
la funzione di etichette fisse… presagendo così la qualità camaleontica loro proteste d’amore appaiono, più che un tenero scambio di affetto,
che caratterizzerà certi motivi nelle opere tarde»9. Ma quello che a una celebrazione di quasi ossessiva passionalità, pronta ad esaltarsi
prima vista colpì il pubblico delle prime rappresentazioni del lavoro (in per la distruzione fisica del loro antagonista. E di conseguenza «nella
appena due anni già oltre quaranta, per la maggior parte in Italia, molte musica di Tosca la malvagità, che Puccini può guardare per la prima
però anche all’estero) non furono gli aspetti innovativi della partitura, volta con sgomento, ha i caratteri dell’impassibilità, della ripetitività, e
quelli che sono invece pienamente ravvisabili dall’odierno spettatore, più profondamente, della minaccia immobile ed informe»11.
bensì l’immersione dei personaggi di Puccini in certe atmosfere di forte
impatto visivo. Una truce scena di tortura (benché fuori ribalta), un Quella di Tosca non è partitura ‘facile’ e scorrevole, se paragonata
tentativo violenza sessuale che sfocia in un assassinio (con il macabro a Manon Lescaut e soprattutto a La bohéme. Né dal punto di vista
cerimoniale che segue), una fucilazione, infine un suicidio. Molto, per musicale, dal momento che nella sua tessitura fittissima, legata ad un
uno spettatore-tipo che non aveva ancora accostato le efferatezze che recitativo/declamato ininterrotto raramente aperto da squarci ariosi,
gli avrebbe propinato in seguito il famigerato genere del grand-guignol, i temi musicali emergono e sprofondano con me un magma vulcanico;
inaugurato qualche anno prima a Parigi.
10
F. D’Amico, L’albero del bene e del male, Lucca 2000.
8
In Giacomo Puccini, Milano 1961. 11
F. Serpa, Tosca. La croce, la morte, la tomba, Teatro Comunale di Firenze,
9
Puccini, di J. Budden, Roma 2005. stagione 2005.p. 20 p. 21
ma neppure dal punto di vista strettamente drammaturgico. Come Pinkerton della Madama Butterfly sarà trattato ancor peggio (come
abbiamo già osservato, quando Puccini aveva deciso di porre in primo tenore) dal compositore di Lucca. Il perfido Scarpia beneficia
musica il dramma di Sardou, sentiva senza ombra di dubbio la spinta invece di due monologhi che si possono considerare ampi ariosi, il
ad eguagliare le prime imprese di Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Largo religioso sostenuto di Tre sbirri… una carrozza (che confluisce
cercando di porsi sul loro stesso piano stilistico; e rispondendo ad nel sontuoso Te Deum posto a sigillo del primo atto), e l’Andante
un intento di rivalsa nei confronti di questi suoi ‘concorrenti’, in un lento Ella verrà… per amor del suo Mario che schiude il secondo. Fa
momento in cui il teatro musicale era tanto un’impresa mercantile (ed eccezione a questa regola solo l’appassionato ed ampio monologo di
un notevole investimento finanziario) oltre che un indubbio impegno Tosca, Vissi d’arte, da cantarsi «dolcissimo con grande sentimento»,
artistico. Ma le atmosfere sanguigne e scabrose del Verismo, in in un accorto gradiente di emozioni. Il compositore esitò a lungo, prima
realtà, ben poco si addicevano alla più delicata vena creativa del di inserire un così vasto assolo che blocca l’azione in un momento di
compositore toscano, che seppe trovare per la sua Tosca (come grande concitazione emotiva: ma contava su una rilevante capacità
vedremo) una via di mezzo tra le due diverse sensibilità. «È anche per di recitazione da parte dell’interprete, e proprio per questo costellò
questa sua intenzionalità, che in qualche modo forzava la mano della il pentagramma di una grande quantità di indicazioni agogiche, sia
sua più intima natura di musicista, che la Tosca avrebbe mostrato per l’interprete sia per l’orchestra: una pletora di piano, pianissimo,
in seguito […] una coesione diversa dalla perfezione della Bohéme, dolcissimo, con grande sentimento, e con precisi suggerimenti per le
momenti meno levigati e in genere un materiale musicale di spessore necessarie prese di fiato. Non a caso, Vissi d’arte la troviamo inclusa
più grosso, una melodiosità più sanguigna e più ruvida, un’intonazione d’obbligo nei recital di tutti i grandi soprano.
a momenti più incline agli effetti violenti ed immediati che non alla Abbondano in compenso nel capolavoro pucciniano (eredità
paziente decantazione poetica» 12. ineludibile del testo originale di Sardou)i dialoghi melodici tra due
personaggi, all’interno dei quali trovano spazio tante arie ‘in miniatura’.
Musicalmente parlando, molte sono nella partitura le melodie che Si vedano, nei duetti tra i due amanti, la tenera invocazione di Floria
vanno e vengono, riaffiorano all’improvviso, raramente dispiegandosi Non la sospiri la nostra casetta al primo atto; oppure i cunei effusivi di
nella loro interezza. Un tessuto musicale continuo, senza una trama O dolci mani e di Amaro sol per te proposti dal pittore, nel terzo atto.
tradizionale di ‘episodi’, con una raffinata elaborazione di intrecci Quanto alla lunga scena tra la protagonista e il brutale capo degli sbirri
motivici volta a realizzare una pertinente coloritura, oltre che papalini, che occupa una buona porzione del secondo atto, per la sua
una continua varietà di effetti sonori. Sembrerebbe a prima vista dirompente forza drammatica la si può considerare come uno dei più
economia di scala, un’ingannevole semplicità di costruzione: in realtà alti ed appassionanti momenti del melodramma del primo Novecento.
Puccini è un architetto abilissimo e di gusto finissimo, creatore di Anzi d’ogni tempo, a ben vedere. Con buona pace di qualche residuo
melodie avvolgenti e vertiginose, un concertatore prodigioso, capace detrattore dell’arte pucciniana.
di «una estrema economia del materiale tematico in situazioni di
costante mutamento… con un risultato apparentemente scritto ‘di
getto’ mentre in realtà Tosca, come le sue altre opere, è risultato di
una soffertissima elaborazione»13.
Come quasi sempre in Puccini, mancano quasi del tutto in questa sua
quinta opera le vere, grandi arie solistiche, indice dell’insofferenza
nei confronti delle consuetudini ‘canoniche’. Tutta la prima breve
apertura lirica di Mario (Recondita armonia) la scopriamo raffreddata
dai borbottii del sagrestano (“a mezza voce brontolando”, indica
la partitura per i suoi pertichini); quanto allo slancio poetico di E
lucean le stelle, dura anch’esso poco più di un amen. Solo l’antipatico
12
L. Pinzauti, Puccini: una vita, Firenze 1974.
13
G. Dotto, Condìte armonie, Teatro La Fenice di Venezia, stagione 2001/2002.l’Ouverture 1812 di Cajkovskij (1880) e all’inizio di Otello.
Il compito delle campane è da ritenersi decisivo per la ‘tinta’ dell’opera, fin dallo
p. 22 p. 23
scorcio in cui il sagrestano recita l’Angelus (il cui trattamento musicale ricorda molto
L’orchestra daperché
vicino la scena
campanain cui Falstaff ode ididodici
è catalizzatrice tocchi della mezzanotte
un atteggiamento superstiziosotravestito da «Cac-
di Michele Girardi ciatore nero», le
in ambedue forse perché la
situazioni). Nelcampana
mattutinoè dell’atto
catalizzatrice
terzo di un atteggiamento
Puccini ideò supersti-
(su gentile concessione gratuita del Gran Teatro La Fenice) un effetto di spazialità del suono da manuale d’orchestrazione; per
zioso in ambedue le situazioni). Nel mattutino dell’atto terzo Puccini ideò un effetto d
realizzarlo è necessario un set di campane che dovrebbero occupare
spazialità del suono da manuale d’orchestrazione; per realizzarlo è necessario un set d
Puccini trattò l’orchestra di Tosca in maniera peculiare. Se in Manon otto diverse posizioni distendendosi su quattordici differenti altezze,
Lescaut aveva puntato particolarmente sull’uso di strumenti fuori
campane
secondoche dovrebbero
uno schema basatooccupare
sullaotto diverse posizioni
lontananza distendendosi
e sulla vicinanza dei su quattordic
registro, raddoppi melodici e sonorità impastate, e nella Bohème differenti
rintocchi (l’ultima nota è il Mi grave del ‘campanone’ di San Pietro che,vicinanza dei rin-
altezze, secondo uno schema basato sulla lontananza e sulla
sulla decantazione delle tinte, nell’opera romana si trovava di fronte tocchi (l’ultima
secondo Luiginota
Ricci,è «va
il Micollocato
grave delal ‘campanone’ di San Pietro
centro del palcoscenico, che, la
dietro secondo Luigi Ric-
al problema di rappresentare un’azione in continuo divenire, e aveva ci, dipinta
«va collocato
cupola dialSan
centro del palcoscenico, dietro la dipinta cupola di San Pietro»):
Pietro»):
quindi bisogno di realizzare un commento musicale in cui i temi meno lontano meno vicino più lontano.........................................................
più vicino........................ lontano...............................
entrassero in gioco grazie alla loro stessa costituzione, piegandosi ai 5 5 6
8 8 8 3 3 3
4 4 4 4
7 7
4
7
4
7 7
8 8 8 8 vicino.................................................
numerosi cambiamenti di stati d’animo e ai frequenti colpi di scena 1 1
lontanissimo
7 7
vicino.......
7 5 5
meno lontano
più vicino.......................
1 1 1 1 1
lontanissimo................................................................. molto lontano.........
(secondo gli schemi di un ‘giallo’ d’impronta ‘politica’). Anche le 3
2
melodie più ampie sono formate da cellule di piccole dimensioni, che 3 3
lontano.......................................
vivono autonomamente nel tessuto orchestrale e contribuiscono in
modo decisivo a determinare il clima del lavoro. Puccini seppe
Puccini seppe anche trarre
trarrepartito
partitodall’isolamento
dall’isolamento didi timbri
timbri puri, e realizzare per lo
Puccini usò il timbro sia per fissare ‘realisticamente’ l’atmosfera, che ro realizzare per loro tramite
tramite collegamenti collegamenti
pregnanti ad altripregnanti
topoi deladmelodramma.
altri topoi del Un esempio, per
spesso passa dallo sfondo al primo piano (non solo l’alba romana melodramma.
chiudere, Un esempio,
sul clarinetto per chiudere,
che intona la melodiasul più
clarinetto
famosache intona la «E lucean le stel
dell’opera,
dell’atto terzo, ma anche il clima chiesastico che affumica d’incenso melodia più famosa dell’opera, «E lucean le stelle». Anche nell’atto
le».secondo
Anche nell’atto secondo della Traviata il clarinetto accompagnava la stesura della
della Traviata il clarinetto accompagnava la stesura della
la trama e in particolare il solenne Te Deum del finale primo), sia per
mettere in fila gli indizi su cui si sviluppa la macchinazione, sin nel
lettera
letterad’addio
d’addioperperAlfredo
Alfredo da
da parte
parte didi Violetta.
Violetta.L’appassionato
L’appassionatocogliecoglie istintivamente
minimo dettaglio. Un solo esempio: nell’istante prima che Floria ceda unaistintivamente
sorta d’analogia fra le d’analogia
una sorta due situazioni
fra legrazie a quel timbro,
due situazioni grazie ae quel
al carattere disperato
al ricatto di Scarpia nel finale secondo, il suo rovello è rappresentato di timbro,
entrambe e allecarattere
melodie.disperato di entrambe le melodie.
da una semplice terza minore La-Do, suggerita da legni e archi gravi;
il dettaglio potrebbe sfuggire se, poco dopo, mentre il barone cerca
l’intesa segreta con Spoletta e gli trasmette l’ordine falso, lo stesso
intervallo non fosse intonato con molta enfasi un tono sopra anche da
trombe e tromboni. In quel momento s’imprime nelle orecchie dello
spettatore che, quando udrà dagli archi la terza (maggiore: La-Do)
prima della fucilazione di Cavaradossi e subito dopo dai tromboni (Re-
Fa), non avrà difficoltà a collegare i due punti come parte di un unico
disegno criminoso, e a recepire come una tragica gag l’esclamazione
ammirata di Tosca («Là! Muori! / Ecco un artista!»).
Un ruolo importante è affidato agli strumenti in scena nella cerimonia
solenne che chiude l’atto primo; lo scorcio richiede quattro corni
e tre tromboni – il cui timbro rafforza la suggestione del richiamo
liturgico insieme a quello dell’organo – che si uniscono alla grancassa
e al cannone, un aerofono a suono indeterminato già comparso
nell’Ouverture 1812 di Cajkovskij (1880) e all’inizio di Otello.
Il compito delle campane è da ritenersi decisivo per la ‘tinta’ dell’opera,
fin dallo scorcio in cui il sagrestano recita l’Angelus (il cui trattamento
musicale ricorda molto da vicino la scena in cui Falstaff ode i dodici
tocchi della mezzanotte travestito da «Cacciatore nero», forsep. 24 p. 25
Le voci tutelato l’effetto della perversione sessuale sadica che lo anima,
di Michele Girardi perché destinato a scoppiare all’improvviso, con un contrasto da cui
(su gentile concessione gratuita del Gran Teatro La Fenice) il dramma trae giovamento. Un mostro sì, ma in guanti gialli.
A fronte di due personaggi così fortemente caratterizzati, Mario
Floria Tosca domina la scena fin da quando la si ode, da fuori, reclamare Cavaradossi si è visto rimproverare l’indole ‘debole’: sin troppo
la piena attenzione del suo amante. Non è un carattere sfumato, anzi: accondiscendente con la sua donna, sale a un eroico Si3 quando
pienamente volitiva è lei che, inseguendo l’idra fosca della gelosia (la proclama di voler mettere in gioco la sua vita pur di salvare Angelotti
stessa malattia di Otello), mette i poliziotti sulle tracce di Angelotti («La vita mi costasse»), e al La3 quando canta «Vittoria», rianimatosi
e, così facendo, inguaia Cavaradossi, causandone l’arresto. La dopo aver subìto la tortura, ma in ambedue i casi più per concessione
tessitura è di due ottave piene, sfruttate per intero. Il suo impegno è al rango tenorile, che per una reale forza interiore. Persino il suo
particolarmente improbo nell’atto secondo, non solo per la frequente rifiuto di un sacerdote viene considerato un gesto blando per un
emissione del Do5, ma perché la voce deve sovrastare la piena vero laico, più interessato alle gonne che alle nobili cause. Credo
orchestra, spesso spinta a tutta forza. Per vigore di carattere, unita invece che si tratti non solo di un personaggio di alto profilo morale,
a un candore sin troppo esibito, è protagonista di un livello diverso ma anche del carattere più moderno di tutta l’opera: il secco no
rispetto alle colleghe pucciniane, tanto che si ravvisano in lei i tratti che oppone ai conforti religiosi basta e avanza, specie se si guarda
eroici delle prime donne verdiane, che l’infiammano, condizionandone al contesto, per qualificarlo come un nobile oppositore a ‘valori’
la vocalità. Se non vi è dubbio che nell’espressione canora la parte sin troppo distruttivi; è tanto laico da ritenere impossibile che una
erediti i tratti delle Leonore, Amelie e altri personaggi femminili di donna giovane e affascinante si rechi in chiesa per pregare, ma
Verdi, tanto che la migliore interprete moderna del ruolo, Leontyne dalla bellezza dell’Attavanti trae solo la conferma della passione che
Price, proviene da quei ranghi, tuttavia una sorta di ‘mal sottile’ lo lega a Floria, sulla base dei valori materiali che stanno alla base
morale che l’invade – non solo la gelosia, ma anche il bigottismo, e una della sua etica, gli stessi che lo portano a proteggere un perseguitato
certa fragilità che la condiziona nello scontro diretto col barone – è politico rischiando la vita, e a rimpiangere, in punto di morte, l’ultima
espressione tipica dell’estetica drammatica di notte d’erotismo passata con Tosca. È Mario, del resto, a intonare la
Puccini. melodia più importante dell’opera, quei dolci baci e languide carezze
Tosca trova il suo Jago nel barone Vitellio che l’orchestra perora fragorosamente dopo che Floria si è gettata
Scarpia, parte di baritono sovente spinta agli dai bastioni di Castel Sant’Angelo, legando il proprio suicidio al
estremi vocali acuti, che ne mettono in rilievo sentimento sensuale dell’amante, che resta l’unico autentico valore
la forza perversa nel momento dell’eccitazione, da rimpiangere in un mondo che ha fatto del cinismo bigotto la sua
così come quando deve far valere le ragioni del unica regola.
perbenismo al suo ingresso in Sant’Andrea Tosca schiera un ampio panorama di comprimari, ai quali non viene
della Valle (è certo preferibile danzare in richiesta una particolare prestanza vocale, a eccezione di qualche
chiesa per la gioia di un «doppio soldo», come passaggio più impegnativo per Angelotti, mentre devono essere
fanno i chierici, che andarci per dare la caccia tutti buoni attori. Una battuta impagabile come quella di Sciarrone
a un perseguitato politico, con la speranza di che, quando Scarpia gli ordina di sciogliere Cavaradossi dai nodi
raccogliere qualche preda femminile grazie al della tortura, chiede, con un qualche rimpianto «Tutto?» deve essere
proprio potere). La parte, come peraltro l’intero pronunciata con intenzione, perché fa parte di quella romanità
cast di Tosca, richiede un cantante-attore di papalina intrigante degli sbirri, come il «Fiuto!… Razzolo!… Frugo!…»
prim’ordine, ma non uno dei troppi urlatori di Spoletta. Di solito, in mancanza di una voce bianca all’altezza, lo
di cui è stata appannaggio per tradizione. Il stornello romanesco viene affidato a una donna, ed è un peccato:
potere che questo losco figuro esercita, se la voce di un bimbo è una luce preziosa d’innocenza proiettata in
pur fondato sulla forza, esige anche astuzia e un panorama fosco e oppressivo, di cui smaschera la sostanziale
buone maniere, e la capacità di persuadere depravazione.
quando è il caso. In questo modo viene megliop. 26 p. 27
Rappresentazioni di TOSCA 1943
Recite straordinarie
al Teatro Mario Del Monaco di Treviso 7/8 dicembre
di Iorio Zennaro FLORIA TOSCA Maria Carbone
MARIO CAVARADOSSI Antonio Salvarezza
1900 IL BARONE SCARPIA Enrico De Franceschi
Stagione di autunno (23 ottobre – 11 novembre) DIRETTORE Manrico De Tura
23/25/27/28/30 ottobre - 1/3/4/6/8/10/11 novembre M° DEL CORO Adolfo Fanfani
FLORIA TOSCA Ada Giacchetti REGIA Arsenio Giunta
MARIO CAVARADOSSI Enrico Caruso
IL BARONE SCARPIA Antonio Magini Coletti 1945
CESARE ANGELOTTI Silvio Beccucci Stagione di autunno (8 – 18 novembre)
IL SAGRESTANO Ettore Borelli 8 novembre
SPOLETTA Carlo Ragni FLORIA TOSCA Lina Berti
SCIARRONE Silvio Beccucci MARIO CAVARADOSSI Mario Del Monaco
DIRETTORE Egisto Tango IL BARONE SCARPIA Antenore Reali
M° DEL CORO Gioacchino Marin DIRETTORE Manno Wolf-Ferrari
DIRETTORE DI SCENA Napoleone Carotini (2 recite)
1929 1958
Stagione di autunno (3 – 11 novembre) Stagione di quaresima (27 – 30 marzo)
6 novembre 27 marzo
FLORIA TOSCA Bianca Scacciati FLORIA TOSCA Rita Saponaro
MARIO CAVARADOSSI Antonio Melandri MARIO CAVARADOSSI Giuseppe Savio
IL BARONE SCARPIA Gino Lulli IL BARONE SCARPIA Domenico Malatesta
DIRETTORE Giacomo Armani DIRETTORE Alfredo Strano
(3 recite)
M° DEL CORO Sante Zanon 1965
DIRETTORE DI SCENA Italo Capuzzo Stagione di primavera sotto il patrocinio dell’ENAL (13 – 16 maggio)
13/16 maggio
FLORIA TOSCA Bornigia Paola Perali/
1938 Maria Angela Rosati
Stagione di autunno (3 – 11 novembre) MARIO CAVARADOSSI Franco Castellana
5 novembre IL BARONE SCARPIA Giovanni Ciminelli
FLORIA TOSCA Margherita Grandi CESARE ANGELOTTI Franco Federici
MARIO CAVARADOSSI Giuseppe Lugo IL SAGRESTANO/SCIARRONE Giorgio Onesti
IL BARONE SCARPIA Luigi Rossi Morelli SPOLETTA Gabriele De Julis
DIRETTORE Antonino Votto DIRETTORE Ottavio Ziino
(2 recite) REGIA Carlo Acly Azzolini
M° DEL CORO Everardo Bernardelli
1941
Stagione di autunno (9 – 16 novembre)
15/16 novembre
FLORIA TOSCA Eleonora Visciola
MARIO CAVARADOSSI Giovanni Malipiero
IL BARONE SCARPIA Vincenzo Guicciardi
DIRETTORE Giovanni Frattini
M° DEL CORO Giuseppe Caleffap. 28 p. 29
1967 1989
I. Autunno Musicale Trevigiano (3 novembre – 3 dicembre) Autunno Musicale Trevigiano (19 settembre – 17 dicembre)
10/12 novembre 27/29/31 ottobre
FLORIA TOSCA Orianna Santunione FLORIA TOSCA Giovanna Casolla
MARIO CAVARADOSSI Amedeo Zambon MARIO CAVARADOSSI Nunzio Todisco
IL BARONE SCARPIA Mario Zanasi IL BARONE SCARPIA Silvano Carroli
CESARE ANGELOTTI Alessandro Maddalena CESARE ANGELOTTI Giovanni Antonini
IL SAGRESTANO Virgilio Carbonari IL SAGRESTANO Giancarlo Ceccarini
SPOLETTA Augusto Pedroni SPOLETTA Romano Emili
SCIARRONE Bruno Grella SCIARRONE Adriano Tomaello
UN CARCERIERE Attilio Barbesi UN CARCERIERE Roberto Santini
DIRETTORE Ugo Rapalo UN PASTORE Grazia Patella
REGIA Antonello Madau Diaz DIRETTORE Sandro Sanna
REGIA Stefano Piacenti
1974
Autunno Musicale Trevigiano (9 ottobre – 22 dicembre) 1996
6/8/10 novembre Autunno Musicale Trevigiano (27 settembre – 30 novembre)
FLORIA TOSCA Gianna Galli 25/27 ottobre
MARIO CAVARADOSSI Ruggero Bondino FLORIA TOSCA Jeanne-Michele Charbonnet
IL BARONE SCARPIA Mario Sereni MARIO CAVARADOSSI Alberto Cupido
CESARE ANGELOTTI Giovanni Antonini IL BARONE SCARPIA Francesco Ellero D’Artegna/
IL SAGRESTANO Giorgio Tadeo Silvano Carroli [27.10]
SPOLETTA Franco Ricciardi CESARE ANGELOTTI Armando Caforio/
SCIARRONE Carlo Proverbio Frano Lufi [27.10]
UN CARCERIERE Bruno Tessari IL SAGRESTANO Alfredo Mariotti
DIRETTORE Carlo Franci SPOLETTA Enrico Cossutta/
REGIA Filippo Crivelli Iorio Zennaro [27.10]
SCIARRONE Davide Rocca
UN CARCERIERE Frano Lufi/
1980 Riccardo Iacopone [27.10]
Autunno Musicale Trevigiano (19 ottobre – 19 dicembre) UN PASTORE Rachele Sacco
24/26/28/30 ottobre DIRETTORE Maurizio Arena
FLORIA TOSCA Giovanna Casolla REGIA Bepi Morassi
MARIO CAVARADOSSI Ottavio Garaventa
IL BARONE SCARPIA Kari Nurmela [Produzione proveniente dal Teatro “La Fenice” di Venezia]
CESARE ANGELOTTI Giovanni Antonini (2 recite)
IL SAGRESTANO Guido Mazzini
SPOLETTA Aronne Ceroni
SCIARRONE Bruno Tessari
UN CARCERIERE Gianni Brunelli
DIRETTORE Roberto Manfredini
REGIA Dario Dalla Cortep. 30 p. 31
2008 Gli interpreti di Lammermoor all’Opéra de Fondazione Arena di Verona
Teatro Comunale Toulon, Nabucco alla Deutsche in due importanti produzioni.
7/8/9 novembre – 6 novembre (Anteprima giovani) Oper di Berlino, La bohème al Dirige inoltre il Coro Lirico
FLORIA TOSCA Antonia Cifrone/ Teatro La Fenice di Venezia, Veneto e importanti gruppi
Olga Perrier * [6/9.11] Rigoletto alla Semperoper di amatoriali come Insieme Corale
MARIO CAVARADOSSI Alejandro Roy/ Dresda, L’elisir d’amore allo Ecclesia Nova, il Coro Maschile
Sferisterio di Macerata, La La Stele e il Coro Marc’Antonio
Lorenzo Decaro * [6/9.11] Traviata alla Oper Frankfurt, Ingegneri di Verona.
IL BARONE SCARPIA Giuseppe Altomare/ West Side Story al Maggio Guida sin dalla sua fondazione
Claudio Sgura [6/8.11] Musicale Fiorentino; tra l’Accademia di Direzione Corale
CESARE ANGELOTTI Alessandro Spina/ gli impegni futuri Macbeth “Piergiorgio Righele”, dove è
Desaret Lika [6/9.11] all’Opernhaus di Zurigo, 7 minuti docente principale di tecnica
IL SAGRESTANO Mirko Quarello * (nuova opera di Battistelli) e concertazione. È invitato
SPOLETTA Massimo Cagnin all’Opéra National de Lorraine nelle giurie di prestigiosi
SCIARRONE Siro Antonelli di Nancy, La Favorite a Palermo, concorsi ed è chiamato a tenere
UN CARCERIERE William Corrò Francesco Lanzillotta La Traviata a Venezia, Le nozze masterclass di canto corale, di
UN PASTORE Valeria Cazacu maestro concertatore di Figaro a Mosca, Carmen direzione e sulla leadership.
e direttore a Macerata; una nuova Fa parte della Commissione
DIRETTORE Giampaolo Bisanti
È considerato uno dei più produzione de Il viaggio a Reims Artistica dell’ASAC Veneto e
REGIA Massimo Gasparon alla Semperoper di Dresda e Le collabora con le più importanti
interessanti giovani direttori
* (Vincitori del XXXVIII Concorso Internazionale per cantanti “Toti Dal Monte” Treviso 2008) nel panorama musicale italiano. nozze di Figaro a Pechino. Tra istituzioni corali nazionali e
Ha diretto nei più importanti gli impegni futuri: Risurrezione internazionali. È direttore
teatri italiani ed è regolarmente a Firenze, Il viaggio a Reims a artistico del Festival corale
ospite di importanti compagini Valencia, Un ballo in maschera internazionale “VOCE!” e
orchestrali, fra le quali a Budapest, Rigoletto ad del Festival della vocalità
l’Orchestra Nazionale della RAI Amburgo, Tosca a Macerata, “Dodekantus”.
di Torino, Orchestra Haydn di Aida a Brisbane, L’elisir d’amore
Bolzano, Filarmonica Toscanini a Monaco.
di Parma, Orchestra Regionale È regolarmente invitato
Toscana. È stato direttore dalla Tokyo Philharmonic,
musicale dell’Orchestra dall’Orchestra Rai di Torino,
Filarmonica Toscanini per dalla Czech Philharmonic.
quattro anni, e continua
con questa Istituzione una
collaborazione regolare per
altri progetti.
Si dedica intensamente alla
musica del XX secolo e all’opera
contemporanea. Ha inaugurato
il Macerata Opera Festival Livia Rado
nel 2015 dirigendo Rigoletto maestro del coro
e nel 2017 viene nominato di Voci Bianche
Direttore Musicale del Festival. Si distingue per la sua attività
Nella stagione 2016-17 ottiene costantemente rivolta al
grande successo nel debutto repertorio contemporaneo,
con la Tokyo Philharmonic Matteo Valbusa avendo eseguito numerosissime
Orchestra, all’Opera Nazionale maestro del coro prime assolute di compositori
di Montpellier, al Teatro Direttore d’orchestra, maestro provenienti da tutto il mondo.
dell’Opera di Essen, nelle di coro e insegnante. Dopo la Voce dell’Ensemble L’arsenale,
produzioni di Roberto Devereux maturità classica, si è laureato ha collaborato inoltre con gli
con Mariella Devia a Genova e brillantemente in Scienze dei ensemble Algoritmo, Prometeo,
Mosca, nella Norma a Tokyo e beni culturali, Direzione di Contempoartensemble,
al Rossini Opera Festival con Coro e Direzione d’Orchestra, Ex Novo, RepertorioZero,
Torvaldo e Dorliska, in cui viene perfezionandosi in decine di Eutopia, Ensemble U, Hyoid,
unanimemente acclamato dalla corsi e masterclass in tutta Aton et Armide. Si è esibita
critica. Europa. per La Biennale di Venezia,
ENRICO CARUSO “Mario Cavaradossi” e ETTORE BORELLI (il sagrestano) nel suo Tra gli impegni recenti: Lucia Nel 2019 ha diretto il Coro della Nuova Consonanza (Roma),
debutto in TOSCA al Teatro di Treviso (23 ottobre 1900)Puoi anche leggere