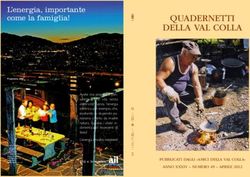CONSEGNE ESTIVE DI ITALIANO
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Reggio Emilia, giugno 2021
CONSEGNE ESTIVE DI ITALIANO
Carissimi ragazzi e carissime ragazze,
innanzitutto i docenti di italiano del Blaise Pascal si complimentano con voi per l'avvenuta
promozione e la positiva conclusione del vostro percorso alla scuola media inferiore! Sicuramente
questo successo è frutto del grande impegno e del costante lavoro svolto insieme ai vostri
insegnanti, che vi hanno condotto ad affacciarvi all'inizio di un nuovo percorso. Ecco, noi siamo qui
per accogliervi con gioia e per sostenervi in questo nuovo inizio.
Abbiamo scelto per voi alcune letture, corredate da esercizi di analisi, con lo scopo di
fornirvi del materiale di accompagnamento nell'ingresso a scuola del prossimo settembre. Durante
l'estate, vi chiediamo di leggere con attenzione e svolgere con cura le consegne indicate, poiché
tutto questo materiale sarà ripreso insieme a voi in classe e sarà il nostro primo strumento di
studio comune.
Auguriamo a ciascuno di voi e alle vostre famiglie una serena estate!
I docenti di italiano del Blaise Pascal
L'unica gioia al mondo è cominciare. È
bello vivere perché è cominciare, sempre, ad
ogni istante (Cesare Pavese)SEZIONE LETTURE Leggi con attenzione i racconti e svolgi le attività indicate: 1. Massimo Bontempelli, Il ladro Luca Attività di comprensione ad analisi della struttura narrativa: dividi in sequenze e dai un titolo nominale ad ogni sequenza, scrivendo direttamente a fianco del testo. 2. Dino Buzzati, Il colombre Attività di interpretazione: qual è secondo te il significato di questo racconto? Qual è il messaggio che l'autore vuole comunicare? E tu cosa ne pensi? (documento Word, interlinea singola, Calibri 11, testo giustificato) 3. Guy de Maupassant, L'orfano Attività di scrittura argomentativ: in base alla lettura del brano, ritieni che l'orfano sia innocente o colpevole? Esponi la tua opinione citando gli elementi del racconto che possono avvalorare il tuo pensiero (documento Word, interlinea singola, Calibri 11, testo giustificato) 4. Italo Calvino, Furto in una pasticceria Attività di scrittura: riassumi il racconto (documento Word, max una facciata, calibri 11, interlinea singola, testo giustificato) 5. Stefano Benni, La chitarra magica Simulazione test Invalsi: svolgi gli esercizi allegati al racconto 6. Dino Buzzati, Il mantello Attività di manipolazione e riscrittura del testo: cambia il finale al racconto, iniziando la tua modifica dalla frase seguente: "Poi la fissò con uno sguardo da cavare l'anima. Si avvicinò alla porta ..."
Il ladro Luca di Massimo Bontempelli
Al ladro Luca, nella notte annuvolata, bastò la luce d'un quarto di luna e di poche stelle per
scendere in una casa dall'abbaìno e farvi un bottino di prim'ordine. Ora ne riusciva con piena
la sacca e l'animo contento. Alzò gli occhi un attimo al cielo che si stava sgombrando, poi
guardò il tetto lentamente in giro. Tutto il mondo era in silenzio e vuoto, non c'era nel mondo
5 altro che lui, Luca, su quel tetto vicino al cielo.
Sentiva stanche le reni e il cuore in pace. Non c'è più da aver paura di niente. Fermata bene la
sacca alle spalle, s'accomodò a sedere sopra le tegole, e appoggiato un braccio alla parete
dell'abbaìno si concesse cinque minuti di riposo.
Nessuno dei suoi compagni ha mai fatto un bottino tanto importante. L’abbaìno sorgeva al
10 mezzo del vasto pendio di tegole che sale dall'orlo del tetto alla cresta. Luca dall'abbaìno,
volgendosi verso l'alto, vedeva quella linea lunga del vertice tagliare il cielo; guardando avanti
e intorno a sé, l'immensa distesa del pendio fino all'altro lato del palazzo, interrotta solo da un
comignolo, in basso quasi addosso al cornicione.
La vista delle tegole lo riposava. Lui sa camminare sui tetti come un gatto. Pregustava la
15 meraviglia dei suoi compagni (biancheria ricamata, seta, argenteria) e forse un elogio del
Capo.
Il ladro Luca senza bisogno d'orologio misurava il tempo a perfezione. Quando i cinque minuti
furono passati, Luca staccò il braccio dalla parete, provò la resistenza delle cinghie della sacca,
poggiò una mano a terra per darsi la spinta a mettersi in piedi. Ma girando frattanto lo
20 sguardo verso la cresta del tetto, agghiacciò.
Da dietro quel vertice era spuntata una testa grossa e nera, due occhi lucidi attraverso l'ombra
lo saettarono, poi di colpo un uomo fu in piedi sulla sommità del tetto col braccio teso e la
rivoltella puntata verso Luca, e nel silenzio sonò il suo comando: «Mani in alto!» Il ladro Luca
alzò tremando le braccia. «E fermo!» aggiunse costui. Senza gridare, le sue parole ferivano
25 l'aria e arrivavano taglienti all'orecchio di Luca che sentiva il cuore battere in petto come se si
spezzasse: avrebbe voluto abbassare una mano per tenerselo fermo. Aveva riconosciuto
l'uomo, era uno dei poliziotti più abili e implacabili della città.
Si guardarono per forse dieci secondi. Lo sbirro fissava Luca negli occhi, Luca guardava l'altro
alle ginocchia, e le braccia ogni tanto stavano per ricadergli giù, ma lui con uno sforzo le
30 rimetteva subito in alto.
In quei dieci secondi passò per la fantasia di Luca una ventata rapida di immagini: il contatto
con le mani orride dello sbirro, il bottino nella sacca, le manette, poi lo sapranno i compagni e
il Capo: tutte mescolate e scompigliate nel soffio della paura.
Lo sbirro s'ergeva verso la parte estrema della cresta del tetto.
35 Ora avanzò di qualche passo; in mezzo alla paura il ladro Luca ebbe modo d’accorgersi che il
piede dell'altro non padroneggiava a fondo la tegola. Forse per questo l'altro ora stava fermo;
s'era piantato sui due piedi, con le corte gambe un po' aperte.
E parlò a Luca, sempre con quella rivoltella spianata: «Attenzione a quello che dico: Alzati,
vieni qua, mani in alto; al primo moto che fai per abbassarle o per cambiare direzione, sparo.
Forza, don Luca!»
40 Mentre quello parlava il ladro Luca aveva infatti rapidamente esaminato la possibilità di
buttarsi a destra verso il cornicione, ma il colpo dell'arma lo avrebbe raggiunto. Scomparire
nell'abbaìno era mettersi in trappola. Non poteva che ubbidire.
Riuscì a levarsi in piedi senza servirsi delle braccia. Poi, ma lentamente (per non rivelareall'altro la propria agilità, per allontanare il più possibile il momento in cui si sarebbe sentito
45 addosso quelle mani, per un istinto professionale di finzione), passo passo cominciò a salire
obliquamente il tetto in direzione di quella rivoltella. Le mani gli tremavano. «Più svelto»,
disse lo sbirro con un sogghigno «pesa tanto quella sacca? Più svelto». Il ladro Luca voleva
rispondere ma non poté che mandar fuori qualche sillaba fioca: si rese conto che non aveva
ancora detto una parola. Fece qualche altro passo incespicando ad arte nelle commessure
50 delle tegole.
«Avanti, don Luca, hai lavorato bene, è giusto che ti porti a dormire. Altrimenti...»
Il cuore di Luca balzò di sorpresa e di gioia, perché lo sbirro per un piccolo moto del piede
aveva barcollato un attimo ed era precipitato scivolando sulle tegole. Subito Luca vide il grosso
corpo rotolare giù per la china del tetto, egli allora si mise a correre su verso la cima. L’altro,
55 smarrito, s'afferrò con la sinistra a una tegola ma questa si staccò di netto e lui mandò un
gemito sentendosi straziare le unghie alla radice; tentò invano di afferrarsi con l'altra che
lasciò andare la rivoltella, rotolò ancora, batté la testa contro il comignolo ma non si fermò; e
il ladro Luca raggiunta la cima si voltò e vide lo sbirro arrivare all'orlo della discesa e il suo
corpo scomparire nel vuoto.
60 Lo invase una folgorante felicità. Fissò allucinato il punto laggiù dove il corpo del nemico era
scomparso.
E, così guardando, s’avvide che non era scomparso tutto: le due mani dello sbirro erano
rimaste afferrate all'orlo del cornicione e furiosamente si sforzavano di tenersi strette. Luca
sedette sulla cima del tetto a fissare quelle due mani grosse, sempre più nere e convulse.
65 Aspettava, prima d'andarsene, di vederle scomparire. Quella sua felicità, che per un minuto
aveva forse raggiunto il delirio, s'era calmata. Ora il ladro Luca era sicuro e tranquillo, stava
seduto col busto e il capo un poco protesi in avanti, come si sta a teatro nei momenti più
ansiosi del dramma. Si figurava il corpo pendente là sotto, il corpo del nemico che tra poco
precipiterà giù a sfracellarsi sul lastrico. Tese l'orecchio per essere pronto a sentire il tonfo.
70 Una di quelle due mani non resse più allo sforzo e si staccò dal cornicione, subito tutta la forza
e lo spasimo dell'uomo si raccolsero per un momento nell'altra, poi la prima tornò ad
afferrarsi e l'altra si staccò e s'agitava nell'aria.
D’improvviso qualche cosa d'ignoto brillò nell'animo del ladro Luca, ed era assai diverso dal
delirio di quella prima felicità. Chiuse e strinse gli occhi e subito li riaperse: di laggiù sentì un
75 rantolo, e pareva venisse da quelle mani. Il ladro Luca non capiva più niente, ma senza capire,
di colpo s'alzò, in un lampo sfilò dalle spalle la sacca e la posò sulle tegole; un'altra volta chiuse
e riaprì per un attimo gli occhi, si passò una mano sulla fronte, e senza sapere perché, senza
sentire quello che stava facendo, corse giù, diritto, fin là; arrivato là si gettò ventre a terra,
s'appese con una delle sue allo spigolo del comignolo, si tese in avanti, porse l'altra gridando:
80 «attaccati!», e prese la mano alzata dell'uomo che si dibatteva. La sentì stringere, la tirò a sé
con tutta la forza, come un pescatore tira la rete pesante: vide venir su la testa e le spalle, tirò
ancora: l'uomo aiutava il suo sforzo, arrivò tutto. Luca gli dette un ultimo strattone, poi aiutò
l'uomo a porsi a sedere sull'angolo del tetto.
Seguì un silenzio e la notte respirava intorno a loro. Lo sbirro fissava in giù verso l'abisso ma
85 certo non vedeva niente, il ladro Luca gli guardava la schiena ma non sapeva di guardarla. E
aveva voglia d'andarsene ormai, ma non si muoveva, come se aspettasse qualche cosa, e non
sapeva che cosa né perché.
Finalmente Io sbirro senza voltare la testa verso il compagno mormorò qualche parola, Luca
non capì e domandò: «Come?»; l'altro ripeté, sempre a capo chino: «Fa freddo». Luca si90 sentiva a disagio. L'altro si prese la testa tra le mani e cominciò a singhiozzare piano.
II ladro Luca si cercò in tasca un fiammifero e una sigaretta, la accese e la porse: «Prendi».
sbirro si voltò, e Luca vide che aveva il volto rigato di lacrime. Ripeté: «Prendi» e chinandosi gli
pose la sigaretta tra le labbra. La sigaretta tra le labbra dello sbirro tremava. Dopo un poco lo
sbirro balbettò: «Grazie» e la sigaretta gli cadde di bocca, sull'orlo del cornicione. Il ladro Luca
95 fu lesto a raccoglierla, scrollò le spalle, finì lui di fumarla. Fatto questo, come l'altro s'era di
nuovo girato in là con la faccia tra le mani, Luca s'alzò in piedi, si voltò senza più guardarlo,
risalì, in cima, dove aveva lasciato la sacca. Se la accomodò sulle spalle, scese piano l'altro
versante avviandosi verso un tubo dell'acqua per cui scivolando si scende a terra. La luna era
scomparsa e non c'era più una nuvola in cielo. Il ladro Luca pensò con orgoglio alla meraviglia
100 dei compagni, all'elogio che forse il Capo gli farà per il bottino. Prima di lasciare il tetto e
abbracciarsi al tubo, guardò una volta ancora il cielo. Aveva cento volte lavorato di notte, ma
non s'era mai accorro che ci fossero tante stelle.
1. Riassumi con le tue parole l’evento corrispondente ad ognuna delle parti indicate dal numero delle righe
e dal titolo. L’esercizio è avviato.
EVENTO ESSENZIALE IDEA CENTRALE
rr. 1-20 Il ladro Luca, su un tetto, si gode la rapina che ha Una rapina riuscita
appena messo a segno, pensando agli onori presso
gli altri ladri e presso il capo.
rr. 21-39 Un arrivo inaspettato
rr. 40-51 Il ladro braccato
rr. 52-87 Un'insperata occasione di
fuga
rr. 88-102 Lieto fine per entrambiDINO BUZZATI da : Il colombre (Oscar Mondadori, Milano, 1992) Il colombre Quando Stefano Roí compí i dodici anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. «Quando sarò grande» disse «voglio andar per mare come te. E comanderò delle navi ancora pi'u' belle e grandi della tua. » « Che Dio ti benedica, figliolo » rispose il padre. E siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole; e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele. E chiedeva di questo e di quello ai marinai che, sorridendo, gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò, incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a intermittenza in superficie, a distanza di due-trecento metri, in corrispondenza della scia della nave. Benché il bastimento già volasse, portato da un magnifico vento al giardinetto, quella cosa manteneva sempre la distanza. E, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile, che lo attraeva intensamente. Il padre, non vedendo Stefano piú in giro, dopo averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla plancia e andò a cercarlo. « Stefano, che cosa fai lí impalato? » gli chiese scorgendolo infine a poppa, in piedi, che fissava le onde. « Papà, vieni qui a vedere. » Il padre venne e guardò anche lui, nella direzione indicata dal ragazzo, ma non riuscí a vedere niente. « C'è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia » disse « e che ci viene dietro. » « Nonostante i miei quarant'anni » disse il padre « credo di avere ancora una vista buona. Ma non vedo assolutamente niente. » Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il cannocchiale e scrutò la superficie del mare, in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. « Cos'è? Perché fai quella faccia? » « Oh, non ti avessi ascoltato » esclamò il capitano. « Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque e che ci segue, non è una cosa. Quello è un colombre. E’ il pesce che i marinai sopra tutti temono, in ogni mare del mondo. E’ uno squalo tremendo e misterioso, piú astuto dell'uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima, e quando l'ha scelta la insegue per anni e anni, per una intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo: che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo stesso sangue. »« Non è una favola? » «No. Io non l'avevo mai visto. Ma dalle descrizioni che ho sentito fare tante volte, l'ho subito riconosciuto. Quel muso da bisonte, quella bocca che continuamente si apre e chiude, quei denti terribili. Stefano, non c'è dubbio, purtroppo, il colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà pace. Ascoltami: ora noi torniamo subito a terra, tu sbarcherai e non ti staccherai mai piú dalla riva, per nessuna ragione al mondo. Me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo. Devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrai fare fortuna.» Ciò detto, fece immediatamente invertire la
rotta, rientrò in porto e, coi pretesto di un improvviso malessere, sbarcò il figliolo. Quindi ripartí senza di lui. Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l'ultimo picco dell'alberatura sprofondò dietro l'orizzonte. Di là dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. Ma, aguzzando gli sguardi, Stefano riuscí a scorgere un puntino nero che affiorava a intermittenza dalle acque: il "suo" colombre, che incrociava lentamente su e giú, ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo con ogni espediente fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studiare in una città dell'interno, lontana centinaia di chilometri. E per qualche tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò piú al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive, tornò a casa e per prima cosa. appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l'estremità del molo, per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo, il colombre, ammesso anche che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all'assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di due-trecento metri dal molo, nell'aperto mare, il sinistro pesce andava su e giú, lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall'acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia guardasse se Stefano Roi finalmente veniva. Cosí, l'idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta ossessione. E anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte con inquietudine. Egli era al sicuro, sí, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre. Eppure egli sapeva che, di là dalle montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E, si fosse egli trasferito pure nel piú remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare piú vicino, con l'inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, ch'era un ragazzo serio e volonteroso, continuò con profitto gli studi e, appena fu uomo, trovò un impiego dignitoso e rimunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per malattia, il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una discreta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori: Stefano si era ormai fatto la sua vita, ciononostante il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio; e, passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi piú insistente. Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma ancora piú grande è l'attrazione dell'abisso. Aveva appena ventidue anni Stefano, quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall'impiego, tornò alla città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L'avere il figlio abbandonato il mare per la città le era sempre sembrato, in cuor suo, un tradimento alle tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la sua condanna, ma proprio per questo, forse, non trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui. « Non vedete niente da quella parte? » chiedeva di quando in quando ai compagni, indicando la scia. « No, noi non vediamo proprio niente. Perché? » « Non so. Mi pareva... » « Non avrai mica visto per caso un colombre » facevano quelli, ridendo e toccando ferro. « Perché ridete? Perché toccate ferro? »
« Perché il colombre è una bestia che non perdona. E se si mettesse a seguire questa nave, vorrebbe dire che uno di noi è perduto. » Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentí padrone del mestiere, acquistò con un socio un piccolo piroscafo da carico, quindi ne divenne il solo proprietario e, grazie a una serie di fortunate spedizioni, poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre piú ambiziosi. Ma i successi, e i milioni, non servivano a togliergli dall'animo quel continuo assillo; né mai, d'altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena, dopo lunghi tragitti, metteva piede a terra in qualche porto, subito lo pungeva l'impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c'era il colombre ad aspettarlo, e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie, da un oceano all'altro. Finché, all'improvviso, Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio, vecchissimo; e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com’era, non lasciasse finalmente la dannata vita del mare. Vecchio, e amaramente infelice, perché l’intera esistenza sua era stata spesa in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari, per sfuggire al nemico. Ma piú grande che le gioie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre la tentazione dell'abisso. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo dei porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non opporsi a ciò che egli stava per fare. L'altro, sull'onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva continuato a inseguirlo per quasi cinquant'anni, inutilmente. « Mi ha scortato da un capo all'altro del mondo » disse « con una fedeltà che neppure il piú nobile amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui, ormai, sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo. » Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi sali, dopo essersi fatto dare un arpione. « Ora gli vado incontro » annunciò. « E’ giusto che non lo deluda. Ma lotterò, con le mie ultime forze. » A stanchi colpi di remi, si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiú, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C'era in cielo una falce di luna. Non dovette faticare molto. All'im'provviso il muso orribile del colombre emerse di fianco alla barca. « Eccomi a te, finalmente » disse Stefano. « Adesso, a noi due! » E, raccogliendo le superstiti energie, alzò l'arpione per colpire. « Uh » mugolò con voce supplichevole il colombre « che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare. E tu fuggivi, fuggivi. E non hai mai capito niente. » « Perché? » fece Stefano, punto sul vivo. « Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi. Dal re del mare avevo avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo. » E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe la famosa Perla del Mare che dà, a chi la possiede, fortuna, potenza, amore, e pace dell'animo. Ma era ormai troppo tardi. « Ahimè! » disse scuotendo tristemente il capo.
«Come è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza: e ho rovinato la tua.» « Addio, pover'uomo » rispose il colombre. E sprofondò nelle acque nere per sempre. Due mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò a una dirupata scogliera. Fu avvistato da alcuni pescatori che, incuriositi, si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco scheletro: e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo. Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi, estremamente raro. A seconda dei mari, e delle genti che ne abitano le rive, viene anche chiamato kolomber, kahloubrha, kalonga, kalu-balu, chalung-gra. I naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno perfino sostiene che non esiste.
L'ORFANO, di Guy De Maupassant
Mademoiselle Source aveva adottato quel ragazzo molto tempo addietro, in circostanze assai tristi.
Aveva allora trentasei anni, e a causa della sua deformità (da bambina era scivolata dalle ginocchia della
domestica nel caminetto, e il viso, orrendamente ustionato, faceva paura a guardarlo) aveva deciso di non
maritarsi, giacché non voleva essere sposata per il suo denaro. Una vicina, rimasta vedova mentre era
incinta, morì di parto senza lasciare un soldo. Mademoiselle Source raccolse il neonato, lo diede a balia,
l'allevò, lo mandò in collegio, poi lo riprese con sé all'età di quattordici anni, per avere nella casa vuota
qualcuno che le volesse bene, che si prendesse cura di lei, che le addolcisse la vecchiaia.
Abitava in una piccola proprietà di campagna a quattro leghe da Rennes, ed ora viveva senza
domestica. Con l'arrivo dell'orfano le spese erano aumentate più del doppio, e i suoi tremila franchi di
rendita non potevano più bastare per tre persone. Accudiva lei stessa alle faccende di casa e alla cucina, e
delle commissioni incaricava il piccolo, che si occupava anche di coltivare l'orto. Il ragazzo era dolce, timido,
silenzioso ed affettuoso. Ella provava una gioia profonda, una gioia nuova ad essere abbracciata da lui,
senza vederlo sorpreso o spaventato della sua bruttezza. La chiamava zia e la trattava come una madre. La
sera sedevano insieme accanto al fuoco, ed ella gli preparava qualche ghiottoneria. Faceva scaldare un po'
di vino e abbrustolire una fetta di pane, insieme si gustavano un delizioso spuntino prima d'andare a letto.
Spesso lo prendeva sulle ginocchia e lo ricopriva di carezze sussurrandogli parole teneramente
appassionate. Lo chiamava :- Fiorellino mio, mio cherubino, angelo dorato, mio tesoro -. Egli la lasciava fare
dolcemente, nascondendo la testa sulla spalla della zitella. Sebbene fosse ora vicino ai quindici anni, era
rimasto gracile e mingherlino, con un'aria un po' malaticcia.
Talvolta Mademoiselle Source lo conduceva con sé in città a trovare due sue lontane cugine,
maritate in un sobborgo: le sole parenti che avesse. Le due donne le serbavano sempre rancore perché
aveva adottato quel bimbo, per via dell'eredità: ma la ricevevano lo stesso con premura, sperando ancora
nella loro parte, un terzo probabilmente, se la successione veniva divisa in parti uguali.
Ella era felice, molto felice, continuamente assorbita dal suo ragazzo. Gli comprò dei libri per
coltivargli la mente, ed egli cominciò a leggere con avidità. La sera, ora, non le saliva più sulle ginocchia per
accarezzarla come faceva una volta: ma sedeva in fretta sulla sua seggiolina accanto al caminetto, e apriva
un volume. La lampada che stava sulla mensola del caminetto, sopra la sua testa, gli illuminava i capelli
ricciuti e una parte della fronte; non si muoveva più, non alzava gli occhi, non faceva un gesto: leggeva,
immerso, interamente assorto nell'avventura del libro. Seduta di fronte a lui, la zitella lo contemplava con
uno sguardo ardente e fisso, stupita della sua attenzione, gelosa, spesso sul punto di piangere. Ogni tanto
gli diceva :- Ti stancherai, tesoro mio! - sperando ch'egli sollevasse la testa e andasse ad abbracciarla; ma
egli non rispondeva neppure, non aveva udito, non aveva capito: non esisteva nulla per lui all'infuori di ciò
che vedeva in quelle pagine. Per due anni divorò un numero incalcolabile di volumi.
Il suo carattere cambiò. Da allora chiese più volte a Mademoiselle Source del denaro, ed ella glielo
diede; ma siccome ne chiedeva sempre di più, finì per rifiutarglielo, perché era di natura ordinata ed
energica, e sapeva essere ragionevole quand'era necessario. A forza di suppliche egli ottenne ancora, una
sera, una forte somma; ma quando la implorò di nuovo, non cedette più. Lui parve rassegnarsi. Tornò
tranquillo come un tempo, contento di stare seduto per ore intere senza fare un movimento, con gli occhi
bassi, immerso nelle fantasticherie. Non parlava più nemmeno con Mademoiselle Source, rispondeva
appena a ciò ch'ella gli diceva, con frasi brevi e precise. Era gentile con lei, tuttavia, e pieno di premure; ma
non l'abbracciava più, mai. La sera, ora, quando sedevano di fronte ai due lati del caminetto, immobili e
silenziosi, a volte le faceva paura. Voleva scuoterlo, dire qualcosa, qualunque cosa, pur di uscire da quel
silenzio angoscioso come le tenebre d'un bosco. Ma il ragazzo non pareva più udirla, ed ella tremava col
terrore d'una povera donna debole, quando gli rivolgeva la parola cinque o sei volte di seguito senza
ottenere una risposta. Che aveva? Se le accadeva di esprimere un desiderio, egli lo eseguiva senza
borbottare. Se aveva bisogno di qualcosa in città, vi si recava subito. Non poteva lamentarsi di lui, non
davvero!
Eppure...
Un altro anno trascorso, e un nuovo mutamento parve compiersi nella mente misteriosa del giovane. Ella
se ne accorse, lo sentì, lo indovinò. Come? Non importa! Era certa di non essersi ingannata; ma non
avrebbe potuto dire in che cosa i pensieri sconosciuti di quello strano ragazzo fossero mutati. Le pareva cheegli fosse stato fino allora come un uomo esitante, e ad un tratto avesse preso una decisione. Quest'idea le
venne una sera incontrando il suo sguardo fisso, singolare, ch'ella non conosceva.
Da quel momento cominciò a osservarla continuamente, ed ella aveva voglia di nascondersi per
evitare quell'occhio freddo, fisso su di lei. La fissava per serate intere, distogliendo lo sguardo solo
quand'ella diceva, all'estremo delle forze :- Non guardarmi a quel modo, ragazzo mio! -. Allora chinava la
testa. Ma non appena aveva voltato le spalle, ella si sentiva di nuovo l'occhio di lui addosso. Ovunque
andasse, lo sguardo di lui la seguiva ostinato. A volte, mentre passeggiava nel giardinetto, ella lo scorgeva a
un tratto accovacciato in un cespuglio come se stesse in agguato; oppure, quando sedeva davanti alla casa
a rammendare le calze, e lui vangava un campicello di legumi, la spiava, pur continuando a lavorare, in
modo sornione e continuo. Aveva un bel chiedergli: - Che hai, bambino mio? Da tre anni sei così cambiato.
Non ti riconosco più. Dimmi che cos'hai, che cosa pensi, te ne supplico -. Con un tono calmo e infastidito,
egli rispondeva invariabilmente: - Ma non ho niente, zia! -. E quand'ella insisteva, supplicando :- Figlio mio,
rispondimi, rispondimi quando ti parlo. Se sapessi il dolore che mi dai, mi risponderesti sempre e non mi
guarderesti a quel modo. Hai qualche dispiacere? Dimmelo, ti consolerò... -. Egli si allontanava con aria
stanca mormorando: - Ma t'assicuro che non ho nulla -.
Non era molto cresciuto, aveva l'aspetto d'un ragazzo, sebbene i tratti del viso fossero d'un uomo.
Erano tratti duri e tuttavia non ancora formati. Sembrava incompleto, mal sviluppato, solo abbozzato, e
inquietante come un mistero. Era un essere chiuso impenetrabile, in cui pareva svolgersi un incessante
lavorio mentale, attivo e pericoloso. Tutto ciò non sfuggiva a Mademoiselle Source, che non dormiva più
per l'angoscia. L'assalivano dei terrori orribili, degli incubi spaventosi. Si chiudeva in camera e barricava la
porta, torturata dallo spavento!
Di che aveva paura?
Non lo sapeva.
Paura di tutto, della notte, dei muri, delle forme che la luna proiettava attraverso le tende bianche della
finestra, e paura di lui soprattutto!
Perché?
Che cosa temeva? Come saperlo!...
Non poteva più vivere a quel modo! Era certa d'essere minacciata da una disgrazia, da una sciagura orribile.
Una mattina partì di nascosto e si recò in città dalle sue parenti. Con voce ansante raccontò loro
ogni cosa. Le due donne pensarono che stesse diventando matta, e cercarono di rassicurarla. La zitella
diceva :- Se sapeste come mi guarda dalla mattina alla sera! Non mi leva mai gli occhi di dosso! In certi
momenti mi viene voglia di gridare aiuto, di chiamare i vicini, tanta è la paura! Ma che cosa poter dire? Non
fa altro che guardarmi -. Le due cugine chiedevano :- Forse qualche volta è brutale, vi risponde con
durezza? -. Ella rispondeva :- No, mai; fa tutto quel che voglio; lavora bene, ha messo giudizio, ormai; ma io
non resisto dalla paura. Ha qualcosa in mente, ne sono sicura, sicurissima. Non voglio più restare così sola
con lui in mezzo alla campagna -. Le parenti, smarrite, osservarono che la gente si sarebbe meravigliata,
non avrebbe capito; e le consigliarono di tacere i suoi timori e i suoi progetti, senza dissuaderla tuttavia
dall'andare ad abitare in città, sperando in un ritorno dell'intera successione. Le promisero anche d'aiutarla
a vendere la sua casa e a trovarne un'altra vicino a loro. Mademoidelle Source ritornò a casa. Ma la sua
mente era così agitata che trasaliva al minimo rumore, e le sue mani si mettevano a tremare alla più piccola
emozione. Due volte ancora tornò a consultarsi con le parenti, ben decisa ormai a non restare più in quella
sua casa isolata. Infine trovò nel sobborgo una villetta adatta a lei e la comprò in segreto. La firma del
contratto avvenne un Martedì mattina e Mademoiselle Source occupò il resto della giornata a fare i
preparativi per il trasloco. Alle otto di sera riprese la diligenza, che passava a un chilometro da casa sua; e si
fece lasciare nel punto in cui il conducente aveva l'abitudine di farla scendere. L'uomo frustò i cavalli e le
gridò :- Buonasera. Mademoiselle Source, buonanotte! -. Ella rispose allontanandosi :- Buonasera, Joseph.-.
L'indomani, alle sette e trenta del mattino, il postino che porta le lettere al villaggio notò sulla
scorciatoia, non lontano dalla strada maestra, una grande pozza di sangue ancora fresco. Si disse :- Guarda
un po'! Un ubriaco ha perduto sangue dal naso -. Ma dieci passi più aventi scorse un fazzoletto pure
macchiato di sangue. Lo raccolse. Il tessuto era fine, e il postino, sorpreso, s'avvicinò al fosso dove credette
di scorgere un oggetto strano. Mademoiselle Source era sdraiata sull'erba del fondo, con la gola squarciata
da una coltellata. Un'ora dopo i gendarmi, il giudice istruttore e parecchie autorità facevano le lorocongetture attorno al cadavere. Le due parenti, chiamate a testimoniare, raccontarono i timori della zitella,
e i suoi ultimi progetti.
L'orfano fu arrestato.
Dopo la morte di colei che l'aveva adottato, piangeva da mattina a sera, immerso, almeno in
apparenza, nel più violento dolore. Provò che aveva passato la serata, fino alle undici, in un caffè. Dieci
persone l'avevano visto, erano rimaste nel locale fino a che lui se n'era andato. Ora il vetturino della
diligenza dichiarò di aver lasciato sulla strada l'assassinata fra le nove e mezzo e le dieci. Il delitto non
poteva aver avuto luogo che durante il tragitto della strada maestra a casa, al più tardi verso le dieci.
L'accusato fu assolto. Un testamento, di vecchia data, depositato presso un notaio di Rennes, lo nominava
legatario universale; ereditò. Per molto tempo la gente del luogo lo tenne in quarantena, sospettandolo
sempre. La sua casa, quella della morta, era considerata maledetta. Per la strada lo evitavano. Ma egli si
dimostrò un così bravo ragazzo, così aperto, così alla mano, che a poco a poco tutti dimenticarono l'orribile
dubbio. Era generoso, premuroso, si fermava a parlare di tutto con i più umili, quanto a loro piacesse. Il
notaio Rameau fu uno dei primi a ricredersi sul suo conto, sedotto dalla sua sorridente loquacità. Una sera,
durante un pranzo in casa dell'esattore, dichiarò :- Un uomo che parla con tanta facilità e che è sempre di
buon umore non può avere un simile delitto sulla coscienza -. Colpiti da questo argomento, i presenti
rifletterono, e ricordarono infatti le lunghe conversazioni di quell'uomo che li fermava, quasi per forza,
all'angolo delle vie, per comunicare le proprie idee, che li costringeva a entrare in casa sua quando
passavano davanti al suo giardino, che aveva battute più spiritose di quelle dello stesso tenente di polizia, e
l'allegria così comunicativa che nonostante la ripugnanza che ispirava, in sua compagnia non si poteva fare
a meno di ridere.
Tutte le porte si aprirono per lui.
Oggi è sindaco del comune.Italo Calvino
Furto in una pasticceria
Il Dritto arrivò al posto convenuto e gli altri lo stavano aspettando già da un po’.
C’erano tutt’e due: Gesubambino e Uora‐uora. C’era tanto silenzio che dalla via si
sentivano suonare gli orologi nelle case: due colpi, bisognava sbrigarsi se non si
voleva farsi cogliere dall’alba.
‐ Andiamo, ‐ disse il Dritto.
‐ Dov’è? ‐ chiesero.
Il Dritto è uno che non spiega mai il colpo che ha intenzione di fare.
‐ Ora ci andiamo, ‐ rispose.
E camminava in silenzio per le vie vuote come fiumi in secca, con la luna che li
seguiva lungo i fili dei tram, il Dritto avanti con quei suoi occhi gialli mai fermi, e
quel suo movimento alle narici che sembra che fiuti.
Gesubambino lo chiamano così perché ha la testa grossa da neonato e il corpo tozzo;
forse anche perché ha i capelli tagliati corti e un bel faccino coi baffetti neri. É tutto
muscoli e si muove soffice che sembra un gatto; per arrampicarsi e raggomitolarsi
non c’è nessuno come lui e quando il Dritto lo porta con sé c’è sempre una ragione.
‐ Sarà un buon colpo, Dritto? ‐ chiese Gesubambino.
‐ Se si fa, ‐ disse il Dritto, una risposta che non voleva dir niente.
Ma intanto, per dei giri che sapeva solo lui, li aveva fatti scantonare in un cortile. I
due capirono che c’era da lavorare in un retrobottega e Uora‐uora si fece avanti
perché non voleva fare il palo. Il destino di Uora‐uora è fare il palo; il suo sogno
sarebbe di entrare nelle case, frugare, riempirsi le tasche come gli altri, ma gli tocca
sempre di fare il palo nelle strade fredde, nel pericolo delle pattuglie, battendo i
denti perché non gelino e fumando per darsi un contegno. É un siciliano
allampanato, Uora‐uora, con una faccia triste da mulatto e i polsi che gli sporgono
dalle maniche. Quando c’è un colpo da fare si veste tutto elegante, non si sa perché:
col cappello, la cravatta e l’impermeabile, e se c’è da scappare si prende le falde
dell’impermeabile in mano che sembra voglia aprire le ali.
‐ A fare il palo, Uora‐uora, ‐ disse il Dritto, muovendo le narici. Uora‐uora
s’allontanò mogio: sapeva che il Dritto può continuare a muovere le narici sempre
più svelto, ma a un certo punto smette e tira fuori la rivoltella.
1‐ Lì, ‐ disse il Dritto a Gesubambino. C’era una finestrella alta da terra, con un
cartone al posto del vetro sinistrato.
‐ Tu monti, entri e mi apri, ‐ disse. ‐ Bada a non accendere le luci che di fuori si vede.
Gesubambino si tirò su come una scimmia per il muro liscio, sfondò il cartone senza
rumore e mise la testa dentro. Fin allora non s’era accorto dell’odore: respirò e gli
salì alle narici una nuvola di quel profumo caratteristico dei dolci. Più che un senso
d’ingordigia provò una trepida commozione, un senso di remota tenerezza.
«Ci devono essere dei dolci, qua dentro», pensò. Erano anni che non mangiava un
po’ di dolci come si deve, forse da prima della guerra. Avrebbe frugato dappertutto
finché non avesse trovato i dolci; sicuro. Si calò giù, nel buio; diede un calcio a un
telefono, una scopa gli s’infilò nei pantaloni, poi fu a terra. L’odore di dolci era
sempre più forte ma non si capiva da che parte venisse.
«Ci devono essere molti dolci, qui» pensò Gesubambino.
Allungò una mano, cercando d’ambientarsi nel buio per raggiungere la porticina e
aprire al Dritto. Subito ritirò la mano, con schifo: ci doveva essere una bestia
davanti a lui, una bestia marina, forse, molle e vischiosa. Rimase con la mano in aria,
una mano diventata appiccicaticcia, umida, come coperta di lebbra. Tra le dita sentì
che gli era spuntato un corpo tondo, un’escrescenza, forse un bubbone. Sbarrava gli
occhi nel buio ma non vedeva nulla, nemmeno a mettere la mano sotto il naso. Non
vedeva nulla ma odorava: allora rise. Capì che aveva toccato una torta e sulla mano
aveva crema e una ciliegia candita.
Cominciò a leccarsi la mano, subito, e con l’altra continuava a brancolare intorno.
Toccò un qualcosa di solido ma soffice, con un velo granuloso in superficie: un
crafen! Sempre brancolando, se lo ficcò in bocca intero. Diede un piccolo grido di
sorpresa, scoprendo che aveva la marmellata dentro. Era un posto bellissimo: in
qualsiasi direzione s’allungasse la mano, nel buio, si trovavano nuove specie di
dolciumi.
Si sentì bussare a una porta, poco distante, con impazienza: era il Dritto che
aspettava gli si aprisse. Gesubambino si diresse verso il rumore e le sue mani
urtarono prima in meringhe, poi in croccanti. Aprì. La lampadina tascabile del
Dritto gli illuminò la faccia coi baffetti già bianchi di crema.
‐ C’è pieno di dolci, qui! ‐ disse Gesubambino come se l’altro non lo sapesse.
‐ Non è tempo di dolci, ‐ fece il Dritto, scansandolo, ‐ non c’è tempo da perdere ‐. E
andò avanti rimestando nel buio col bastone di luce della lampadina. E in ogni
punto che illuminava scopriva file di scaffali e sopra gli scaffali file di vassoi e sopra
i vassoi file di paste allineate di tutte le forme e di tutti i colori e torte cariche di
2creme che stillavano come cera da candele accese, e batterie schierate di panettoni
e muniti castelli di torroni.
Allora uno sgomento terribile s’impadronì di Gesubambino: lo sgomento di non
avere il tempo di saziarsi, di dover scappare prima d’aver assaggiato tutte le qualità
di dolci, d’avere sottomano tutta quella cuccagna solo per pochi minuti in vita sua.
E più dolci scopriva più il suo sgomento aumentava, e ogni nuovo andito, ogni
nuova prospettiva del negozio che appariva illuminata dalla pila del Dritto, gli si
parava dinanzi come per chiudergli ogni strada.
Si buttò sugli scaffali ingozzandosi di paste, cacciandone in bocca due, tre per volta,
senza nemmeno sentirne il sapore, sembrava lottasse con i dolci, minacciosi nemici,
strani mostri che lo stringevano d’assedio, un assedio croccante e sciropposo in cui
doveva aprirsi il varco a forza di mandibole. I panettoni mezzo tagliati aprivano
fauci gialle e occhiute contro di lui, strane ciambelle sbocciavano come fiori di
piante carnivore; Gesubambino ebbe per un momento la sensazione che sarebbe
stato lui a esser divorato dai dolci.
Il Dritto lo tirava per un braccio.
‐ La cassa, ‐ disse, ‐ dobbiamo prendere la cassa. Ma intanto, passando, si ficcò in
bocca un pezzo di pandispagna multicolore, e poi la ciliegina d’una torta, e poi una
“brioche”, sempre con fretta, cercando di non distrarsi dal suo compito. Aveva
spento la pila.
‐ Di fuori ci vedono come vogliono, ‐ disse.
Erano arrivati nel locale della pasticceria, con le bacheche di vetro e i tavolini di
marmo. C’era la luce notturna della strada, perché le saracinesche erano a griglia e
fuori si vedevano le case e gli alberi, con uno strano gioco d’ombre.
Ora bisognava forzare la cassa.
‐ Tieni qua, ‐ disse il Dritto a Gesubambino dandogli la pila da reggere verso il basso
perché non si vedesse da fuori.
Ma Gesubambino con una mano teneva la pila e con l’altra annaspava intorno.
Afferrò un plumcake intero e mentre il Dritto s’affannava coi suoi ferri alla
serratura, cominciò a morsicarlo come fosse pane. Se ne stufò presto e lo lasciò sul
marmo mezzo mangiato.
‐ Leva di lì! Guarda che porcaio fai! ‐ gli gridò a denti stretti il Dritto, che malgrado il
suo mestiere aveva uno strano amore per il lavoro ordinato. Poi non resistette alla
tentazione e si mise due biscotti in bocca, di quelli mezzo savoiardi mezzo di
cioccolato, sempre senza smettere di lavorare.
Ma Gesubambino, per avere le mani libere, aveva costruito una specie di paralume
con pezzi di torrone e tovagliette da vassoio. Aveva visto certe torte con la scritta
3“buon onomastico”. Ci si aggirò intorno, studiando il piano d’attacco: prima le passò
in rassegna con il dito e leccò un po’ di crema al cioccolato, poi ci affondò la faccia
dentro cominciando a morderle dal centro una per una.
Ma gli restava una smania che non sapeva come soddisfare, non riusciva a trovare il
modo per goderle del tutto. Ora era carponi sul tavolo, con le torte sotto di sé: gli
sarebbe piaciuto spogliarsi e coricarsi nudo sopra quelle torte, rivoltarcisi sopra,
non doversene staccare mai. Di lì a cinque, dieci minuti, invece, tutto sarebbe finito:
per tutta la vita le pasticcerie sarebbero tornate proibite per lui, come quando da
bambino schiacciava il naso contro le vetrine. Almeno ci si potesse fermare tre,
quattro ore...
‐ Dritto! ‐ fece. ‐ Se ce ne stiamo qui nascosti fino all’alba, chi ci vede?
‐ Non fare lo scemo, ‐ disse il Dritto che era riuscito a forzare il cassetto e stava
frugando tra i biglietti. ‐ Qui bisogna portare via i piedi prima che arrivi la Celere.
Proprio in quel momento si sentì picchiare alla vetrina. Nella mezzaluna si vide
Uora‐uora che bussava attraverso la griglia della saracinesca e faceva gesti. I due
nella bottega ebbero un balzo ma Uora‐uora faceva segno di star calmi, e a
Gesubambino di venire al suo posto, che lui sarebbe venuto lì. Gli altri gli
mostrarono i pugni e i denti, e fecero segno di togliersi da davanti al negozio, se
non gli dava di volta il cervello.
Intanto il Dritto aveva scoperto che in cassa c’erano solo poche migliaia di lire e
sacramentava, e se la pigliava con Gesubambino che non lo voleva aiutare.
Gesubambino sembrava fuori di sé: addentava strudel, piluccava zibibbi, leccava
sciroppi, imbrattandosi e lasciando rimasugli sui vetri delle bacheche. Aveva
scoperto che non aveva più voglia di dolci, anzi sentiva la nausea salirgli su per le
volute dello stomaco, ma non voleva cedere, non poteva arrendersi ancora. E i
crafen diventarono pezzi di spugna, le omelette rotoli di carta moschicida, le torte
colarono vischio e bitume. Egli vedeva solo cadaveri di dolci, che putrefacevano
stesi sui bianchi loro sudari, o che si disfacevano in torbida colla dentro il suo
stomaco.
Il Dritto prese a imbestialirsi contro la serratura d’un altro cassetto, dimentico
ormai dei dolci e della fame. Fu allora che dal retrobottega entrò Uora‐uora
bestemmiando in siciliano che nessuno lo capiva.
‐ La Celere? ‐ chiesero gli altri due, già pallidi.
‐ Il cambio! Il cambio! ‐ gemeva Uora‐uora nel suo dialetto, e s’affaticava a spiegare
a furia di parole in “u” l’ingiustizia di lui digiuno nel freddo mentre loro
s’ingozzavano di dolci.
4‐ Va’ a fare il palo! Va’ a fare il palo! ‐ gli gridava Gesubambino con rabbia; la rabbia
d’essere già sazio che lo faceva ancor più egoista e cattivo.
Il Dritto capiva che dare il cambio a Uora‐uora sarebbe stato più che giusto, ma
capiva anche che Gesubambino non si sarebbe lasciato convincere così facilmente,
e senza palo non si poteva restare. Perciò tirò fuori la rivoltella e la puntò su
Uora‐uora.
‐ Subito al tuo posto, Uora‐uora, ‐ disse.
Disperato, Uora‐uora pensò di far la sua provvista prima d’andarsene, e si radunò
un mucchietto d’amaretti coi pinoli nelle grandi mani.
‐ E se ti pescano coi dolci in mano, scemo, cosa gli racconti, ‐ inveì ancora il Dritto. ‐
Lascia lì tutto e fila.
Uora‐uora piangeva. Gesubambino sentì d’odiarlo. Sollevò una torta col «buon
compleanno» e gliela tirò in faccia. Uora‐uora avrebbe potuto benissimo schivarla,
invece sporse la faccia in avanti per pigliarla in pieno, poi rise, con la faccia, il
cappello, la cravatta impiastricciati di torta, e scappò via dandosi linguate fin sul
naso e sugli zigomi.
Alla fine il Dritto era riuscito a forzare il cassetto buono e stava intascando
banconote, imprecando perché gli si appiccicavano alle dita sporche di marmellata.
‐ Dài, Gesubambino, è ora d’andarcene, ‐ disse.
Ma per Gesubambino tutto non poteva finire così: quella doveva essere una
mangiata da raccontare per anni ai compagni e a Mary la Toscana. Mary la Toscana
era l’amante di Gesubambino: aveva delle gambe lunghe e lisce e un corpo e un viso
quasi equini. Gesubambino le piaceva perché si raggomitolava e s’arrampicava sul
suo corpo come un grosso gatto.
La seconda entrata di Uora‐uora interruppe il corso di questi pensieri. Il Dritto tirò
fuori la rivoltella, subito, ma Uora‐uora disse: ‐ La Celere! ‐ e scappò di corsa,
svolazzando con le falde dell’impermeabile in mano. Il Dritto, raccolti gli ultimi
biglietti, fu in due salti alla porta; e Gesubambino dietro.
Gesubambino stava pensando a Mary: solo allora s’era ricordato che poteva
portarle delle paste, che non le faceva mai regali, che forse lei ci avrebbe fatto su
una scena. Tornò indietro, arraffò dei cannoli, se lì ficcò sotto la camicia, poi
rapidamente pensò che aveva scelto le paste più fragili, ne cercò delle più solide e
se ne infarcì il seno. In quella vide le ombre dei poliziotti sulla vetrina che
s’agitavano e indicavano qualcuno in fondo alla via; e uno puntò un’arma in quella
direzione e sparò.
Gesubambino s’acquattò dietro a un banco. Non dovevano aver colpito il bersaglio:
ora facevano gesti di dispetto e guardavano dentro. Poco dopo sentì che avevano
5scoperto la porticina aperta, e che entravano. La bottega fu piena di poliziotti
armati. Gesubambino stava aggomitolato, ma intanto, scoperta della frutta candita
a portata delle sue braccia, per tenersi calmo s’ingozzava di cedri e bergamotti.
Quelli della Celere constatavano il furto e le tracce della mangiata sugli scaffali. E
così, distrattamente, cominciarono a portarsi alla bocca qualche pasticcino rimasto
sbandato, badando bene a non confondere le tracce. Dopo qualche minuto,
infervorati alla ricerca dei corpi del reato, erano tutti lì che mangiavano a quattro
palmenti.
Gesubambino masticava, ma gli altri masticavano più forte di lui e coprivano il
rumore. E sentiva un denso liquefarsi tra pelle e camicia, e la nausea salirgli per lo
stomaco. S’era tanto stordito a furia di canditi che tardò un po’ ad accorgersi che la
via della porta era libera. Quelli della Celere dissero poi d’aver visto una scimmia
col muso impiastricciato, che traversava a salti la bottega, rovesciando vassoi e
torte. E prima che si fossero riavuti dallo stupore e spiccicate le torte di sotto i piedi
lui s’era già messo in salvo.
Da Mary la Toscana quando aprì la camicia si trovò col petto ricoperto da uno
strano impasto. E rimasero fino al mattino, lui e lei, sdraiati sul letto a leccarsi e
piluccarsi fino all’ultima briciola e all’ultimo rimasuglio di crema.
Da: Italo Calvino, Ultimo viene il Corvo, Einaudi, Torino, 1994.
6Dino Buzzati, IL MANTELLO Dopo un’interminabile attesa, quando la speranza già cominciava a morire, Giovanni ritornò alla sua casa. Non erano ancora suonate le due, sua mamma stava sparecchiando, era una giornata grigia di marzo e volavano cornacchie. Egli comparve improvvisamente sulla soglia e la mamma gridò: “Oh benedetto! ” correndo ad abbracciarlo. Anche Anna e Pietro, i due fratellini molto più giovani, si misero a gridare di gioia. Ecco il momento aspettato per mesi e mesi, così spesso balenato nei dolci sogni dell’alba, che doveva riportare la felicità. Egli non disse quasi parola, gli costava troppa fatica trattenere il pianto. Aveva subito deposto la pesante sciabola su una sedia, in testa portava ancora il berretto di pelo. “Lasciati vedere” diceva tra le lacrime la madre, tirandosi un po’ indietro, “Lasciati vedere quanto sei bello. Però sei pallido, sei. “. Era alquanto pallido, infatti, e come sfinito. Si tolse il berretto, avanzò in mezzo alla stanza e si sedette. Che stanco, che stanco, perfino a sorridere sembrava facesse fatica. “Ma togliti il mantello, creatura” disse la mamma, e lo guardava come un prodigio, sul punto di esserne intimidita; com’era diventato alto, bello fiero (anche se un po’ troppo pallido). “Togliti il mantello, dammelo qui, non senti che caldo? “. Lui ebbe un brusco movimento di difesa, istintivo, serrandosi addosso il mantello, per timore forse che glielo strappassero via. “No, no, lasciami” rispose evasivo, “preferisco di no, tanto tra poco devo uscire… “. “Devi uscire? Torni dopo due anni e vuoi subito uscire? ” fece lei desolata, vedendo subito ricominciare, dopo tanta gioia, l’eterna pena delle madri; “Devi uscire subito? E non mangi qualcosa? “. “Ho già mangiato, mamma. ” rispose il figlio con un sorriso buono, e si guardava attorno assaporando le amate penombre. “Ci siamo fermati ad un’osteria, qualche chilometro da qui… “. “Ah, non sei venuto solo? E chi c’è con te? Un compagno di reggimento? Il figlio della Mena, forse? “. “No, no, era uno che ho incontrato per via. È fuori che aspetta adesso. “. “È lì che aspetta? E non l’hai fatto entrare? L’hai lasciato in mezzo alla strada? “. Andò alla finestra e attraverso l’orto, di là del cancelletto di legno, scorse sulla via una figura che camminava su e giù lentamente; era tutta intabarrata e dava la sensazione di nero. Allora nell’animo di lei nacque, incomprensibile, in mezzo ai turbini della grandissima gioia, una pena misteriosa ed acuta. “È meglio di no. ” rispose lui, deciso. “Per lui sarebbe una seccatura, è un tipo così.” “Ma un bicchiere di vino? Glielo possiamo portare, no, un bicchiere di vino?” “Meglio di no, mamma. È un tipo curioso, capace di andar su tutte le furie.” “Ma chi è, allora? Perché ti ci sei messo assieme? Che cosa vuole da te?” “Bene non lo conosco” disse lui lentamente e assai grave, “L’ho incontrato durante il viaggio. È venuto con me, ecco. 2. Sembrava preferisse parlar d’altro, sembrava se ne vergognasse. E la mamma, per non contrariarlo, cambiò immediatamente discorso, ma già si spegneva nel suo volto amabile la luce di prima. “Senti” disse, “ti figuri la Marietta quando saprà che sei tornato? Te l’immagini che salti di gioia? È per lei che volevi uscire? “. Egli sorrise soltanto, sempre con quell’espressione di chi vorrebbe esser lieto eppure non può, per qualche segreto peso. La mamma non riusciva a capire: perché se ne stava seduto, quasi triste, come il giorno lontano della partenza? Ormai era tornato, una vita nuova davanti, un’infinità di giorni disponibili senza pensieri, tante belle serate insieme, una fila inesauribile che si perdeva di là delle montagne, nelle immensità degli anni futuri. Non più le notti d’angoscia quando all’orizzonte spuntavano i bagliori del fuoco e si poteva pensare che anche lui fosse là in mezzo, disteso immobile a terra, il petto trapassato, tra le sanguinose rovine. Era tornato, finalmente, più grande, più bello, e che gioia per la Marietta. Tra poco cominciava la primavera, si sarebbero sposati in chiesa, una domenica mattina, tra il suono di campane e fiori. Perché dunque se ne stava smorto e distratto, non rideva più, perché non raccontava le battaglie? E il mantello? Perché se lo teneva stretto addosso, col caldo che faceva in casa? Forse perché, sotto, l’uniforme era rotta e infangata? Ma con la mamma, come poteva vergognarsi di fronte alla mamma? Le pene sembravano finite, ecco invece subito una nuova inquietudine. Con il dolce viso piegato un po’ da una parte, lo fissavacon ansia, attenta a non contrariarlo, a capire subito
Puoi anche leggere