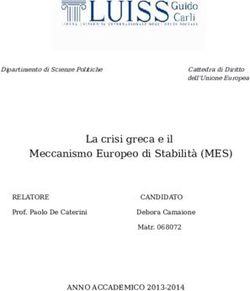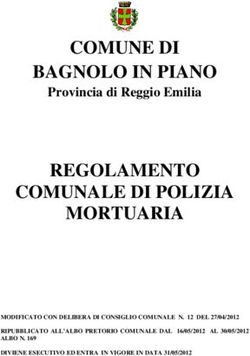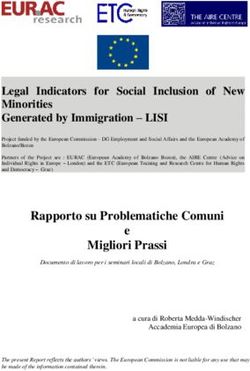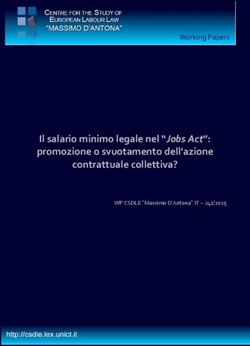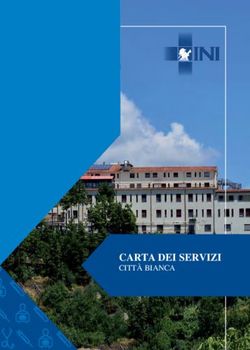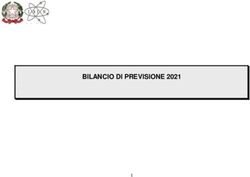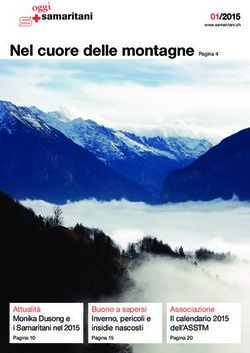IRAN, DIRITTO INTERNAZIONALE ED ENERGIA ATOMICA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
IRAN, DIRITTO INTERNAZIONALE
ED ENERGIA ATOMICA
di Paolo Bargiacchi*
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Due possibili ed ulteriori
elementi di valutazione del comportamento iraniano. - 3. Le
iniziali posizioni di Iran, AIEA e Stati Uniti. – 4. I Reports del
Direttore Generale dell’AIEA. – 5. La proposta S/2006/521, la
Risoluzione 1696 (2006) e gli ultimi sviluppi negoziali. - 6. La
delayed limited enrichment proposal dell’International Crisis
Group. – 7. Il problema della mancanza di un credible
international system for providing nuclear fuel. – 8. Conclusioni.
1. Indipendentemente dalla sua conclusione, la questione
nucleare iraniana pone interrogativi politici e giuridici di portata
generale che riguardano l’intero settore dell’energia atomica.
In tal senso, perciò, prima di svolgere alcune brevi
riflessioni sulla vicenda (con i limiti che derivano dall’essere
questa ancora in corso), riteniamo necessario evidenziare
l’assoluta peculiarità del settore data dal fatto che - mentre in
ogni altro ambito regolato dal diritto internazionale vige (almeno
sul piano formale) il principio giuridico della parità interstatuale
- in ambito nucleare, invece, il presupposto di partenza è proprio
quello della non paritarietà, neanche formale, tra gli Stati.
In aggiunta alla discriminazione di base tra Stati nucleari e
non nucleari, si notino anche i diversi controlli cui vengono
assoggettati gli Stati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia
Atomica, AIEA (gli Stati nucleari possono evitarli invocando la
national security clause)1 e, ulteriormente, la peculiare
* Ricercatore di diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Palermo ed incaricato di diritto dell’Unione europea nel
Polo di Trapani.
1
Sul punto, si veda DI LIETO “L’Agenzia svolge un controllo anche sugli
impianti ed i materiali degli Stati nucleari, ma in questo caso le misure sono
meno rigide … perché gli Stati nucleari possono sottrarsi ai controlli
adducendo motivi di difesa o di sicurezza” (Attività nucleari e diritto
internazionale, Napoli, 2005, p.97) e, ibidem (nota 299, p.97, citando
BLIX, Aspects juridiques des garanties de l’Agence internationale de
l’Énergie atomique, in Annuaire français de droit international, 1984, p.39
ss.): “Cf. in particolare gli accordi stipulati dall’AIEA con la Gran Bretagna
e gli Stati Uniti in base ai quali è previsto che l’impegno da parte dei due2
situazione di quegli Stati (India, Pakistan, Israele) che, sebbene
nucleari (e dotati di armi atomiche), non intendono divenire parti
al Trattato di Non Proliferazione, TNP, rimanendo così liberi da
ogni vincolo e controllo a differenza, invece, degli Stati parte.
Queste discriminazioni, insieme alla prassi degli Stati in
materia, determinano effetti peculiari sulla produzione
normativa: autorevole dottrina e la Corte internazionale di
giustizia hanno, da un lato, evidenziato – per l’intero settore
dell’energia atomica – l’inesistenza di norme consuetudinarie
certe e ricostruibili (e la presenza di sole norme convenzionali)
e, dall’altro, valutato le ulteriori conseguenze della non
paritarietà della posizione giuridica degli Stati nel contesto
normativo che regola il settore dell’energia atomica.2
Stati di accettare l’applicazione delle garanzie sulle materie brute e su tutti i
prodotti fissili può essere derogato per motivi di sicurezza nazionale”.
2
Per PICONE, “L’assenza (almeno in via di principio) di norme di diritto
internazionale generale … comporta a fortiori l’inesistenza di norme
generali produttive di obblighi erga omnes, e suscettibili quindi in caso di
violazione … di legittimare una reazione almeno potenziale di tutti gli Stati
… a tutela di valori rilevanti per la stessa Comunità internazionale” e,
inoltre, “per gli obblighi incombenti sugli Stati nel campo della non
proliferazione nucleare, ai sensi del relativo Trattato, è anche in generale
dubbio che la struttura non paritaria delle posizioni dei vari Stati, sancita
sul piano convenzionale, possa costituire la base del formarsi di norme
internazionali non solo imperative, ma anche produttive di veri e propri
obblighi degli Stati nei confronti della Comunità internazionale” (La guerra
contro l’Iraq e le degenerazioni dell’unilateralismo, in Rivista di diritto
internazionale, 2003, p.367 e nota 92, pp.367-368). Secondo SIMMA,
invece, “the Non-Proliferation Treaty, like the veto power in the UN
Security Council, consecrates a hierarchical distinction between States
which is difficult to reconcile with the overall spirit of the United Nations
Charter, marked by respect for sovereign equality” (From Bilateralism to
Community Interest in International Law, in Recueil des Cours, 1994,
p.334). Per la Corte de L’Aja, si possono vedere le pronunce aventi ad
oggetto il tema nucleare [per le due Advisory Opinions dell’8 luglio 1996:
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, in Reports, 1996, p.226,
e Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict –
Preliminary Objections, in Reports, 1996, p.66; per i Contentious cases, i
due Judgments del 20 dicembre 1974 in Nuclear Tests (Australia v. France
e New Zeland v. France), in Reports, 1974, pp. 253 e 457] nelle quali la
Corte conclude per la sostanziale inesistenza di obblighi internazionali
attesa la prassi degli Stati nucleari che non pongono limiti alla loro attività
in questo ambito. In tal senso, quindi, l’irrilevanza, per la formazione di una
norma proibitiva dell’uso dell’arma nucleare, delle dichiarazioni di protesta
in luogo di quelle di condanna (come avvenne in occasione dei tests3
A noi sembra, ulteriormente, che simili anomalie, che
informano poi tutto il successivo sviluppo normativo della
materia, non consentano di equipare questo settore agli altri
regolati dal diritto internazionale secondo il principio della parità
dei soggetti.
Se, in un ordinamento giuridico, la presenza di principi
strutturali (come la parità interstatuale) determina (come, a
nostro avviso, avviene) la necessaria conformità a questi delle
discipline dei singoli settori che compongono l’ordinamento,
allora, a fronte dell’anomalia di settore data dalla “struttura non
paritaria delle posizioni dei vari Stati”, si potrebbe ipotizzare -
come conseguenza ultima - o la stessa non giuridicità della
regolamentazione (che si caratterizzerebbe per la sua politicità
normativizzata) oppure la comparsa nel tessuto socio-giuridico
internazionale di un fenomeno di egemonizzazione (giuridica)
dell’ordinamento con una struttura ancora giuridica ma fondata
sulla diseguaglianza di status tra gli enti che necessariamente vi
appartengono.
Pur non potendo in questa sede affrontare più
diffusamente simili ipotesi ricostruttive, ci sembra importante
averle comunque introdotte atteso il rilievo giuridico che
potrebbero assumere in futuro nelle relazioni internazionali: ed
in questo ci sembra di essere “confortati” anche da una parte
della dottrina statunitense.3
nucleari effettuati da India e Pakistan, Stati non parte al TNP; sul punto,
ancora PICONE, op.cit., p.367, nota 91).
3
La possibilità di un diritto internazionale egemonico è già apertamente
discussa e ricostruita da alcuni Autori negli Stati Uniti, anche come
sviluppo giuridico dell’impostazione neorealistica delle relazioni
internazionali della Scuola di Yale. Sul diritto internazionale egemonico,
senza pretesa di completezza, si veda ALVAREZ, Hegemonic International
Law Revisited, in 97 AJIL 873 (2003) [per le conseguenze
istituzionalistiche che, nel campo delle organizzazioni internazionali,
derivano dall’impostazione egemonica e dalla c.d. move to institutions (la
definizione è di KENNEDY, The Move to Institutions, in 8 Cardozo L. Rev.
841, 1986-1987), si veda ancora ALVAREZ, International Organizations
as Law-Makers, New York, 2006; per un approccio addirittura post-
istituzionalistico a favore di un “period dominated by international civil
society”, invece, KU, Global Governance and the Changing Face of
International Law, in ACUNS Rep. & Papers, 2001]; VAGTS, Hegemonic
International Law, in 95 AJIL 843 (2001); ID., International Law in the
Third Reich, in 84 AJIL 661 (1990); GLENNON, Has International Law
Failed the Elephant?, in 84 AJIL 1 (1990); ID., How International Rules4
2. L’art. IV, § 1, del TNP prevede “il diritto inalienabile
della Parti di promuovere la ricerca, la produzione e
l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, senza
discriminazioni e conformemente alle disposizioni degli articoli
I e II”.
Il combinato disposto degli articoli I, II, III e IV del TNP
è, quindi, coerente e lineare: tutti hanno il diritto di condurre
ricerche e produrre energia atomica con il solo e penetrante
limite della sua utilizzazione pacifica sotto il controllo
Die, in 93 Geo.L.J. 939 (2005); ID., Limits of Law, Prerogatives of Power:
Interventionism after Kosovo, New York, 2001 [per un serrato confronto tra
GLENNON e FRANCK - sul ruolo del diritto e su un eventuale “new
American (or, if possibile, American-led) international order” - scaturito
dalle affermazioni (critiche verso GLENNON) di FRANCK in The Power
of Legitimacy and the Legitimacy of Power, in 100 AJIL 88 (2006), si veda
Correspondence, in 100 AJIL 413 (2006)]; REISMAN, In Defense of World
Public Order, in 95 AJIL 833 (2001); WEIL, Towards Relative Normativity
in International Law?, in 77 AJIL 413 (1983); RUBENFELD (con accenti,
però, critici verso l’unilateralismo egemonico), The Two World Orders, in
The Wilson Quarterly (Autumn 2003). Ancora in senso critico, SANDS,
Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules
from FDR’s Atlantic Charter to George W. Bush’s Illegal War, New York,
2005; ID., Lawless World: The Whistle-Blowing Account of How Our
Leaders Are Taking the Law into Their Own Hands, New York, 2006. Tra
quelli che, invece, dubitano, come conseguenza dell’egemonia politica,
dell’esistenza stessa del diritto internazionale, non si può prescindere da
BOLTON (per il quale “no law graces the hegemon’s universe”), Is There
Really “Law” in International Affairs?, in 10 Transnat’l L. & Contemp.
Probs 1 (spring 2000); ID., The Global Prosecutors: Hunting War
Criminals in the Name of Utopia, in 78 Foreign Affairs 157
(January/February 1999); ID., Courting Danger: What’s Wrong with the
International Criminal Court, in National Interest, Winter 1998/99 [e per
una review del boltonism, BOSCO, The World According to Bolton, in 61
Bulletin of the Atomic Scientists 24 (July/August 2005)]. Con sfumature,
invece, diverse, CARON, Does International Law Matter?, in ASIL
Proceedings, 2004, 311. Alcune recenti decisioni della Corte Suprema, poi,
hanno sollevato molti interrogativi sul rapporto tra Costituzione americana
e diritto straniero ed internazionale: in particolare, con riferimento al caso
Roper v. Simmons (125 S.Ct. 1183, 1 marzo 2005), ANDERSON, Foreign
Law and the U.S. Constitution, in 131 Policy Review (June/July 2005);
POSNER, No Thanks, We Already Have Our Own Laws, in Legal Affairs
(July/August 2004); KIRGIS, Is Foreign Law International Law?, in 9
ASIL Insights 33, 31 Ottobre 2005.5
dell’AIEA: in caso di violazione degli obblighi sanciti dall’art. II
si perdono i diritti previsti dall’art. IV.4
In ogni caso, il diritto di produrre energia atomica
ricomprende anche il diritto di arricchire l’uranio sul proprio
territorio e, in tal senso, non è giuridicamente divisibile come
emerge dalle singole norme e dal senso complessivo del TNP.
Del resto, non avrebbe neanche fondamento logico riconoscere e
garantire il diritto dello Stato alla produzione di energia,
impedendogli, però, di procurarsi in modo indipendente il
carburante necessario al funzionamento delle sue centrali.
In tal senso, allora, l’attuale proposta internazionale che
riconosce il diritto iraniano alla produzione di energia ma chiede
un enrichment off-shore ha un valore politico (anche
apprezzabile) che, però, appare priva di fondamento normativo e
giuridico.
L’accordo tra Iran ed AIEA per la definizione e
l’applicazione delle garanzie contro la diversione a fini militari
(in vigore dal maggio 1974) segue la falsariga di quelli conclusi
con tutti gli altri Stati non nucleari richiamando, quindi, nel
Preambolo il paragrafo 1 dell’articolo III del TNP che sancisce il
generale limite del controllo internazionale sull’attività dello
Stato.5 L’articolo 1 della Prima Parte (Basic Undertaking) del
Safeguards Agreement evidenzia, poi, un tratto, a nostro avviso,
caratterizzante la complessiva disciplina in tema di ricerca e
sviluppo (research & development, R&D): i controlli effettuati e
le garanzie applicate dall’ente internazionale, giustamente ampi,6
sono finalizzati e condizionati ad un “exclusive purpose”
4
Gli articoli I e II vietano la disseminazione di materiale nucleare e di
tecnologia militare. L’art. III determina, invece, il limite di esercizio del
diritto inalienabile sancito dal successivo art. IV: qualunque Stato parte al
Trattato non può divergere l’energia nucleare “dall’impiego pacifico alla
produzione di armi nucleari o altri congegni esplosivi” e, a tal fine, “si
impegna ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e
concludere con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica”.
5
Agreement between Iran and the International Atomic Energy Agency for
the Application of Safeguards in connection with the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (INFCIRC/214, 13 dicembre 1974, in
www.iaea.org/Publications/Documents).
6
“The safeguards required by this Article shall be applied on all source or
special fissionable material in all peaceful nuclear activities within its
territory, under its jurisdiction or carried out under its control anywhere”.6
consistente nel “verifying that such material is not diverted to
nuclear weapons or other nuclear explosive devices”.
La volontà di garantire – almeno nel settore del R&D – la
parità orizzontale degli Stati e quella verticale verso l’AIEA ha
così prodotto testi convenzionali (il TNP e i Safeguards
Agreements) in base ai quali il diritto inalienabile al R&D da
parte di qualunque Stato è limitato al solo scopo di impedire la
diversione a fini militari: in altre parole, la libertà di ricerca è la
regola e la sua limitazione è l’eccezione.
Ciò è confermato da quelle altre norme dei Safeguards
Agreements informate al principio della minima interferenza e
dell’effetto utile come l’art. 4 (le safeguards saranno applicate in
modo da evitare “hampering the economic and technological
development of Iran or international cooperation in the field of
peaceful nuclear activities, including international exchange of
nuclear material” e da evitare “undue interference in Iran’s
peaceful nuclear activities”) e l’art. 5 (l’AIEA è obbligata a
prendere ogni precauzione per proteggere i segreti industriali e le
conoscenze riservate dello Stato); ed ancora, l’art. 8 stabilisce
che saranno richieste “only the minimum amount of information
and data consistent with carrying out its [dell’AIEA]
responsibilities under this Agreement” e che “Information
pertaining to facilities shall be the minimum necessary for safe-
guarding nuclear material subject to safeguards under this
Agreement”.
Insomma, ci sembra emergere - in punto di R&D – la
volontà internazionale di garantire, da un lato, la parità
interstatuale e, dall’altro, di limitare qualitativamente ed
orizzontalmente (ferma restando, invece e comunque, una
rimarchevole ampiezza quantitativa e verticale del regime
ispettivo) i controlli sulle attività dello Stato.
A nostro avviso, questa prima peculiarità legata
all’impostazione sistematica del regime dei controlli potrebbe
essere tenuta in conto in sede di valutazione degli inadempimenti
iraniani (particolarmente in relazione alla richiesta dell’AIEA di
sospendere l’esercizio del diritto previsto dall’art.IV del TNP)
determinando, in via interpretativa, un affievolimento della loro
gravità (attesa anche la triplice progressività delle violazioni
individuata dal sistema del TNP).7
7
“An IAEA finding of non-compliance (as opposed to an anomaly or a
breach) [corsivi nostri] that is not corrected results in mandatory referral to7
Similmente, poi, e sempre per giungere ad una valutazione
degli inadempimenti iraniani che tenga conto anche delle
peculiarità strutturali dell’intero settore, si potrebbe accedere ad
una ricostruzione peculiare della nozione di “minaccia alla pace
e alla sicurezza internazionale” nel contesto del TNP.
A ben vedere, infatti, la nozione in questo ambito è
integrata, come tratto caratterizzante, anche dall’elemento della
cooperazione internazionale e del diritto degli Stati non nucleari
di produrre energia nucleare a fini pacifici. Garantire, quindi, la
pace e la sicurezza nucleare non significherebbe solamente
evitare la proliferazione e la violenza nucleare ma anche
garantire un effettivo e credibile sistema multilaterale di
cooperazione e di approvvigionamento del combustibile nucleare
(essendo, poi, questo un presupposto logico essenziale per il
raggiungimento della pace e della sicurezza).
In tale ottica, allora l’esistenza e l’effettivo funzionamento
di questo sistema multilaterale potrebbe anche diventare una
condizione giuridica capace, in funzione del suo maggiore o
minore grado di attuazione, di determinare parallelamente anche
il grado di responsabilità dello Stato in caso di loro violazione:
l’inattuazione di alcune, quindi, potrebbe sospenderne l’efficacia
normativa o, comunque, affievolire la gravità della loro
violazione.8
Attese le lacune di attuazione del sistema del TNP, allora,
la valutazione sulla gravità delle violazioni iraniane (al fine di
valutare poi la proporzionalità delle contromisure assunte)
potrebbe, in primo luogo ed innanzitutto, tenere conto del valore
the SC. An abnormal situation that is rapidly addressed is considered an
‘anomaly’. If further investigation reveals that the activities violate the
Safeguards Agreement, they are considered breaches. For instance, Iran’s
import of nuclear materials from China, which was not reported in a timely
manner, was deemed a breach of the agreement. Finally, if further
investigation and information provided dot not resolve the suspicion, the
IAEA Board of Governors may make a determination of non-compliance,
which triggers UNSC referral. In the past, Iran has been in breach of the
Safeguards Agreement and, had corrective measures not been taken, could
have been found in non-compliance” [ICG (International Crisis Group),
Iran: Is There a Way Out of the Nuclear Impasse?, Middle East Report,
n.51, 23 febbraio 2006, p.15, nota 102.
8
In caso di disfunzioni normative in un sistema giuridico, la presenza di
principi giuridici che informano la struttura, determinerebbe, così, la
possibilità – per via interpretativa – di derogare al dato normativo attraverso
le due vie indicate.8
sostanziale e concreto di queste (bilanciato anche dalla
considerazione degli adempimenti iraniani) e, in secondo luogo
o residualmente, anche di questi due criteri di interpretazione e
ricostruzione “teleologica” del TNP (che, per tal via,
diverrebbero ulteriori parametri giuridici di valutazione dei
comportamenti iraniani).
Astraendo dall’avvenuta violazione formale delle richieste
dell’AIEA e rapportando le attività iraniane anche al contesto
sostanziale (e alle peculiarità, anche patologiche) del settore
dell’energia atomica, si potrebbe, quindi, concludere per una
minore gravità (tale, ad esempio, da non giustificare la richiesta
di sospensione delle nuclear activities, la determinazione di non-
compliance ed il referral al Consiglio di Sicurezza) dei
comportamenti iraniani.
In tale ottica, il raggiungimento unilaterale di obiettivi che
si sarebbero dovuti raggiungere attraverso una (ad oggi inattuata
o ineffettiva) cooperazione multilaterale, pur contrastando con il
dato formale e normativo del TNP e delle decisioni AIEA,
evidenzierebbe una ridimensionata lesività dell’ordine giuridico.
3. Sulla base dell’art.IV del TNP gli Stati non nucleari
(come l’Iran) hanno il diritto di sviluppare la full nuclear fuel
cycle capability (che comprende anche l’enrichment dell’uranio)
sotto il controllo dell’AIEA.
Il timore di una possibile deriva militare iraniana una volta
acquisite certe conoscenze (tanto più dopo la scoperta nel 2002
del programma nucleare clandestino),9 ha spinto la Comunità
internazionale a chiedere all’Iran – pur riconoscendo il suo
diritto a sviluppare un programma nucleare civile (in questo
senso il Direttore Generale dell’AIEA e persino il Presidente
degli Stati Uniti)10 - di riguadagnare la fiducia del mondo prima
9
Sulla questione iraniana, si segnala un recente e molto interessante (anche
per una puntuale ed esauriente ricostruzione storica) contributo di
ANNIBALE, La questione iraniana – Dichiarazioni del Presidente
iraniano – Programma nucleare iraniano, in Rivista della Cooperazione
Giuridica Internazionale, 25, 2006.
10
Il Direttore Generale dell’AIEA, in una intervista a Newsweek del 12
gennaio 2006, nel rispondere ad una domanda nella quale si evidenziava
come “there’s nothing in the Non-Proliferation Treaty itself to prevent them
from enriching uranium”, sottolineava come “the board is saying, ‘You
have the right under the treaty to enrich uranium, but because of the lack of
confidence in your program and because the IAEA has not yet given a clean9
di continuare su questa strada e, quindi, di sospendere per il
momento ogni attività (a cominciare dall’enrichment).11
La parte iraniana, invece, è irremovibile nell’affermare i
propri diritti sulla base del TNP e nel respingere ogni richiesta di
loro sospensione dichiarandosi, comunque, e nel caso vengano
riconosciuti dalla Comunità internazionale, disponibile ad una
piena cooperazione con l’AIEA.12
Sebbene divergano specularmente sulla sospensione delle
attività nucleari, le due posizioni sembrano essenzialmente
bill of health, you should not exercise that right”. Il Presidente Bush, poi,
nel proporre una sistema esterno di approvvigionamento del combustibile
nucleare che non impedisca all’Iran di avere un “civilian nuclear power”,
notava come “Some of us are wondering why they need civilian nuclear
power anyway. They’re awash with hydrocarbons. Nevertheless, it’s a right
of a government to want to have a civilian nuclear program” (Reuters, 13
settembre 2005).
11
Fu la resolution adottata il 4 febbraio 2006 dal Board of Governors della
AIEA (GOV/2006/14) a chiedere l’adozione di confidence building
measures allo scopo di meglio risolvere le ancora aperte questioni sul
rispetto del Safeguards Agreement e chiarire la natura esclusivamente
pacifica del programma nucleare iraniano. Le measures comprendevano, tra
le altre, la sospensione completa di tutte le enrichment-related and
reprocessing activities (compreso il R&D) e la riapplicazione de facto del
Protocollo Addizionale firmato il 18 dicembre 2003 ma non ancora
ratificato dall’Iran. La stessa resolution, poi, chiedeva al Direttore Generale
“to report on the implementation of that resolution” al Board e “to convey
that report to the Security Council”. Il Direttore Generale, ad oggi, ha
presentato (al Board e al Consiglio) quattro Reports sulla Implementation of
the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran: il
GOV/2006/15 del 27 febbraio; il GOV/2006/27 del 28 aprile; il
GOV/2006/38 dell’8 giugno ed il GOV/2006/53 del 31 agosto.
12
In una Press Release of Iran’s Permanent Mission to the UN of February
17, 2006 (che, a sua volta, riportava l’intervista concessa il giorno prima dal
capo negoziatore iraniano Ali Larijani) si legge che: “Should the EU
change its discourse and stand ready to clearly recognise Iran’s rights in the
framework of the NPT … there will be a complete readiness on Iran’s side
to cooperate with Europe … The best guarantee for peacefulness of the
nuclear program … could include the following measures: Accepting the
current IAEA monitoring and verification system; use of modern
centrifuges, proposed by some American and British scientists, which
permit only limited enrichment; participation of interested countries in
Iran’s peaceful nuclear activities in form of a consortium. Accordingly
there are various ways to ensure that Iran is not pursuing military nuclear
programs. Should these guarantees be acceptable, the Islamic Republic of
Iran would accept to send the Additional Protocol to the Parliament for
ratification”.10
distinguersi per la diversa valutazione che operano dei fatti. Del
resto, attesa la complessità, anche tecnica, di simili valutazioni è
molto difficile (cominciando da chi scrive) assumere una
posizione netta e priva di dubbi sulla vicenda: non è un caso,
quindi, che le parti siano alla ricerca di un difficile compromesso
fondato più sulla negoziazione politica che su un “asettico”
accertamento giuridico delle circostanze di fatto.
Vi è da notare, però, anche una terza posizione (di
impronta fortemente politica e sostanzialmente riconducibile agli
Stati Uniti) secondo la quale le omissioni iraniane del passato (e
certi presenti atteggiamenti) dimostrerebbero indiscutibilmente
le illecite finalità militari del programma nucleare e, quindi,
imporrebbero di negare ora e sempre (e anche nel caso in cui
l’AIEA, completati i controlli, rilasciasse un clean bill of health
per l’Iran) qualunque diritto in tal senso e di consentire, al più,
un approvvigionamento esterno di combustile nucleare.13
Impedire l’esercizio dei diritti previsti dal TNP sulla base
di una valutazione politica e preventiva circa future diversioni
militari appare, però, giuridicamente in contrasto con il TNP (e
con lo stesso modus procedendi dell’AIEA),14 oltre che
politicamente incauto e pericoloso.
13
Il tema della non-proliferazione nucleare, insieme a quello della lotta
contro il terrorismo, è divenuto uno dei primi sull’agenda politica
statunitense. In tal senso, si veda, ad esempio, il Report “American
Interests and UN Reform” presentato nel giugno 2005 dallo USIP (U.S.
Institute of Peace) nel quale il Panel di esperti (chiamati ad individuare le
linee di riforma onusiana consone agli interessi americani) ha manifestato
pieno appoggio all’intenzione dell’Amministrazione Bush di affrontare
insieme il problema del terrorismo e quello della proliferazione nucleare,
con particolare riguardo alla proposta che “countries and companies selling
nuclear material and equipment should not assist in the development of new
nuclear processing facilities in any country that does not already have
them”. Proposta che implicherebbe l’impossibilità per ogni Stato ancora
privo della tecnologia (pacifica) nucleare di accedere un domani, per via
diretta, ai suoi benefici.
14
“We are not in the business of judging intentions. What we look for are
facts and proof, and so far we have no proof of a nuclear-weapons program.
The jury is still out … Unless you are ready to bomb your way through
every country you suspect of developing weapons of mass destruction, I see
no alternative to international inspectors” (così il Direttore Generale
dell’AIEA, Mohamed El Baradei, in una intervista del 24 novembre 2005 al
Time Europe).11
Si potrebbe, infatti, offrire il pretesto all’Iran per
denunciare il TNP sottraendo a quel punto, e al pari dei tre Stati
nucleari che già non ne sono parti, ogni attività nucleare iraniana
al controllo internazionale. E a ben poco servirebbe denunciare
l’illegittimità del recesso una volta che, di fatto, l’Iran è uscito
dal sistema TNP.15
E altrettanto disctubile dal punto di vista giuridico sarebbe
qualificare il recesso come una “minaccia alla pace e alla
sicurezza internazionale” visto che, a quel punto, l’Iran si
troverebbe nella stessa situazione di Pakistan, India e Israele: se,
infatti, esiste il “diritto” di non essere parte del TNP (evitando i
controlli e conducendo liberamente attività di R&D fino al
15
La dottrina (dopo le dichiazioni iraniane secondo le quali un intervento
del Consiglio avrebbe reso “invalid” il TNP per l’Iran) ha richiamato il
combinato disposto dell’art.X del TNP (che prevede la possibilità di
“withdrawn from the Treaty if it [lo Stato] decides that extraordinary
events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the
supreme interests of its country”) e del principio di buona fede indicato
dalla Convenzione di Vienna del 1969 per affermare l’illegittimità del
recesso in mancanza degli “extraordinary events … jeopardiz[ing] the
supreme interests” (così KIRGIS, Iran and the Nuclear Nonproliferation
Treaty, in 10 ASIL Insights 13, 30 maggio 2006). Premessa l’assorbente (e,
per noi, sufficiente) considerazione che le relazioni internazionali sono
caratterizzate giuridicamente dal principio di effettività (ex facto ius oritur
e, talvolta, ex iniuria ius oritur), resta il fatto che, come la stessa dottrina
citata riconosce, manca un meccanismo per accertare la buona fede del
denunciante e, nel caso, l’illegittimità del recesso. E, comunque, il tema
delle sanzioni e della responsabilità statuale per il recesso contra bona
fidem ci appare distinto da quello del perdurare del vincolo dello Stato
verso il trattato illegittimamente denunciato: è pretendendo di identificare
questi due piani di ragionamento (dichiarando inefficace il recesso
illegittimo) che si rischiano pericolose confusioni e si dà indebito ingresso
alla politica nella disciplina giuridica delle relazioni internazionali. Del
resto, la prevalenza della volontà politica sulla legittimità giuridica del fatto
sembra implicitamente (e, per noi, contraddittoriamente) ammessa proprio
da chi, mentre parla di legal issues, buona fede e “mechanism for making a
determination as to whether a party has acted in good faith”, conclude però
ritenendo che “If Iran withdraws from the NPT either lawfully or
unlawfully [corsivo nostro], the SC could determine under Chapter VII that
there is a threat to the peace and could decide on measures to maintain or
restore peace and security” (KIRGIS, op.ult.cit.). Che, poi, non significa
altro che accettare il fatto che il Consiglio non abbia limiti, né giuridici né
politici, alla sua azione (per una serrata critica di questa impostazione, su
tutti ARANGIO-RUIZ, On the Security Council’s “Law-Making”, in
Rivista di diritto internazionale, 2000, p.609 ss.).12
possesso di armi nucleari), allora questo “diritto” non può non
rivivere una volta che lo Stato abbia denunciato il TNP.
Sembra, quindi, che alla deplorazione politica che può
accompagnare il rifiuto dei tre Stati (e, parimenti, l’eventuale
recesso iraniano) di assoggettarsi ad ogni forma di controllo
internazionale, non possa anche aggiungersi una censura di
illegittimità giuridica16
4. La scoperta nel 2002 delle programma nucleare
clandestino iraniano spinse i c.d. EU3 (Francia, Germania e Gran
Bretagna) ad intervenire con l’obiettivo di convincere l’Iran ad
abbandonare (e, per l’intanto sospendere) l’arricchimento
dell’uranio (e, più in generale, le attività nucleari) e a firmare il
Protocollo Addizionale (che amplia i poteri di controllo
dell’AIEA) al Safeguards Agreement.
In effetti, i primi accordi del 21 ottobre 2003 e del 15
novembre 2004 (Paris Agreement) avevano determinato una
intesa (che doveva aprire la strada a successivi negoziati per un
accordo generale) caratterizzata, da un lato, dall’impegno
iraniano a non produrre armi nucleari, a cooperare pienamente
con la AIEA e a prorogare la sospensione delle attività di
enrichment e reprocessing e, dall’altro, dalla promessa europea,
una volta ricostruita la fiducia internazionale, di un “easier
access to modern technology and supplies in a range of areas” e
di “firm guarantees on nuclear, technological and economic
cooperation and firm committments on security issues”.17
L’intesa, prettamente politica come i risultati raggiunti
(applicazione del Protocollo anche se non vincolante; rinuncia
volontaria all’enrichment), però, “side-stepped the [legal] core of
the dispute, Iran’s asserted right to enrich” (che, infatti, è ancora
il punto chiave del dissenso tra Iran e Comunità
internazionale).18
16
Sul valore giuridico delle dichiarazioni del Presidente iraniano contro
Israele, si può leggere ANNIBALE, op.cit.
17
L’accordo di Parigi - come anche la revised March 2005 proposal e la
Comunicazione dell’8 agosto di Francia, Germania e Gran Bretagna (infra,
nota 20) - si legge in www.iaea.org/Publications/Documents.
18
Così, ICG, Iran: Is There a Way Out, cit., p.2.13
Nonostante i tentativi compiuti nella prima metà del 2005
di trovare un accordo,19 i negoziati non registrarono progressi
fino alla rottura avvenuta all’inizio di agosto 2005.20
Poiché fino a quando l’Iran resta nel sistema TNP, i suoi
diritti vanno garantiti e controllati dall’AIEA mediante un
sistema di ispezioni che, se violato, può dar luogo a sanzioni di
varia intensità, si pone il problema di valutare la gravità delle
violazioni.
La non applicazione di un Protocollo Addizionale non
vincolante, di per sé, non costituisce una violazione mentre
l’attività di R&D, legittima sulla base del TNP salva la
violazione dell’art.II, è invece formalmente contraria alla
richiesta di sospensione di questa attività contenuta nella
decisione del Board of Governors dell’AIEA (fatta, poi, propria
dal Consiglio) che, però, non sancisce la violazione dell’art.II del
TNP.21
Resta il dubbio, secondo noi, che dal punto di vista
sostanziale gli inadempimenti iraniani possano non essere così
19
In quel periodo, l’Iran aveva respinto tutte le offerte che non affrontavano
il tema del diritto all’arricchimento. Similmente, gli EU3 avevano respinto
una articolata proposta iraniana in 4 fasi (presentata ai colloqui di Parigi del
23 marzo 2005) secondo la quale, nella prima fase, sarebbe ripresa ad
Isfahan la conversione dell’uranio (rimanendo sospesa l’attività di
enrichment); nella seconda, sarebbero state assemblate, installate e testate
3.000 centrifughe a Natanz con l’impegno a convertire tutto l’uranio
arricchito in barre di combustibile e a non produrne di highly enriched;
nella terza fase, l’Iran avrebbe completato a Natanz un impianto di
centrifughe su scala industriale sotto la continua sorveglianza on-site di
ispettori AIEA ed europei; nella quarta, infine, l’inizio della produzione
industriale a Natanz avrebbe coinciso con la ratifica del Protocollo
Addizionale.
20
Poco prima della rottura dei negoziati, l’1 agosto 2005, l’Iran aveva
introdotto una revised March 2005 proposal nella quale offriva di
abbandonare definitivamente la riprocessazione del combustile esaurito
(utile a recuperare uranio e plutonio) e di sottomettersi ad un regime
ispettivo rafforzato. La risposta europea (presentata con un framework
agreement del 5 agosto e ulteriormente illustrata l’8 agosto in una
Communication), pur riconoscendo il diritto allo sviluppo di un programma
nucleare civile, respingeva l’ipotesi di un Iran capace di arricchire l’uranio
sul proprio territorio e, anzi, chiedeva di limitare le attività solamente alla
costruzione e alla gestione di un light-water power and research reactor.
Dopo pochissimi giorni, si interruppero i negoziati.
21
Sul tema della violazione della decisione e, in generale, sulla gravità
degli inadempimenti iraniani, si veda ancora infra il § 8.14
gravi da giustificare – quanto a necessarietà e proporzionalità - la
richiesta di sospensione (e, ancor meno, il referral al Consiglio).
Raffrontando e soppesando le violazioni e gli
adempimenti iraniani sulla base degli ultimi quattro Reports del
Direttore Generale dell’AIEA sembrerebbe emergere, infatti, un
complesso quadro generale dove si ritrovano gli uni e gli altri.22
Come è tipico dei regimi ispettivi internazionali,
l’obiettivo finale è duplice: da un lato, to account for all
declared nuclear material e, dall’altro, accertare che non
esistano undeclared nuclear materials or activities.
In tal senso, il primo Report del febbraio 2006
(GOV/2006/15), nel Current overall statement conclusivo, dopo
aver evidenziato le passate e ripetute violazioni e la presente
cooperazione,23 sottolinea che “all the declared nuclear material
in Iran has been accounted for” ma che “although the Agency
has not seen any diversion of nuclear material to nuclear
weapons or other nuclear explosive devices, the Agency is not at
this point in time in a position to conclude that there are no
undeclared nuclear materials or activities in Iran”.24
Con rispetto ai vari outstanding issues, quindi, si
evidenziano elementi positivi, negativi e ancora pending nel
comportamento iraniano e la mancanza, però, di una full
transparency che consentirebbe di raggiungere prima il secondo
residuale obiettivo di stabilire che non ci sono undeclared
nuclear materials or activities in Iran.25
22
Il primo report sull’Iran fu presentato oralmente dal Direttore Generale
alla riunione del Board del 17 marzo 2003. Da allora, ed escludendo gli
ultimi 4 del 2006, il Direttore ha presentato 16 reports scritti e alcuni oral
statements.
23
“Iran has made substantial efforts over the past two decades to master an
independent nuclear fuel cycle, and, to that end, has conducted experiments
to acquire the know-how for almost every aspect of the fuel cycle. Many
aspects of Iran’s nuclear fuel cycle activities and experiments … had not
been declared to the Agency in accordance with Iran’s obligations under its
Safeguards Agreement, Iran’s policy of concealment continued until
October 2003, and resulted in many breaches of its obligations to comply
with that Agreement ... Since October 2003, Iran has taken corrective
actions with respect to those breaches”, §§ 46-47, Report n.15.
24
§ 53, Report n.15.
25
Il Report n.15 individua alcuni outstanding issues (tra i quali, Enrichment
Programme, Uranium Metal, Plutonium Experiments, Transparency Visits
and Discussions, Suspension) a loro volta suddivisi in ulteriori aspetti [per
l’Enrichment Programme, vi è, ad esempio, la questione della15
Ad esempio, sul tema della contamination da HEU
particles (la presenza di particelle di uranio highly enriched in
alcuni siti nucleari), la AIEA nota come le analisi tendano a
confermare le spiegazioni date dall’Iran (che, cioè, le centrifughe
erano già contaminate prima del loro arrivo dall’estero in Iran)
sebbene siano necessarie ulteriori ricerche su altre HEU e LEU
(low-enriched) particles.26
Similmente, sull’acquisizione delle centrifughe di prima e
seconda generazione (P-1 e P-2), si nota come “although some
progress has been made ... in the verification of statements by
Iran regarding the chronology of its centrifuge enrichment
programme, the Agency has not yet been able to verify the
correctness and completeness of Iran’s statements concerning
those programmes” mentre, in relazione alle ispezioni condotte
nei siti di Kolahdouz, Parchin e Lavisan, la AIEA già conclude
per l’assenza di unusual activities e di nuclear material nei primi
due, mentre continua l’analisi delle informazioni già ricevute (e
attende di riceverne altre) relative al sito di Lavisan.27
Il secondo Report dell’aprile 2006 (GOV/2006/27) – e
così i successivi (GOV/2006/38 di giugno e GOV/2006/53 di
agosto) – non hanno evidenziato significativi passi avanti o
indietro nello scioglimento delle questioni dubbie o sospese
(anche a causa dell’intervento del Consiglio di Sicurezza che era
fortemente osteggiato dall’Iran).28
Contamination da HEU (high enriched uranium) particles rilevata in alcuni
siti e quella dell’Acquisition of P-1 and P-2 centrifuge technology].
26
§§ 7-10, Report n.15. Il quarto e più recente Report (il n.53) evidenzia la
mancanza di progressi e nuove informazioni sul punto (come anche sul
tema delle centrifughe P-1 e P-2).
27
Sui due temi, si vedano rispettivamente i §§ 11-18 (e 50-51) e 32-40 (e
52) del Report n.15. Per le centrifughe P-1, poi, un punto dolente è
rappresentato da un documento di una pagina scritto a mano (nel quale è
contenuta una offerta fatta nel 1987 all’Iran da un intermediario straniero
relativa alla fornitura di centrifughe non assemblate, informazioni tecniche
e materiale per 2000 macchine) che l’Iran si rifiuta, pur avendolo fatto
esaminare agli ispettori, di fornire in copia all’Agenzia. Sulla questione
delle visite ai tre siti sensibili, invece, si contrappongono i chiarimenti e le
informazioni aggiuntive già fornite, l’attesa per i risultati delle analisi
ancora in corso (e per altre additional information to provide) e il rifiuto di
far intervistare un precedente Direttore del PHRC, Physics Research Center
(l’altro, invece, ha già incontrato gli ispettori) di Lavisan-Shian.
28
In una lettera del 27 aprile inviata al Direttore Generale, infatti, l’Iran
aveva sottolineto di essere “fully prepared to continue granting the16
Il tema dei Plutonium Experiments (relativi alla
separazione di piccole quantità di plutonio) appare
particolarmente delicato (e, al momento, il più negativo) anche
alla luce del fatto che, a fronte di certe inconsistencies emerse tra
i chiarimenti iraniani ed i risultati delle analisi, la AIEA “cannot
exclude the possibility that the plutonium analysed was derived
from sources other than the ones declared by Iran”.29
La questione, invece, del livello di arricchimento
raggiunto sembra smentire, fino ad oggi, certi timori della
Comunità internazionale. Si ritiene, infatti, che un arricchimento
fino al 5% sia compatibile (e, soprattutto, sufficiente) con il
proposito di condurre R&D a scopi pacifici mentre il
superamento della soglia aprirebbe prospettive militari all’uso
dell’energia nucleare. Il primo livello di arricchimento (del
3.6%) dichiarato dall’Iran fu confermato dalle analisi condotte il
18 aprile presso il PFEP (Pilot Fuel Enrichment Plant) di
Natanz;30 il nuovo livello del 5% (raggiunto in giugno) è in corso
di verificazione da parte dell’AIEA.31
Agency’s inspection in accordance with the Comprehensive Safeguards
provided that the Iran’s nuclear dossier will remain, in full, in the
framework of the IAEA and under its safeguards” (§ 6, Report n.27).
29
Così il § 17 del Report n.27. Il Report n.38 (il terzo) dava conto (al § 9,
Plutonium Experiments) del fatto che l’Iran avesse fornito, in giugno,
all’AIEA “further explanations, and a copy of the longbook kept by the
researcher responsible for the plutonium experiments” subito sottoposte a
verifiche sulle quali riferisce negativamente l’ultimo Report n.53: le
explanations e il longbook non forniscono informazioni sufficienti per
chiarire le questioni ancora dubbie e l’Iran afferma di non avere altre
informazioni disponibili (§ 15). Inoltre, gli environmental samples prelevati
da uno dei containers situati nella facility di Karaj (dove vengono stoccati i
depleted uranium targets che sono prodotti durante gli esperimenti sul
plutonio) indicano la presenza di particelle di uranio altamente arricchite. Il
15 agosto l’AIEA ha chiesto informazioni sulla fonte di tale
contaminazione e sull’uso che dei containers è stato fatto in passato (§ 17).
30
“In February 2006, Iran started enrichment tests at PFEP by feeding UF6
gas into a single P-1 machine, and later into 10-machine and 20-machine
cascades. … On 13 April 2006, Iran declared to the Agency that an
enrichment level of 3.6% had been achieved. On 18 april 2006, the Agency
took samples at PFEP, the results of which tend to confirm as of that date
the enrichment level declared by Iran. … The enrichment process at PFEP,
including the feed and withdrawal stations, is covered by Agency
safeguards containment and surveillance measures” (§ 31, Report n.27).
31
“In June 2006, Iran stated that it had achieved enrichment levels of 5%
U-235 in a test run in the 164-machine cascade. Iran provided measurement17
Anche l’overall assessment del secondo Report sottolinea
come tutto il materiale nucleare dichiarato sia stato controllato e
che non è stato trovato altro materiale nucleare non dichiarato (in
aggiunta a quello prodotto, fino al 2003, in attuazione del
ventennale programma nucleare clandestino).32
Resta la preoccupazione legata a certi gaps in the
Agency’s knowledge che non consentono di concludere
definitivamente per l’assenza di undeclared nuclear material
and activities e la constatazione che, dopo tre anni di ispezioni e
nonostante la cooperazione iraniana, il problema non è stato
ancora risolto.33
In particolare, l’obiettivo della full transparency, secondo
l’Agenzia, può essere raggiunto andando oltre le “mere”
previsioni normative del Safeguards Agreement e del Protocollo
Addizionale e adottando, con atto di volontà politica, ulteriori
transparency measures non giuridicamente obbligatorie.34
E su questo punto, ancora una volta, la Comunità
internazionale e l’Iran assumono posizioni diverse (tanto che le
“transparency measures are not yet forthcoming”) dichiarandosi
results from the on-line mass spectrometer to substantiate this statement.
The Agency collected environmental samples, the results of which are still
pending. Iran has refused the Agency access to operating records
concerning product and tail assays which the Agency requires to complete
its auditing activities. However, on 30 August 2006, Iran provided the
Agency with some information about product assays, which the Agency is
currently assessing” (§ 5, Report n.53, cioè il quarto e più recente).
32
Il Summary dell’ultimo Report di agosto evidenzia, come elementi
positivi, il fatto che l’Iran abbia consentito l’accesso al materiale e ai siti
nucleari (con l’eccezione di “certain operating records at PFEP”) e fornito i
required reports e, come elementi negativi, il non aver affrontato certe
questioni da molto tempo in sospeso e non avere offerto la necessaria
trasparenza per chiarire certi dubbi (oltre al mancato rispetto del Protocollo
Addizionale) il che impedisce all’Agenzia di raggiungere la conclusione
che il programma nucleare iraniano sia esclusivamente per scopi pacifici
(§§ 27-29, Report n.53).
33
§§ 33-34, Report n.27.
34
L’accesso “addizionale” a documenti, materiale dual use ed individui
servirebbe a comprendere lo scopo e l’utilizzo del materiale dual use e di
certi studi che potrebbero rivestire valenza militare. Si noti, poi, come
l’AIEA distingua tra safeguards obligations e confidence building
measures definendole different, distinct and not interchangeable. In
particolare, “the implementation of confidence building measures is no
substitute for the full implementation at all times of safeguards obligations”
(§§ 34-36, Report n.27).18
quest’ultimo, a fronte della maggiore disponibilità politica
richiesta, pronto ad adempiere i soli obblighi giuridicamente
vncolanti.
5. Il Consiglio di Sicurezza, raccogliendo le indicazioni e
le preoccupazioni contenute nei Reports, il 31 luglio ha adottato
- under Article 40 of Chapter VII - la Risoluzione 1696 (2006)
nella quale, tra l’altro, chiede il rispetto del Protocollo
Addizionale, la sospensione di tutte le enrichment-related and
reprocessing activities (incluso il R&D), l’attuazione di tutte le
confidence building and transparency measures richieste
dall’AIEA per condurre le ispezioni e, pur non qualificando la
situazione come una “minaccia alla pace e alla sicurezza
internazionale”, manifesta serious concern per questa.
E’ difficile, a nostro avviso, stabilire con certezza se gli
inadempimenti al regime dei controlli e la mancata cooperazione
politica su certi aspetti non vincolanti per l’Iran giustificassero
l’involvment del Consiglio (o, perlomeno, con la tempistica
adottata), tanto più considerando alcuni elementi positivi della
vicenda come la conformità di tutte le declared nuclear activities
e la cooperazione comunque prestata dalle autorità iraniane
Giuridicamente parlando, questi ultimi elementi – se calati
in un contesto che tenga conto anche degli squilibri e delle
lacune dell’intero sistema normativo - potrebbero far apparire
prematuro l’ormai avvenuto rinvio della questione al Consiglio
di Sicurezza.
Politicamente, comunque, non ci sembra convincente il
presupposto politico da cui muove il Consiglio (su indicazione
dell’AIEA), vale a dire “the conviction that such sospension [di
tutte le enrichment-related and reprocessing activities, including
R&D] as well as full, verified Iranian compliance with the
requirements set out by the IAEA Board of Governors, would
contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees
Iran’s nuclear programme is for exclusively peaceful purpose”.35
Porre la sospensione delle activities come precondizione
di ogni possibile negoziato potrebbe non essere la migliore
strategia con l’Iran, anche considerando alcune variabili
politiche quali i pessimi rapporti con gli Stati Uniti, l’attuale
situazione internazionale di forte contrapposizione e tensione, le
discriminazioni e le lacune del sistema TNP e le critiche (giuste
35
Così il § 3 della Resolution 1696 (S/RES/1696, 2006).19
o sbagliate che siano) di double standards che, in generale, si
rivolgono contro il Consiglio.
In ogni caso, il Consiglio ha fatto propria questa
impostazione e, inoltre, ha accolto, richiamandola nella
risoluzione 1696, la proposta S/2006/521 del 13 luglio 2006 per
un accordo complessivo “that would allow for the development
of relations and cooperation with the Islamic Republic of Iran,
based on mutual respect and the establishment of international
confidence in the exclusively peaceful nature of the nuclear
programme of [Iran]”.36
Così, in prima battuta la Comunità internazionale – in
cambio della piena cooperazione con l’AIEA, della sospensione
di tutte le enrichment-related and reprocessing activities e
dell’applicazione del Protocollo Addizionale da parte dell’Iran –
è pronta a riaffermare il diritto iraniano allo sviluppo di un
programma nucleare civile e pacifico, a sostenere actively and
through international joint projects la costruzione di un rettore
ad acqua leggera (in luogo del construendo rettore ad acqua
pesante) e a sospendere l’esame della questione in Consiglio una
volta ripresi i negoziati.
Al di là degli incentivi politici ed economici,37 la proposta
prevede anche la negoziazione di un accordo di cooperazione
nucleare tra Iran ed Euratom, la cogestione del combustibile
nucleare già impiegato e dei rifiuti radioattivi (attraverso
ulteriori accordi da definire) e, soprattutto, una serie di garanzie
circa l’approvvigionamento off-shore di combustile (l’idea, cioè,
che sin dall’inizio aveva avanzato la Russia).
36
La proposta S/2006/521 fu presentata, con lettera del Rappresentante
permanente francese alle Nazioni Unite, da Cina, Francia, Germania,
Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti (Letter dated 13 July 2006 from the
Permanent Representative of France to the United Nations addressed to the
President of the Security Council; i termini della proposta sono contenuti
nell’Annex). La risoluzione 1696 menziona anche il “support of the
European Union’s High Representative” (punto 4 della risoluzione).
37
Principalmente, facilitare l’accesso iraniano ai mercati, ai capitali e
all’economia internazionale (anche tramite l’ingresso nella World Trade
Organization) favorendo gli investimenti stranieri; poi, favorire la
cooperazione nel settore dell’aviazione civile (eventualmente rimuovendo
le restrizioni europee e statunitensi sulle esportazioni di aeromobili civili in
Iran), sostenere la modernizzazione della rete di telecomunicazioni
(eventualmente rimuovendo certe limitazioni all’esportazione imposte dagli
Stati Uniti) e assicurare un possibile accesso ai prodotti e alle tecnologie
agricole europee e statunitensi.20
Attraverso garanzie legally binding, cioè, all’Iran sarebbe
assicurata la partnership nella gestione di un impianto
internazionale in Russia che arricchirebbe il materiale per poi
effettuare una reliable fornitura di combustile ai reattori nucleari
iraniani. Inoltre, sarebbe garantita per l’Iran una riserva di
combustibile nucleare (con la partecipazione e sotto la
supervisione dell’AIEA) fino a 5 anni.38
A questa proposta, è seguita il 22 agosto una
controproposta dell’Iran che, però, su sua richiesta, è rimasta
confidential ed è attualmente allo studio dei c.d. P5 plus 1 (i 5
membri permanenti del Consiglio più la Germania): essa,
probabilmente, è l’oggetto principale dei colloqui attualmente in
corso a Berlino tra il Responsabile della Politica Estera
dell’Unione Europea ed il capo negoziatore iraniano.39
E’ trapelato, comunque, che essa contiene “some positive
elements” (tra cui la disponibilità a riprendere i negoziati sul
proprio programma nucleare) ma che, allo stesso tempo, non
accoglie, ancora una volta, la precondizione circa la sospensione
dell’enrichment. Gli Stati Uniti, pur dichiarando la proposta “not
satisfactory because it did not envisage a suspension of uranium
enrichment and remained vague on transparency issues”, hanno
comunque riconosciuto la serietà dell’approccio iraniano al
dialogo (tra l’altro, gli Stati Uniti sembrano – rispetto alla loro
38
La proposta, in punto di Fuel guarantees, prevede anche il “development
with IAEA of a standing multilateral mechanism for reliable access to
nuclear fuel, based on ideas to be considered at the next meeting of the
Board of Governors” (S/2006/521, Annex to the Letter, cit., p.3).
39
All’esito della due giorni di colloqui (28-29 settembre 2006), Javier
Solana ha dichiarato in conferenza stampa di “non essere riuscito a
raggiungere un accordo … ma di aver posto le basi per future discussioni:
‘Facciamo progressi … Abbiamo ancora alcune questioni che non sono
state chiuse’ ha detto Solana [che] spera in nuovi contatti con gli iraniani a
metà della prossima settimana” (Reuters, 29 settembre 2006). Sempre la
Reuters, poi, richiama il Washington Times secondo il quale “l’Iran è vicino
ad un accordo che comporterebbe una sospensione di 90 giorni
dell’arricchimento dell’uranio e aprirebbe la strada a negoziati sui dettagli
del pacchetto. L’Iran ha bollato la notizia come propaganda. Ma fonti
francesi dicono che Larijani si è offerto di prendere in considerazione una
sospensione temporanea in un vertice con Solana due settimane fa”
(Reuters, 29 settembre 2006). Questi brevi righe vengono licenziate per la
stampa il 29 settembre 2006.Puoi anche leggere