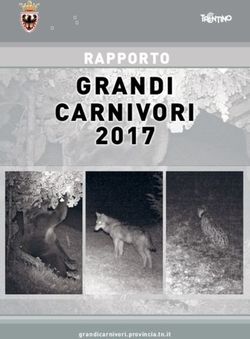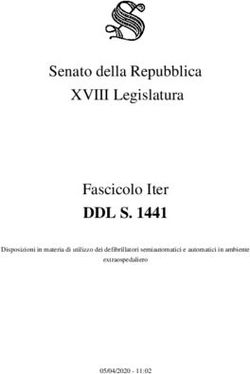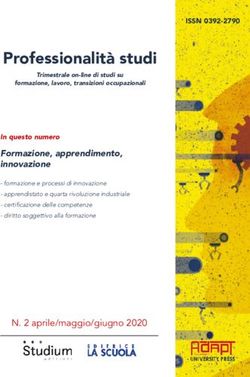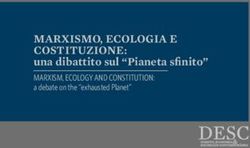Presenza del lupo in Puglia
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Presenza del lupo in Puglia
di
Giampaolo Pennacchioni
Nel periodo dei mesi di novembre e dicembre 1987, gennaio, febbraio,
ottobre, novembre e dicembre 1988, gennaio e febbraio e dicembre 1989,
gennaio, febbraio, marzo 1990, inverno 1991, dicembre gennaio 1992, gennaio,
febbraio, novembre e dicembre 1993, Gennaio e febbraio 1994, si sono
effettuate una serie di indagini volte a stabilire in primo luogo la presenza o
meno del lupo in Puglia e, in secondo luogo, ove vi fossero stati risultati
positivi, cercare di determinarne il numero.
Lo stimolo all'operazione è stato dato da una serie di fatti estremamente
significativi quali una lunga sequela di danni a bestiame domestico attribuiti di
solito al lupo e le numerose segnalazioni di presunti avvistamenti da parte delle
più disparate categorie di persone.
Ad onor del vero, nel 1986, chi scrive era stato chiamato dalla stazione
della Forestale di Orsara di Puglia per il recupero di un individuo
immediatamente attribuito a lupo da contadini ed allevatori, nonché dal
dirigente della Stazione forestale. L'esame effettuato con un zoologo,
appositamente giunto dal Parco Nazionale d'Abruzzo, permise di stabilire che
si trattava di un esemplare che aveva alcune spiccate caratteristiche lupine ma
che, stante la taglia, il colore di fondo della pelliccia ed altri caratteri minori, era
ragionevole definire come meticcio fra cane e lupo.
A questa situazione si aggiungeva il fatto che in Puglia, oltre alle voci
circolanti con la solita abbondanza, nulla si sapeva di concreto e verificabile
sulla "situazione lupo" e che, forte di questo stato di cose, l'Amministrazione
Regionale non pagava i risarcimenti dei danni al bestiame domestico, con la
conseguente nefasta tendenza degli operatori zootecnici ad usare con troppa
facilità i fucili.
Occorrendo quindi mettere un punto fermo alla situazione, si varava un
piano preliminare di ricerca per verificare l'attendibilità o meno
349delle varie segnalazioni, che, per lo più sotto forma di lamentela, giungevano da
parte di numerosi allevatori.
Per questa fase preliminare si è optato per la tecnica del "Wolfhowling"
sia per la sua attendibilità, che per la sua relativa facilità di uso, in un
comprensorio dalla morfologia tutt'altro che semplice.
Una prima fase ha avuto come obiettivo la conoscenza completa dei
comprensori che, stante la presenza di un ambiente ancora vivibile per il lupo,
potevano essere presi in considerazione per il controllo.
In questa prima fase sono state individuate tre unità territoriali ove
incentrare le ricerche. Queste unità possono essere definite come segue:
la prima nella parte settentrionale del Subappennino Settentrionale nei
territori dei comuni di Motta Montecorvino, Volturara Appula, S. Marco la
Catola, Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio
di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino;
la seconda unità, individuabile a cavallo fra la porzione meridionale del
Subappennino Settentrionale e la porzione settentrionale del Subappennino
Meridionale e comprendente i territori dei Comuni di Biccari, Alberona,
Roseto Valfortore, Faeto, Celle S. Vito, Castelluccio Valmaggiore, Orsara di
Puglia;
la terza unità, definibile nel territorio dei comuni di Bovino, Panni,
Deliceto, Accadia, Monteleone di Puglia.
Caratteristica comune alle tre unità territoriali è la morfologia piuttosto
movimentata del territorio e la presenza di numerose zone boscate, anche di
vasta estensione e poco frequentate dall'uomo.
Un peso particolare è stato dato alla possibilità di comunicazione fra le
varie aree naturali con buona potenzialità per il predatore, comunicazioni per lo
più rappresentate da corsi di torrenti impervi e fortemente boscati.
La seconda fase ha visto il coinvolgimento delle strutture amministrative
mediante una richiesta di collaborazione, consistente nell'informazione agli
abitanti, sulla ricerca in corso, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti
(sparatorie contro i ricercatori "ululanti") ed inutili allarmismi.
Gli Enti interessati sono stati i Comuni, le due Comunità Montane,
l'Assessorato Caccia della Provincia, la Prefettura, il Corpo Forestale dello
Stato.
La maggiore sensibilità è stata riscontrata nei Comuni, i quali hanno
provveduto in gran parte ad avvisare la popolazione sia me
350diante manifesti sia attraverso "avvisi a voce" diramati con altoparlanti e da
parte delle Comunità Montane.
Silenzio più assoluto invece da parte dell'Amministrazione Provinciale.
La terza fase è consistita nell'esecuzione vera e propria della ricerca, con
un gruppo di emissione dell'ululato di richiamo ed almeno due gruppi di
ascolto, con collegamenti via radio per un migliore coordinamento. A questa
fase ha collaborato anche un'Associazione ambientalista di Bovino, P.A.T.A.
(protezione ambientale -tutela antincendio) che ha messo a disposizione, oltre a
personale e mezzi, anche e soprattutto una profonda conoscenza del territorio.
Sono stati effettuati in totale più di 600 lanci di richiami mediante
trombetta esponenziale da 12 Watt impiegando complessivamente oltre 80
nottate di lavoro.
Ogni lancio veniva registrato su scheda compilata a cura di un centro di
coordinamento mobile che raccoglieva le informazioni via radio. Ogni ululato
di risposta veniva verificato personalmente dal direttore della ricerca per
l'individuazione della provenienza e per l'accertamento della risposta stessa
(lupo o cane).
A conclusione della ricerca sono stati identificati tre siti con sicura
presenza di lupi, anche se con un numero di esemplari estremamente ridotto.
Il primo nucleo è stato localizzato la prima volta nel Bosco Vetruscelli in
agro di Roseto Valfortore. La risposta, nettissima, è stata individuata come
proveniente dal fondo di un canalone che percorre il bosco in senso
longitudinale ed è stata giudicata relativa a tre individui adulti.
Nella zona, in realtà, durante altre emissioni in altro periodo, erano stati
registrati altri ululati di risposta, ma ad un attento esame era stata scartata la
possibilità che si trattasse di esemplari di lupo, in parte perché individuati
provenire da casolari con cani ed in parte perché la tipologia dell'ululato pareva
discostarsi nettamente da quella ritenuta tipica del lupo, con la tendenza più al
latrato ed all'abbaiamento che all'ululato. Inoltre, a successive emissioni
continuate, non corrispondevano costanti risposte con ululati, rarefacendosi
questi nel corso dei richiami, per essere sostituiti da abbaiamenti e latrati.
Questa discriminazione veniva poi confermata da successive indagini "a
vista" che permettevano l'individuazione di numerosi cani nelle località ove si
erano avute le risposte sospette.
351La risposta proveniente dal bosco Vetruscelli, inoltre ha avuto il,
successivo supporto di ulteriori conferme indirette consistenti nelle reazioni dei
cani presenti nel territorio che hanno accentuato i latrati in concomitanza
dell'ululato di risposta.
La località, da tempo, era interessata da numerosi danni al bestiame
domestico.
In epoca successiva alla ricerca condotta con il metodo del wolfhowling,
è stato compiuto un avvistamento di quattro esemplari di lupo in una zona
poco distante dal luogo del primo accertamento. Questo avvistamento, oltre a
confermare la presenza del lupo, conferma anche alcune ipotesi già fatte sulle
direttrici di spostamento degli esemplari censiti al Bosco Vetruscelli e sulla zona
di frequentazione dello stesso nucleo.
Le successive ulteriori verifiche, negli anni successivi, hanno permesso di
delineare con una certa attendibilità l'area di maggiore concentrazione del
gruppo di lupi in esame.
E’ purtroppo necessario, per motivi di tutela, tacere ulteriori particolari
circa la zona di più intensa frequentazione, ma in linea di massima si può dire
che tutta l'area comprendente i Comuni di Biccari, Alberona, Roseto
Valfortore, Orsara di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle S. Vito
sono interessati alla presenza del predatore.
Il secondo gruppo è stato localizzato per la prima volta in agro di
Accadia, ai piedi del Monte Crispiniano, nel versante che guarda verso
l'Avellinese.
Qui è stato possibile registrare la presenza iniziale di tre esemplari adulti e
di un giovane dell'anno precedente, individuabile dall'ululato non ancora
maturo.
Anche qui, all'atto della risposta si è avuta un'esaltazione delle reazioni dei
cani del circondario.
In questa zona, appartenente alla seconda unità territoriale esaminata, non
si erano registrati ululati riferibili a cani.
Una ulteriore indagine nel 1988-89 ha permesso di censire ancora una
volta la presenza del predatore nello stesso comprensorio, molto
probabilmente con gli stessi esemplari.
Ulteriori conferme, in zone limitrofe e pertinenti allo stesso gruppo,
sono state ottenute negli anni successivi, sino ad oggi.
Gli ultimi censimenti hanno permesso di stabilire una consistenza
numerica del gruppo non superiore ai 4 - 5 esemplari e non tutti gli anni si
sono registrate riproduzioni.
352Anche qui si sono potute fare alcune ipotesi circa le zone di
frequentazione del branco, zone che sicuramente comprendono territori
pugliesi e campani.
In effetti, l'ambiente del comprensorio, almeno per quanto riguarda la
porzione pugliese, non appare ideale allo sviluppo di una consistente
popolazione di lupi in quanto le aree naturali boscate, possibile rifugio del
predatore, appaiono troppo frammentate e talvolta prive di validi collegamenti
fra di loro.
Maggiore potenzialità è invece presente nella zona campana, ove
l'ambiente potrebbe offrire qualche chance in più.
E’ quindi ragionevole pensare ad un fenomeno di erratismo del gruppo
con incursioni nelle due aree.
La terza zona di presenza del lupo è stata definita nel comprensorio
boscato che va da Monte Sambuco a Celenza, Carlantino, Casalnuovo,
Castelnuovo della Daunía, Casalvecchio di Puglia, Pietra Montecorvino. t
un'area piuttosto estesa, con una zona protetta corrispondente
approssimativamente al Bosco di Celenza, per lo più difficilmente accessibile se
non con mezzi adeguati.
Il rilevamento della presenza degli esemplari nella zona è avvenuto in più
fasi, con l'accertamento dell'esistenza iniziale di un nucleo di 5 esemplari e
probabilmente di un ulteriore individuo isolato.
Il lavoro si è presentato alquanto più complesso delle altre zone per le
difficoltà di percorrenza a causa della morfologia del territorio, con notevoli
problemi anche per quanto riguarda i collegamenti radio fra i vari operatori.
Il nucleo iniziale, composto presumibilmente da 5 esemplari, è stato
censito più volte, in giorni diversi, a distanze anche ragguardevoli dal punto di
individuazione precedente. In ogni caso il territorio percorso dal branco risulta
gravitare intorno al comprensorio boscato prima menzionato.
La disponibilità di riserve di acqua relativamente abbondanti e distribuite
in modo sufficientemente omogeneo permette al branco di potersi spostare
per il territorio con una certa libertà.
L'esemplare isolato è stato censito per due volte di seguito, la seconda
volta a qualche chilometro di distanza dal punto di individuazione precedente.
Successivamente, la sua presenza non è stata più rilevata. A questa ultima
individuazione si riserva il beneficio del dubbio e non verrà calcolata nel
computo complessivo delle presenze in zona.
353Negli anni successivi al primo di indagine, si è assistito ad una crescita
continua e regolare del branco, oltre che ad una stabilizzazione del territorio.
In effetti, in tutto il territorio subappenninico, questo è il gruppo che più
riveste interesse in quanto, nonostante si siano registrate alcune morti, sia
accidentali (un esemplare è stato investito da una macchina nel novembre 1993),
sia intenzionali (un altro esemplare adulto è stato rinvenuto nella boscaglia
ucciso a fucilate), purtuttavia il branco ha continuato a crescere numericamente,
con riproduzioni regolari tutti gli anni, sino a raggiungere una consistenza, nel
gennaio 1994, di una diecina di esemplari. t su questo branco che,
prossimamente, si accentreranno le maggiori attenzioni, costituendo, a tutt'oggi,
il nucleo più numeroso di tutta la Puglia.
Il lavoro condotto in tutte e tre le zone ha permesso inoltre di ottenere
una ulteriore conferma della presenza approssimativa dei cani nel territorio,
confermando, per alcune zone un'alta densità della popolazione canina.
In conclusione si è potuta verificare l'esistenza di un numero iniziale
stimabile in una diecina - dodici di esemplari di lupo, divisi in tre nuclei
presumibilmente separati tra di loro, sino al raggiungimento di un numero
stimabile, a gennaio -febbraio 1994, di una ventina di esemplari e forse più..
E’ da tener presente che fra le prime due zone interessate dalla presenza
dei predatori vi è una notevole barriera ecologica costituita dalla esistenza, una a
fianco all'altra, di una strada statale, del fiume Cervaro e della ferrovia Foggia-
-Napoli, barriera difficilmente valicabile anche in relazione alle frequenti
costruzioni abitate sorte in corrispondenza di queste strutture. Fra la terza zona
ed il resto del comprensorio le barriere sono meno pesanti, intendendo con ciò
la mancanza di grosse arterie di traffico e di strutture industriali.
Esistono però delle interruzioni della fascia boscata costituite da
coltivazioni intensive di cereali.
Questo fatto, comunque, non può essere considerato assoluto.
Esistono numerosi indizi, non del tutto verificati, che le abitudini del
lupo stiano lentamente cambiando. ~ stato infatti talvolta accertato che i coltivi
e le zone antropizzate non costituiscano una barriera insormontabile in senso
assoluto e, in qualche raro caso, alcuni avvistamenti sono avvenuti proprio in
aree intensamente coltivate (zone coltivate a grano, a mais, ecc.).
354Qualche considerazione
Le ricerche si sono incentrate su un territorio che da tempo lamentava
una serie di danni al bestiame domestico, danni che si verificavano
essenzialmente nei periodi tardo autunnali, invernali e all'inizio della primavera,
per poi rarefarsi negli altri periodi, senza però mai calare a zero.
D'altra parte, da lungo tempo ormai si riteneva che il lupo si fosse
estinto nel comprensorio e si imputava la totalità dei danni alla presenza di
numerosi cani randagi.
Mai però era stata condotta una seria indagine sull'effettiva scomparsa
del nostro predatore nel comprensorio, né era stata mai condotta alcuna ricerca
approfondita circa l'effettiva consistenza numerica del cane. Alcuni episodi,
comunque, mantenevano sospesa la questione, almeno fino al 1986 quando un
pastore della zona di Orsara uccideva a fucilate un esemplare che ad una
approfondita analisi risultava essere attribuibile ad un meticcio fra cane e lupo.
Veniva quindi a prendere corpo il sospetto che alcuni lupi fossero
sopravvissuti nell'area o in qualche località ancora naturalmente integra ai confini
della regione Puglia.
Un avvistamento, da parte dello scrivente, su segnalazione di alcuni
cacciatori di Roseto Valfortore, confermava questo sospetto nello stesso
periodo del recupero dell'esemplare di Orsara di Puglia.
Le attuali conferme, dopo la ricerca condotta con la tecnica del wolf
howling, giustificano il sospetto che esistano alcuni corridoi che dalle zone
Beneventane ed Avellinesi permettano incursioni del predatore nelle nostre
zone.
Per quanto riguarda l'origine dei tre nuclei individuati nel territorio
pugliese è ragionevole pensare che possa esistere uno scambio fra la zona
dell'Avellinese e la zona di Accaffia e fra la zona Beneventana e quella del
Subappennino Dauno Settentrionale (nucleo della zona di Roseto) e fra il
Subappennino ed il Molise (nucleo del bosco di Celenza).
Questa ipotesi troverebbe una conferma nel fatto che l'esemplare ucciso
ad Orsara di Puglia nel 1986 si trovava al confine con la regione Campania e
che anche in quei territori erano da tempo stati segnalati danni al bestiame.
E quindi ipotizzabile che gli esemplari attualmente censiti nel
comprensorio del Subappennino Dauno non debbano essere conoide-
355rati strettamente "residenti" nel territorio, ma che quest'ultimo faccia parte di
una ben più vasta area familiare a cavallo fra le due regioni confinanti (Puglia e
Campania).
Per la zona del bosco di Celenza, invece, potrebbe essere ormai
accreditata l'ipotesi di un nucleo residente, anche se occorrerà ampliare ed
approfondire le ricerche prima di poter affermare con sicurezza la cosa.
La possibilità di permanenza di un nucleo di predatori quali il lupo in un
territorio è strettamente legata anche alla possibilità di rinvenire nell'area di
frequentazione una adeguata riserva alimentare a cui attingere.
Scomparsi dal comprensorio i grandi erbivori, il lupo ha visto
estremamente ridotte le riserve trofiche. D'altra parte, un fenomeno
sufficientemente diffuso di pastorizia potrebbe costituire un notevole stimolo
alla predazione di domestici da parte del nostro selvatico.
Nonostante le numerose segnalazioni di danni al bestiame allevato, però,
si deve supporre che questo non costituisca se non una fonte alimentare
secondaria, utilizzata esclusivamente in caso di stretto bisogno.
A questo livello è significativo l'esame del contenuto stomacale degli
esemplari uccisi e fin qui recuperati. Si sono rinvenute tracce evidenti di
predazione su micromammiferi, essenzialmente ratti e topi, mentre sicuramente,
in alcuni casi (soprattutto per l'esemplare di Orsara) l'animale si apprestava a
predare alcuni ovini.
La presenza nello stomaco di roditori selvatici ci porta a considerare
questa categoria come una delle fonti di alimentazione del lupo, ciò in accordo
con osservazioni effettuate in altre zone.
Non è stato purtroppo possibile esaminare altri contenuti stomacali in
quanto di alcune uccisioni si sono avute solo vaghe notizie e gli eventuali
esemplari uccisi sono stati occultati per paura, causando quindi in questo modo
la perdita di importantissime informazioni.
Inoltre, spesso, quando si giunge a poter recuperare l'esemplare, è
trascorso diverso tempo dalla morte e l'esame delle parti interne, soprattutto lo
stomaco, risulta assolutamente impossibile.
Non ostante questa scarsità di notizie sull'argomento, è ragionevole
pensare che la maggiore fonte di alimentazione del lupo sul territorio in esame
sia costituita da micromammiferi selvatici, seguita in ordine da selvaggina
reintrodotta a scopo venatorio e, successivamente, da animali allevati.
356Soprattutto ultimamente, sono state accertate predazioni sul cinghiale,
anche se al momento sembra che oggetto dell'interesse del lupo siano
soprattutto i piccoli. Anche questo, comunque può essere considerato, al
momento, una ipotesi di lavoro, da verificare con maggiore accuratezza.
E’ lecito quindi supporre che una migliore gestione del patrimonio
faunistico selvatico ed una sua ricostituzione allontanerebbero il lupo dagli
allevamenti, mantenendolo nelle zone più selvagge del territorio, restituendo al
nostro predatore la sua funzione di controllore dell'ambiente.
Un altro problema sollevato dall'indagine è quello dell'aumento,
soprattutto nel comprensorio settentrionale del Subappennino, del numero di
lupi.
L'analisi fenotipica degli esemplari recuperati mostra alcuni dettagli che ci
porterebbero ad ipotizzare, in alcuni casi, l'esistenza di meticci fra cani e lupi.
In effetti occorre fare alcune considerazioni che in questo momento
costituiscono, ancora una volta, solo una ipotesi di lavoro.
La vitalità di una popolazione di animali è garantita, oltre che dalla
disponibilità di un ambiente adatto e di cibo a sufficienza, da un numero
minimo di animali e dalla possibilità di interscambio fra questa ed altre
popolazioni. In mancanza di questo presupposto si va incontro al fenomeno
dell'imbriding, ovvero del reincrocio fra consanguinei, con il conseguente
indebolimento del patrimonio genetico.
Questa situazione, a lungo andare, porta all'estinzione della popolazione,
passando attraverso alcuni fenomeni anomali che possono portare, nei casi più
frequenti, a malattie genetiche debilitanti e che, in molti casi, documentati
soprattutto paleontologicamente, sono costituiti da fenomeni di gigantismo o
di nanismo.
All'atto del primo censimento era stata rilevata una popolazione
totalmente insufficiente a soddisfare questa esigenza numerica, tanto che si era
ipotizzato che ormai la popolazione di lupi del comprensorio fosse allo
"stremo genetico".
In periodo successivo, come già accennato, si è notato uno sviluppo
notevole della stessa popolazione, con la comparsa, però, di caratteri che si
discostavano dal fenotipo lupino conosciuto in altre zone.
D'altro canto, come più avanti verrà affermato, un lupo che incontri una
femmina di cane in calore è portato ad accoppiarsi piuttosto
357che ad attaccare, attuando, con questo atto, una sorta di rinnovamento del
patrimonio genetico.
Poiché il genotipo selvatico è dominante su quello domestico, i frutti
dell'accoppiamento mostreranno la maggioranza dei caratteri selvatici, cioè
lupini, mentre dell'apporto genetico domestico, spesso, non rimangono che
labili tracce (nel nostro caso, aumento della taglia, pelame più rossiccio che nel
selvatico, ecc.).
Paradossalmente, ma qui siamo nel campo delle ipotesi di lavoro tutte
da verificare, molto probabilmente la salvezza del lupo nel Subappennino è da
attribuire proprio ad un elemento negativo, vale a dire la presenza del cane
vagante.
L'accoppiamento con esemplari di cani avrebbe, infatti, avuto la
funzione di rinnovare il patrimonio genetico evitando quindi l'estinzione del
lupo per i motivi su accennati.
Tutela: interazione fra cani e lupi
Sia il cane che il lupo sono predatori e, sotto un certo aspetto, a livello
ecologico, possono essere considerati uno sostitutivo dell'altro.
Anche a livello tassonomico le due forme devono essere considerate
appartenenti alla stessa specie (Canis lupus), essendo fra essi interfecondi e,
soprattutto, dando origine ad una prole a sua volta fertile
Sarebbe quindi pienamente rispettata una delle condizioni che la scienza
pone per poter attribuire due esseri viventi alla stessa specie.
Il problema della convivenza delle due forme, lupo e cane, nasce ed
esplode in tutta la sua importanza nel momento in cui si va a considerare
l'impatto che le due forme hanno nei confronti dell'ambiente. Già in
precedenza, in questo stesso lavoro, si è accennato alla questione.
Vi sono infatti delle fondamentali differenze sia a livello
comportamentale che a livello di impatto sull'ambiente che portano a dover
fare una netta distinzione fra cani e lupi e a dover giungere ad una serie di
conclusioni a tutto sfavore della presenza incontrollata del cane in natura.
Per rendere comprensibili le conclusioni ovvie a cui si giungerà in questo
lavoro, ma che comunque traspaiono nettamente sin dalle prime righe, occorre
premettere una serie di considerazioni, forse
358altrettanto ovvie, ma che per lo più sfuggono durante l'analisi del problema.
In primo luogo, il lupo, dopo millenni di selezione naturale, si è
perfettamente adattato all'ambiente, sviluppando una serie di tecniche di
predazione altamente specializzate e "costruite" sulle prede tradizionalmente
presenti sul territorio.
Questo adattamento manca nel cane, la cui presenza sul territorio è da
imputarsi a sconsideratezza umana. Il cane, infatti, si presenta con centinaia di
forme estremamente diversificate, ognuna con una sua caratteristica peculiare,
con una sua specializzazione non già frutto di selezione naturale e quindi di
adattamento all'ambiente, ma bensì frutto di selezioni artificiali operate
dall'uomo in relazione a sue ben specifiche necessità.
In molti casi, quindi il cane si trova in un ambiente a lui estraneo o
comunque ostile, soprattutto per quanto riguarda i primi tempi.
Se l'animale non soccombe, sopravviene una specie di adattamento, il
più delle volte consistente nella frequentazione degli immondezzai che
forniscono una buona fonte di alimentazione. Per lo più in prossimità di questi,
i cani vanno a partorire, aumentando considerevolmente di numero.
Anche in questo caso, la riproduzione, si evidenziano grosse differenze
nei confronti del lupo. In quest'ultimo, infatti, la riproduzione è affidata a due
esemplari dominanti, maschio e femmina, una sola volta l'anno. Il resto del
branco non si riproduce.
Nel cane invece, tutti i maschi si accoppiano con tutte le femmine, due
volte l'anno.
E’ evidente quindi come il potenziale riproduttivo del cane sia
enormemente maggiore di quello del lupo.
Tale fatto porta già di per sé ad una conseguenza negativa consistente
essenzialmente in una maggiore potenzialità infestante, a livello sanitario, del
cane per ben due aspetti. Questo infatti, frequentando elettivamente discariche,
sta a contatto con materiali anche infetti, oltre che con animali (principalmente
ratti e topi) che in situazioni tipiche quali quelle esistenti nelle discariche
divengono portatori di numerose malattie. Il cane può contrarre queste malattie
e trasmetterle anche a distanza notevole.
A questo si aggiunge il suo notevole potenziale riproduttivo.
Nel lupo, i riproduttori sono i due individui dominanti, due individui,
cioè, che sono al momento i più forti del branco. Generalmente
359questo fatto si traduce nella produzione di prole altrettanto forte. Nel cane, il
fatto che si riproducano tutti gli individui, ivi compresi quelli portatori di tare,
fa sì che anche la prole possa portare tali tare, producendo individui che a
lungo andare daranno origine a popolazioni non sane, facili ad essere preda di
infestazioni e potenzialmente capaci di trasmetterle. Il tutto va considerato,
inoltre, alla luce di una densità di popolazione che nel cane è estremamente
maggiore rispetto al lupo, con conseguenti maggiori scambi di contatti, oltre
che di individui. Qui infatti entra in gioco l'esistenza di un più o meno marcato
stimolo alla coesione, stimolo che, si è visto, nel cane è minimo rispetto al lupo.
In una siffatta situazione è facile che si verifichi che individui di cane,
passando da un branco all'altro, divengano efficacissimi veicoli di trasmissione
di infestazioni.
L'altro problema dovuto alla presenza di un numero elevato di cani
vaganti in un ambiente popolato anche dal lupo, prende le mosse dalla
situazione anomala delle risorse alimentari disponibili sul territorio.
Nella zona in esame queste, se si fa astrazione dalle discariche, sono
scarse, essendo numericamente esigue le popolazioni delle possibili prede. In
tale contesto la competizione alimentare diviene estremamente pesante, a tutto
danno del lupo, numericamente più esiguo. Ciò costringe il nostro predatore
ad un maggiore erratismo e, come ultima risorsa per la sopravvivenza ad
avvicinarsi sempre più spesso agli allevamenti. Da ciò, prendono origine i
consistenti danni al bestiame causati dal lupo.
Il ricorso alla discarica come fonte alimentare alternativa porterebbe
anche per il lupo alla esposizione a possibili infestazioni, oltre che ad un
progressivo eccessivo avvicinamento dell'animale ai centri abitati.
In una situazione "ambientalmente sana", cani e lupi di solito non
interferiscono in modo pesante fra di loro, se non a livello di competizione per
il territorio o per le citate risorse alimentari.
In situazioni anomale, come quelle che attualmente si presentano su quasi
tutto il territorio italiano e, particolarmente nell'area del Subappennino Dauno,
ove il lupo è estremamente rarefatto ed i branchi sono ridotti a pochi individui
e dove sempre più frequentemente ci si trova di fronte a lupi solitari, le
interazioni, soprattutto a livello riproduttivo, divengono più pesanti con
conseguenze nefaste, a lungo
360andare, per la stessa sopravvivenza del lupo. Si assiste cioè alla produzione di
meticci, risultato dell'accoppiamento fra cani e lupi, con una prima gravissima
conseguenza a livello ereditario, costituita essenzialmente dall’ "inquinamento"
del patrimonio genetico del lupo.
Nella zona in esame, in effetti, la maggior parte dei lupi" recuperati
morti, presentava, a livello fenotipico, caratteri morfologici alterati rispetto a
quelli tradizionalmente presenti in popolazioni lupine più pure: aumento della
taglia, alterazione del colore del mantello, scomparsa o diminuzione di caratteri
cromatici tipicamente lupini (barre nere sulle zampe anteriori, alterazione della
mascherina cromatica facciale, ecc.), alterazioni morfologiche a carico della
forma, dimensione e posizione delle orecchie, a carico della coda (risulta
sovente alterato il rapporto lunghezza totale dell'animale/lunghezza della coda),
ecc.
Questi dati rilevati a livello fenotipico sono indice di sicure modificazioni
genotipiche, quindi di inquinamento del patrimonio genetico. Tali caratteri
"canini", in caso di ulteriore riaccoppiamento del meticcio con altri cani,
verranno trasmessi alla prole e, soprattutto in caso di continuo accoppiamento
della prole con altri cani, verranno successivamente rafforzati man mano che
procederanno le generazioni sino a far scomparire il genotipo lupo e a dar vita
infine a popolazioni esclusivamente canine, sia pure con una componente
genetica di tipo lupino. In quel momento si sarà perso definitivamente il
predatore selvatico.
Ciò, anche se, come evidenziato in precedenza, molto probabilmente, in
assenza di cani vaganti, avremmo già perso il lupo per “esaurimento genetico”.
Il problema risulta quindi particolarmente complesso per l’ aspetto
conservazionistico, come appresso maggiormente evidenziato.
Un altro problema legato alla protezione del lupo, e imputabile ancora
alla presenza di un elevato numero di cani vaganti, è costituito dalle reazioni di
difesa degli operatori agricoli, zootecnici e forestali impegnati quasi
quotidianamente sul nostro territorio.
Più volte, infatti, sono stati registrati attacchi a persone da parte di cani,
attacchi per lo più imputati al lupo. Più volte, infatti, si è sparsa la voce di lupi
uccisi per legittima difesa e che, ad una analisi delle carcasse, sono risultati essere
cani.
Il problema della sicurezza delle persone è un aspetto da non
sottovalutare. La cultura tradizionale vuole il cane buono, amico
361dell'uomo, mentre il ruolo di cattivo è attribuito costantemente al lupo.
Si genera così una sorta di psicosi che porta come conseguenza a girare
per le campagne e per i boschi armati e a sparare al minimo sospetto di
aggressione od anche al solo avvistamento di un "qualche cosa che potrebbe
essere un lupo".
Sono stati eliminati, in questo modo, diversi cani, ma ugualmente sono
caduti sotto il fuoco dei fucili anche alcuni lupi. L'uomo in definitiva è portato
a sparare prima ancora che l'animale mostri un qualsiasi atteggiamento di
aggressività, con la scusa che "prima o poi, tanto, attacca".
Questi fatti, testimoniati da più di una persona, costituiscono un reale
pericolo per la sopravvivenza del lupo, costantemente scambiato con il cane (e
viceversa con cani costantemente scambiati per lupi).
A livello conservazionistico i risultati della ricerca dovranno servire a
permettere alla Regione Puglia di prevedere interventi di risarcimento dei danni
al bestiame domestico (attualmente la Regione riconosce il risarcimento anche
per il lupo, ma a tutt'oggi non risulta effettuato alcun rimborso), ma nello
stesso tempo aprono nuovi interrogativi ai quali sarà doveroso rispondere con
ulteriori fasi di indagine.
Uno di questi, legato strettamente al problema conservazionistico, è
costituito dalla possibilità di ulteriore incrocio con i cani che, si evince dai
risultati dello studio condotto, sono piuttosto numerosi in zona
Facendo astrazione dal discorso se sono cani rinselvatichiti, randagi o
padronali, il fatto importante resta che questi animali sono liberi di vagare per il
territorio, di accoppiarsi, partorire indisturbati ed invadere sempre di più
l'areale del lupo.
D'altro canto il numero estremamente esiguo di questi ultimi ci induce a
pensare che esista una forte tendenza all'incrocio con i cani, a causa della
scomparsa, proprio per effetto dell'esiguità numerica, dell'effetto branco che
porterebbe piuttosto ad una competizione che ad una coabitazione con
possibilità di accoppiamento.
L'affermazione fatta circa la presenza di una ventina di esemplari di lupo
nel territorio in esame, alla luce di quanto detto, potrebbe opportunamente
essere corretta, fino a nuove e più conclusive indagini, con l'affermazione che si
tratta di esemplari di lupo o di meticci fra cane e lupo, propendendo per
quest'ultima conclusione fino a prova contraria.
362Come già in precedenza accennato, infatti, il progressivo "inquinamento"
del patrimonio genetico del lupo con elementi "canini" potrebbe portare, nel
giro di pochi anni, alla sostituzione del predatore selvatico puro con una
popolazione di meticci che tenderebbero sempre più ad evolversi verso una
forma canina con la conseguenza di ritrovarci un territorio popolato da un
buon numero di cani selvatici a tutti gli effetti, con conseguenze non facilmente
prevedibili. L'unico effetto sicuramente individuabile, infatti, sarebbe quello, già
accennato, della perdita di un patrimonio faunistico unico al mondo e di una
conseguente ulteriore squalificazione del comprensorio.
A questi problemi di tutela genetica si sovrappongono inoltre quelli di
conservazione delle popolazioni attualmente esistenti sul territorio.
La presenza del lupo ha infatti innescato una serie di reazioni da parte
degli operatori zootecnici, e non solo di questi, consistenti in definitiva in una
attività serrata di caccia al predatore, forse per un risveglio di ataviche paure o,
talvolta, di semplici bravate consistenti nel far vedere a qualche amico che si è
ancora capaci di uccidere lupi.
Si sono persi, in questo modo, da alcuni anni a questa parte, un buon
numero di esemplari, mettendo in serio pericolo la sopravvivenza della specie,
a livello immediato.
Il rinvenimento dei citati esemplari di lupo nel territorio pugliese, messo
a confronto con la mentalità corrente, ha posto quindi un primo immediato
problema pratico riguardante la loro effettiva tutela.
L'Amministrazione regionale infatti, finora non ha mai pagato i danni
attribuiti al lupo, verosimilmente per la mancanza di "dati certi" sulla sua
presenza sul territorio.
L'attribuzione dei danni ai cani vaganti ha quindi provocato una serie di
reazioni di autodifesa degli operatori zootecnici, reazioni generalmente
consistenti nel l'abbattimento, quando possibile, dei cani randagi, aiutati in ciò
da numerosi cacciatori che non fanno mistero del fatto di essere coinvolti in
questo genere di "bonifica".
Questo atteggiamento di autodifesa, virtualmente indotto
dall'atteggiamento di noncuranza dell'Amministrazione, mette quindi in serio
pericolo l'effettiva sopravvivenza del lupo in quanto ben poche persone, per
quanto esperte, e per quanto intenzionalmente vogliano impattare sul cane,
possono avere la sicurezza, soprattutto di notte, di riconoscere un cane dal
predatore selvatico.
D'altra parte, l'atteggiamento delle Amministrazioni sollecita il
363risveglio e la sopravvivenza ancora, in zona, dell'idea che le attività umane e la
conservazione del patrimonio naturale non possano assolutamente andare
d'accordo.
È necessario quindi un deciso e tempestivo intervento
dell'Amministrazione regionale a livello legislativo, con l'adozione di una
normativa che permetta il risarcimento dei danni da fauna protetta e nel
contempo preveda l'elaborazione urgente di un piano, basato su seri
presupposti scientifici ed affidato a personale competente, per il risanamento
del territorio dal randagismo canino, soprattutto tenendo ben presente che gli
interventi degli "accalappiacani" non possono essere assolutamente considerati
una soluzione al problema anche perché la loro azione si svolge
prevalentemente in ambiente urbano, trascurando quasi del tutto i nuclei di cani
che gravitano nelle campagne e nei boschi e che, come abbiamo visto,
costituiscono il grosso del fenomeno dei cani vaganti.
Esiste inoltre un ulteriore problema costituito dalla legislazione attuale
che impedisce l'eliminazione dei cani vaganti e obbliga le Amministrazioni al
loro mantenimento in strutture comprensoriali che rappresenterebbero, allorché
fossero realizzate, un impegno di spesa notevolissimo sia in strutture, sia in
persone (custodi, inservienti, veterinari) sia, da ultimo nello stretto
mantenimento delle popolazioni ospiti.
A dir la verità, comunque, negli ultimissimi anni, per merito di una azione
capillare svolta da più persone sensibili, si è notato un leggero cambiamento di
atteggiamento almeno da parte degli operatori agricoli e zootecnici più
illuminati che non parlano più del lupo come una calamità naturale ma, spesso,
ne accettano la presenza, aumentando si le precauzioni a protezione del
bestiame, ma non riuscendo a nascondere del tutto una punta di orgoglio per il
fatto che nel loro territorio esista ancora questo comunque leggendario
predatore.
Le ricerche di cui qui si accennano i primi risultati non devono e non
possono comunque essere considerate definitive. Sono necessari interventi di
finanziamento di ulteriori fasi da attuare quanto prima e tese ad accertare con
maggiore precisione le zone di presenza del lupo, eventuali ulteriori incrementi
dei tre piccoli nuclei e soprattutto la dinamica degli spostamenti dei branchi.
Occorre, inoltre, a questo punto, studiare le dinamiche delle popolazioni
oltre che un effettivo piano di salvaguardia della specie che,
364al di là di ogni interpretazione, rimane comunque un elemento estremamente
qualificante per il territorio.
Questo piano di conservazione, naturalmente non può passare attraverso
la sola tutela dell'animale con il divieto di uccisione, ma deve forzatamente
comprendere una ben più vasta gamma di interventi, con miglioramento della
situazione ambientale, controllo dell'azione dell'uomo sul territorio,
miglioramento delle presenze faunistiche con adeguati e studiati interventi di
ricostituzione delle eventuali prede del lupo, ecc.
Non è infatti possibile proteggere la singola entità, facendo astrazione dal
contesto che permette alla stessa entità di sopravvivere.
Così, alla luce delle ricerche sulle dinamiche di spostamento degli
esemplari, ad esempio, dovranno essere adottati particolari accorgimenti nella
effettuazione del periodico taglio degli alberi per la ceduazione, soprattutto
quando tale attività va ad impattare nelle zone ove si svolge l'attività riproduttiva
del predatore, magari tutelando quel sito e non permettendovi l'accesso
all'uomo.
Sono in effetti piccoli interventi concordabili con gli esperti del settore,
interventi che non costano assolutamente nulla e che, al contrario servono a
qualificare ancora di più il territorio.
Danni agli allevamenti
Come già accennato nel corso del lavoro, il fenomeno più vistoso della
situazione analizzata è costituito dai danni agli allevamenti. t lecito pensare, anzi,
che se non fossero state registrate predazioni a carico di animali domestici,
molto probabilmente il fenomeno “lupo” ed il problema "cane vagante"
sarebbero stati notati soltanto dagli specialisti del settore.
La situazione attuale è facilmente sintetizzabile: l'allevatore
sistematicamente perde alcuni capi di bestiame, si rivolge alle autorità senza
ottenere soddisfazione in quanto "ufficialmente" la presenza del lupo non è
accertata con sicurezza, ci sono in giro dei cani ed il danno potrebbe essere
imputato a loro.
Inoltre, i veterinari che vengono interpellati in caso di danno non
possono distinguere la causa della morte degli animali "in quanto non si è in
grado di distinguere se l'aggressore è stato il lupo od il cane" (entrambi
mordono nello stesso modo e per lo più la tecnica di caccia
365è la stessa). Risultato: l'allevatore rimane insoddisfatto e, una volta tornato a
casa, controlla la grana del piombo per vedere di farsi giustizia da solo.
Questo è, né più né meno, il quadro che è venuto fuori dai colloqui con
decine di allevatori che hanno subito danni al bestiame.
In una situazione del genere, l'allevatore vede solo un fatto: perde
animali, quindi soldi e nessuno risulta disposto a rimborsarlo della perdita.
Si imposta a questo punto una reazione, eticamente riprovevole, ma
comprensibile, visto e considerato che chi alleva animali non lo fa per sport ma
per guadagnare e nutrire la famiglia.
Una reazione che consiste nel difendere il proprio patrimonio
zootecnico con i mezzi a disposizione, siano essi fucili, bocconi avvelenati o
tagliole.
Il problema si complica in quanto, tutte le volte che viene denunciato un
danno, per l'Amministrazione pubblica la competenza a periziare il danno
stesso è del veterinario che, il più delle volte, non ha mai visto un lupo
nemmeno da lontano.
Onestamente, quindi, il professionista, per non sbagliare, o non emette
verdetto, oppure genericamente attribuisce il danno a canidi, comprendendo
quindi il lupo ed il cane.
D'altra parte, dall'esame del solo animale predato e delle tracce che
porta su di sé, non è assolutamente possibile distinguere se il predatore che lo
ha assalito sia lupo o cane, in quanto entrambi hanno le stesse modalità di
assalto, e, essenzialmente, entrambi hanno un apparato masticatorio uguale per
cui la traccia del morso è identica.
È evidente, quindi, come sia necessario conoscere la situazione faunistica
del territorio per poter definire, almeno come minima possibilità se, nel danno,
possa essere coinvolto il lupo.
Ragione vorrebbe che, coesistendo sia il predatore selvatico che i cani,
l'Amministrazione pagasse i danni sia dell'uno che dell'altro, come in effetti
fanno alcune Regioni italiane.
Ciò, almeno, in attesa di realizzare una bonifica del territorio dal
randagismo canino.
Che i danni al bestiame domestico, infatti, siano da imputare sia al lupo
che al cane è ormai cosa certa.
Sono stati documentati casi in cui gli stessi cani del pastore hanno assalito
di notte pecore del proprio gregge facendo vere e proprie stragi.
366Nell'area di Orsara di Puglia sono stati osservati cani da pastore fare
comunella con branchi di randagi che di giorno seguivano a distanza le greggi e
successivamente, di notte, si avvicinavano e con la complicità e l'aiuto dei cani
"da guardia" assalivano le pecore riuscendo a portar via alcuni esemplari.
Il fatto, a prima vista inspiegabile, può benissimo essere compreso se si
considera che in moltissimi casi i cani che vengono posti a guardia degli armenti
non sono assolutamente addestrati, sono di dubbia origine e quindi risultano
inadatti al compito che si vuole venga espletato.
Causa di tutto ciò un errato concetto di risparmio, visto che un cane
addestrato per la guida del gregge viene a costare considerevolmente.
Ciò spiega anche l'atteggiamento dei cani in occasione di assalti di lupi.
Più di un allevatore, la mattina dopo l'assalto, ha trovato i cani ancora impauriti
e nascosti nei posti più impensati. Cani la cui taglia superava abbondantemente
quella del lupo e che, a prima vista, avrebbero spaventato chiunque. La
mancanza di addestramento li portava a non reagire, ma anzi, a nascondersi al
sopraggiungere dei predatori.
Un dato di fatto ci conforta in queste affermazioni: i pochi pastori che
hanno cani di razza e convenientemente addestrati, non hanno subito
considerevoli danni e, comunque, hanno assistito a reazioni positive nei cani,
reazioni che hanno permesso l'intervento dell'uomo che ha potuto così
contribuire a mettere in fuga il predatore.
Un altro aspetto negativo della questione è nascosto dietro alla già più
volte citata mancanza di rimborso dei danni da lupo.
Il lupo è un animale protetto e definito "patrimonio indisponibile dello
Stato". La protezione di un carnivoro passa anche attraverso la possibilità che
questo abbia a disposizione prede con cui sostentarsi.
Scomparse quasi totalmente le prede tradizionali del lupo, questo si
rivolge anche al bestiame domestico.
Compito dello Stato, quindi, è quello di rimborsare i pastori del danno
subito.
In effetti, per l'allevatore, vendere la pecora al mercato o venderla allo
Stato è la stessa cosa.
L'essenziale è che possa ricavarne un utile.
Il risarcimento del danno, soprattutto in tempi brevi, porterebbe, come
prima conseguenza, alla sospensione delle ostilità da parte degli allevatori nei
confronti del lupo. Si imposterebbe quindi il primo passo per la sua effettiva
tutela.
367Una successiva bonifica del territorio dal randagismo porterebbe ad una
sicura diminuzione di rimborsi, con un notevole risparmio e con la sicurezza di
rimborsare solo danni effettivi da lupo. L'eliminazione del randagismo avrebbe
inoltre come conseguenza positiva l'eliminazione di competitori territoriali e
alimentari del lupo, ponendo quindi a sua disposizione ulteriori riserve trofiche
e allontanandolo ulteriormente dagli allevamenti.
Una prospettiva questa del risanamento dal randagismo da considerare a
medio-lungo termine, ma non come impossibile, insieme al risarcimento dei
danni, come unico rimedio ai danni stessi ed unica strada da percorrere per la
tutela del lupo.
Intervento sul randagismo canino
Intervenire su un grosso fenomeno di randagismo canino come quello
presente nel territorio in esame e soprattutto su un comprensorio così vasto
potrebbe sembrare un'impresa disperata, senza possibilità di riuscita.
Molto probabilmente così finirebbe per essere se l'operazione venisse
programmata e condotta con le tecniche attualmente operanti sul territorio:
accalappiacani e fucilate da parte di pastori e cacciatori.
Il cane, universalmente riconosciuto come animale dal comportamento
complesso e dai processi mentali piuttosto evoluti, apprende queste tecniche a
suo danno e ogni giorno diviene più difficile perseguirlo.
Come risultato si ottiene una popolazione di cani elusiva, “furba”,
difficile ad avvicinarsi: dal punto di vista umano, quindi, un completo
fallimento.
Si tratta, in effetti di evitare di cadere nell'assurdo di quel famoso
indovinello che dice: “se su un albero vi sono tre merli ed il cacciatore spara e
ne uccide uno, quanti ne rimangono?”
La risposta che viene spontanea, complice la matematica, è: “due”!.
La risposta vera, invece, è: "nessuno!", considerato che gli altri due
fuggono.
Lo stesso succede nei cani.
Metodi di cattura traumatici non possono fare altro che aumentare il
timore nei confronti dell'uomo e rendere l'animale più diffidente e quindi più
difficilmente avvicinabile.
368I sistemi di cattura dei vari esemplari di cani vaganti nel territorio,
appartengano essi alla categoria dei cani inselvatichiti o di quelli randagi o
comunque di quelli padronali senza temporaneo controllo, devono basarsi su
principi tali da non spaventare o comunque mettere in allarme gli altri esemplari
eventualmente presenti in zona.
Si tratta in definitiva di organizzare le catture, e non solo nei centri abitati,
in modo tale che la "trappola" diventi un punto di attrazione nel quale il cane
entri senza particolari timori e, una volta scattata, stimoli un comportamento
non solo rassicurante nei confronti della residua popolazione eventualmente
presente, ma ne stimoli la competizione per accedere alla trappola stessa.
Una attrazione basata principalmente su stimoli di tipo alimentare
consistenti in esche gradite al cane o, comunque a cui il cane sia abituato.
Ciò si ottiene mediante una struttura a gabbia sufficientemente grande
provvista di acqua e cibo, in modo che nell'animale catturato si inneschi un
comportamento aggressivo a difesa della "sua conquista", atteggiamento che,
una volta vuotata la gabbia, convinca gli altri cani ad entrarvi senza esitazione.
Sono stati da tempo effettuati studi sull'argomento con la creazione di
una struttura quale quella accennata, coperta da brevetto, che è stata adottata in
più parti con notevole successo.
È evidente che la buona riuscita delle operazioni dipende da una serie di
fattori per lo più derivanti dalla correttezza dell'applicazione delle varie
metodologie nelle molteplici fasi del processo.
La trappola, infatti, non deve divenire un elemento estraneo all'ambiente
e tale da suscitare sospetti, deve essere piazzata in opportuna posizione ed avere
un odore gradito all'olfatto del cane.
Attirato dall'odore e dall'esca, l'animale entra nella gabbia e, addentando
l'esca, fa scattare il congegno di chiusura. Una volta imprigionato, l'animale si
trova a proprio agio in relazione alla presenza di acqua e di cibo. In tale
situazione, l'avvicinarsi di un altro cane provoca una reazione di aggressività a
difesa del cibo, reazione che non fa che innescare una ulteriore reazione di
competizione per cui, la prima volta che il cane libero trova la gabbia vuota ne
prende possesso rimanendovi imprigionato.
A seconda della densità dei cani vaganti nel territorio, il controllo
periodico ed il periodico svuotamento delle gabbie da parte del personale
addetto dovrà avvenire una o due volte al giorno, considerando
369anche che quanto più la posizione della gabbia è protetta dalle intemperie, tanto
più il cane potrà sostarvi in attesa di essere prelevato.
In considerazione che le principali ore di attività dei randagi coincidono
con l'imbrunire e con le prime ore del mattino, lo svuotamento giornaliero
dovrà comunque essere attuato entro la mattinata, con un ulteriore controllo la
sera.
È evidente che anche il piazzamento delle trappole deve essere posto in
relazione con le zone di regolare frequentazione da parte dei cani (discariche,
punti di abbeverata, luoghi accertati di sosta, ecc.) e comunque in posizione tale
da non rendere arduo e difficoltoso il recupero delle gabbie piene.
Dall'operazione di "trappolaggio" dovrebbero essere invece escluse le
aree ove la presenza del lupo sia accertata come costante, o almeno, il controllo
delle trappole dovrebbe essere effettuato da personale in grado di riconoscere
il predatore che dovrà essere immediatamente liberato.
Ciò, in via prudenziale in quanto è stato accertato che il lupo raramente si
lascia convincere ad avvicinarsi ad una struttura estranea al suo ambiente ed alla
quale non si sia abituato.
Se quello del trappolaggio e della bonifica del territorio dal randagismo
è un intervento che cerca di mettere riparo ad una situazione già esistente, quindi
un intervento "repressivo", il problema vero da affrontare sta a monte del
fenomeno stesso ed è un problema di cultura e di civiltà da parte dell'uomo.
Il fenomeno dei cani vaganti nasce dal poco controllo che l'uomo
esercita sui propri animali, volontariamente o involontariamente, permettendo
loro di allontanarsi dall'abitazione, consentendo una riproduzione incontrollata
e, infine, rilasciando i cani in natura quando il loro possesso diventa scomodo o
ci si è stancati della loro presenza.
Il problema del rapporto uomo-cane, quindi, è alla base della piaga del
randagismo.
Impedire che l'uomo abbandoni al loro destino i propri cani, può
significare estinguere un fenomeno i cui risvolti negativi sono incalcolabili.
Impedire che l'uomo abbandoni il cane significa in primo luogo
esercitare un controllo, che attualmente esiste solo sulla carta, creando quella
struttura che da anni si auspica, ma che fino ad ora nessuno si è sentito di
proporre a livello politico: l'anagrafe canina obbligatoria per tutti i cani.
370Questa anagrafe permetterebbe di censire tutti i cani padronali del
territorio e di seguirne poi gli eventi (parti, decessi, cambiamento di
proprietario, ecc.).
Tutto ciò avverrebbe sia attraverso il censimento individuale dei cani, sia
attraverso il loro tatuaggio (realizzato all'interno della coscia, ad esempio) per
permetterne la precisa individuazione.
Trovare un cane vagante tatuato (e quando il tatuaggio è effettuato
all'interno della coscia risulta difficilmente asportabile) senza controllo per le
campagne od anche in città, porterebbe immediatamente all'individuazione del
proprietario attraverso la sigla tatuata, cosa che permetterebbe di porre lo
stesso padrone di fronte alle sue responsabilità e, magari, di fronte ad un
robusta contravvenzione.
Tutti i cani non tatuati, a questo punto, dovrebbero essere trattati alla
stregua di randagi o inselvatichiti e quindi prelevati dall'ambiente.
Le attività umane: la ceduazione
Nell'area interessata dalla presenza del lupo sono presenti numerosi
centri abitati e tutto il comprensorio è occupato da attività produttive a vario
livello, ma con una prevalenza netta di imprese agrosilvo-pastorali.
Alcuni aspetti più deteriori di tali attività potrebbero entrare in conflitto
con la presenza e la sopravvivenza del lupo nella zona.
Sono, in effetti, aspetti che possono tranquillamente essere abbandonati
o riconvertiti o, comunque, resi compatibili con le esigenza di tutela ambientale.
È bene, in questa sede, analizzare con un certo approfondimento alcuni
di questi aspetti evidenziando alcune possibili soluzioni.
La maggior parte dei boschi del comprensorio è governata a ceduo ed è
soggetta al cosiddetto uso civico.
In pratica, all'incirca ogni venti anni, particelle di bosco vengono messe a
disposizione per il taglio con destinazione del prodotto per uso domestico
(legna da ardere). Prevalentemente il taglio viene effettuato durante i periodi
tardo primaverile - estivo, con l'ingresso nel bosco di mezzi meccanici pesanti,
apertura di strade, presenza massiccia di uomini e mezzi, disturbo attraverso
l'uso delle motoseghe, ecc.
371Ciò avviene in concomitanza con il periodo più delicato del ciclo annuale
del lupo: la riproduzione.
Il susseguirsi dei turni di ceduazione porterà, ad un certo momento,
inesorabilmente, a interessare le aree ove sono situate le tane riproduttive, con la
distruzione delle stesse o, nella migliore delle ipotesi, con un disturbo tale da
obbligare le madri ad abbandonare i cuccioli appena nati, con le conseguenze
che si possono immaginare.
Né è da prevedere solo l'impatto negativo per l'anno della turnazione, in
quanto, per la manomissione dell'ambiente che ne risulta, l'area non sarà
utilizzabile più per numerosi anni, costringendo i predatori ad un rischioso
erratismo in cerca di nuovi luoghi idonei.
In una situazione ambientale diversa (grandi estensioni di boschi, scarsa
antropizzazione, abbondanza di prede, ecc.) una siffatta evenienza non sarebbe
poi così tragica, ma nel caso in questione, la limitatezza degli ambienti idonei
porterebbe i nostri animali a dover sconfinare in aree non adatte ove le
possibilità di sopravvivenza risulterebbero estremamente ridotte, in pratica solo
teoriche.
È evidente che le possibilità di compatibilizzazione dell'attività di
ceduazione con quella di tutela delle popolazioni di lupo sono numerose, ma la
soluzione del problema dovrebbe prima di tutto passare attraverso la presa di
coscienza delle Amministrazioni interessate dell'esistenza del lupo, con una
successiva accettazione di questo fatto e, in ultimo, con una serie di
provvedimenti volti a mantenere questa attività lontano dalle aree di
riproduzione del predatore.
È da tenere presente che, ai ricercatori che da anni si interessano al
problema, queste aree son note e che quindi non esisterebbero problemi nella
loro individuazione e successiva tutela.
D'altro canto, una riduzione della superficie boschiva da destinare all'uso
civico, riduzione peraltro irrisoria, sull'ordine di 5-6 ettari per ogni zona di
presenza del lupo (15-18 ettari per tutto il Subappennino), non comporterebbe
grossi sacrifici per le popolazioni residenti che di anno in anno, con il
progredire della metanizzazione e delle tecnologie di riscaldamento, dipendono
sempre di meno dalla legna per la climatizzazione invernale delle abitazioni.
La bruciatura delle stoppie
Tradizionalmente, nel comprensorio, e più in generale in tutta la
372Puoi anche leggere