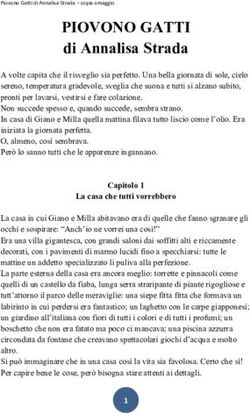Viaggio nella tradizione iconografica de I Promessi Sposi
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Viaggio nella tradizione iconografica de I Promessi Sposi
Selvaggia Cerquetti, Università di Bologna
Citation: Cerquetti, Selvaggia (2008), "Viaggio nella tradizione iconografica de I
Promessi Sposi", mediAzioni 5, http://mediazioni.sitlec.unibo.it, ISSN 1974-
4382.
I promessi sposi rappresenta, insieme alla Divina Commedia di Dante Alighieri,
uno dei capolavori e delle pietre miliari della letteratura italiana. Con
quest'opera, Alessandro Manzoni inaugura il genere del romanzo in Italia,
all'insegna dell'innovazione e parallelamente alla maturazione personale e
all'evoluzione del suo pensiero.
A sedici anni i suoi primi componimenti sono delle prove liriche, classico mezzo
attraverso il quale un adolescente cerca di esprimere se stesso. Poi, la voglia di
mostrare la realtà “oggettiva” lo porta alla predilezione del genere drammatico.
Il teatro rappresenta, per antonomasia, la mimesi della natura, la pura
riproduzione di ciò che è, il genere letterario più diretto in quanto non necessita
di un narratore o mediatore poiché il pubblico è chiamato direttamente in causa.
Ad un certo punto, però, anche il teatro rivela i suoi limiti: in una
rappresentazione teatrale non si può certo parlare di classi subalterne. La figura
del contadino a teatro è vista, infatti, come comica attraverso il recupero
dell'antica accezione della parola “villano”, mentre Manzoni vuole affrontare la
storia schierandosi dalla parte di quelli che ne sono sempre stati esclusi. Il
romanzo, allora, sotto questo punto di vista, gli lascia molta più libertà: può
eleggere a protagonista del racconto il popolo e, in questo passaggio, non è
vincolato dalla celebrità delle figure storiche più note. Di un nobile o di un
condottiero non si possono narrare altro che vicende vere perché la loro
biografia è già tutta documentata e conosciuta. Di un “filatore di seta”
qualunque, al contrario, si possono dire molte cose fantastiche, inventare molte
avventure. L'importante è che il risultato sia verosimile, in accordo con gli
avvenimenti della Grande Storia e, soprattutto, con gli usi, i costumi, le leggi, le
tradizioni, la mentalità, le problematiche del periodo nel quale il personaggio in
questione è inserito. Cosa che richiede un enorme lavoro di documentazione,
1proprio come quella compiuta da Manzoni che decide di ambientare il suo
romanzo nel '600.
L’autore finge di trovare un manoscritto dell'epoca per svincolarsi dalla
responsabilità di ciò che scrive e vi inserisce una forte critica alla società
contemporanea e, in particolar modo, all'occupazione austriaca attraverso la
narrazione indiretta dell'occupazione spagnola seicentesca o della calata dei
lanzichenecchi. Ma in questo distacco si può anche rintracciare l'influenza del
romanzo storico di Walter Scott. Con il successo di Ivanoe, infatti, inizia a
diffondersi la moda di collocare in epoche lontane le vicende dei romanzi e di
mescolare la fantasia ad un contesto storicamente ben preciso.
Manzoni vuole essere democratico fino alla fine e deve risolvere anche la
questione della lingua. In una Italia che si sta avvicinando all'unificazione, quale
idioma permetterebbe al romanzo di essere accessibile anche alle classi meno
istruite senza, allo stesso tempo, fargli perdere eleganza e stile? Da ciò nasce
l'ultima revisione de I promessi sposi. Il passaggio dal Fermo e Lucia a I
promessi sposi del 1927 serve per sistemare e rivedere l'impostazione e
l'economia di tutto il romanzo attraverso tagli e cambiamenti, di pari passo con
l'evoluzione della poetica manzoniana. Ma il passaggio tra l'edizione
ventisettana e la quarantana non subisce modifiche di tipo contenutistico, bensì
solo a livello linguistico. Da una forma ricca di latinismi, francesismi e residui del
dialetto milanese si passa alla stesura definitiva nell’idioma fiorentino,
precisamente quello parlato dai ceti colti.
Già dall’edizione del ’27 Manzoni pensa a I promessi sposi come ad un vero e
proprio libro illustrato. Se, però, la prima pubblicazione conteneva solo sei
immagini, è solo con quella definitiva che si raggiunge l’apice, sfoggiando la
bellezza di circa quattrocento disegni. Questo delicato compito è affidato
all’abilità grafica di Francesco Gonin che, sotto le direttive dello scrittore,
produce in maniera dettagliata e precisa i personaggi, i paesaggi, le vicende del
romanzo. A partire da queste illustrazioni, ho scelto di analizzare tutte le altre
rappresentazioni prodotte successivamente sulle vicende di Renzo, Lucia, Don
Rodrigo, l'Innominato, la monaca di Monza, e di vedere come i diversi artisti ne
abbiano differentemente interpretato le sorti.
21. Don Abbondio e i bravi
L’abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov’era giunto il curato, si
poteva distinguer dall’aspetto, non lasciavan dubbio riguardo alla loro
condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che
cadeva sull’omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale
usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in
punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol
corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un manico di
coltellaccio che spuntava fuori d’un taschino degli ampi e gonfi calzoni: uno
spadone con una gran guardia traforata a lamine d’ottone, congeniate come
in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui
della specie de’ bravi. (Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. I)
Ecco quali parole sceglie Manzoni per descrivere il modo in cui i bravi si
presentano a don Abbondio la mattina in cui lo minacciano e gli intimano di non
celebrare il matrimonio fra Renzo e Lucia. In questo passaggio la descrizione
fisica è molto importante perché è attraverso gli oggetti, i vestiti, i movimenti e le
parole dei personaggi che traspare la loro personalità. Manzoni, infatti, adotta la
tecnica, tipica del realismo di Flaubert e Balzac, di non elencare direttamente le
caratteristiche psicologiche dei suoi soggetti, ma di lasciarle indirettamente
intuire grazie ad una descrizione esteriore apparentemente oggettiva. È così
che dei bravi si sottolinea soprattutto l’abbigliamento e la presenza delle armi
ben in vista.
La rappresentazione dell’edizione del ’27 (Fig. 1) è molto semplice. Lasciando
incompiuto lo sfondo, i protagonisti sono messi di tre quarti, come se si
trattasse di un teatrino dove i protagonisti della scena si presentano al pubblico.
Evidenti e ben definiti i costumi. Anche la rappresentazione ufficiale di Gonin1
(Fig. 2) punta l’attenzione sugli stessi elementi. Come per qualsiasi altro
episodio del romanzo, Gonin fotografa le parole di Manzoni: il panorama, la
piccola edicola, don Abbondio che cammina, i bravi ai due lati del sentiero, uno
in piedi appoggiato al parapetto, l’altro seduto con una gamba cavalcioni. Tutto
è chiaro e preciso, dettagliato e lineare come lo stile delle corrispettive frasi nel
primo capitolo.
Per quanto riguarda le rappresentazioni degli artisti che, successivamente, si
sono cimentati nell’illustrazione dei passaggi più significativi de I promessi
1
Francesco Gonin nacque a Torino nel 1808 e morì a Giaveno nel 1889. Fu un pittore ed
illustratore specializzato in ritratti di genere storico ed in illustrazioni per opere letterarie.
Numerosi suoi ritratti, quadri storici e affreschi si trovano presso le varie dimore dei Savoia e in
qualche chiesa di Torino. [http://it.wikipedia.org/wiki/Gonin]
3sposi, non si può negare che il confronto con Gonin sia arduo. Questo è dovuto
sostanzialmente al fatto che la tradizione iconografica manzoniana non è
vastissima e la maggior parte dei pittori che hanno scelto di realizzare delle
illustrazioni nuove sulle disavventure di Renzo e Lucia sono contemporanei o
quasi a Manzoni. Molti di loro, come è comprensibile, non hanno avuto il
coraggio di allontanarsi dalle direttive dell’autore o dall’immagine comune che si
era ormai creata nella mente dei lettori e, perciò, hanno prodotto solo delle
piccole variazioni sul tema, cambiando per lo più la composizione dell’opera,
ossia la disposizione degli elementi all’interno della cornice, senza apportare
modifiche significative. Mi riferisco, nello specifico, ai disegni di Gallo Gallina2
(Fig. 3), Bartolomeo Pinelli3 (Fig. 4) e Roberto Focosi4 (Fig. 6).
2
Gallo Gallina nacque in uno dei quartieri più popolari di Cremona nel 1796. Non ebbe un
biografo personale e, anche negli anni di grande popolarità, le notizie che si posseggono sulla
sua vita si rintracciano in articoli di giornale o in alcune rievocazioni che conservano il sapore
romantico e agiografico delle “Gazzette” di Cremona e Milano. Sul rame incise numerose opere
e in litografia le ben note 12 stampe create dalla sua fantasia e ispirate a I promessi sposi del
Manzoni. Il suo panorama artistico è veramente ampio: parecchie opere si trovano al Museo
civico di Cremona, ma molte altre opere sono andate ad abbellire le collezioni private e le
pinacoteche pubbliche. La sua partecipazione grafica e pittorica è presente anche alla Scala di
Milano dove lavorò come bozzettista scenografico, costumista e scenarista per balletti. La
collezione di disegni, stampe, litografie, acquerelli, ancora conservati presso la biblioteca del
“Museo alla Scala”, dimostrano la partecipazione competente di Gallina al mondo dello
spettacolo. Morì a Milano nel 1874. [Laura Ferrazzi, La pittura neoclassica di Gallo Gallina,
artista cremonese del XIX secolo, Cremona, Banca Popolare di Cremona, 1997]
3
Figlio di un modellatore di statue devozionali, Bartolomeo Pinelli si formò prima a Bologna poi
all’Accademia di San Luca a Roma. Fu un artista estremamente prolifico, illustratore di grandi
poemi epici e altri numerosi soggetti. Il tema in generale più ricorrente è Roma, i suoi abitanti, i
suoi monumenti, la città antica e quella a lui contemporanea. Morì nel 1835.
[http://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Pinelli]
4
Roberto Focosi, pittore tardo-romantico, nacque nel 1806 e morì nel 1862. Fu allievo di
Francesco Hayez e ritrattista filo-risorgimentale, illustratore di Manzoni e litografo.
[http://www.iulm.it/document_loader.aspx?idDocument=9210]
4Le soluzioni iconografiche di Aligi Sassu5 (Fig. 5) e di Giorgio de Chirico6 (Fig.
7), invece, azzardano di più (non a caso risalgono già alla prima metà del
novecento). Sassu abbandona completamente la dimensione spaziale
dell’incontro e punta il suo obiettivo solo sulle figure dei tre uomini. La
precisione descrittiva dell’abbigliamento dei bravi viene meno a causa di un
tratteggio a matita molto lungo, ma il senso di minaccia rimane attraverso la
postura altera e spavalda dei due e quella goffa e insicura del curato. Inoltre, le
gambe del bravo in primo piano ricordano le zampe di un animale, mentre il
mantello arrotolato intorno al busto e il gomito appoggiato sul fianco
assomigliano al muso di un predatore, che rimanda alla metafora di don
Abbondio agnello, vittima e codardo tremante nelle mani dei potenti, dei leoni
come don Rodrigo che i due delinquenti rappresentano. Giorgio de Chirico, al
contrario, recupera lo sfondo, il paesaggio di contorno alla scena e i dettagli dei
vestiti e delle armi. Anche lui, però, preferisce puntare l’attenzione
sull’atteggiamento servile di don Abbondio, che con la mano destra sul cuore
accenna un inchino, e su quella minacciosa e prepotente dei bravi, in
particolare su quello che con l’indice imita la forma di una pistola.
Le rappresentazioni più moderne risalgono agli anni 2000, eppure sono molto
diverse fra loro. Una è di Giovanni Schiaroli7 (Fig. 8), e le altre di Federico
5
Aligi Sassu nacque a Milano nel 1912. A sedici anni presentò le prime opere alla Biennale di
Venezia ispirandosi al Futurismo di Boccioni, Previati, Carrà e osservando anche Cezanne e
Picasso. Nel 1928 fondò, insieme a Bruno Munari, il Manifesto della Pittura. Nel 1937 per via di
un manifesto che celebrava la vittoria in Spagna delle Brigate Internazionali contro l’esercito
franchista venne arrestato per due anni. Nel dopoguerra visse un’esistenza sociale e artistica
appartata poiché lontano dal cubismo di Braque e Picasso. Studiò invece Van Gogh. Morì
all’età di ottantotto anni nel 2000.
[http://www.italica.rai.it/index.php?categoria=biografie&scheda=sassu]
6
Data la fama di Giorgio De Chirico, mi limiterò solo a ricordare che nacque nel 1888 nella
Tessaglia in Grecia. Si trasferì nel 1912 a Parigi dove passò anni di attività molto intensa. Nel
1916 fondò insieme a suo fratello la “scuola metafisica” e nel 1917 entrò in contatto con Tristan
Tzara e col movimento Dada. Negli anni successivi scrisse importanti testi teorici e fu in
contatto con André Breton, con il gruppo del Neoplasticismo olandese, con Paul Elouard e con
Max Ernst. Espose a Milano, Parigi, Torino, Firenze e Roma. Illustrò i calligrammi di Apollinaire.
Nel decennio precedente la seconda guerra mondiale la sua produzione artistica fu molto
feconda, mentre il secondo dopoguerra fu periodo di polemiche e riconoscimenti ufficiali. Il suo
novantesimo compleanno fu festeggiato in Campidoglio a Roma dove morì nel 1978.
[http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico]
7
Giovanni Schiaroli nacque nel 1949 a Filetto, frazione di Senigallia in provincia di Ancona.
Ancora vive e lavora nello stesso posto, un angolo appartato fra un saliscendi di colline verdi,
alberate e cespugliose e questo paesaggio è il suo tema principale, il suo filone centrale, la sua
costante ispirazione. Molto bravo nell’uso del colore, delle sfumature e delle tonalità, non ha
frequentato scuole d’arte o accademie, ma è autodidatta. Nonostante le mostre a Buenos Aires
5Maggioni8 (Fig. 9a e 9b). Schiaroli ricorda lo stile di de Chirico, mantenendo il
paesaggio e enfatizzando l’indice del bravo contro le mani giunte e volutamente
impotenti del curato. Maggioni, invece, è quello che, non solo in questa
occasione, ma in tutti i suoi disegni, si allontana di più dall’iconografia classica,
inaugurata da Gonin, e si lascia andare ad interpretazioni che, a prima vista,
possono sconvolgere il lettore per la novità e la diversità dallo standard, ma che
poi si rivelano quelle più interessanti. Con i loro colori forti e brillanti, le immagini
sono state considerate infantili, tanto da essere state inserite in una edizione
ridotta de I promessi sposi per ragazzi delle scuole medie, ma a mio avviso
sono proprio quelle meno adatte a dei bambini. Sono le immagini più
angoscianti e che meglio rappresentano il male e la corruzione della nostra
società, di poco differente da quella rappresentata da Manzoni nel romanzo.
Don Abbondio è sempre disegnato di nero, anche in volto, ed il breviario è
tenuto molto distante dal corpo, quasi a sottolineare come la sua non sia stata
affatto una scelta di fede. Don Abbondio non si fa prete per amore del
prossimo, per devozione o per carità, ma decide di entrare nell’ordine
sacerdotale perché ha paura e sente la necessità di essere protetto da
qualcuno, qualcuno di potente e soprattutto di “fisico”, il che significa che questo
qualcuno non potrà mai essere Dio. La sua è una esistenza dedita all’utile
personale ed è proprio questo che lo contrappone all’altra figura ecclesiastica
del romanzo, fra Cristoforo. Fra Cristoforo è il contrario assoluto di don
Abbondio in quanto abbraccia il sacerdozio per cercare di espiare il peccato di
aver ucciso un uomo, comprendendo il valore cristiano del sacrificio e
prodigandosi per i più bisognosi. Vive nell’etica del prossimo e percepisce il
vero senso della giustizia, mentre don Abbondio vive nell’etica dell’egoismo,
della paura, della percezione realistica del mondo. Don Abbondio non è stupido,
come gran parte della critica ama giudicarlo. Don Abbondio è pronto a capire il
verso delle cose e a schierarsi dalla parte che gli fa più comodo senza muovere
e a Roma, rimane sempre molto legato alle campagne marchigiane.
[http://www.schiaroli.it/biografia.html]
8
Nato a Campo Ossuccio, in provincia di Como, vive e lavora a Milano. Otre che illustratore,
Maggioni è grafico di successo e ha lavorato anche nel settore dei fumetti. È stato responsabile
artistico del Corriere dei Piccoli, del Corriere dei Ragazzi e della storica edizione italiana di Pilot.
In qualità di consulente artistico ha collaborato con numerose case editrici, fra cui Bompiani,
Ipsoa, Il sole 24 Ore Libri, Mondadori Ragazzi. I suoi disegni sono apparsi sulle principali riviste
italiane e sul Corriere della Sera. Ha progettato e illustrato libri e copertine per le maggiori case
editrici italiane e per l’editore Corraini ha illustrato con Alberto Rebori un’inconsueta edizione di
Cuore di Edmondo De Amicis. Ha vinto molti premi internazionali tra cui: nel 1986 il premio
Andersen-Baia delle favole per l’illustrazione; nel 1991 il trofeo Palma d’Argento al Salone
Internazionale dell’Umorismo di Bordighera; nel 1993 il Premio Plaque BIB alla Biennale
d’Illustrazione di Bratislava; nel 1995 il Dattero d’Argento al Salone Internazionale
dell’Umorismo. [http://www.zam.it/home.php?id_autore=975]
6un dito per combattere l’orgoglio e le prepotenze di quelli come don Rodrigo il
quale, per un puro capriccio di sesso, è pronto a impedire il matrimonio dei due
giovani protagonisti. Il curato, potenzialmente, potrebbe evitare questa
ingiustizia, ma di fronte alla minaccia dei bravi preferisce perorare, per
l’ennesima volta, la causa dei potenti. A questo proposito, nei disegni di
Maggioni, è ricorrente un elemento molto significativo, un uccello nero, un corvo
dalla testa rosso sangue e dal becco appuntito, esplicito riferimento al raven di
Poe (Fig. 9c). Questo uccello è il simbolo della corruzione, della paura,
dell’odio, del peccato, dell’imbroglio, della prepotenza, dell’egoismo, della
lussuria, della legge asservita al potere, della violenza e ricorre in tutti i momenti
in cui questi mali prevalgono sui personaggi. Vola alto sui bravi e segue don
Abbondio fino a casa, quando racconta l’accaduto a Perpetua (Fig. 10).
Edizione del 1827 (Fig. 1) Francesco Gonin (Fig. 2)
Gallo Gallina (Fig. 3) Bartolomeo Pinelli (Fig. 4)
7Aligi Sassu (Fig. 5) Roberto Focosi (Fig. 6)
Giorgio de Chirico (Fig. 7)
Giovanni Schiaroli (Fig. 8)
Federico Maggioni (Fig. 9a) Federico Maggioni (Fig. 9b)
8Federico Maggioni (Fig. 9c) Federico Maggioni (Fig. 10)
2. La monaca di Monza
Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni, faceva a prima vista
un’impressione di bellezza, ma di una bellezza sbattuta, sfiorita, direi quasi,
scomposta. Un velo nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa,
cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso; sotto il velo, una
bianchissima benda di lino cingeva, fino al mezzo, una fronte di diversa, ma
non d’inferiore bianchezza; un’altra benda a pieghe circondava il viso, e
terminava sotto il mento in un soggolo, che si stendeva alquanto sul petto,
a coprire lo scollo d’un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso,
come per una contrazione dolorosa; e allora due sopraccigli neri si
ravvicinavano, con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch’essi, si
fissavano talora in viso alle persone, con un’investigazione superba; talora
si chinavano in fretta, come per cercare un nascondiglio; in certi momenti,
un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto,
corrispondenza, pietà; […] Le gote pallidissime scendevano con un
contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta
estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d’un roseo sbiadito,
pure, spiccavano in quel pallore: i loro moti erano, come quelli degli occhi,
subitanei, vivi, pieni d’espressione e di mistero. La grandezza ben formata
della persona scompariva in un certo abbandono nel portamento, o
compariva sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute
per una donna, non che per una monaca. Nel vestire stesso c’era qua e là
qualcosa di studiato o di negletto, che annunziava una monaca singolare:
la vita era attillata con una certa cura secolaresca, e dalla benda usciva sur
una tempia una ciocchettina di neri capelli; cosa che dimostrava o
dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre
corti, da quando erano stati tagliati, nella cerimonia solenne del vestimento.
(Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. IX)
9Queste sono le parole usate per descrivere come si presenta al lettore la
monaca di Monza, uno dei personaggi più interessanti e amati del romanzo.
Siamo in uno dei momenti clou della storia, in uno dei punti “cerniera”, cioè
quando, dopo la separazione da Renzo, Lucia e la madre vengono
accompagnate dal padre guardiano presso il monastero di Monza, affinché
possano chiedere aiuto e restare lì nascoste.
La monaca viene introdotta nella narrazione in due modi: indirettamente,
attraverso il punto di vista degli altri personaggi, e direttamente attraverso il
ritratto del narratore sopra riportato, fisico e psicologico allo stesso tempo.
Gonin (Fig. 11) ritrae il momento in cui Lucia viene direttamente interpellata e,
riconfermando le parole della madre, commuove la suora che decide di
ospitarla. In questa inquadratura la monaca è in penombra e l’attenzione viene
puntata soprattutto sul gesto imbarazzato della protagonista che sta parlando
del suo innamorato, sulla reticenza del padre guardiano e sulla vergogna di
Agnese nell’essere stata da poco ripresa per aver parlato al posto della figlia.
Significativa la grata, descritta come singolare, a suggerimento della
“singolarità” della monaca.
In un altro disegno (Fig. 12), poi, Gonin riproduce il ritratto della sventurata,
dando vita alle parole manzoniane e rispettandone tutte le antitesi e le
particolarità. La descrizione, e quindi l’illustrazione di conseguenza, si gioca
tutta sulle contrapposizioni: in primo luogo, a livello cromatico attraverso
l’opposizione bianco-nero, quasi come un’antica fotografia della quale vengono
sottolineati alcuni particolari rivelatori come il saio attillato o il ciuffo di capelli
che sfugge al velo; in secondo luogo, a livello motorio attraverso l’opposizione
immobilità-movimento, rivelata dalla postura eretta e fissa della donna, con una
mano appoggiata alla grata, e dalla fronte spesso raggrinzita, dai sopraccigli
che si avvicinano rapidamente o ancora dalle mosse repentine, irregolari e
risolute. Si tratta di tutti elementi che rimandano al disordine interiore, al
tormento della donna, senza però rivelarne direttamente nulla. È un linguaggio
che allude a qualcosa di più profondo e che cerca di celare l’evidente contrasto
tra l’essere e l’apparire della monaca, tra ciò che è veramente e ciò che
sembra, tra verità e inganno.
Come sempre, le rappresentazioni di Roberto Focosi (Fig. 13) e di Gallo Gallina
(Fig. 14) non si discostano affatto dall’originale di Gonin e l’unico elemento che
entrambi osano aggiungere è quello della dimensione spaziale. Allargano il
campo visivo e immaginano il mobilio del parlatorio nel quale la scena ha luogo,
10ma per quello che concerne le quattro figure protagoniste, l’approccio della
rappresentazione resta immutato.
Giorgio de Chirico osa di più (Fig. 15). Preferisce ignorare il momento del
dialogo con le donne a favore di un “a solo” della monaca, completamente
abbigliata di nero, di spalle, immersa nell’austerità delle colonne e degli archi a
sesto acuto della navata. Anche qui il contrasto chiaro-scuro è forte,
sottolineato in particolar modo dai fasci di luce che si riflettono a terra e dalle
ombre slanciate degli elementi architettonici. Questa rappresentazione, a mio
avviso, è molto più significativa delle altre perché riesce meglio a trasmettere il
senso di solitudine e di impotenza, oltre che di sofferenza, di una Gertrude
schiacciata da forze incontrollabili.
Giovanni Schiaroli (Fig. 16) si rifà al ritratto di Gonin, ma la sua illustrazione è
molto meno precisa. Il contrasto bianco-nero è meno potente, data anche
l’importante presenza del rosso sullo sfondo e sulle labbra della donna, come di
un rossetto. Riesce, però, a trasmettere l’idea di una donna vissuta che
dimostra più della sua età e che è ancora insofferente per qualcosa che la
tormenta. I colori caldi che decorano lo sfondo, non a caso, ricordano l’amore,
la passione, ma anche il sangue e la sofferenza. D’ora in poi è evidente la forte
evoluzione dai disegni originali alle illustrazioni più moderne. Se Gonin non
doveva far altro che trasportare le parole in tracce di matita, senza aggiungere
o sottrarre dettagli alla narrazione e senza svelare informazioni non presenti nel
testo, qui ci troviamo di fronte a delle riproduzioni che tengono clamorosamente
conto di tutto quello che si è scoperto sulla storia della monaca di Monza. È
palese che viene presa in considerazione tutta quella parte che ne I promessi
sposi viene omessa e che rappresenta, invece, un romanzo nel romanzo nel
Fermo e Lucia.
Ciò è ancora più lampante se esaminiamo l’elaborato di Federico Maggioni (Fig.
17). La monaca è deforme, con un viso orrendo che ricorda un po’ L’urlo di
Munch, di un bianco sporco, come la sua anima. Il velo, che dovrebbe
anch’esso essere di un puro bianco, è grigio e nasconde la parte sottostante del
vestito, completamente macchiata di sangue, sulla quale pende un crocifisso,
sporco anch’esso. Lo sfondo non potrebbe essere altro che rosso e irregolare.
Riflettendo su questa composizione non si può non dedurre che Maggioni abbia
letto il Fermo e Lucia, o che, per lo meno, ne conosca il contenuto. È chiaro che
con tutte quelle macchie sul vestito stia facendo riferimento non solo ai capricci
della monaca e alle punizioni inflitte ingiustamente alle novizie per sfogo, ma
anche a tutti gli omicidi legati alla scandalosa relazione con Egidio.
11Manzoni taglia la parte più crudele e meno morale della vicenda e preferisce
farci immedesimare nella situazione della disgraziata attraverso il flashback
della sua infanzia e adolescenza:
La nostra infelice era ancor nascosta nel ventre della madre, che la sua
condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da
decidersi se sarebbe un monaco o una monaca; decisione per la quale
faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne
alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse
immediatamente l’idea del chiostro, e che fosse stato portato da una santa
d’alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi
balocchi che le si diedero in mano; poi santini che rappresentavano
monache; e que’ regali eran sempre accompagnati con gran
raccomandazioni di tenerli ben di conto, come cosa preziosa, e con
quell’interrogare affermativo: “bello eh?”. (cap. IX)
E Gallo Gallina non fa altro che rappresentare questi momenti (Fig. 18 e Fig.
19) facendo apparire tutto il più lineare possibile. Il principe padre ha violentato
psicologicamente i figli cadetti fin dalla nascita, affinché prendessero i voti e
l’eredità potesse considerarsi salva nelle mani del solo primogenito.
Anche qui Federico Maggioni va oltre (Fig. 20) e non si limita a riprodurre ciò
che viene narrato oggettivamente, ma interviene trasformando il padre in una
figura diabolica. Il colore dominante, non a caso, è il rosso, e la bambolina
vestita da suora è veramente ambigua in quanto può rappresentare sia il
giocattolo di Gertrude che la bambina stessa. Qui, l’anima malvagia del padre è
evidente e senza allusioni. È un padre che prima di tutto è uomo e principe, il
cui interesse più grande è preservare il patrimonio e, a questo scopo, non ha
scrupoli e arriva a rovinare la vita di Gertrude in modo subdolo e imperdonabile.
Capisce e conosce la mentalità di una bambina, circuendola e forzandola verso
scelte che le sono imposte senza che lei riesca a rendersene conto e a
prendere il controllo della situazione. Da piccola la incanta con giocattoli a tema
e con l’aspettativa di una vita da principessa come badessa nel convento. Poi,
quando torna a casa determinata a vivere la vita come tutte le altre ragazze
della sua età, la isola e costringe chiunque, anche la servitù, ad ignorarla e ad
aumentare la sua inadeguatezza e fragilità. Sventata la tresca con il paggio,
tutto è finalizzato a far crescere in lei il senso di colpa per un fallo che non ha
commesso e per far aumentare il rimpianto di aver lasciato un ambiente dove
veniva rispettata e amata da tutti. Perciò viene indotta a ad ammettere di
preferire il convento, anche se tutto ciò rappresenta soltanto la conseguenza di
uno sfogo e della necessità di sentirsi amata e considerata. Il padre, cosciente
di questa fase, la riempie di attenzioni e di premure per evitare che riaffiorino in
12lei i suoi veri sentimenti e la intrappola con lo sguardo quando, ritornando a
Monza, la giovane chiede alle suore di entrare nel convento. La corruzione
arriva anche alle monache e all’ispettore delle novizie che, interiormente,
intuiscono la natura delle scelte della ragazza, ma preferiscono fingere di
credervi piuttosto che aiutare Gertrude ad essere felice.
Di tutta la frustrazione della vita monacale, ne I promessi sposi Manzoni narra
brevemente solo qualche episodio e della storia con Egidio si limita a dire:
Quel lato del monastero era contiguo ad una casa abitata da un giovine,
scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro sgherri,
e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi
della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio,
senza parlar del casato. Costui, da una finestrina che dominava un
cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o
girandolar lì, per ozio, allettato anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà
dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. E la sventurata rispose.
(cap. X)
Potendo rifarsi solo a queste poche righe, Gonin non ci fornisce alcuna
rappresentazione relativa all’incontro o alla storia d’amore, ma alcuni illustratori
successivi sì.
Giorgio de Chirico (Fig. 21) inquadra bene il momento dell’ incontro fra i due e
sottolinea la devozione della monaca a Egidio, ponendo lui in alto e lei in basso
con le mani giunte, come nell’atto di pregare e con l’atteggiamento di una
devota. Solo che in questo caso si tratta di una devota al sesso e non a Dio.
La suora possiede questa carnalità insita nelle sue fibre e, in un contesto del
genere, non può far altro che sfogarsi attraverso la colorazione delle labbra, la
cura dei capelli o il saio particolarmente attillato. È chiaro che la presenza e
l’iniziativa di Egidio scatenano in lei la voglia di liberarsi dalla vita che non ha
mai desiderato e di abbandonarsi alla pienezza della sua voglia di amare un
uomo. D’altra parte Egidio è veramente malvagio. Perverso e riprovevole,
ricorda vagamente la figura del principe padre, in quanto capisce la debolezza
della monaca e la sfrutta a proprio vantaggio, sottomettendola, ricattandola e
schiavizzandola, nella consapevolezza che ormai lei non può più fare a meno di
lui e dei loro incontri. È probabile che questi caratteri così crudeli siano ispirati
ai personaggi di Sade, dal momento che Manzoni vive a Parigi proprio quando
le opere del letterato, rinchiuso in manicomio, iniziano ad entrare in
circolazione.
13Federico Maggioni (Fig. 22) preferisce riportare solo il luogo che fa da sfondo
alle vicende dei due amanti e il colore dominante è il nero, simbolo di malvagità
e corruzione. Gli unici punti di riferimento sono le due frecce che specificano la
natura delle due costruzioni. In generale tutto è cupo, triste e tetro. Anche qui è
evidente come i riferimenti vadano oltre le parole del testo e richiamino tutto
quello che non è sopravvissuto nella stesura finale del romanzo, processo
evidentissimo anche in un altro passaggio della storia. Infatti, là dove Manzoni
dice solo:
Per qualche tempo, non parve che nessuna pensasse più in là; […] la
conversa, buttò là una parola, che lei sapeva qualche cosa, e che, a tempo
e luogo, avrebbe parlato. Da quel momento in poi, la signora non ebbe più
pace. Non passò però molto tempo, che la conversa fu aspettata in vano,
una mattina, a’ suoi ufizi consueti. […] Forse se ne sarebbe potuto saper di
più, se, in vece di cercar lontano, si fosse scavato vicino. (cap. X)
Gonin rappresenta Gertrude, visibilmente preoccupata, parlare con un’altra
suora (Fig. 23). In fin dei conti, la verità viene solo accennata e la fantasia del
lettore è libera di immaginare che cosa possa essere successo.
Maggioni, al contrario, non lascia immaginare nulla (Fig. 24): sfondo bianco,
disegno nero e tratti lunghi e violenti, un sole nero all’orizzonte, un albero dai
rami affilatissimi come urlassero verso il cielo, un teschio enorme che ricorda il
volto della bambola con la quale giocava Gertrude da piccola e che il
padre/diavolo tiene in mano nella Fig. 19. Ma è ovvio e comprensibile che,
all’epoca, Manzoni non potesse permettere di mantenere nel suo romanzo degli
episodi e dei particolari così violenti. Tutte le modifiche che applica a questa
vicenda, a quella dell’Innominato e a quella della morte di don Rodrigo sono
finalizzate alla trasmissione di un messaggio etico che deve formare la
coscienza di una Italia in via di unificazione. Non sarebbe credibile che, dopo
tutto quello che ha passato, al termine della sua vita, la monaca si converta e
decida di murarsi viva, come sarebbe altrettanto ridicola la conversione
dell’Innominato se non venissero censurate le malefatte del conte del Sagrato,
così come sarebbe inammissibile il perdono di Renzo di fronte all’ennesimo
torto di don Rodrigo prima di morire di peste. Il messaggio, oltre che facilmente
fraintendibile, non riuscirebbe a trasmettere il valore del perdono, dell’umiltà,
della fede e della Provvidenza che, invece, muovono tutta la morale del libro e
che, quindi, hanno senso solo se gli episodi sono immersi dalla vaghezza.
È così che, al termine del libro, ha senso la conversione e il cambio di rotta di
Gertrude:
14Seppe dalla vedova che la sciagurata, caduta in sospetto d’atrocissimi fatti,
era stata, per ordine del cardinale, trasportata in un monastero di Milano;
che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s’era ravveduta, s’era accusata; e
che la sua vita attuale era supplizio volontario tale, che nessuno, a meno di
non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare uno più severo. (cap. XXXVII)
Gonin (Fig. 25) la ritrae come una vera monaca che prega, prostrata, in
ginocchio, di fronte al crocifisso, con l’aria di chi finalmente ha trovato la pace
che tanto le mancava prima.
Alberto Sughi9 (Fig. 26) la vede rinchiusa nel suo martirio volontario, con una
mano sul cuore e un raggio di sole (o di speranza) che la raggiunge da una
fessura, all’altezza del volto.
Federico Maggioni (Fig. 27), cinico come in qualsiasi altro suo disegno, scende
a mio avviso nel macabro e pone la sciagurata lunga, avvolta di nero, con una
mano chiusa a mo’ di artiglio e l’altra protesa verso l’alto. È un po’ come se
fosse in un sarcofago e dalla sua bocca sputa liquido nero, mentre dal
crocifisso escono fiotti di sangue, come fuoco. L’interpretazione che voglio dare
è che le emissioni rappresentano la purificazione della donna attraverso l’auto-
supplizio. Il rosso potrebbe essere legato ai delitti e alla lussuria, il nero alla
malvagità e alla sofferenze causate dalla donna.
9
Alberto Sughi è nato a Cesena nel 1928. Pittore autodidatta, grazie a varie esperienze
formative, scelse con decisione la strada del realismo, nell’ambito del dibattito fra astratti e
figurativi dell’immediato dopoguerra. I dipinti di Sughi rifuggono tuttavia ogni tentazione sociale;
mettono piuttosto in scena momenti di vita quotidiana senza eroi. La ricerca di Alberto Sughi
procede, in modo quasi costante, per cicli tematici, che hanno il sapore della sequenza
cinematografica. Sughi ha partecipato a tutte le più importanti rassegne d’arte contemporanea,
dalla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia alla Quadriennale di Roma, sino alle numerose
mostre che hanno proposto all’estero le vicende dell’arte italiana dagli Anni Settanta ad oggi.
Nel 1994, ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ente Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma.
Nello stesso anno ha partecipato alla mostra “Il ritratto interiore”, al Museo Archeologico
Regionale di Aosta e ha, inoltre, ricevuto il prestigioso premio De Sica, destinato a personalità
di rilievo nel campo delle arti, della cultura e delle scienze, direttamente dall’allora Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
[http://biografie.leonardo.it/biografia.htm?BioID=1235&biografia=Alberto+Sughi e
http://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Sughi]
15Francesco Gonin (Fig. 12)
Francesco Gonin (Fig. 11)
Roberto Focosi (Fig. 13)
Gallo Gallina (Fig. 14) Giorgio de Chirico (Fig. 15)
16Giovanni Schiaroli (Fig. 16) Federico Maggioni (Fig. 17)
Gallo Gallina (Fig. 18) Gallo Gallina (Fig. 19)
Federico Maggioni (Fig. 20)
17Giorgio de Chirico (Fig. 21) Federico Maggioni (Fig. 22)
Francesco Gonin (Fig. 23) Federico Maggioni (Fig. 24)
Francesco Gonin (Fig. 25) Alberto Sughi (Fig. 26)
18Federico Maggioni (Fig. 27)
3. Il rapimento di Lucia
Lucia, entrandovi, e vedendola affatto solitaria, sentì crescere la paura, e
allungava il passo; ma poco dopo si rincorò alquanto, nel vedere una
carrozza da viaggio ferma, e accanto a quella, davanti allo sportello aperto,
due viaggiatori che guardavano in qua e in là, come incerti della strada.
Andando avanti, sentì uno di que’ due, che diceva: “ecco una buona
giovine che c’insegnerà la strada”. Infatti, quando fu arrivata alla carrozza,
quel medesimo, con un fare più gentile che non fosse l’aspetto, si voltò, e
disse: ”quella giovine, ci sapreste insegnar la strada di Monza?”.
"Andando di lì, vanno a rovescio,” rispondeva la poverina: “Monza è di
qua…” e si voltava, per accennar col dito; quando l’altro compagno (era il
Nibbio), afferrandola d’improvviso per la vita, l’alzò da terra. Lucia girò la
testa indietro atterrita, e cacciò un urlo; il malandrino la mise per forza nella
carrozza: uno che stava a sedere davanti, la prese e la cacciò, per quanto
lei si divincolasse e stridesse, a sedere dirimpetto a sé: un altro,
mettendole un fazzoletto alla bocca, le chiuse il grido in gola. Intanto il
Nibbio entrò presto anche lui nella carrozza: lo sportello si chiuse, e la
carrozza partì di carriera. L’altro […] era costui uno sgherro di Egidio.
(Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XX)
Anche in questo caso le immagini di Gonin (Fig. 28), Gallina (Fig. 29) e Focosi
(Fig. 30) sono pressoché identiche. La carrozza, il Nibbio che la tiene da dietro,
l’altro complice che si guarda attorno per accertarsi che non vi siano testimoni
nei paraggi.
Giorgio de Chirico (Fig. 31), come gli atri, non si lancia in un’interpretazione
singolare dell’evento ma si limita a sottolineare la rapidità e la violenza dell’atto
attraverso tratti molto irregolari, imprecisi e veloci.
19Indubbiamente Maggioni (Fig. 32) è quello che sorprende di più. Ritroviamo,
un’altra volta, l’elemento dell’uccello comparso nei primi capitoli, quando don
Abbondio viene minacciato dai bravi di don Rodrigo. Ricordiamo che questo
volatile è il simbolo della malvagità, dell’odio, dei soprusi, della violenza e è
particolare come l’artista scelga di immortalare il momento del rapimento di
Lucia attraverso l’immagine del rapace che agguanta la poverina portandola via
come una preda. Anche questa volta, a mio avviso, è evidente come Maggioni
scelga di andare oltre e di rivelare ciò che nel testo non viene esplicitamente
detto, contrariamente agli altri illustratori che rimangono spesso molto fedeli alle
descrizioni dell’autore. Secondo me non è un caso che l’abbigliamento con il
quale l’artista veste Lucia ricordi quello di una monaca. In fin dei conti il legame
con Gertrude è automatico. Entrambe le donne sono vittime di uomini
prepotenti e malvagi. Gertrude è indissolubilmente legata a Egidio e Lucia viene
perseguitata dalla brama di sesso e dai capricci del potente don Rodrigo. La
monaca, per di più, è proprio una delle complici maggiori. Ricattata da Egidio,
combatte con i sensi di colpa anche se poi, incapace per natura di ribellarsi,
rimane chiusa nella trappola tesale dall’amante. Evidente quando Manzoni dice:
Quando Gertrude, che dalla grata la seguiva con l’occhio fisso e torbido, la
vide metter piede sulla soglia, come sopraffatta da un sentimento
irresistibile, aprì la bocca, e disse: “sentite, Lucia!”
Questa si voltò, e tornò verso la grata. Ma già un altro pensiero, un
pensiero avvezzo a predominare, aveva vinto di nuovo nella mente della
sciagurata di Gertrude. (cap. XX)
La monaca di Monza è lacerata da un conflitto interno tra l’aspirazione al bene
e una volontà, debole e incerta, che le impedisce di ribellarsi all’ordine dello
scellerato amante. Viene messa in luce, per l’ennesima volta, non solo la
fragilità della donna, ma anche la sua tentazione di cedere al bene. Anche
Gertrude, quindi, sarebbe rappresentabile attraverso un’immagine simile e qui
l’unico elemento distintivo che ci può far comprendere che la figura in questione
è Lucia e non la monaca è rappresentato dalle scarpe rosse e dalla sottoveste,
rossa anch’essa.
20Francesco Gonin (Fig. 28) Gallo Gallina (Fig. 29)
Roberto Focosi (Fig. 30) Giorgio de Chirico (Fig. 31)
Federico Maggioni (Fig. 32)
214. La peste
Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in
boccia, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato. (Alessandro
Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXIV)
La peste descritta da Manzoni viene rappresentata da Gonin attraverso
l’allegoria di un mostro munito di falce. Nell’illustrazione (Fig. 33), infatti, la
peste è un essere con ali di pipistrello che regge una falce mantenendo, in
volto, un ghigno che lo deforma.
Allo stesso modo Giovanni Schiaroli (Fig. 34) mantiene l’immagine della falce,
ma preferisce non soffermarsi troppo sui dettagli fisici e abbozza malamente la
figura della peste, coprendola con un velo verde scuro che ricorda,
nell’immaginario comune, il lenzuolo dei fantasmi della morte. Preferisce,
inoltre, collocarla in un prato e ritrarla proprio nel momento in cui, inesorabile,
trancia via erbe e fiori.
Maggioni non si smentisce nemmeno con la peste (Fig. 35). Egli immagina la
diffusione della malattia come degli scampoli di stoffa neri che si propagano per
la città avvolgendone e contaminandone gli abitanti. La scena è dominata dal
rosso, premonitore di morte e anticipatore di sofferenza. Riguardo a questa
immagine occorre anche fare delle precisazioni sull’ambiente circostante le
figure in primo piano (due cittadini che stanno contraendo la malattia). Mentre
Gonin e Schiaroli fanno della peste una allegoria e la collocano in una
dimensione poco concreta e molto simbolica, Maggioni entra nello specifico e la
inserisce all’interno di una città, Milano, che sta vivendo disordini a livello
sociale. Ci sono molti elementi che rimandano alla situazione politica e sociale
della Milano dell’epoca. Prime fra tutto, le frasi scritte sul muro di fondo, in
diverse lingue, richiamano i graffiti moderni lasciati lì a denuncia dei mali dello
Stato e dei problemi dei lavoratori. Troviamo infatti slogan come: “Pan y
Libertad” (pane e libertà), chiaro sintomo della fame e della miseria del popolo
che si sente schiavo delle proprie leggi; “No tengo dinero” (non ho soldi), altra
denuncia dell’estrema povertà e delle difficili condizioni di vita; “El pueblo unido”
(il popolo unito), minaccia verso i pochi che comandano sui molti, a ricordare
che è l’unione delle masse a fare la forza di uno stato; “Abbaso il viccario”,
esempio, fra le altre cose, anche del basso livello di scolarizzazione e
alfabetizzazione; “Crepi la giunta” o “Moiano gli affamatori”, già chiari senza
bisogno di ulteriori spiegazioni; “Wir sind die ordnung” (noi siamo l’ordine) e
“Der sieg wird unser sein” (la vittoria sarà nostra), ulteriore rivendicazione della
22forza di un popolo nella sua collettività e unione. Ma tutto questo disordine e
tutte queste frasi intimidatorie contro lo stato, a mio avviso, forse sono anche un
modo per esprimere indirettamente la critica manzoniana alla superficialità e
agli errori commessi dalle commissioni sanitarie nel prendere provvedimenti
contro l’epidemia. In un passaggio del romanzo Manzoni scrive:
In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto:
proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea
s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste; vale a dire
peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale
non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza
contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del
malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non si
può più mandare indietro. (cap. XXXI)
Innanzi tutto la critica è mossa verso la mancanza di prontezza delle autorità.
Esse hanno la colpa di negare l’evidenza e, per paura, fingono di non
comprendere quello che sta realmente accadendo, una epidemia di peste.
All’inizio cercano giustificazioni attraverso la possibilità che si tratti di un’altra
malattia, poi viene assunto un commissario che, con l’aiuto dei medici, valuta i
casi delle prime vittime per accertarne la natura. Si preferisce dare la colpa al
tempo o alle esalazioni autunnali delle paludi e, a causa della forte
incompetenza dell’autorità pubblica e della lentezza burocratica, si incitano
manifestazioni pubbliche di massa, senza considerare l’eventualità che la
vicinanza di così tante persone favorisca il contagio. È così che i provvedimenti
tardivi delle autorità permettono l’ingresso definitivo della malattia in città e
l’aumento dei casi di peste non fanno altro che sconvolgere la folla, la quale,
ignorante e facilmente condizionabile e impressionabile, cerca un capro
espiatorio, un bouc émissaire, come lo chiama Camus ne La Peste, che viene
riconosciuto negli untori. Ecco perché Maggioni pone, in un angolo del suo
disegno a sinistra, a terra, un volantino sul quale è riportata l’immagine stilizzata
di un uomo che unge un muro e la scritta “Achtung”, cioè attenzione.
Per quello che riguarda le vicende dei capitoli sulla peste, molti sono gli incontri
importanti che fa Renzo, ma uno più di tutti è rimasto nella memoria collettiva,
quello della madre di Cecilia.
Scendeva dalla soglia di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una
donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non
trascorsa; […] La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi
non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; […] Portava
essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben
23accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo,
come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto
tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere sur
un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non
che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una
certa inanimata gravezza, e il capo posava sull’omero della madre, con un
abbandono più forte del sonno: della madre, ché, se anche la somiglianza
de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due
ch’esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la
bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con
un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però
dimostrare sdegno né disprezzo, “no!” disse: “non me la toccate per ora;
devo metterla io su quel carro: prendete.” Così dicendo, aprì una mano,
fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese.
Poi continuò: “promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che
altri ardisca di farlo, e di metterla sotto terra così.” […] La madre, dato a
questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, ce l’accomodò, le
stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: “addio, Cecilia! riposa
in pace! stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega
intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri.” Poi voltatasi di nuovo al
monatto, “voi” disse, “passando di qui verso sera, salirete a prendere anche
me, e non me sola.”
Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra,
tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte
in volto. (cap. XXXIV)
Considerata come una delle pagine più struggenti e commoventi di tutta la
letteratura italiana, lo strazio e la pena per questa madre che aspetta di morire
con la figlia più piccola hanno ispirato tantissimi artisti. Gonin (Fig. 36) ritrae la
madre con Cecilia in braccio, il carro dei monatti e i corpi accatastati e
scomposti.
Aligi Sassu, invece (Fig. 37), si concentra solo sulla figura della madre. In
questa inquadratura il carro dei monatti è solo accennato con qualche tratto di
matita sullo sfondo e la donna è sola, in primo piano, completamente avvolta di
nero. Sembra reggere in mano qualcosa, ma è difficile intravederne la natura,
perciò possiamo supporre che sia il momento in cui la donna ha appena
abbandonato il corpicino della figlia e si sta dirigendo verso la più piccola per
lasciarsi andare alla pace dell’altro mondo e al ricongiungimento con la creatura
perduta.
Giorgio de Chirico (Fig. 38) preferisce ritrarre la madre in una posizione di
prostrazione: in ginocchio, offre la sua bimba ai monatti con la richiesta di
lasciarla così, coperta, e di passare a prendere lei e l’altra figlia al tramonto. La
24posizione della bambina è completamente diversa da come viene descritta nel
romanzo. La disperazione della donna è visibile in volto e il braccio sinistro della
bambina sembra appoggiato al ginocchio della madre, come per incoraggiarla e
farle forza, all’insegna della speranza in una vita migliore. De Chirico opera
praticamente a rovescio. Se Gonin fa in modo che tutto della bambina sembri
ancora vivo tranne il braccio, indice del decesso, qui il braccio è l’unica cosa
che sembra essere animata da sentimento.
Schiaroli (Fig. 39) gioca di più sull’effetto cromatico. La pertinenza al testo
manca sia per quello che riguarda la figura della madre, che qui sembra una
bella donna, vestita a modo, con delle scarpe eleganti e tutt’altro che malata in
punto di morte, sia nella posizione della bambina, stesa sulle braccia della
madre invece che semi-seduta. Cecilia, però, è soffusa dal bianco della sua
veste che riflette l’ innocenza e la purezza di una bambina di nove anni.
Maggioni (Fig. 40) decide di rappresentare la madre ed entrambe le figlie
insieme. Cecilia è quasi invisibile stretta fra le enormi braccia della mamma.
Quest’ultima e la figlia più piccola sono avvolte dalla peste e il loro viso ricorda
un teschio. Anche qui, in teoria, non dovrebbe essere la fisicità a contare, bensì
dovrebbe essere il valore simbolico degli elementi a renderli meno angoscianti
di quello che appaiono a prima vista. A mio avviso Maggioni non ci riesce. Il
significato nascosto non va oltre la durezza dei suoi disegni: entrambe le figure
sono vestite di rosso (non c’è più bisogno di sottolineare il perché) e la morte
giace proprio accanto a loro, lì, stesa per terra, avvolta da un panno nero e
legata come una mummia, pronta ad accogliere l’intera famiglia.
Ed allora non possiamo che concludere questa sezione se non con l’immagine
del lazzaretto:
S’immagini il lettore il recinto del lazzaretto, popolato di sedici mila
appestati; quello spazio tutt’ingombro, dove di capanne e di baracche, dove
di carri, dove di gente; quelle due interminate fughe di portici, a destra e a
sinistra, piene, gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi, o
sulla paglia; e su tutto quel quasi immenso covile, un brulichio, come un
ondeggiamento; e qua e là, un andare e venire, un fermarsi, un correre, un
chinarsi, un alzarsi, di convalescenti, di frenetici, di serventi. Tale fu lo
spettacolo che riempì a un tratto la vista di Renzo, e lo tenne lì, sopraffatto
e compreso. (Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXV)
Gonin (Fig. 41) non entra nei particolari e guarda tutto da lontano, dandoci solo
un’idea della vista che si apre agli occhi di Renzo all’arrivo nel lazzaretto.
25Maggioni interpreta, va oltre e stupisce il lettore con un effetto grafico senza
precedenti (Fig. 42a). Inizia ponendo fra una parola e l’altra alcuni piccoli
scarafaggi, simili fra loro e colorati diversamente. Si capisce subito che sono la
rappresentazione dei malati, ma quando si volta la pagina ci si trova di fronte ad
uno spettacolo che lascia proprio sbalorditi (Fig. 42b). Ci sono due pagine
bianche, senza parole, piene di questi piccoli insetti, che camminano, in massa,
tutti verso la stessa destinazione: la morte. Chi più avanti, chi più indietro,
ognuno col suo passo, chi da solo e chi in compagnia, ma comunque tutti malati
e io credo che l’espressione del lettore nel vedere questo ammasso irregolare e
confuso di scarafaggi sia proprio la stessa di Renzo all’ingresso del lazzaretto.
A modo suo, come sempre, Maggioni ha ricreato la situazione del libro e, con
questa veduta d’insieme, ci ha voluto ricordare come la peste sia la malattia più
equa. È, per così dire, una malattia democratica, che colpisce tutti,
inesorabilmente, senza distinzioni di ceto e condizioni (notare il diverso colore
degli animali). Tutti sono sottoposti allo stesso supplizio, dal riccone prepotente
alla bambina innocente, dall’umile frate alla mercantessa, dai ladri alla gente
per bene. Tutti sono messi alla prova e tutti hanno la possibilità di far riaffiorare
la propria umanità. La peste è, infatti, capace di tirar fuori il vero animo, la vera
essenza, quella che resta per la maggior parte delle volte nascosta e che, a
volte, nemmeno noi conosciamo.
Francesco Gonin (Fig. 33) Giovanni Schiaroli (Fig. 34)
26Puoi anche leggere