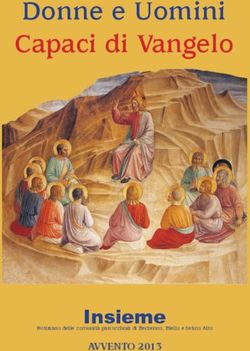Al tramonto ancora vivere - ATTI DEL CONVEGNO Da credenti accanto alle persone al finire della vita
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Consulta Diocesana per la Pastorale della salute - Brescia
Al tramonto
ancora vivere
Da credenti accanto alle persone
al finire della vita
ATTI DEL CONVEGNOAl tramonto
ancora vivere
Da credenti accanto alle persone
al finire della vita
23
Consulta Diocesana per la Pastorale della salute - Brescia
Al tramonto
ancora vivere
Da credenti accanto alle persone
al finire della vita
ATTI DEL CONVEGNO
24 maggio 2003
4PRESENTAZIONE
Don Maurizio Funazzi*
Le persone che si avvicinano alla fine della vita si trovano oggi ad affrontare il
periodo conclusivo della loro esistenza in un contesto sociale e culturale molto mutato, che
può rendere più difficile e meno scontato – se mai lo è stato – vivere nell’approssimarsi
della morte anziché soltanto subire tale momento. Il contesto odierno è mutato a tal punto
che si pone il problema del valore e del senso della vita in situazioni di precarietà e di
sofferenza e si va affermando che se esiste il diritto di vivere, non esiste però il dovere di
farlo. Da parte di alcuni si teorizza anzi la possibilità di rinunciare alla vita ad arbitrio del
soggetto o del gruppo (eutanasia) come una nuova forma di “diritto” della persona. Questa
situazione è acuita dal fatto che la cura del morente è sovente ridotta ad intervento tecnico,
chirurgico o farmacologico, mentre minime energie vengono investite per sostenere
umanamente e spiritualmente il malato in pericolo di vita, per farlo uscire dall'isolamento
relazionale, dall'esperienza del non senso e dell'espropriazione della propria umanità
ridotta a ”numero” o a ”caso”.
Chi accosta gli ammalati ed i morenti, si trova così sovente a confrontarsi con
domande che li interpellano sul senso di ciò che l’ammalato inguaribile sta vivendo e
chiedono ai servizi socio-sanitari, agli operatori pastorali, al volontariato e a ogni cristiano
che accosta il morente, di trovare strade per aggiungere alla competenza di un servizio
reso, anche l’umanizzazione di tale servizio – che sia capace di sostenere la persona a fare
esperienza che la vita che gli rimane è ancora un valore e un dono prezioso – e l'apertura
alla speranza cristiana.
Il Convegno, voluto e pensato dalla Consulta Diocesana per la pastorale della
salute, è stata un’occasione in questo senso. Si è qualificato come Convegno pastorale, che
si è rivolto ai credenti per aiutarli a porsi di fronte alla vita nel suo finire in atteggiamento
coerente al vangelo, non solo come singoli, ma soprattutto come soggetti di una comunità
cristiana (in ospedale; RSA; parrocchia…).
Vuol essere un aiuto all’azione dei credenti perché contribuiscano ad umanizzare
l'esercizio delle professioni sanitario-assistenziali, attingendo al tesoro di sapienza,
competenza e umanità della tradizione religiosa cristiana e delle scienze moderne; perché
sappiano darsi e dare ragione dei motivi etici e di fede per cui una vita anche in situazione
fragile e che si approssima alla morte ha e mantiene tutto il suo valore. Intende inoltre
offrire alcuni strumenti che siano di aiuto al cristiano, all’operatore pastorale o sanitario
*
Presidente della Consulta Diocesana e direttore dell’Ufficio Diocesano per la pastorale della salute
5per essere prossimo intelligente al malato e alla persona che si confronta con il problema
della morte illuminandola con il Vangelo della Salvezza, e perché sappia aprirsi al dialogo
anche con chi non crede o non condivide l’etica ecclesiale, così da favorire la creazione di
équipe terapeutiche e pastorali collaborative e motivate a tessere quel caldo mantello di
attenzioni e relazioni che può favorire anche nell’uomo e nella donna del nostro tempo il
viaggio verso una morte che costituisca un accettato compimento della propria storia e
un'apertura al futuro di Dio, anziché il disperato scontro con un muro di non senso.
Ai molti che hanno investito energie, tempo e passione per realizzare il
Convegno, a tutti coloro che ad esso hanno attivamente partecipato ed a tutti coloro che,
attraverso queste pagine, ne condivideranno sensibilità e preoccupazioni, va il nostro
sentito ringraziamento.
IL PERCORSO DEL CONVEGNO
Accoglienza e preghiera.
Introduzione - IL SENSO DEL CONVEGNO
Dott. Giovanni Zaninetta
Prima relazione.
AL CALAR DEL SOLE. LA MORTE: PROBLEMA O MISTERO?
LE RISPOSTE DELLA CULTURA CONTEMPORANEA
Padre Angelo Brusco
Seconda relazione.
LA LUCE NELLA SERA. LA CURA DEL MORENTE COME PROBLEMA DI BIOETICA
D.ssa Roberta Sala
Interventi-dibattito.
Terza relazione.
OLTRE IL TRAMONTO. VERSO UNA NUOVA PRASSI DI ACCOMPAGNAMENTO
DELLA PERSONA MORENTE
Don Renzo Pegoraro
Interventi-dibattito
Santa Messa
Gruppi di lavoro
Sintesi assembleare e conclusione dei lavori
6Introduzione
IL SENSO DEL CONVEGNO
Dott. Giovanni Zaninetta*
“Nunc dimitte servum tuum, Domine”(Lc 2,29): la preghiera di Simeone è, a mio
parere, il paradigma dell’atteggiamento evangelico alla conclusione di una vita illuminata
dalla Fede; l’atteggiamento del discepolo che ha servito fedelmente Dio ed ha avuto la
grazia di percepire concretamente la salvezza che gli è stata offerta e si prepara ad
incontrarLo.
Detto questo, probabilmente, potremmo andare a casa tutti dato che questa, a mio
parere, è la sintesi di quello che dovrebbe essere il nostro morire.
La quotidianità però è diversa: la morte è uscita dai nostri orizzonti di vita per
diventare oltraggio insopportabile, mostro da combattere o angoscia da ignorare.
Nostro compito è riaffermare oggi, in questo incontro di comunità cristiana
diocesana, che non si può parlare della morte ignorando la vita che la precede, così come
non si può parlare della vita terrena senza circoscriverla dentro i confini della morte,
superati i quali ci aspetta l’incontro con Dio.
Clemenceau sosteneva che la guerra è una faccenda troppo seria per lasciarla ai
militari; noi potremmo parafrasare che la morte è una vicenda troppo seria per lasciarla
alla gestione dei medici; anche se è esperienza purtroppo comune, che essa può essere
troppo dolorosa e angosciante per lasciarla solo all’accompagnamento spirituale.
Mi sembra questo un richiamo utile, anche in un’occasione come quella di oggi in
cui ci occuperemo soprattutto degli aspetti non medici dell’ultimo tratto della vita. Oggi
dovremo soprattutto cercare di compiere una riflessione sul significato e l’importanza che
la morte deve ritrovare dentro la nostra vita; d’altra parte tale riflessione sarebbe assai
limitata se non si collocasse dentro l’alveo più grande della tutela della persona umana, di
cui la cura del morente è solo il capitolo più estremo.
Così come, infatti, sarebbe colpevole trascurare la cura del morente per limitarsi
alla cura dei malati guaribili, non possiamo nasconderci che oggi, ed il nostro Vescovo,
mons. Giulio Sanguineti, lo ha testimoniato autorevolmente durante l’omelia di San
* Medico Responsabile dell’Hospice per malati oncologici “Domus Salutis” di Brescia, è vice-
presidente nazionale della Società Italiana di Cure Palliative e Membro della Consulta Diocesana per
la pastorale della salute.
7Faustino, è tutto il sistema di tutela della salute ad essere messo in difficoltà, a volte assai
dolorose, da una serie di scelte politiche ed economiche verso le quali dobbiamo esercitare
un sano discernimento.
Anni fa si diceva per esemplificare l’attenzione ai rendiconti, “la salute non ha
prezzo, ma ha un costo”, oggi possiamo dire che la salute ha sia un costo che un prezzo:
dentro questo slogan, infatti, stanno prendendo corpo scelte che, passo dopo passo,
spostano l’equilibrio della tutela della salute sempre più verso un arido bilancio di entrate e
di uscite, verso piani aziendali, verso valutazioni economiciste e verso l’affermazione che,
alla fine, qualcosa bisognerà pagare per essere curati meglio.
Non possiamo negare che le risorse siano limitate ma dobbiamo sapere che
seguendo questa linea compiamo una scelta precisa, anche se sottaciuta: anteponiamo i
bilanci alle esigenze della persona, che in questo modo saranno soddisfatte in base alle
risorse disponibili e predeterminate e non ai suoi bisogni oggettivi ed ai suoi diritti di
cittadino.
Io credo che la comunità cristiana, portatrice di valori fondamentali riferiti alla
persona, debba riaffermare il primato della dignità sul calcolo, della libertà dalla sofferenza
attraverso cure adeguate sul contingentamento delle prestazioni e debba pure affermare che
ogni vita è preziosa, non in senso astratto ma nella sua corporeità, nelle sue relazioni, nel
suo essere creatura di Dio.
Dobbiamo allora interrogarci, e lo faremo con l’aiuto di relatori esperti e attenti
alla situazione, sul nostro agire nel mondo, senza mai dimenticare l’ammonimento
evangelico “ciò che farete a questi piccoli, l’avrete fatto a me”.
8Prima relazione
AL CALAR DEL SOLE. LA MORTE:
PROBLEMA O MISTERO?
LE RISPOSTE DELLA CULTURA CONTEMPORANEA.
Padre Angelo Brusco*
Mentre stavo per mettere in ordine alcune idee da comunicarvi in questa conferenza,
ho avuto la visita di alcune persone amiche. Terminati i convenevoli, esse si resero conto
che ero un po’ inquieto, come qualcuno che ha un impegno da assolvere: quando vennero a
sapere che il motivo della mia irrequietezza era la preparazione di questa relazione sulla
morte nella cultura contemporanea, si offrirono di aiutarmi. Quanto vi presento questa
mattina è il frutto di quell’incontro e dello scambio che ne è seguito.
Cominciò a parlare un signore dalla barba fluente; con voce pacata egli disse: “Uno
sguardo alla cultura contemporanea mette in evidenza due atteggiamenti contrapposti nei
confronti della morte. Da una parte c’è chi considera la morte come problema e dall’altra
chi la vive come mistero”.
Dopo una breve pausa continuò: “Secondo il filosofo francese Gabriel Marcel, il
problema è qualcosa che incontro sul mio cammino, un ostacolo che mi sbarra la strada,
che mi sta davanti, separato da me, il mistero invece è una realtà non separata da me, nella
quale io stesso sono coinvolto”.
Tutti lo guardavano con interesse, curiosi di sentire il seguito del suo discorso. “Chi
considera la morte come problema – egli proseguì – è portato a rimuoverla, come si
rimuove un ostacolo, cioè ad eliminarla dal proprio campo di coscienza”.
Intervenne una ragazza dagli occhi celesti. “Questo processo di rimozione è solo
del nostro tempo?” chiese. “No – rispose prontamente l’uomo dalla barba fluente – esso è
sempre stato presente nell’esperienza degli uomini, trovando la sua origine nella psicologia
della persona umana, come ha fatto notare Freud già agli inizi del secolo XX”. “E’ vero –
interruppe una donna con voce tranquilla – nel 1915 infatti il fondatore della psicanalisi
scriveva che per noi è assolutamente impossibile raffigurarci la propria morte ed ogni volta
che tentiamo di farlo, ci rendiamo conto di assistervi da spettatori, è per questo che la
scuola psicoanalitica si è ritenuta in diritto di affermare che, in fondo, nessuno crede alla
propria morte o (il che è lo stesso) che ciascuno inconsciamente è convinto della propria
immortalità”.
* Religioso dell'Ordine Ospedaliero di San Camillo di cui è stato Superiore generale dal 1989 al
2001, è laureato in filosofia (Università Cattolica, Milano), teologia (Università Laval, Québec,
Canada) e Psicologia (Università Laval). Tra i fondatori delle cure palliative italiane, è
attualmente Professore Ordinario all'Istituto Internazionale di Teologia Pastorale sanitaria
«Camillianum» di Roma e Direttore del «Centro Camilliano di Formazione» di Verona.
9Mentre la ragazza dagli occhi celesti sorrideva, forse identificandosi con quanto
scritto da Freud, prese la parola un anziano signore dal volto scavato. “Se la tendenza a
rimuovere la morte è qualcosa di naturale – gli disse – e quindi presente in ogni epoca, essa
però assume connotazioni particolari nei diversi periodi storici”. Si schiarì la gola, poi
riprese. “Al tempo dei Greci, per esempio, Epicuro era ricorso ad un sofisma, cioè ad un
falso ragionamento di successo; di nessuna cosa dobbiamo aver paura, egli scriveva, e
meno ancora della morte. Infatti quando essa è presente noi non ci siamo e quando noi ci
siamo essa non c’è”.
Tutti sorrisero senza però interromperlo. “Nel secolo XVII - egli continuò - Pascal
ha elaborato una fine analisi di quel processo psicologico che egli chiamava
‘divertissement’ – divertimento – cioè un’operazione mentale che porta a deviare
l’attenzione dalla considerazione della propria condizione finita. E più vicino a noi,
Heidegger, il filosofo esistenzialista, si è azzardato a descrivere in maniera meravigliosa, la
strategia adottata dagli uomini per sfuggire all’angoscia che deriva dal sapersi mortale.
Egli parla del sottile gioco della distrazione, della chiacchiera quotidiana, che tiene lontane
le persone dal riflettere sul loro essere per la morte”.
“A me viene alla memoria una pagina del romanzo di Giovanni Arpino, Passi di
addio, in cui l’autore mette a fuoco i traguardi raggiunti dalla rimozione, dall’occultamento
della morte nel nostro tempo”. A prendere la parola era ancora il signore dalla barba
fluente. Parlando adagio, citò quasi a memoria un passo del romanzo: “E’ colpa grave del
nostro mondo, di questi nostri anni, scrive Arpino, il non voler più parlare della morte, la
nascondiamo, la camuffiamo come accidente da eliminare subito, la neghiamo come i gatti
sotterrano i loro escrementi e con inalterata superbia se ne allontanano. Mentre la morte fu
sempre onorata nei tempi davvero umani, forse terribili, ma umani. Ora la si rimira come
se costituisse un’offesa, un oltraggio. Chi muore è quasi accusato di tradire chi resta. Ecco
qual è la nostra spaventosa bestemmia, continua Arpino, il voler far morire la morte,
abbiamo espulso la morte dalla sfera dei nostri pensieri e così siamo diventati burattini
ridicoli di una mentalità meccanica che esige di ignorare il suo destino mortale. Ci
ritroviamo infelici, vili, proprio mentre andiamo recitando sicurezza ed energia”.
Tutti rimasero in silenzio sotto il peso di quella citazione. Fu la ragazza a
interrompere la pausa meditativa: “Com’è possibile mettere d’accordo quanto detto finora
con il fatto che oggi si parla più che nel passato della morte e che essa occupa tanto spazio
nei mass media, venendo per così dire spettacolarizzata?”.
“Non bisogna lasciarsi ingannare” rispose la signora dalla voce pacata. “La morte di
cui si discute – essa disse – la morte vista in televisione, la morte in diretta (per fare
riferimento ad un recente film), è pur sempre la morte degli altri, mentre la morte vera,
quella nostra, con cui dobbiamo fare i conti, quando ci pensiamo? E a quella di chi ci sta
intorno, di chi conosciamo: rimane in realtà un tabù insormontabile. Non se ne parla,
perché resta un argomento angoscioso, perché il parlarne ci metterebbe in discussione
spietatamente, non ci consentirebbe risposte provvisorie, rinvii, alibi di alcun tipo”.
La conversazione procedeva speditamente. Il tema divenne ancora più interessante
quando l’anziano signore dal volto scavato disse, quasi tra sé: “Quale immagine di uomo
emerge dall’atteggiamento verso la morte appena illustrato?”.
10“Quella del padrone assoluto” rispose immediatamente il signore dalla barba fluente.
“Quella dell’arbitro insindacabile di sé, delle sue decisioni, delle sue scelte, della realtà
della sua vita e quindi anche di questa particolare realtà che è la morte. Mi sembrava di
aver letto qualcosa di simile in un intervento del Cardinal Dionigi Tettamanzi”.
Infatti, la donna dalla voce pacata intervenne dicendo: “Il Cardinale di Milano
identifica due sintomi molto evidenti della concezione dell’uomo come padrone di sé e
pertanto anche della morte. Da un lato l’accanimento terapeutico e dall’altro l’eutanasia.
Sono modi apparentemente diversi, ma in realtà identici di affrontare da parte dell’uomo la
realtà della morte”.
“L’ipotesi di Tettamanzi – intervenne il signore dalla barba fluente – è confermata
dal Prof. Malherbe, medico e filosofo dell’Università di Lovanio. Secondo questo studioso
tra accanimento terapeutico ed eutanasia vi è una continuità logica, perché in essi è sempre
l’uomo che non si lascia misurare in maniera umana dalla morte. Con l’accanimento
terapeutico l’uomo fa di tutto per posticipare la morte, per ritardarla e con l’eutanasia
l’uomo fa di tutto per anticipare la morte e quindi, in ambedue i casi, l’uomo vuole
esercitare il suo comando, il suo dominio sulla morte”.
“Questa visione della realtà trova un appoggio in un certo tipo di progresso
scientifico tecnico, confermando quanto è scritto nella Costituzione del Concilio Vaticano
II, Gaudium et spes: «Vi è il pericolo che l’uomo, fidandosi troppo delle odierne scoperte,
pensi di bastare a se stesso e più non cerchi cose più alte»”. Queste ultime parole le
pronunciò un sacerdote di mezza età che aveva seguito con interesse il discorso.
Egli continuò: “Mi piacerebbe sapere se il rifiuto della morte si ripercuote anche
sull’atteggiamento verso il morire e verso il morente”.
“Non vi sono dubbi”. Rispose il signore dalla barba fluente. “La gente viene assai
meno esposta a quello spettacolo del morire che nel passato faceva parte dell’esperienza
comune. La maggior parte delle persone muore ancora nelle istituzioni sanitarie che ne
regolano le sequenze con minuziose prescrizioni intese ad isolare sia l’avvenimento del
moribondo, che il cadavere del defunto”.
“Potremmo dire – intervenne la signora dalla voce pacata – che il periodo che
precede la morte è desocializzato, perché la società malata della rimozione della morte si
trova impotente nel farsi carico degli ultimi istanti di vita di colui che muore.
Contrariamente a quanto avveniva nel passato, il morente è abbandonato ad una pesante
solitudine. Una solitudine più psicologica e spirituale che fisica, perché causata dalla
mancata comunicazione della verità (la cosiddetta «congiura del silenzio»), dalla tendenza
a dare risposte prevalentemente tecniche alla sofferenza, ciò che impedisce di coglierne il
senso”. Dopo un attimo riprese: “La rimozione e l’occultamento della morte costringono
anche ad una repressione del dolore e del lutto, ad un’auto censura che spesso provoca
gravi danni psicologici. Il sociologo Ariés ha sottolineato come nella società attuale, un
dolore troppo visibile non ispira pietà, ma ripugnanza. E’ un segno di perturbazione
mentale o di cattiva educazione, è morboso e anche all’interno della stessa cerchia
familiare, si esita a lasciarsi andare per non impressionare i bambini. Abbiamo il diritto di
piangere solo se nessuno ci vede e ci sente. Il lutto solitario e pieno di vergogna, è l’unica
risorsa”.
11“Non avrei mai immaginato che il pensare alla morte, considerata come problema,
potesse avere tutte queste implicazioni” disse la ragazza dagli occhi celesti, rimanendo
pensosa.
Prese la parola il signore dalla barba fluente: “Una conclusione di quanto abbiamo
condiviso finora è bene espressa dalle parole dell’antropologo Ziegler. «Con l’interdizione,
il tabù e il silenzio sulla morte, la società occidentale non dà i mezzi per capirla, e
soprattutto combattere e gestire l’angoscia che essa genera»”.
A stimolare la continuazione del discorso, ci pensò ancora la ragazza dagli occhi
celesti. “Cosa accade quando si pensa alla morte come mistero?” ella chiese.
“Chi considera la morte come mistero – rispose l’uomo dalla barba fluente – è
portato a vederla come parte della propria esperienza, non da eliminare quindi, ma da
integrare creativamente”. Socchiuse per un attimo gli occhi e poi continuò. “Si tratta di un
processo impegnativo, infatti l’assumere questo atteggiamento non elimina il carattere
tragico della morte”.
“E’ vero” intervenne il sacerdote, che continuò: “Molti sono portati a pensare che il
cristiano dovrebbe morire sereno, confidente nel futuro, libero dalla disperazione di chi
non crede. La riflessione e l’esperienza inducono a cambiare idea”.
Visto che tutti erano attenti alle sue parole, riprese: “Silvano Zucal, un filosofo
attento a quanto sta svolgendosi nella cultura attuale, invita a riflettere sul modo con cui il
Cristo diversamente da Socrate, da Buddha o dai grandi interpreti di una mentalità stoica,
ha affrontato la morte. Certo, alla fine Cristo si abbandonò nelle mani del Padre con un atto
estremo di fiducia filiale, ma non si possono rimuovere od occultare quelle terribili parole
interrogative «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», che non troveremo mai
sulle labbra di Socrate, né su quelle di Buddha, né in bocca degli stoici. Il credente non
cerca mai la ‘bella’ morte, la morte vissuta con distacco limpido, la morte eroica; la
affronta con una percezione viva e sincera della tragedia che essa contiene, del carico
d’assurdo che in essa si manifesta e dell’angoscia radicale che sempre si accompagna ad
essa. Per il cristiano, nella morte si rivela la spina che è conficcata nella nostra carne e che
è il frutto del peccato. Certo la si vive poi anche con fede, ma la fede non è mai frutto di
forza umana e di umana grandezza, è dono invocato. Quindi il credente che affronta la
morte non è esentato dal vedere e dallo scoprire in essa tutto ciò che gli altri fratelli e
l’umanità vi vedono. Non è portato a dissimularne la tragicità, se neppure il Figlio
dell’Uomo lo ha fatto”.
Interessata dalla piega della conversazione, la signora dalla voce pacata disse: “Che
l’accogliere la morte come una realtà che fa parte della vita esiga una lotta, appare
chiaramente anche da un episodio della Bibbia che ha sempre ha attirato la mia attenzione.
Al capitolo 32° della Genesi viene narrata la lotta tra Giacobbe e un personaggio
misterioso. Di ritorno in Palestina dopo una lunga assenza, Giacobbe attraversa il torrente
Iabbok, un affluente del Giordano. Fatta avanzare la carovana, egli rimane solo alla riva
del torrente. Durante la notte egli intraprende la lotta con un misterioso personaggio,
quest’ultimo non potendo vincerlo, colpisce Giacobbe al nervo sciatico, lasciandolo zoppo.
12Il misterioso personaggio, quando la notte sta per finire, chiede a Giacobbe di lasciarlo
andare, ma egli non acconsente se prima non riceve la sua benedizione”.
La signora fece una pausa, poi riprese. “Sono d’accordo con quanti pensano che il
simbolismo più evocativo di questo episodio è quello della lotta del popolo d’Israele con il
mistero di Dio, specialmente con il suo procedere nei confronti della sofferenza umana
della morte. Perché il dolore, perché la morte? Come conciliare queste realtà negative con
l’onnipotenza e la bontà del Signore? Questa lotta avviene nella piena notte del mistero e
dura quanto dura la notte. Il dolore e la morte sono messi in relazione con l’oscurità della
notte, non considerata come valore negativo, bensì come mistero del quale solo Dio
conosce la risposta. La notte è il momento in cui Dio condensa in sommo grado la sua
azione misteriosa”. “Però ogni notte ha la sua alba” concluse il sacerdote con un sorriso.
I miei amici avevano preso gusto all’argomento, infatti l’anziano signore dal volto
scavato disse: “Anche alla base dell’atteggiamento che vede la morte come mistero, vi sarà
una particolare antropologia, penso”.
“Indubbiamente” rispose il signore dalla barba fluente. “Tale atteggiamento mostra
l’essere umano sia nella sua grandezza, sia anche nella sua precarietà. Il morire diventa il
simbolo più rilevante di tale precarietà, la vita è preziosa e fragile. Preziosa proprio perché
è fragile. L’uomo è portato a capire che non è lui ad essere padrone di sé, la sua esperienza
lo rimanda a qualche cos’altro o a qualcun altro”.
La ragazza dagli occhi celesti ripeté a bassa voce: “La vita è preziosa e fragile.
Preziosa proprio perché è fragile”.
Desideroso di portare il discorso a delle conclusioni pratiche, il signore dalla barba
fluente chiese: “Da questo atteggiamento nei confronti della morte derivano delle
conseguenze per l’azione personale e comunitaria?”
“A me ne balza alla mente una” disse il sacerdote di mezza età: “chi vede la morte
come mistero è portato a scegliere la via della autenticità nei confronti della vita, evitando
la via del libertino e dell’avaro”.
“Puoi spiegarti?” intervenne la ragazza dagli occhi celesti.
“Sì”, rispose il sacerdote di mezza età e poi disse: “Vedi, il libertino, angosciato
dalla consapevolezza della sua condizione mortale, opta per un’etica quantitativa,
aprendosi disordinatamente ad ogni tipo di esperienza. Al lato opposto c’è l’atteggiamento
dell’avaro la cui stolta logica è bene illustrata dalla parabola evangelica dell’uomo che ha
riempito i granai e si prepara a godere delle ricchezze accumulate, i suoi progetti sono
stroncati dal sopravvenire della morte. Insensatamente egli aveva considerato la vita come
qualcosa di dovuto. C’è infine la via della autenticità, la cui caratteristica principale è la
vigilanza, atteggiamento di profondo realismo verso il proprio essere, nella consapevolezza
dei limiti esistenziali. Alla vigilanza corrisponde l’etica della qualità, la ricerca del valore,
la prevalenza dell’essere sull’avere. La vita è accolta come un dono che non si può
pretendere, ma soltanto accogliere con gratitudine, come tempo di crescita per sé e per gli
altri”.
13“Sono d’accordo” intervenne la signora dalla voce pacata. “Alla luce della morte
possiamo capire quale strada dobbiamo imboccare nella nostra vita, perché soltanto la
morte rimette nella giusta dimensione le sofferenze, le gioie, i successi, i fallimenti, le
ambizioni, come la dispersione delle nostre giornate. Affrontare il mistero della morte,
guardarla in faccia con consapevolezza e responsabilità è uno dei principali compiti
esistenziali dell’uomo”.
“Un’altra conseguenza - disse l’anziano signore dal volto scavato - è
l’umanizzazione della morte e del morire. È la consapevolezza del dovere di umanizzare la
morte. In questo termine - egli aggiunse - in apparenza così semplice, ma in realtà così
denso, si possono concentrare tutti gli impegni umani ed etici riguardanti il morire”.
“Sono d’accordo” disse l’uomo dalla barba fluente. “L’umanizzazione della morte e
del morire riguarda innanzitutto la concezione della morte come fatto antropologico, non
come un semplice fatto biologico e fisiologico. Un fatto che interessa l’uomo; l’uomo tutto
intero: non solo nel suo organismo, nelle sue evoluzioni, ma anche in primo luogo nella
sua consapevolezza, nella sua libertà e nella sua responsabilità”.
“Ciò esige che si metta la persona del morente al centro delle cure” intervenne la
signora dalla voce pacata, “considerandolo nella totalità delle sue dimensioni come un
essere bio-psico-socio-spirituale. Si tratta, come afferma Gaudium et spes, del dovere di
tener fermo il concetto della persona umana integrale in cui eccellano i valori
dell’intelligenza, della volontà, della coscienza, della fraternità”.
Approfittando di una pausa, intervenne ancora il signore dalla barba fluente: “Vista
dal versante operativo – egli disse – l’umanizzazione comporta:
• Primo, la consapevolezza da parte del malato della sua situazione di gravità; gestire in
maniera adeguata il diritto del morente alla verità diventa quindi un imperativo etico
che non si può trascurare.
• Secondo, la messa in atto di un’appropriata terapia del dolore che elimina la
sofferenza inutile, senza privare il malato della sua coscienza ed una vita
qualitativamente elevata.
• Terzo, l’evitamento dell’accanimento terapeutico.
• Quarto, la risocializzazione della morte e del morire. Non si tratta evidentemente –
egli disse – di ritornare puntualmente ai rituali della società tradizionale, bensì di
immettere il morente in un contesto ricco di umanità con gesti e atteggiamenti che
ogni persona vicina alla morte ha diritto di attendersi. Per utilizzare una terminologia
ormai abusata, si tratta di passare dal curare al prendersi cura”.
Il gruppo non poteva non assentire a quanto era stato detto. A rompere il silenzio che
ne seguì, fu la ragazza dagli occhi celesti. “Dei due atteggiamenti di fronte alla morte:
morte-problema, morte-mistero, quale a più incidenza nella nostra società?”.
“Non vi sono dubbi che la bilancia penda dalla parte dell’atteggiamento che
considera la morte come un problema”, rispose il signore dalla barba fluente. “Nello stesso
tempo, però - egli continuò - non si può ignorare l’affermarsi della tendenza a considerare
la morte come mistero. Essa trova una delle espressioni più fruttuose negli hospice e nelle
14cure palliative, nel fiorire di gruppi di auto-aiuto per le persone colpite dal lutto e in molte,
molte altre iniziative”.
“Infatti – intervene il sacerdote – il fiorire degli hospice e delle cure palliative ha le
sue origini nella filosofia ispirata ai valori cristiani. L’hospice, sia l’hospice classico nato
in Irlanda nel secolo XIX, sia quello moderno fondato in Inghilterra dalla D.ssa Cicely
Saunders hanno trovato la loro motivazione profonda in una concezione della persona
umana radicata nel Vangelo, prefiggendosi di essere veicoli della compassione del Signore
verso chi soffre e muore. In questo solco, poi, sono confluiti molti altri rivoli, ispirati da
valori umanistici validi, anche se non collegati alla spiritualità cristiana”.
“E la Chiesa?” a porre questa domanda, rivolgendosi con un sorriso al sacerdote,
era la donna dalla voce pacata.
Rispose il signore dalla barba fluente. “Come in tanti altri settori della vita sociale –
egli disse – anche in quello dell’assistenza al morente, la Chiesa ha perso il protagonismo
esercitato nel passato, tanto che un autore si domanda se la morte sia ancora una faccenda
ecclesiale. L’evoluzione culturale e sociale sviluppatasi nella seconda metà del secolo XX,
unitamente all’emergere del pluralismo religioso ed etico e al fiorire delle scienze umane e
del comportamento, ha portato alla comparsa di specialisti nella preparazione al morire,
che non fanno necessariamente ricorso ai valori della tradizione cristiana. Tale fenomeno,
se da una parte costituisce una vera ricchezza, dall’altra non manca di suscitare importanti
sfide, sollevando spesso conflitti di ordine antropologico ed etico”.
Continuando nella stessa linea intervenne il signore dal volto scavato. “Diventa
quindi necessario – egli affermò con vigore – che la comunità ecclesiale trovi forme
sempre rinnovate per stabilire un’alleanza – ripeto un’alleanza – con tutte le forze
impegnate per promuovere l’umanizzazione della morte e del morire, apportandovi il suo
contributo originale, mossa dalla convinzione che se davanti alle persone in ricerca si
accendono tante luci, tra di esse vi è anche quella di Cristo senza il quale, come afferma
Pascal, «noi non sappiamo che cosa sia la nostra vita, la nostra morte, Dio e noi stessi».
Figlio di Dio, Egli si è fatto Uomo, passibile e mortale. Attraverso la sua Passione, Morte e
Resurrezione, Egli rende possibile alla persona umana di uscire dalla tenebra del dubbio e
della disperazione per aprirsi alla luce della speranza”.
Il signore dalla barba fluente aveva chiuso gli occhi. Tutti lo guardarono con aria
interrogativa. Egli disse: “Stavo pensando che è innato nello spirito umano il desiderio di
godere per sempre dell’esperienza umana su questa terra, della bellezza che la
impreziosisce, dell’amore che la riscalda. Questo desiderio è bene espresso nei versi del
poeta catalano Joan Naragall. Rivolgendosi a Dio dice:
Se il mondo è tanto bello; se si specchia
la tua pace nei nostri occhi, tu
potrai darci di più in un’altra vita?
Perciò ci tengo tanto, Signore, agli occhi,
al volto, al corpo che m'hai dato e al cuore
che vi batte; e perciò temo la morte.
L’irruzione della morte attraverso la scomparsa di persone significative fa vacillare
la possibilità di realizzare il desiderio di rimanere su questa terra per sempre. E allora vi è
15una risposta nichilista che porta a credere che tutto finirà con la morte. Accanto ad essa
però, ne fiorisce anche una che proclama la continuità della vita, con la prospettiva della
fede così espressa dallo stesso poeta:
E quando verrà l’ora del timore,
che chiuderà questi miei occhi umani,
aprimene Signore altri più grandi,
per contemplare l’immensa tua pace,
e la morte mi sia un più grande nascere.
“Il vedere la morte nella prospettiva della fede – disse la signora dalla voce pacata –
non solo ha un valore terapeutico, ma imprime anche un senso più ricco a quanto è
compiuto attraverso i gesti dell’assistenza per togliere la persona del morente dalla sua
solitudine”. “Non è forse vero?” aggiunse guardando il gruppo.
Era già trascorso molto tempo, per cui i miei amici mostravano il desiderio di
andarsene. Li ringraziai per il prezioso aiuto che mi avevano prestato. Prima di partire
però, la ragazza dagli occhi celesti volle aggiungere ancora qualcosa. “Qualche tempo fa –
ella disse – è apparsa sui giornali una notizia curiosa, alcuni medici statunitensi hanno
identificato una nuova malattia chiamandola Season Affective Disorder, cioè Disordine
Affettivo Stagionale. Questa malattia consiste in una specie di depressione dovuta al calo
della luce, soprattutto in quei paesi che sono meno esposti al sole, oppure in quegli
ambienti di lavoro o di vita privi della necessaria illuminazione. La terapia suggerita dagli
esperti è la Light Therapy, cioè la terapia della luce. Pensando a quella notizia e
collegandolo al tema da noi trattato, mi è venuto naturale – ella disse – associare la
condizione della sofferenza e della morte nelle sue varie espressioni, alla stagione priva di
sufficiente luce. Quando la persona è colpita da malessere fisico, psichico o spirituale e si
approssima alla morte, si trova in una situazione di oscurità. Infatti i sociologi e gli
antropologi qualificano la malattia, la sofferenza e la morte come la «dimensione notturna»
della vita, mentre attribuiscono agli aspetti del vivere umano quale la giovinezza, la
vitalità, la forza, un carattere più luminoso”.
Poi concluse con un sorriso: “Perché non impegnarci tutti, comunità ecclesiale,
uomini di buona volontà, per produrre autentiche espressioni della terapia della luce in
favore di quanti si trovano nell’oscurità, causata dall’avvicinarsi della morte? Una luce che
illumina riscalda, una luce che è mediazione dell’amore tenero e misericordioso del
Signore”.
Sull’onda di queste parole, i miei amici si congedarono e anch’io mi congedo da voi,
ripetendo quanto appare nell’introduzione di un libro famoso, il Tractatus Logico-
philosoficus di Ludwig Wittgenstein: «Il mio volume consta di due parti. La prima è
costituita da ciò che ho scritto, la seconda da ciò che non ho scritto. Questa seconda parte è
la più importante».
Proprio così. Lo scopo di questa relazione sugli atteggiamenti della nostra cultura
nei confronti della morte non era quella di dire cose definitive, quanto piuttosto quella di
suggerire spunti capaci di stimolare la riflessione, di invitare ad un approfondimento, in
vista di un costante impegno per aiutare chi passa all’altra vita.
16Seconda relazione:
LA LUCE NELLA SERA.
LA CURA DEL MORENTE COME PROBLEMA DI BIOETICA.
D.ssa Roberta Sala*
Il titolo della relazione che mi è stato proposto è il seguente: La luce nella sera: la
cura del morente come problema di bioetica. In realtà, parlare della morte anche come
problema di bioetica significa fare riferimento a questioni in cui la morte è a volte cercata,
a volte procurata, in generale rifiutata come esperienza umana. In questa relazione non mi
soffermerò sul valore dell’accompagnamento del morente e su quello delle cure palliative
perché credo che di questo parlerà il professor don Renzo Pegoraro, che mi seguirà.
Eutanasia e accanimento terapeutico, temi centrali all’interno del dibattito bioetico
sul quale intendo soffermarmi, sono nozioni assai lontane dalla cultura cristiana e dal
valore della vicinanza ai morenti, dall’atteggiamento di cura, di fratellanza e di carità che
sono invece espressione dell’accompagnamento alla morte nel rispetto di coloro che
muoiono.
Vediamo ora le ragioni di questa lunga premessa. La bioetica può essere intesa
come la riflessione morale sulle questioni proprie della medicina, nate all’interno delle
pratiche mediche, in un contesto e in un periodo ben precisi; la nascita della bioetica si fa
risalire agli inizi degli anni Settanta, quando cioè cominciarono a delinearsi molte
alternative di cura, in particolare molte forme di sostegno vitale alle persone morenti ed
anche, questione eticamente più complessa, agli individui in stato vegetativo permanente.
Si ricorda spesso un evento, accaduto alla fine degli anni Sessanta, noto come il caso
dell’ospedale di Seattle, che stimolò la riflessione etica: si trattava di decidere chi
assegnare alla terapia dialitica, avendo un’unica macchina a disposizione e più malati in
attesa di cure.
In generale, la bioetica si impone come ambito di riflessione su quei problemi
suscitati dal continuo progresso delle tecnologie in ambito medico, sia per la difficoltà di
stabilire a priori il confine del loro utilizzo, sia per quella di stabilirne i possibili fruitori. Si
tratta, evidentemente, non solo di interrogativi medici ma anche, precisamente, di domande
morali, alle quali devono essere date risposte non tecniche bensì morali. Nello specifico, si
tratta di decidere che fare dei morenti, che fare delle persone non morenti ma che versano
in situazioni gravi, come gli stati vegetativi, persone che soffrono di malattie degenerative
del sistema nervoso e che rischiano di perdere qualsiasi capacità decisionale.
*
Laureata in Filosofia e Dottore in Bioetica, è Docente di bioetica presso la Facoltà di Psicologia
dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, e di etica infermieristica presso il Corso di Laurea
in Infermieristica nella stessa Università.
17«Che fare?» è la domanda centrale, ed è una domanda squisitamente morale. Il
problema è decidere, a volte ancor prima di definire le rispettive posizioni, i vari valori in
gioco, e farlo con urgenza. Significa dover decidere in condizioni di incertezza: non è
semplice decidere quando non sono chiare o prevedibili le alternative, quando non si
conoscono le possibilità di successo di questi nuovi trattamenti, di queste nuove tecnologie
impiegate per la cura. Non è semplice decidere anche per la presenza di conflitti di valori
ed anche per la conflittualità dei modi di pensare propri delle differenti professioni. Ogni
soggetto agente porta con sé la propria scala di valori, ispirati a diverse concezioni del
bene e della vita buona, a diverse opinioni su ciò che è giusto e che perciò deve essere
perseguito e ciò che è invece sbagliato e va dunque evitato.
Veniamo quindi al problema bioetico della morte e del suo trattamento.
La morte è diventata un problema di bioetica: ciò significa che non si muore più
come un tempo bensì nei modi diversi resi disponibili dall’impiego delle tecnologie. La
morte diventa un problema bioetico nella misura in cui l’impiego di nuovi mezzi riesce
persino ad interferire con la morte o, almeno, con il processo del morire, certamente con il
valore che intendiamo conferire alla sofferenza.
Qui vorrei ritornare ad alcune considerazioni di Padre Brusco quando poco fa
accennava alla paura della morte, anzi all’angoscia della morte. Le enormi potenzialità che
la tecnologia pone nelle mani dei medici, dei tecnici, in genere di tutti gli ‘operatori’ delle
cure, rispondono in un certo senso allo sforzo di fare dell’angoscia della morte una più
controllabile paura. Si cerca di controllare l’angoscia che l’idea della propria morte
suscita in ciascuno di noi convertendola in paura, ovvero in un sentimento nei confronti di
qualcosa di determinato e non già nei confronti dell’ignoto che la morte comporta. Si
finisce per parlare della morte degli altri, mai della propria morte, anzi della morte di
persone che non si conoscono, della morte come di un concetto astratto, che sfugge di per
sé alla realtà.
La medicina cerca quasi di controllare la morte, il suo accadere, la riconduce quasi
a una malattia che si illude di curare e guarire. In questo modo, come si diceva, della morte
si può avere paura, e tuttavia confidare nell’esistenza di mezzi utili a dominarla, ad
addolcirla, ad addomesticarla. La paura in qualche modo si affronta, si gestisce, l’angoscia
no perché rimane una domanda aperta cui non bastano risposte tecniche, quelle che la
medicina è in grado di fornire. In questo modo si fa della morte una parte della vita senza
riuscire a darle il significato di esperienza della vita; se ne fa un momento che si possa
prevedere o addirittura prevenire.
Come si rende più tollerabile la morte? Come facciamo a sottrarla a questa
indefinitezza, a questa indeterminatezza per ricondurla all’interno delle pratiche della cura?
Come fa la medicina con le sue possibilità terapeutiche ad offrire un’immagine più
tollerabile della morte?
Cerca di negarla, anticipandola oppure posticipandola. La morte è anticipata,
quando viene invocata l’eutanasia, oppure è posticipata (o ci si illude di posticiparla),
attraverso l’accanimento terapeutico. Sia l’una sia l’altra delle pratiche sono in realtà due
facce della stessa mentalità che nega la morte, o quanto meno che ne nega una positività,
18anzi che ne nega il suo essere esperienza esistenziale. In entrambi i casi, infine, si ha l’idea
di poterla gestire a proprio piacimento.
Al fondo di questa mentalità c’è proprio l’angoscia della morte che anche la
medicina incarna. La medicina tecnologica è abitata da queste illusioni di gestire la morte,
anzi di sconfiggerla, anche nel momento in cui sembra rassegnarsi al suo accadimento. Lo
stesso abbandono terapeutico esprime quest’illusione della medicina: essa tace quando non
sa più dare risposte tecniche. Colpa della medicina è quella di suscitare delle illusioni, di
fare delle promesse senza essere in grado di mantenerle, promesse – addirittura – di
immortalità.
Si nutrono oggi, nei confronti della medicina, grandi aspettative, quasi che essa
possieda un “potere magico” oltre che terapeutico. Si pensi all’esperienza di coloro che
sono in attesa di un organo; a volte l’enorme speranza riposta nei confronti del potere
medico non è equamente bilanciata con la consapevolezza della scarsità degli organi e
della difficoltà di reperirne in misura a sufficienza per poter soddisfare i bisogni di tutti.
Cerchiamo allora di vedere di che parliamo quando parliamo di eutanasia. Si diceva
che fare eutanasia significa anticipare la morte, più precisamente significa porre
deliberatamente fine ad una vita, sulla base della considerazione che tale vita sembra ormai
priva di qualità, o comunque quando il soggetto sembra condannato ad inutili sofferenze
fisiche e psicologiche. In quest’ottica l’eutanasia è considerata la via più dignitosa di
morire. Ciò implica una particolare concezione della dignità: dignità significherebbe
decidere, anzi poter decidere, di sé, della propria vita e della propria morte, dignità
significherebbe insomma viversi come soggetti autonomi, considerare la propria
autonomia come il massimo valore della propria esistenza. Con ciò, naturalmente, non
abbiamo chiarito affatto se l’essere umano possa dirsi realmente e completamente
autonomo o meno.
Possiamo dire che l’eutanasia esprima il convincimento, o la tentazione, di
dominare la morte, eutanasia significa affermare il diritto di morire, di dare seguito in
questo modo al volere assoluto del soggetto di decidere il momento della sua morte, per
sue proprie ragioni. L’eutanasia in cui prevale il volere del singolo e il suo diritto di
controllare la propria morte è detta volontaria: si tratta di una richiesta esplicita di essere
aiutati a morire. Il problema più grave si presenta quando si ha a che fare con soggetti che
non esprimono alcuna volontà in ordine alla propria morte; si tratta di quei casi in cui è
venuta meno la capacità di esprimere la propria volontà, di chiedere qualcosa. Il tipo di
eutanasia in questo caso è quella non volontaria, ed è decisa da altri sulla base di due
fondamentali considerazioni: si decide in base alla ipotetica volontà del soggetto, quella
che avrebbe manifestato in vita se avesse potuto farlo, oppure si decide in base alla
considerazione che, per certi individui in certe condizioni, è meglio morire che continuare
a vivere. In quest’ultimo caso si persegue una nozione di vita buona o, meglio, di qualità
buona di vita, che si pretende valga per tutti.
Ma noi già qua ci possiamo immaginare le conseguenze possibili di una tale
mentalità, di un tale atteggiamento. Noi decidiamo della morte di altri, non potendo
costoro decidere della propria: ma alla luce di quali criteri decidiamo della loro morte? Si
19corre il rischio di affermare criteri del tutto arbitrari di dignità, criteri del tutto soggettivi e
discutibili. Come si decide, infatti, della morte degli altri? Come si fa a decidere di
anticipare il momento della loro morte? Si finisce per nutrire il sospetto che si finisca per
adottare criteri comuni, veicolati dalla società. Il punto è che la società attuale non sembra
“scusare” la malattia, la sofferenza, ed ancora meno sembra “scusare” coloro che chiedono
di essere curati, di ricevere cure costose, a fronte di pochissime probabilità di tornare a
vivere con “dignità”. La società sembra disposta ad adottare criteri che non tengono in
dovuto conto il bene reale della persona. Si invoca in realtà il bene delle persone, senza
essere in grado di dire di che bene si tratta. Coloro che sostengono questa posizione
vengono definiti genericamente utilitaristi: secondo loro l’eutanasia serve per il bene della
persona che soffre, quindi l’atto eutanasico è richiesto al fine di procurare il suo bene. In
quest’ottica il bene corrisponde all’interruzione della vita e alla cessazione della sofferenza
che rende tale vita priva di dignità.
Le precedenti affermazioni sembrano eccessive; tuttavia non dobbiamo
sottovalutare casi in cui l’eutanasia è effettuata anche se in modo poco evidente. Pensiamo
ai casi di quei familiari che “staccano la spina” ai loro cari; a volte si parla di forme di
eutanasia passiva – intendendo erroneamente indicare casi di legittima sospensione delle
cure inutili – senza tenere conto che di eutanasia si tratta comunque, ovvero di interruzione
della vita delle persone, ancorché attraverso una omissione di una terapia o di un
trattamento e non attraverso un’azione posta in essere al preciso scopo di togliere la vita,
come il fare un’iniezione letale o il somministrare veleno. A volte si sospendono cure
ancora inutili per continuare a vivere ma non si parla di eutanasia. È chiaro che, nei casi di
confine, la distinzione tra eutanasia e rifiuto delle cure inutili è molto difficile da indicare
concretamente, per quanto sia astrattamente semplice da definire. Si tratta di casi di ardua
soluzione: a volte neppure i medici sono in grado di stabilire con così grande sicurezza fin
dove ha senso curare le persone e dove invece inizia il momento in cui bisogna
comprendere la morte come l’esito del naturale processo del morire. È davvero difficoltoso
tracciare la linea tra ciò che si presenta come un trattamento inutile, e che in realtà è una
forma di accanimento, e quello che invece, al contrario, si configura come un trattamento
che chiunque continuerebbe a somministrare.
Della distinzione teorica tra eutanasia e sospensione delle cure inutili parlò già nel
1957 Pio XII; tale distinzione venne ripresa nella Dichiarazione della Congregazione per
la Dottrina della Fede sull’eutanasia del 1980; in essa si dice appunto che “il giudizio
della bontà o meno dei trattamenti viene formulato mettendo a confronto il tipo di terapia,
il grado di difficoltà, il rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di
applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni del
malato e delle sue forze fisiche e morali”. Si parla di giudizio di proporzionalità, così detto
proprio perché non è ricavato da un algoritmo ma va formulato sempre nel caso
particolare, in base alle caratteristiche del singolo paziente.
Vediamo ora alcune considerazioni contrarie all’eutanasia. Un argomento
importante è quello teologico: la vita è dono di Dio, dunque non è a nostra disposizione,
non è affidata al nostro volere. Benché siamo soggetti liberi, autonomi, desiderosi di
20alcune cose per noi e per gli altri, noi non siamo proprietari della nostra vita, ma ne siamo
soltanto i custodi.
Contrari sono anche coloro che ragionano in un’ottica medico-deontologica, e che si
appellano al giuramento di Ippocrate, il giuramento che i medici fanno prima di
intraprendere la loro attività professionale, dove si dice “non porrai mai fine alla vita dei
tuoi malati”.
E poi ci sono anche altre due considerazioni, direi interessanti, almeno in questo
dibattito. Chi è contrario ancora all’eutanasia? In un’ottica che viene definita
comunitarista, i contrari all’eutanasia la considerano espressione di una mentalità di
negazione della morte, esito di una società in cui tutto, anche la morte, è frutto di scelta. Il
punto è che la morte non è né può essere una scelta, la morte è tutt’al più un’esperienza.
Dice Callahan che occorre ritrovare il senso della morte come morte umana; occorre quindi
ritrovare la collocazione dei morenti dentro una comunità umana. Callahan non fa
riferimento alla comunità dei cristiani, ma in generale alla comunità umana, in cui gli
individui sono collegati tra loro da relazioni, da valori, dalla condivisione di sentimenti ed
emozioni, da una certa concezione del bene del singolo ma, ancor prima, di tutta la
comunità. In questa comunità i morenti hanno un loro ruolo, una loro dignità che tutti gli
altri sono disposti a riconoscere loro, ma anche a se stessi come un’occasione per
riscoprire un proprio valore.
In quest’ottica di società buona, la morte è una delle tante esperienze della vita.
Quella comunitarista è un’ottica che combatte le illusioni della medicina contemporanea e
che arriva a dire che essa deve porsi dei limiti, in primo luogo deve evitare di sperperare le
sue risorse per nutrire illusioni e impiegarle piuttosto per far fronte a malattie più diffuse e
che spesso le persone meno abbienti non sono in grado di procurarsi. Si tratta di attuare
una sorta di rivoluzione ‘umana’ dove ogni esperienza ha un suo senso umano e una sua
collocazione nell’esistenza delle persone.
Altra considerazione, di tipo più utilitaristico, è quella che esprime una contrarietà
nei confronti dell’eutanasia, delineando più precisamente le ragioni contro una sua
eventuale legalizzazione. Alcuni paesi in Europa già hanno una legge sull’eutanasia tra cui,
come è noto, l’Olanda. Per quanto questa legge fissi delle condizioni precise per poter
ricorrere all’eutanasia, è lo spirito della legge che lascia tanti nodi irrisolti. La domanda è
di fondo: se esistesse una legge sull’eutanasia, che tipo di vissuto potrebbe colpire chi
decide di continuare a chiedere le cure, benché inutili al fine di godere di una vita
qualitativamente degna? I morenti finirebbero per sentirsi “fuori posto” solo perché
ritengono di avere il diritto di essere curati. Si potrebbe creare una mentalità che invita le
persone a togliere il disturbo, e che vedrebbe esclusi coloro che non vogliono togliere il
disturbo e che non considerano la loro vita un disturbo ma una ricchezza per gli altri.
Essere contrari all’eutanasia significa in questo essere contrari agli effetti della sua
legalizzazione: effetti di discriminazione, di disumanizzazione, di perdita della morte.
Queste sono le cose che io intendevo dire illustrando brevemente un panorama
bioetico.
Ho trascurato appositamente di ampliare il discorso su quella che invece è la luce
della sera, la luce che è data dall’assistenza ai morenti, dal loro accompagnamento, dalle
21Puoi anche leggere