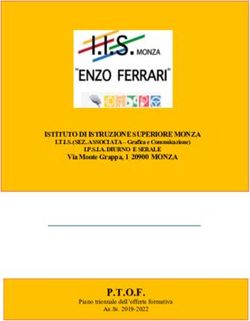LICEO GINNASIO STATALE "G. B. BODONI" E SEZ. ANNESSA LICEO SCIENTIFICO SALUZZO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI A.S. 2019/2020 ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BODONI”
E SEZ. ANNESSA LICEO SCIENTIFICO
SALUZZO
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI
DEL CORSO DI STUDI
A.S. 2019/2020
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO
DELLA CLASSE 5^C
LICEO SCIENTIFICO
DELLE SCIENZE APPLICATE
Saluzzo, 30 maggio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenzo RubiniLICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
2LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
INDICE
1. PROFILO DELL’INDIRIZZO ………………………………………………………………………. p. 4
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE …………………………………………………………….. p. 5
2.1 Elenco dei candidati ………………………………………………………………………………. P. 5
2.2 Relazione sulla classe …………………………………………………………………………….. p. 5
2.3 Evoluzione della classe nel triennio ………………………………………………………. P. 6
2.4 Insegnanti del triennio …………………………………………………………………………… p. 6
2.5 Commissari interni ………………………………………………………………………………… p. 7
3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA ………………………… P. 8
3.1 Obiettivi formativi …………………………………………………………………………………. p. 8
3.2 Obiettivi cognitivi ………………………………………………………………………….………. p. 8
3.3 Metodologie e strategie didattiche ……………………………………………………….. p. 9
3.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento …………………………………………… p. 9
3.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ALS) ……… P. 9
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, INIZIATIVE COMPLEMENTARI E
INTEGRATIVE …………………………………………………………………………… P. 11
4.1 Attività di recupero ……………………………………………………………………………………… p. 11
4.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” …………………….. p. 11
4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa …………………………………. P. 12
4.4 Viaggi di istruzione …………………………………………………………………………………….. p. 13
4.5 Percorsi interdisciplinari ……………………………………………………………………………… p. 13
5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME ………………………………………. P 14
6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE ………………………………………………………. P. 14
6.1 Colloquio …………………………………………………………………………………………………. p. 14
7. SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE ……. P. 16
7.1 Italiano ……………………………………………………………………………………………………. p. 16
7.2 Inglese ………………………………………………………………………………………………….… p. 20
7.3 Storia ………………………………………………………………………………………………….…… p. 23
7.4 Filosofia ……………………………………………………………………………………………….….. p. 26
7.5 Matematica ………………………………………………………………………………………….……p. 29
7.6 Fisica ………………………………………………………………………………………………….………p. 32
7.7 Scienze naturali …………………………………………………………………………………………p. 35
7.8 Chimica e Laboratorio ……………………………………………………………………………… p. 38
7.9 Informatica ……………………………………………………………………………………………… p. 42
7.10 Disegno e Storia dell’arte …………………………………………………………………………p. 45
7.11 Scienze Motorie e Sportive……………………………………………………………………… p. 48
7.12 Religione ………………………………………………………………………………………………….. p. 50
8. IL CONSIGLIO DI CLASSE …………………………………………………………..P. 52
3LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
1. PROFILO DELL’INDIRIZZO
Il Liceo delle Scienze Applicate offre una formazione in cui sono collegati teoria e laboratorio,
conoscenza e sperimentazione. Ciò è reso possibile dalla dotazione dei laboratori attrezzati di
cui la Scuola dispone e dalla copresenza dei docenti e di tecnici per l’insegnamento di Fisica,
di Chimica e di Informatica in laboratorio.
L'intero corso di studi è mirato a far acquisire allo studente:
- una solida preparazione generale (scientifica, storico-filosofica, linguistica) di livello liceale,
capace di avviare i diplomati ad affrontare con consapevolezza una formazione universitaria nei
settori più moderni del sapere;
- un’articolata cultura scientifica teorica;
- competenze informatiche, intese come strumento di sviluppo del rigore logico;
- una consapevolezza critica dei processi di interazione fra le due culture, quella scientifica e
quella umanistica;
- una formazione in cui sono collegati teoria e laboratorio, conoscenza e sperimentazione,
grazie alla dotazione di laboratori e alla copresenza di due insegnanti nelle discipline
scientifiche
ORARIO DI INSEGNAMENTO
LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE
MATERIE 1 Sc.ap. 2 Sc.ap. 3 Sc.ap. 4 Sc.ap. 5 Sc.ap.
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze Naturali 3 2 2 2 2
Chimica e laboratorio 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o Attiv. al-
1 1 1 1 1
ternativa
Numero ore complessivo 27 27 30 30 30
4LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1 ELENCO DEI CANDIDATI
L’elenco cartaceo dei candidati viene allegato alla documentazione consegnata alla
commissione d’esame
2.2 RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe 5^C è composta da un gruppo di 21 allievi (6 ragazze e 15 ragazzi), frequentanti il
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
Come dimostrano le tabelle sulle variazioni numeriche degli studenti, nel corso del terzo anno
tre studenti non sono stati ammessi alla classe successiva, mentre nel quarto e quinto anno
due studenti si sono aggiunti al gruppo originario. Inoltre nel corso del quarto anno uno
studente della classe ha frequentato il secondo pentamestre presso l’istituzione scolastica
“PEM High School” di Plainview – Minnesota – USA, riportando buoni risultati sul piano del
profitto e dell’esperienza culturale e umana.
Nell’insieme la classe presenta un profitto più che discreto, pur nella naturale varietà di
interesse, applicazione e partecipazione. Un certo numero di allievi denota apprezzabili
capacità che ha saputo adeguatamente sfruttare realizzando un proficuo metodo di lavoro.
Questi studenti hanno lavorato con serietà e impegno costanti partecipando al dialogo
scolastico in modo positivo e raggiungendo risultati nel complesso decisamente più che buoni.
Altri alunni, invece, non hanno saputo tradurre in uno studio ed in una rielaborazione personale
efficaci la loro partecipazione alle attività in classe. Per questi alunni i risultati sono nel
complesso discreti. Alcuni allievi, infine, hanno evidenziato difficoltà nel mantenere constante
l’impegno nello studio, tale da determinare risultati modesti.
Negli anni scolastici passati la frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, come pure
durante l’attuale a.s., fino alla forzata interruzione delle attività didattiche in presenza. Si deve
segnalare a questo proposito un’eccezione costituita da un allievo (proveniente da altro istituto
e inserito nella classe 5^C all’inizio del presente a.s), che già entro il periodo antecedente la
sospensione della didattica in presenza aveva accumulato moltissimi giorni di assenza (per
problemi personali e familiari, senza documentazione).
Con l’introduzione della didattica a distanza docenti e allievi hanno cercato di elaborare
differenti strategie di insegnamento e studio, ricorrendo alle piattaforme di e-learning già
utilizzate nel nostro Istituto (Moodle) e attivandone altre specifiche per le videolezioni (Zoom,
Nimbus Screenshot, e altre) e per la valutazione del percorso didattico. E’ stato un
adattamento a volte faticoso, che ha comportato un cambiamento di abitudini di vita, lavoro e
studio non indifferente, ma che è stato affrontato con impegno da parte di tutta la comunità
scolastica, con riscontri – nel caso della maggior parte degli allievi - soddisfacenti sul piano
formativo e della valutazione.
5LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
2.3 EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
Anno Class Inizio anno Fine anno
Scolastico e
da classe Promossi Non ammessi alla classe
precedente successiva
Senza Con
sospensione sospensione
del giudizio del giudizio
(a Giugno) (a settembre)
2017/18 3^C 22 18 1 3(1)
2018/19 4^C 20(2) 19(3) 1 0
2019/20 5^C 21(4)
(1) Di cui uno non scrutinato per non avere frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato (ex art.14 c.7 DPR 122/09).
(2) Nell’a.s. 2018-19 si è aggiunto alla classe un allievo proveniente da altro istituto
(3) Nell’a.s. 2018-19 uno studente ha frequentato il secondo pentamestre presso l’istituzione
scolastica straniera “PEM High School” di Plainview – Minnesota – USA.
(4) Nell’a.s. 2019-20 si è aggiunto alla classe uno studente proveniente da altro istituto.
2.4 INSEGNANTI DEL TRIENNIO
Discipline Classe Terza – Classe Quarta – Classe Quinta –
A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20
Italiano LOVOTTI Fulvia LOVOTTI Fulvia LOVOTTI Fulvia
Inglese QUAGLIA Marisa QUAGLIA Marisa QUAGLIA Marisa
Storia POPOLLA Fabio POPOLLA Fabio POPOLLA Fabio
Filosofia POPOLLA Fabio POPOLLA Fabio POPOLLA Fabio
Matematica MONGE Stefania MONGE Stefania MONGE Stefania
Fisica BARBERO Fabrizio BARBERO Fabrizio MAZZARI Alberto
Scienze IOIME Patrizia BORSOTTO Monica BORSOTTO Monica
Chimica e laboratorio BORSOTTO Monica GONELLA Graziana GONELLA Graziana
Informatica BONAVIA Marco GRECO Pietro GALFRE’ Elena
Disegno e Storia dell’Arte ASVISIO ELISA ASVISIO Elisa ASVISIO Elisa
Religione CASSANO Anna CASSANO Anna CASSANO Anna
Ed. Fisica TIBLE Luisella TIBLE Luisella SABENA Renato
6LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
2.5 COMMISSARI INTERNI
Discipline Commissario
Matematica / Fisica MAZZARI Alberto
Italiano LOVOTTI Fulvia
Storia dell’Arte ASVISIO Elisa
Inglese QUAGLIA Marisa
Scienze Naturali e Chimica GONELLA Graziana
Filosofia / Storia POPOLLA Fabio
7LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA
3.1 Obiettivi formativi
Obiettivo primario della scuola è assicurare agli studenti un percorso formativo in cui ciascuno
possa sviluppare le proprie potenzialità e la propria personalità, partecipando in modo
consapevole all’attività educativa. A tale scopo questa istituzione scolastica si propone di:
- evitare la dispersione scolastica con interventi seri, adeguati e tempestivi di prevenzione,
recupero e controllo;
- garantire la continuità educativa tra la scuola media e il biennio e tra il biennio e il triennio;
- promuovere un adeguato orientamento nei confronti delle scelte universitarie;
- promuovere ogni forma di partecipazione attraverso un’informazione completa e
trasparente;
- operare in una dimensione interdisciplinare, ponendo ogni componente dell’istituzione
scolastica in relazione alle altre al servizio della maturazione personale dell’alunno;
- favorire forme di attività extrascolastica capaci di contribuire alla realizzazione della
promozione culturale, sociale e civile degli studenti;
- rispettare razionali tempi di studi degli alunni nell’assegnazione dei lavori domestici, in
coerenza con la programmazione didattico-educativa del Consiglio di Classe;
- realizzare un processo educativo nell’assoluto rispetto della personalità di tutti gli alunni.
3.2 Obiettivi cognitivi
- Sviluppo della capacità di analisi e di sintesi mediante l’acquisizione di un metodo di studio
proficuo e autonomo
- Acquisizione della capacità di decodificare i messaggi che provengono dal mondo della
cultura, dell’arte, della scienza e dell’informazione
- Acquisizione di una reale capacità di utilizzare il codice linguistico, pianificando gli interventi
in rapporto agli specifici obiettivi comunicativi
- Acquisizione delle basi e degli strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva
delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle società umane
- Sviluppo delle capacità logico-sequenziali
- Sviluppo della sensibilità estetica
Il Consiglio di Classe ha cercato di declinare gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze
e capacità nel seguente modo:
Conoscenze:
conoscere i dati fondamentali e i concetti essenziali desumibili da testi letterari in lingua
italiana e straniera, testi storici e filosofici, opere artistiche, formule, teoremi, ecc.
Competenze:
applicare le conoscenze teoriche a livello individuale, dando prova di saper interpretare i
testi, risolvere un problema secondo i modelli forniti dal docente.
Capacità:
- analitica: individuare e cogliere gli elementi che permettono collegamenti
pluridisciplinari;
- sintetica: pervenire a un modello unitario che aggreghi elementi dei singoli percorsi
disciplinari o pluridisciplinari;
8LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
- critica: sapere individuare i limiti e i problemi aperti emersi da quanto appreso al fine di
indicare ulteriori direzioni di ricerca e di approfondimento per elaborare giudizi più
meditati e personali.
3.3 Metodologie e strategie didattiche (metodi, mezzi, spazi, strumenti e
criteri di valutazione, obiettivi raggiunti)
Per questa parte del documento si rimanda in particolare alle schede informative che
introducono il programma analitico delle singole discipline. Non si può, tuttavia, non presentare
le principali linee guida che la nostra scuola ha perseguito da quando – in seguito alla
sospensione della didattica in presenza a partire dalla fine del mese di febbraio – si sono
dovute attivare forme di DAD (didattica a distanza). Innanzi tutto la nostra scuola si è sempre
basata sulle indicazioni contenute nelle note ministeriali e nei decreti governativi (nota MIUR
n.388 del 17-3-2020 e DPCM 4-3-2020 e successivi aggiornamenti) e, in secondo luogo, ha
cercato - nel rispetto dell’autonomia scolastica e di insegnamento - di dotarsi di metodologie e
strumenti didattici adeguati alle esigenze di ciascuna materia. In questa analisi va sottolineato
il lavoro svolto dai Dipartimenti disciplinari, che hanno adeguato le strategie didattiche e
valutative con l’evolversi della situazione di “anomalia” in cui la scuola si è trovata.
Nell’erogazione della DAD, quindi, ciascun insegnante del Consiglio di Classe ha adottato
metodologie ritenute adeguate agli obiettivi da raggiungere, in termini di formazione e
valutazione, sfruttando piattaforme di e-learning già in uso presso l’istituto o altre di propria
conoscenza, attivando forme di audio o videolezione in diretta o registrata, lavorando su varie
tipologie di materiali didattici e cercando di ottenere dagli studenti feedback che potessero
contribuire al processo di valutazione finale. A livello di Consiglio di Classe si è cercato di
distribuire in modo equlibrato il carico didattico.
3.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento
Lo svolgimento dell’attività CLIL in inglese è stata svolta dall’insegnante di Scienze, Prof.ssa
Monica Borsotto (abilitata a questa metodologia) per n.10 ore di lezione, trattando i seguenti
argomenti:
Earth science highlights: Plate tectonics
DNA structure and replication
protein synthesis
Lactose operon
Genetic engineering
3.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ALS)
Tutti gli studenti hanno svolto attività relativa ai PCTO, totalizzando un numero di ore ben
superiore alle 90 previste dalle norme, prima che il Decreto 8-4-2020 derogasse dall'obbligo di
tali attività per l’ammissione all’Esame conclusivo, a causa della situazione generata dalla
pandemia di Coronavirus.
Il regolamento interno della scuola prevede la possibilità che i PCTO si svolgano in due periodi
coincidenti con le vacanze estive del terzo e del quarto anno. I percorsi hanno compreso le
attività di formazione generale e della sicurezza, visite aziendali, stage e corsi collegati.
9LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
Per gli studenti è stata una esperienza didattica e formativa importante che ha permesso loro
di acquisire competenze nella gestione dei rapporti interpersonali e in campo sociale, tecnico,
amministrativo, scientifico, linguistico.
Le esperienze di alternanza scuola – lavoro sono specificate in un documento cartaceo e nelle
relazioni degli studenti allegate al presente documento.
10LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO,
INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
4.1 Attività di recupero
Per gli studenti che presentavano debiti formativi sono stati attivati interventi didattici ed
educativi integrativi attraverso corsi di recupero di gruppo sia in orario scolastico, sia in orario
extrascolastico, e/o sportello didattico per disciplina.
4.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Nell’ambito del progetto attinente a “Cittadinanza e Costituzione” sono stati trattati argomenti
volti all’acquisizione delle sottoelencate competenze:
Capacità di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società, nell'ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione
Saper confrontare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale con la tradizione politico-
giuridica occidentale moderna e contemporanea
Sviluppo di una personale sensibilità alla tolleranza, al pluralismo culturale, ai diritti e ai doveri
del cittadino, in vista di un responsabile inserimento nella società.
Alcuni studenti hanno preso parte al progetto di “Educazione alla legalità”, partecipando ad una
serie di conferenze riguardanti tematiche legate alla presenza delle organizzazioni mafiose
nella società italiana.
Il percorso di “Educazione alla salute” ha affrontato il tema dei rischi da dipendenza da alcool e
sostanze, mentre il progetto “Porgi una mano” ha sensibilizzato i ragazzi sulla donazione del
sangue, del plasma, del midollo e degli organi.
Sono stati attivati corsi di “Educazione stradale” e di “Guida sicura”.
Sono stati trattati i seguenti argomenti dal prof. Popolla, docente di Filosofia e Storia:
La Costituzione Italiana (principi fondamentali e ordinamento dello Stato)
◦ Origine storica della Costituzione repubblicana
◦ I principi fondamentali
◦ L’ordinamento dello Stato.
Unione Europea.
◦ Storia della sua formazione
◦ Istituzioni europee (visita al Parlamento Europeo a Strasburgo)
Elementi di “cittadinanza digitale”. Tutti gli studenti hanno seguito il percorso online
“VIVINTERNET AL MEGLIO” (https://vivinternet.azzurro.it/) attivato da Telefono
Azzurro, Altroconsumo e Google, con l’obiettivo di indicare ai giovani come vivere il Web
responsabilmente, attraverso semplici strumenti per apprendere i principi base di
educazione digitale:
◦ Sviluppare un pensiero critico per affrontare la complessità del Web
◦ Proteggersi da cyberbullismo, frodi e altri rischi online
◦ Riconoscere il valore e l'attendibilità dei contenuti prima di condividerli
◦ Valutare le modalità con cui condividere informazioni
◦ Trattare gli altri con rispetto e gentilezza, nella vita online come nella vita reale
◦ Rispettare e tutelare non solo la propria privacy e la propria reputazione, ma anche
quella altrui
11LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
La prof.ssa Asvisio, docente di Storia dell’Arte, ha approfondito con la classe la legislazione
sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Sono state attivate inoltre dai docenti iniziative di approfondimento sulla pandemia di
Coronavirus attualmente in corso:
Nell’ambito della disciplina di Scienze Naturali, gli studenti hanno svolto un
approfondimento individuale in merito all’epidemia di SARS-CoV-2, analizzando gli
aspetti scientifici, ma anche socio-economici, della stessa, con relazione finale valutata
dall’insegnante, Prof.ssa Borsotto.
Il prof. Cimato (docente di diritto ed economia) è intervenuto con due videolezioni per
illustrare alla classe le conseguenze socio-economiche della pandemia, toccando
anche problematiche già diffuse in ambito europeo (conseguenze della Brexit,
ridefinizione delle funzioni dell’Unione).
4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
Gli studenti hanno partecipato alle attività culturali proposte dalla scuola traendone vantaggi
sia sotto il profilo cognitivo, sia sotto il profilo formativo, intervenendo anche in prima persona
alle iniziative interdisciplinari realizzate nel triennio.
Vanno ricordate le seguenti attività e progetti che hanno coinvolto gli allievi della classe
nell'ultimo triennio:
spettacoli teatrali organizzati dalla scuola;
progetto “cinema di qualità”;
progetto “educazione alla salute”: sensibilizzazione sui rischi da dipendenza, dalle
malattie sessualmente trasmissibili, sulla donazione di organi, sangue e midollo.
Progetti “Guida sicura” ed “Educazione stradale”
Progetto “imbookiamoci”
corsi in preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese (FIRST) con
conseguente superamento dei suddetti esami (Dipartimento di Lingua);
esami per il conseguimento della patente europea del computer (ECDL);
seminari e convegni organizzati dalla scuola;
Partecipazione Premio “Cherasco Storia”
Concorso di storia contemporanea del Consiglio Regionale del Piemonte
Convegno e mostra a cherasco: Picasso e la sua eredita' nell'arte italiana
Partecipazione ai week end del Fai come “Apprendisti Ciceroni” al Castello della Manta
Visita al Castello di Rivoli ed attività di laboratorio a tema “arte e supermarket”
progetto Pon: Cambridge Student Experience;
olimpiadi di matematica, scienze naturali, chimica, informatica;
progetto Politecnico: corso in preparazione al test per il Politecnico (Dipartimento di
Matematica e Fisica);
corso di scacchi e partecipazione ai campionati nazionali;
attività di orientamento;
interventi didattici educativi ed integrativi;
gare sportive;
12LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
4.4 Viaggi di istruzione
III anno: Bologna, Parma e Piacenza.
IV anno: Roma.
V anno: Friburgo – Strasburgo (Parlamento Europeo) - Colmar e Linea Maginot
4.5 Percorsi interdisciplinari
ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE
Magnetismo Fisica, Scienze
Applicazione di limiti, derivate e integrali nella Matematica, Fisica
risoluzione dei problemi di fisica
Romanticismo Italiano, Storia dell’arte, Filosofia
Secondo ottocento Italiano, Storia dell’arte, Filosofia, Inglese
Estetismo Italiano, Inglese
Primo novecento Italiano, Storia dell’arte, Filosofia, Inglese,
Storia
13LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME
E’ stata effettuata una simulazione di prima prova scritta (Italiano) in data 7 febbraio 2020
- Tempo assegnato: 5 ore
6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
6.1 PROVA UNICA. COLLOQUIO
Griglia di valutazione del colloquio (Allegato B all’O.M. N. 10 del 16-5-2020)
Vedi pagina seguente
14LICEO GINNASIO STATALE “G.B. BODONI” CLASSE V C
157. SCHEDA INFORMATIVA
RELATIVA ALLE SINGOLE DISCIPLINE
CON PROGRAMMA ANALITICO
7.1 ITALIANO
INSEGNANTE: Lovotti Fulvia
LIBRO DI TESTO: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 4;
Giacomo Leopardi; 5; 6, Ed. Paravia.
D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso (edizione in possesso dei singoli alunni).
1. Macroargomenti/moduli svolti:
Il Romanticismo. I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione; il
contrasto io-mondo; il tempo e lo spazio; la concezione dell’arte e della letteratura. I
caratteri del Romanticismo italiano.
La Scapigliatura; la figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà sociale del
secondo Ottocento.
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: la poetica e i contenuti.
Il Decadentismo: la visione del mondo; la poetica; temi e miti della letteratura
decadente.
Le poetiche del primo Novecento: Futurismo, Crepuscolarismo e Ermetismo,
caratteri e temi (argomento trattato in Didattica a Distanza).
2. Altre discipline coinvolte:
Inglese; Storia; Filosofia.
3. Obiettivi formativi e didattici:
Conoscenze
conoscere le strutture della lingua e le caratteristiche delle diverse tipologie testuali
conoscere lo sviluppo della storia letteraria e i principali movimenti culturali
conoscere le linee portanti della biografia e della poetica degli autori dell’Ottocento e del
primo Novecento
Competenze
saper esporre oralmente le conoscenze acquisite, attraverso un discorso coerente e
coeso
saper analizzare e commentare un testo, individuando gli elementi stilistico-retorici
sapere riconoscere, in un testo, tracce del clima in cui è stato prodotto e dell’esperienza
umana e letteraria dell’autore
sapere produrre elaborati scritti, applicando le norme delle diverse tipologie testuali
Capacità
comprendere e rielaborare i contenuti disciplinari trattati
argomentare opportunamente le proprie tesi, supportandole con adeguati argomenti
Metodi
4. Metodi
La spiegazione degli argomenti oggetto di studio è stata condotta attraverso lezioni frontali;
si è utilizzato un metodo di tipo deduttivo, partendo dal contesto storico-culturale per
arrivare al movimento letterario o all’autore e ritrovare, nello specifico dei testi, esempi di
quanto esposto a livello teorico, anche attraverso l’apporto di altre discipline.
13La presentazione dei testi è stata effettuata in modo sistematico, cercando di favorire negli
alunni l’acquisizione di un modello interpretativo. La sospensione delle attività in presenza, a
seguito dell’emergenza sanitaria, ha reso necessario il ricorso a audiolezioni e videolezioni,
nelle quali, per quanto possibile, si è mantenuta l’impostazione del lavoro cui gli alunni
erano abituati in aula.
5. Strumenti
Libri di testo; altri volumi; dizionari; audio e videolezioni (piattaforme Moodle e
Zoom).
6. Spazi
Aula
7. Tipologie delle prove di verifica utilizzate per la valutazione:
verifiche orali (anche a distanza)
tema (in presenza)
analisi di testi (anche a distanza)
quesiti a risposta singola (in presenza)
quesiti a risposta multipla (in presenza)
8. Criterio di sufficienza adottato (nelle prove orali e nelle prove scritte):
nelle valutazioni dell’orale, per il raggiungimento della sufficienza sono state richieste
conoscenza di base e comprensione dei dati, correttezza nell’interpretazione dei testi,
utilizzo di un linguaggio appropriato.
Nelle valutazioni delle verifiche scritte, sono stati considerati sufficienti gli elaborati
aderenti alle indicazioni fornite nelle consegne delle differenti tipologie testuali,
basati su documentazione corretta, privi di gravi errori di morfosintassi, ortografia,
lessico.
PROGRAMMA D’ESAME
Argomenti svolti in presenza:
Giacomo Leopardi: profilo biografico. Le coordinate del pensiero leopardiano: la
teoria del piacere; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico. La poetica del vago e
dell’indefinito. Il rapporto con il Romanticismo.
Lo Zibaldone: La teoria del piacere (165-172, fino alla riga 35); Teoria della visione
(1744-1747); La doppia visione (4418); La rimembranza (4426).
I Canti: struttura e titolo; le canzoni civili; gli Idilli; i canti pisano-recanatesi; l’ultima
stagione della poesia leopardiana.
L’infinito; La sera del dì di festa; Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il
sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-86; 158-
201; 297-317.
Le Operette morali.
Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e di un amico; Cantico del
gallo silvestre; Dialogo d’Ercole e di Atlante.
E. Praga: la poetica degli Scapigliati.
Penombre: Preludio.
14Giovanni Verga: profilo biografico. L’approdo al Verismo: la “conversione”,
l’ideologia e la tecnica narrativa.
Vita dei campi
Fantasticheria; Rosso Malpelo.
Il progetto letterario del “ciclo dei vinti”.
I Malavoglia: la vicenda; le tematiche del romanzo: il mondo arcaico e l’irruzione
della storia; modernità e tradizione; la disgregazione della famiglia; il sistema dei
personaggi; il superamento della visione idealizzata del mondo contadino. La lingua
e lo stile; il punto di vista: discorso indiretto libero; regressione; straniamento.
Prefazione.
Mastro-don Gesualdo: la vicenda; le tematiche del romanzo: la “religione della
roba”; il conflitto valori-economicità; la sconfitta esistenziale del protagonista.
La tensione faustiana del self-made man parte I, cap. IV, righe 87-296.
Novelle rusticane
La roba; Libertà.
Gabriele D’Annunzio: profilo biografico. L’ideologia e la poetica: l’estetismo, il
superuomo, il panismo.
I romanzi.
Il piacere: l’estetismo e la sua crisi.
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, capitolo II); Una
fantasia «in bianco maggiore» (libro III, capitolo III).
Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco: il superuomo a confronto con le
forze negative.
Le Laudi: struttura e organizzazione interna; le tematiche e l’ideologia; la lingua e lo
stile.
Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.
- Argomenti svolti tramite Didattica a distanza :
Giovanni Pascoli: profilo biografico. L’ideologia; la poetica: il fanciullino; le
tematiche della poesia.
Il fanciullino: Una poetica decadente (righe 76-128).
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale; il mito della famiglia; i temi
inquieti. Le soluzioni formali: lingua; sintassi e apparato retorico.
Myricae: Novembre; X Agosto; L’assiuolo.
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
Italo Svevo: profilo biografico. La particolarità dell’ambiente triestino e la
formazione culturale.
Una vita: la vicenda; le tematiche; la forma della narrazione.
Senilità: la vicenda; le tematiche e i personaggi; i procedimenti narrativi; la critica
alla figura e alla mentalità del piccolo borghese.
15 La coscienza di Zeno: la vicenda; i temi; il nuovo impianto narrativo; il “flusso di
coscienza”; il “tempo misto”; Zeno e la “presa di coscienza” dell’inetto. Lettura di
brani scelti del romanzo.
Luigi Pirandello: profilo biografico. L’ideologia: il vitalismo e la crisi dell’identità
individuale (“flusso vitale”, forme e maschere; trappola della famiglia e della condizione
economica); il relativismo conoscitivo e l’isolamento del singolo (“filosofia del lontano” e
“forestiere della vita”). La poetica dell’«umorismo» (“avvertimento del contrario” e
“sentimento del contrario”).
L’Umorismo: la differenza tra comico e umoristico; la “vita” e le “forme”; il poeta
epico “compone un carattere”, l’umorista lo “scompone”.
Un’arte che scompone il reale.
Novelle per un anno.
Il treno ha fischiato; Ciàula scopre la luna.
I romanzi.
Il fu Mattia Pascal: la vicenda; i temi principali; la struttura della narrazione
(memoriale e punto di vista).
Lettura integrale del romanzo.
Uno, nessuno e centomila: la vicenda, le tematiche e il confronto con Il fu Mattia
Pascal; la tecnica narrativa (monologo).
Il teatro.
Il teatro borghese, la forzatura di trama e personaggi attraverso il grottesco. Così è
(se vi pare); Il giuoco delle parti (riferimenti alla trama a titolo di esempio).
Il metateatro, la difficoltà del teatro (e dell’intellettuale) nel comunicare in modo
autentico.
Sei personaggi in cerca d’autore: trama e temi principali.
Enrico IV: trama e temi principali (maschere e vita come recita).
Il teatro dei “miti”, il passaggio dall’umorismo al simbolo.
I giganti della montagna: trama e significati dei personaggi.
U. Saba: profilo biografico. Poetica e tematiche principali del Canzoniere.
Canzoniere: Amai; Trieste; La capra.
G. Ungaretti: profilo biografico. Temi e caratteri formali de L’allegria.
L’allegria: I fiumi; Veglia; Soldati.
E. Montale: profilo biografico. La parola e il significato della poesia; le scelte
tematiche e la poetica in Ossi di seppia.
Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto.
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso: lettura, analisi e commento dei
canti I, III, VI, XI (attività svolta in presenza); XII, XVII, XXXIII (attività svolta in
Didattica a distanza).
Lettura del romanzo di Lia Levi, Questa sera è già domani.
167.2 LINGUA E CULTURA INGLESE
INSEGNANTE: Quaglia Marisa
LIBRO DI TESTO: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Compact Performer. Culture and
Literature” – Zanichelli
1. Macro argomenti /moduli svolti
- Modulo 1: A Two-Faced Reality (The Victorian Age: CH. DICKENS, R. L. STEVENSON,
O. WILDE)
- Modulo 2: The Great Watershed (The devastating experience of the war: R. BROOKE,
W. OWEN; the alienation of modern man: T.S. ELIOT; The disruption of traditional
forms: J. JOYCE)
- Modulo 3: A New World Order (The committed writers: W. H. AUDEN; the dystopian
novel: W. G. ORWELL, W. GOLDING; the Theatre of the Absurd: S. BECKETT)
2. Altre discipline coinvolte
- Italiano
- storia
- filosofia
3. Obiettivi formativi e didattici
- Sviluppo e consolidamento delle capacità comunicative
- Comprensione ed esposizione di semplici concetti di carattere socio-culturale e
letterario
- Riconoscimento dei tratti caratteristici dello stile e dei temi trattati dall’autore
- Confronto tra tematiche dello stesso autore o fra autori diversi
- Analisi dei testi letterari
4. Metodi
- Lezione frontale
- Lezione interattiva
- Discussione guidata
- DAD: il programma di lingua e letteratura inglese è stato svolto in parte in classe e in
parte in modalità di Didattica a Distanza attraverso video lezioni registrate e video
lezioni in presenza con l’ausilio delle Piattaforme Zoom e Moodle.
5. Strumenti
- libro di testo
- sussidi audiovisivi
- sussidi multimediali
6. Spazi
- Aula
- Didattica a distanza (video lezioni registrate e video lezioni in presenza con l’ausilio
delle Piattaforme Zoom e Moodle)
7. Tipologie delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
- verifiche orali
- analisi di testi
- quesiti a risposta singola
- quesiti a risposta multipla
- comprensione del testo
178. Criterio di sufficienza adottato (nelle prove orali e nelle prove scritte)
- Comprensione dei concetti essenziali
- Acquisizione accettabile delle capacità comunicative (uso di funzioni e regole, anche
se in modo non sempre preciso)
- Esposizione dei concetti appresi in maniera sufficiente, anche se piuttosto
mnemonica (specificatamente per l’orale)
9. PROGRAMMA D’ESAME
La competenza letteraria non esclude quella comunicativa e linguistica, ma le comprende
entrambe, rappresentandone il momento più alto e consapevole. Tenendo presente questo
concetto, nello svolgere il programma, ho cercato di stimolare, negli allievi, l’interesse nei
confronti del messaggio letterario attraverso una serie di attività di lettura ed interazione
con il testo. Ho approfondito una serie di autori e opere significativi dall’epoca Vittoriana
all'età contemporanea. Pur non trascurando le informazioni di tipo biografico, ho privilegiato
le tematiche e l'esame dei testi letterari che sono stati letti, analizzati e commentati.
Queste attività da un lato hanno reso possibile il recupero della competenza linguistica
acquisita precedentemente, e dall'altro hanno posto gli alunni di fronte ad una varietà di
messaggi, stili e generi letterari.
Ho cercato di guidare gli alunni alla comprensione del contesto socio-culturale e
all'identificazione delle caratteristiche specifiche del testo e del punto di vista dell'autore
individuando percorsi tematici attraverso le opere trattate.
Pur dovendosi districare tra difficoltà di ordine linguistico culturale e letterario, molti degli
studenti hanno sviluppato un atteggiamento attivo che ha consentito loro di accostarsi ai
testi assorbendo via via una terminologia letteraria appropriata. Non pochi degli alunni, che
incontravano difficoltà sul piano dell'esposizione e della pronuncia, hanno, poi, ottenuto con
l'impegno risultati abbastanza soddisfacenti. Alcuni allievi, inoltre, hanno dimostrato fin da
subito una crescente autonomia di apprendimento unita a capacità d'interazione audio-orale
e di comprensione e produzione del testo.
Il programma di lingua e letteratura inglese è stato svolto in parte in classe e in parte in
modalità di Didattica a Distanza attraverso video lezioni registrate, video lezioni in presenza
e materiale integrativo con l’ausilio delle Piattaforme Zoom e Moodle. Gli alunni hanno
interagito in modo positivo e costruttivo fin da subito con questa nuova modalità di
insegnamento e hanno seguito regolarmente entrambe le tipologie di video lezioni sopra
menzionate. Personalmente, pur rilevando l’importanza della tecnologia che rende attuabile
una modalità di didattica a distanza in situazioni di emergenza, come quella che stiamo
vivendo, ritengo che l’efficacia e la ricaduta dell’insegnamento in classe sia di gran lunga
superiore per quanto riguarda la comunicazione con gli alunni e la trasmissione del
messaggio letterario ed educativo.
ARGOMENTI SVOLTI IN CLASSE
Modulo 1: A Two-Faced Reality
THE VICTORIAN AGE: social and literary background
The first half of Queen Victoria’s reign (pages 148-149)
Life in the Victorian town (page 150)
The Victorian compromise (page 154)
The Victorian novel (page 155)
Fiction:
C. DICKENS and children (page 156)
Oliver Twist – the story, London life, the world of the workhouses (page 157)
Hard Times – the story, the theme of education (page 160)
from Oliver Twist: Oliver wants some more (page 158)
from Hard Times: Coketown (page 151 lines 1-39)
from Hard Times: The definition of a horse (page 161)
R. L. STEVENSON: Victorian hypocrisy and the double in literature (page 178)
from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door (page 179)
18The Aesthetic Movement (page 184)
O. WILDE: the brilliant artist and Aesthete (page 185)
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty (page 186)
from The Picture of Dorian Gray: Dorian’s death (page 187)
The Importance of Being Earnest (full text)
Modulo 2: The Great Watershed
THE EDWARDIAN AGE / WORLD WAR I: social background (pages 225-226)
Modern Poetry: tradition and experimentation (page 233)
Poetry:
The War Poets: different attitudes to war – Rupert Brooke and Wilfred Owen (page 234)
R. BROOKE: The Soldier (page 235)
W. OWEN : Dulce et Decorum Est (page 236)
The alienation of modern man
T.S. ELIOT: The Waste Land - structure, themes, style (page 244)
from The Waste Land: The Fire Sermon (page 246)
THE MODERN AGE: a deep cultural crisis (page 248)
Modernist writers (pages 250-251)
ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA
Fiction:
J. JOYCE: ordinary Dublin: style and technique (page 264)
Dubliners – origin of the collection, themes, epiphanies, narrative techniques (page 265 /
photocopy)
from Dubliners:
Araby (photocopy)
Eveline (photocopy)
Modulo 3: A New World Order
THE LITERATURE OF COMMITMENT (page 295)
Poetry:
W. H. AUDEN: Refugee Blues (page 297)
Fiction:
The dystopian novel (page 303)
G. ORWELL: political dystopia (page 304)
Nineteen Eighty-Four – a dystopian novel, the story, Winston Smith, themes (page 305)
from Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you (page 306)
from Nineteen Eighty-Four: Newspeak (photocopy)
W. GOLDING: dystopian allegory (photocopy)
Lord of the Flies - the story, themes, symbolical characters and objects (photocopy)
from Lord of the Flies: A View to a Death (photocopy)
from Lord of the Flies: The End of the Play (photocopy)
Drama:
S. BECKETT: themes / the Theatre of the Absurd (page 310)
Waiting for Godot - the story, symmetrical structure, characters, themes, language (page
311)
from Waiting for Godot: Nothing to be done (page 312)
from Waiting for Godot: Waiting (photocopy)
197.3 STORIA
Insegnante: Prof. Fabio Popolla
Libro di testo: Gentile, Ronga, Rossi, Millennium, La Scuola, voll. 2-3
1. Macroargomenti/moduli svolti
MODULO INTRODUTTIVO – L'ITALIA E L'EUROPA NELLA SECONDA META'
DELL'OTTOCENTO.
MODULO 1 - LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
MODULO 2 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA
MODULO 3 – L’AFFERMAZIONE DEI TOTALITARISMI E IL SECONDO CONFLITTO
MONDIALE
MODULO 4 – IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
2. Altre discipline coinvolte:
Filosofia, Italiano, Inglese, scienze, fisica
3. Obiettivi formativi e didattici
COMPETENZE DA ACQUISIRE
Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina;
capacità di valutazione delle fonti storiche e delle prospettive e interpretazioni
storiografiche
capacità di collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nella
corretta situazione geografica.
Capacità di rielaborazione ed esposizione dei temi trattati in modo articolato, sia in
forma scritta sia oralmente.
Capacità di orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici, ai tipi di società, nell'ambito dei percorsi di Cittadinanza e
Costituzione
Saper confrontare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale con la
tradizione politico-giuridica occidentale moderna e contemporanea
4. Metodi
Data l’organizzazione per temi del manuale, si è cercato innanzi tutto di legare i temi
trattati ad una scansione cronologica necessaria alla costruzione della linea del tempo e
funzionale alla disposizione corretta degli argomenti trattati. La trasmissione,
spiegazione e discussione dei contenuti è avvenuta attraverso lezioni frontali durante le
quali si sono chiariti i concetti presenti sul testo di riferimento e si sono illustrati e
spiegati i contenuti del programma sotto riportato. La lezione frontale si realizza sia
nella forma della spiegazione dell’insegnante alla classe, sia nella partecipazione della
classe attraverso l’intervento degli studenti durante la discussione guidata. Per verificare
l’avvenuta comprensione del testo e delle spiegazioni, si sono somministrati test a
risposta chiusa o aperta utilizzando il testo di esercizi allegato al manuale
Con la sospensione della didattica in presenza a partire dalla fine di febbraio, si sono
adottate varie metodologie di DAD: invio di materiali audiovisivo, documenti scritti,
audiolezioni, grazie alle quali sono state svolte attività di studio e esercitazione valutate
formativamente e sommativamente
5. Strumenti
Si è utilizzato il libro di testo sia nella parte manualistica, sia in quella antologica, oltre a
dispense approntate dall’insegnante ad integrazione del manuale. Sono stati utilizzati
20strumenti audiovisivi di argomento storico. Si sono altresì indicate risorse on line per la
ricerca bibliografica.
Durante il periodo di attivazione della DAD si sono sfruttate al massimo le risorse
informatiche già a disposizione della scuola (piattaforma di e-learning Moodle e aule
virtuali su registro elettronico) e di nuova introduzione (piattaforme di videoconferenza
in particolare)
6. Spazi
Aula scolastica con LIM (prima della sospensione della didattica in presenza)
7. Tipologie delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Le verifiche sono state orali e scritte, anche a carattere interdisciplinare, in riferimento
alle tipologie delle prove di esame. Sono stati utilizzati sia i questionari a risposta aperta
sia quelli a crocette. Nel valutare si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della
partecipazione, unitamente al progressiva maturazione dell’allievo. I criteri utilizzati per
la valutazione sono stati i seguenti:
acquisizione di adeguate conoscenze, fondate sia sulla proprietà lessicale, sia sulla
padronanza di termini relativi alla storia, sia sulla correttezza dei costrutti sintattici,
sia sulla scioltezza dialogica e sulla coerenza argomentativa;
capacità di orientarsi, secondo opportune coordinate concettuali, nell’ambito delle
varie problematiche storiche;
possesso di congrue capacità logiche, facenti capo all’analisi e alla sintesi, alla
deduzione all’induzione, alla astrazione e alla concettualizzazione;
padronanza di una concreta competenza rielaborativa, fondata su un personale
accostamento alle tematiche di studio e sul conseguimento di abilità critiche e
riflessive;
approccio ai vari contenuti culturali in prospettiva problematica e pluralistica.
Con l’attivazione della DAD si è cercata una certa continuità di valutazione sia formativa sia
sommativa attraverso gli strumenti di comunicazione informatici, ricorrendo sia a
esercitazioni scritte, test a domanda aperta e chiusa, colloqui orali in videoconferenza
8. Criterio di sufficienza adottato (nelle prove orali e nelle prove scritte)
La sufficienza viene conseguita quando si sono compresi i concetti essenziali ed acquisite
in modo accettabile le capacità fondamentali, anche se la preparazione esige ancora
approfondimenti; l’alunno (nelle prove orali) sa ripetere i concetti appresi in maniera
sufficiente, ma piuttosto mnemonica e (nelle prove scritte) articola i concetti in forma
chiara, anche se sussistono improprietà di linguaggio e imprecisioni nei collegamenti
causali tra eventi storici
PROGRAMMA D’ESAME DI STORIA
MODULO 1 – LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
L’imperialismo tra Otto e Novecento. La spartizione dell’Africa. Gli imperi coloniali in
Asia. I trattati di alleanza tra le grandi potenze tra i due secoli
Caratteri delle società di massa all'inizio del Novecento. La politicizzazione delle
masse (lo sviluppo dei grandi partiti politici di massa cattolici, socialisti e
nazionalisti). Origini del razzismo moderno.
l’Europa nella belle époque. La “Weltpolitik” della Germania Guglielmina. I conflitti di
nazionalità in Austria-Ungheria. La rivoluzione russa del 1905
l’Italia di Giolitti
La questione balcanica
21MODULO 2 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA
La prima guerra mondiale. Origine, sviluppo e trattati di pace.
La rivoluzione russa
La nascita dell'URSS e l’affermazione dello stalinismo
MODULO 3 – L’AFFERMAZIONE DEI TOTALITARISMI E IL SECONDO CONFLITTO
MONDIALE
Le conseguenze sociali e politiche della Grande Guerra in Europa. Il fenomeno del
combattentismo
Il primo dopoguerra in Germania e la nascita della Repubblica di Weimar
Il “biennio rosso” in Italia e l'avvento del fascismo
[da questo punto il programma è stato svolto in modalità DAD]
La crisi del ’29 e il New Deal negli USA
Il Nazismo in Germania
Il regime fascista in Italia. La fascistizzazione della società. Le fasi della politica
economica del regime. La politica estera italiana negli anni '30
La situazione Europea alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.
La seconda Guerra Mondiale. L’Europa sotto il nazismo. La Shoah e le sue
interpretazioni (il revisionismo di Nolte; le tesi di Goldhagen e Browning). La
Resistenza in Italia e nel Cuneese
MODULO 4 – IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Il nuovo ordine mondiale e la guerra fredda
la nascita della Repubblica in Italia
MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La Costituzione Italiana (principi fondamentali e ordinamento dello Stato)
L’unione Europea. Evoluzione storica e principali istituzioni
Elementi di “cittadinanza digitale”. Tutti gli studenti hanno seguito il percorso online
“VIVINTERNET AL MEGLIO” (https://vivinternet.azzurro.it/) attivato da Telefono
Azzurro, Altroconsumo e Google, con l’obiettivo di indicare ai giovani come vivere il
Web responsabilmente, attraverso semplici strumenti per apprendere i principi base
di educazione digitale:
Sviluppare un pensiero critico per affrontare la complessità del Web
Proteggersi da cyberbullismo, frodi e altri rischi online
Riconoscere il valore e l'attendibilità dei contenuti prima di condividerli
Valutare le modalità con cui condividere informazioni
Trattare gli altri con rispetto e gentilezza, nella vita online come nella vita
reale
Rispettare e tutelare non solo la propria privacy e la propria reputazione, ma
anche quella altrui
Iniziative di approfondimento sulla pandemia di Coronavirus:
◦ Le conseguenze socio-economiche della pandemia di SARS-CoV-2 (prof. Cimato –
diritto ed economia)
22Puoi anche leggere