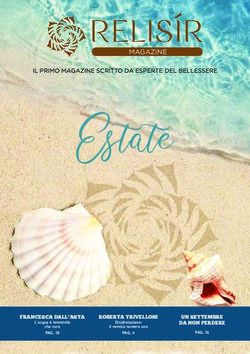Le Metamorfosi Publio Ovidio Nasone - 8 d.C Principato Augusteo - "Ernesto Pascal" Pompei
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il Capolavoro Ovidiano Opera di argomento epico-mitologico scritta in esametri, con cui Ovidio abbandona momentaneamente i distici elegiaci di carattere amoroso. Pubblicata nell’8 d.C., poco prima della relegazione. Lo scopo dell’autore è quello di ripercorrere la storia umana attraverso i miti più importanti della cultura greca e romana. Progetto alquanto ambizioso, che vede il tutto incentrato su una tematica fondamentale: la metamorfosi, data anche dal titolo stesso. Per la maggior parte, infatti, sono miti di trasformazione, che vedono come elemento centrale della fabula il mutamento di uno dei protagonisti.
Il modello Alessandrino
Ovidio, nella composizione dell’opera, dovette confrontarsi con un’imponente
tradizione mitologica, caratteristica soprattutto della cultura greca. Infatti, un modello
in particolare è stata la poesia alessandrina, che si è occupata in maniera accurata anche
della mitologia. Dagli Alessandrini Ovidio ha ripreso:
• la brevitas: basti pensare al fatto che l’opera sia composta da 15 libri, di certo un
numero esiguo se confrontato con tutti i miti che ci sono pervenuti sia dalla
tradizione culturale greca che romana.
• il carattere eziologico: in molti casi diversi miti ovidiani, nella loro narrazione,
concorrono a spiegare il significato di una pianta, di un animale o una celebrazione
rituale dal punto di vista etimologico. Il modello, in questo, è rinvenibile in
un’importante opera di Callimaco: gli Aitia, per l’appunto di carattere eziologico.
Una delle caratteritiche fondamentali dell’opera è anche l’intertestualità ovidiana, con la
quale l’autore fa riferimento diretto a sue opere precedentemente composte e anche alle
stesse fonti che hanno costituito un modello. Infatti, per il poeta, citare le fonti non è
una deminutio, bensì una prova maggiore della sua grandezza, dal momento che è
riuscito a destreggiarsi con opere di un valore così elevato e, sulla base di queste, ne ha
elaborato una del tutto autentica.La politica culturale di Augusto
È importante ricordare che Ovidio è un autore vissuto durante il
principato Augusteo. Periodo in cui, il princeps, Ottaviano
Augusto, definito come il salvatore della repubblica, portò avanti
una politica culturale basata sul recupero dell’integrità morale
del popolo romano. Infatti, nel corso della storia romana, ciò che
ha sempre reso grandiosa una civiltà così potente è stata la loro
rigidità nell’attenersi alle norme etiche del Mos Maiorum. Con il
passare del tempo tutto era andato perso, portando a maturare
nei Romani una concezione molto più individualistica: non
veniva più glorificato il cittadino che sacrificava se stesso nel
nome del bene comune, per la propria patria. Questo è stato
dunque l’elemento segnante che ha portato i Romani a mettersi
l’uno contro l’altro, dando inizio alle guerre civili, l’avvio al
declino della Res Publica. Ciò spiega una politica così reazionaria
da parte di Augusto; è da ricordare che tesi del genere sono
rinvenibili anche nelle opere di Sallustio e di Cicerone.
Vercingetorige getta le armi ai piedi di Cesare, Lioner Royer, 1899,
Puy-En-Velay Auvergne, FranciaLa celebrazione della romanitas
Ovidio dunque, con l’opera, decide di comporre
qualcosa che possa essere compatibile con la
politica di Augusto, rispetto ai precedenti distici
elegiaci di carattere amoroso. Non a caso la parte
finale delle Metamorfosi è dedicata alla storia
romana, partendo proprio dalla mitica
fondazione grazie allo sbarco di Enea sulle coste
italiche, in seguito alla fuga da Troia. Tutto è
volto a celebrare la romanitas, la grandezza del
popolo romano nella storia che l’ha reso un
popolo di dominatori. Nell’opera sono
rinvenibili anche sottili riferimenti ad Augusto,
che elogiano la salvezza della repubblica e la sua
magnanimità.
Virgilio legge l’Eneide ad Augusto ed Ottavia, Pelagio Palagi, 1806, collezioni d’arte, BolognaOvidio e Virgilio
Per quanto riguarda la narrazione
È possibile evidenziare delle differenze tra le Metamorfosi di delle imprese di Enea, sembra
Ovidio e il poema di Virgilio: alquanto ovvio che Ovidio abbia
i libri, a differenza di quelli dell’Eneide, non sono ritrovato un importante punto di
caratterizzati da un’organicità. Molte narrazioni che iniziano riferimento nell'Eneide di Virgilio.
in un determinato libro possono concludersi anche in quello
successivo, una sorta di stratagemma dell’autore per suscitare
la curiosità del lettore e invogliarlo alla lettura di più versi.
Il mito nelle Metamorfosi non ha carattere sacrale, a differenza
del poema di Virgilio, dove la narrazione epico-mitologica
concorre a elogiare e a divinizzare la gens Iulia, stirpe
dell’imperatore Ottaviano.
Nelle Metamorfosi vi è la presenza di una pluralità di
narratori, a volte lo stesso Ovidio, in altri casi gli stessi
personaggi delle narrazione, basti pensare, ad esempio, ai
miti di Orfeo.Pluralità di tematiche - l’originalità di Ovidio
Particolare attenzione merita il tema amoroso, che assume
connotazioni decisamente diverse e più serie rispetto alle opere
erotiche giovanili. Infatti, il poeta con quest’opera vuole essere
funzionale al programma politico di Augusto: non avendolo fatto con
le opere precedenti, ora cerca di creare delle condizioni che possano
risalire alla romanità. Il motore della trasformazione è sempre l’amore,
inteso come il desiderio di colmare una distanza. Tipico degli amori è
l’abbandono di ogni visione oggettiva del reale, che rende folli gli
innamorati (l’insania) e li fa bruciare di una violenta passione
(il furor), senza che, talora, essi ne abbiano percezione; di conseguenza, Venere e Adone, Hendrick Goltzius, 1614, Alta Pinacoteca, Monaco
essi agiscono rovesciando le loro abituali maniere di comportamento.
Le passioni amorose hanno un loro scenario naturale: si tratta in
prevalenza di luoghi ombrosi in cui la frescura offrirà un insperato
ristoro agli stanchi e accaldati protagonisti.
Oltre ai rapporti d’amore, vengono trattati anche rapporti d’empietà, storie di
guerre, rapporti genealogici fra i personaggi, catastrofi cosmiche, o
ancora, torbide passioni incestuose.
Amore e Psiche, Francesco Scaramuzza, 1833, Palazzo della Pilotta, ParmaAltre tecniche utilizzate Un altro aspetto innovativo delle Metamorfosi è dato dalla pluralità dei narratori. In assenza di un protagonista, il vero elemento stabile e unificatore è costituito proprio dalla figura del narratore, che quando s’identifica col poeta stesso, assiste con atteggiamento divertito alla narrazione. Si tratta quindi di un narratore onnisciente, che talvolta interviene aggiungendo pareri personali, con interventi meta-narrativi, altre volte si riferisce direttamente ai personaggi. Sulle scelte di Ovidio ha influito molto la sua formazione retorica: notevole, soprattutto, è stato l’influsso delle controversie (tipico prodotto delle scuole di retorica) sui monologhi, in particolare quando il protagonista è posto di fronte ad una scelta drammatica fra due valori antitetici. I versi, inoltre, appaiono celati da una certa ironia. Ricorrendo alla tecnica dell’ekphrasis, Ovidio inserisce un mito nell’altro, seguendo in particolare i seguenti criteri di presentazione: successione cronologica: collega un mito ad un altro in ordine genealogico successione geografica: associa vari miti avvenuti nel medesimo luogo successione tematica: lega più miti che presentano affinità dal punto di vista del tema
La riflessione filosofica
Nell’ultimo libro del poema, Ovidio espone la teoria
pitagorica della metempsicosi ed enuncia il principio
in base al quale avviene la trasmigrazione di ogni
forma di vita in forme nuove, sicché nulla perisce e
tutto si ricrea. Tali principi pitagorici trovano piena
corrispondenza nella concezione ovidiana, secondo
cui i mutamenti non annullano l’identità di coloro che
li subiscono, perché immortale è lo spiritus che
trasmigra da un posto all’altro. È tuttavia eccessivo
sostenere che i principi pitagorici costituiscano la
base speculativa per una serie interminabile di storie,
in cui la metamorfosi è vista nel suo aspetto
spettacolare e prodigioso.
Busto di Pitagora, musei capitolini, RomaSala dei giganti, dettaglio della cupola, Giulio Romano, 1532-34, Palazzo Te, Mantova
Le Metamorfosi e l'arte
È come se l’autore fosse in grado, attraverso il solo utilizzo
dei versi, di dipingere un affresco nella mente del lettore,
grazie alle particolareggiate descrizioni che vengono
impiegate. Basti pensare agli affreschi delle domus
pompeiane di argomento mitologico oppure ad opere
risalenti al 1600 di artisti barocchi con gli stessi soggetti
Ovidio è sempre stato definito nel corso dei secoli rappresentati. Fra le raffigurazioni si può notare
come uno dei più grandi ispiratori per i diversi artisti, sicuramente una somiglianza, di certo non giustificata dal
grazie alla straordinaria capacità espressiva fatto che gli artisti seicenteschi si siano ispirati agli
manifestata nei versi. affreschi pompeiani, che sono stati rinvenuti il secolo
successivo. Ciò significa che, per entrambe le tipologie di
rappresentazione, l'ispirazione deve essere stata letteraria.Tra tanti altri, particolarmente significativi risultano i seguenti miti Apollo e Dafne Narciso Diana e Atteone «Fer, pater, opem mutando «si se non noverit» «Actaeon ego sum: dominum cognoscite perde figuram, qua ninium vestrum!» placui»
Il mito di Narciso
«ISTE EGO SUM! SENSI, NEC ME MEA FALLIT IMAGO»
Nicolas Poussin, Narciso, 1628, Museo del Louvre, ParigiLa trama Il fiume Cefiso, innamorato della ninfa Liriope,
rinchiude l’amata in un antro, avvolgendola nelle
sue onde e nelle sue correnti, possedendola: da
questa violenza nasce Narciso. Il giovane era così
bello che tutti, uomini e donne si innamoravano
di lui; egli però, incurante, era profondamente
superbo tanto che respingeva tutti coloro che
erano attratti da lui. La hybris di Narciso, tuttavia,
non rimane impunita: sarà maledetto da uno dei
tanti amanti delusi e dalla dea della vendetta
divina, Nemesi, che si incarica di fargli scontare la
sua superbia. Narciso sarà destinato ad
innamorarsi di se stesso, dopo aver contemplato la
propria immagine riflessa in una sorgente.
Progressivamente si rende conto che l’immagine
che vede non è niente altro che il riflesso del
proprio aspetto, dunque si invaghisce di sé,
attratto dalla perfetta simmetria che nota con
l’avvenente immagine. È particolarmente descritto
l’innamoramento dal punto di vista psicologico,
che si può suddividere in quattro fasi.
Infine Narciso morirà travolto da un amore per il
Gerard Van Kuijl, Narcissus, 1969, Museum of Art, Florida suo corpo, amore struggente che lo annienta.La situazione originaria
ORDINE
«Enixa est utero pulcherrima pleno
Infantem nymphe, iam tunc qui posset amari,
Narcissumque vocat»
Narciso era un giovane cacciatore caratterizzato
da una bellezza tanto raffinata che tutte le
persone che lo rimiravano, sia uomini che donne,
se ne innamoravano perdutamente. Egli era solito
soffermarsi in luoghi verdi per riprendersi dalla
calura e dalla fatica della caccia.
15
Franz Caucig, Narciso, 1810, SloveniaAtto di trasgressione
DISORDINE
« Sic hanc, sic alias undis aut montibus ortas
luserat hic nymphas, sic coetus ante viriles»
Narciso rifuggiva qualsiasi legame amoroso: la
sua superbia lo portò a disprezzare chiunque si
innamorasse di lui, rifiutando persino le ninfe.
Si tratta dunque di un atto di hybris volontario,
quella tracotanza che lo faceva sentire al pari
degli Dei. Si dice che per la sua vanità, regalò
una spada ad Aminia, un suo spasimante,
perché si suicidasse arrendendosi per l’amore
non corrisposto.
Francesco Curradi, Narciso, 1622, Galleria Palatina e Palazzo Pitti, FirenzeLa metamorfosi Narciso rimase a lungo presso la fonte
cercando di afferrare quell’immagine senza
accorgersi che il tempo trascorresse
IL RIPRISTINO DELL’ORDINE inesorabile, dimenticando di mangiare e
bere. Alla fine egli morì e quando le Naiadi
«Iamque rogum quassasque faces feretrumque parabat: e le Driadi andarono a prendere il suo corpo
nusquam corpus erat; croceum pro corpore florem per collocarlo sulla pira funebre, al suo
inveniunt folliis medium cingemtibus albis» posto fu trovato uno splendido fiore color
di croco che da lui prese il nome di narciso.Il commento del poeta Si individuano in particolare degli interventi da parte di Ovidio in funzione di narratore: al v. 432 «Credule, quid frustra simulacra fugacia captas?» si individua un’apostrofe con la quale il poeta si riferisce direttamente a Narciso con l’intento di risvegliarlo, perché prenda coscienza che l’immagine che vede nella fonte, in realtà è il suo riflesso. Il commento assume una sfumatura ironica e allo stesso tempo polemica, tipico dei contesti patetici. Al v. 447 «tantus tenet error amantem»: secondo alcuni critici si tratta di un commento dello stesso Narciso che ha compreso totalmente la sua degradazione; secondo altri, seguendo l’ingegnosa tesi del critico E. J. Kenney, questo intervento dovrebbe essere attribuito ad Ovidio, che interromperebbe in questo modo il monologo di Narciso. D’altra parte, l’uso di «error» presume una coscienza sulla propria «insania» che solo più avanti affiora in Narciso. Quindi, quest’affermazione sarebbe poco arguta rispetto all’apostrofe precedente, di carattere fortemente polemico.
Prima fase Narciso che vede la sua immagine riflessa nell’acqua della fonte, e brucia di un amore passionale, che lo porta a volersi congiungere a tutti costi con l’amato. Il poeta descrive l’ingenuità del fanciullo, che ancora non si rende conto di essersi innamorato di un’illusione, di qualcosa che non è corporeo e non potrebbe mai ricambiare il suo sentimento. Viene rappresentato questo amore che progressivamente investe Narciso, offuscandogli la ragione e facendogli vedere, nel comportamento riflessivo dell’acqua, un amato che ricambia le sue gesta amorose. Il poeta scende nel dettaglio della raffigurazione della bellezza efebica del fanciullo, che è ciò che lo rende degno di ammirazione, e che, di conseguenza, lo ha portato a bruciare per sé stesso. Narciso alla fonte, I sec d.C. Scavi di Pompei, Casa di Lucrezio Frontone (V 4, II)
Testo latino e traduzione
Adstupet ipse sibi vultuque immotus eodem Prova meraviglia per se stesso e resta con il
volto immobile, simile ad una statua forgiata
haeret, ut e Pario formatum marmore signum; nel marmo di Pario; contempla, steso a terra,
spectat humi positus geminum, sua lumina, sidus un duplice astro, i suoi occhi, i capelli degni
et dignos Baccho, dignos et Apolline crines sia di Bacco che di Apollo, le guance imberbi,
il collo d’avorio, la grazia del viso e il rossore
inpubesque genas et eburnea colla decusque misto al candore nevoso; e tutto quello che
oris et in niveo mixtum candore ruborem, ammira è ciò a causa del quale lui stesso è
cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse: degno di ammirazione: desidera se stesso,
imprudente, e lui stesso che ammira, è
se cupit inprudens et, qui probat, ipse probatur, ammirato, e mentre cerca, è cercato, allo
dumque petit, petitur, pariterque accendit et ardet. stesso modo si accende e arde.Seconda Fase
Narciso si rende conto che c’è qualcosa che non va, ma
ancora non comprende del tutto e, ancora illuso, spera di
potersi unire all’amato.
A questo punto il fanciullo capisce che c’è qualcosa
che ostacola il suo amore, ma non ha compreso ancora
del tutto la natura dell’amato e pensa sia ancora un
altro fanciullo, un altro corpo in grado di
contraccambiare al suo amore. Narciso arriva all’apice
della sua disperazione, perché non ha idea di cosa gli
stia accadendo. Il dolore viene al meglio rappresentato
attraverso il discorso diretto, in cui Narciso si rivolge
alla selva circostante e spiega che la sua sofferenza è
data dall’apparenza che ciò che rende impossibile il
loro amore sia qualcosa di esiguo e facilmente
valicabile, un semplice velo d’acqua.
Jan Cossiers, Narciso alla fonte, 1636-38, Museo del Prado, MadridTesto latino e traduzione
[...] Et placet et video; sed quod videoque placetque, [...] E mi piace e lo vedo; ma ciò che vedo e mi
piace non riesco a trovare»- un errore così
non tamen invenio» - tantus tenet error amantem - grande possiede colui che ama- «provo ancora
«quoque magis doleam, nec nos mare separat ingens più dolore, non ci separa un mare immenso,
nec via nec montes nec clausis moenia portis; né una strada, né dei monti, né delle mura di
cinta chiuse; per poca acqua siamo lontani!
exigua prohibemur aqua! Cupit ipse teneri:
Lui stesso desidera essere tenuto: infatti
nam quotiens liquidis porreximus oscula lymphis, quante volte abbiamo dato baci alle acque
hic totiens ad me resupino nititur ore. limpide, tante volte costui si è proteso verso di
Posse putes tangi: minimum est, quod amantibus obstat [...] . me con il viso rivolto verso l’alto. Penseresti
che si possa toccare: è minimo, ciò che
ostacola gli amanti [...] .Terza fase
Viene finalmente analizzata la presa di consapevolezza
da parte del fanciullo, che comprende di aver rivolto
questo amore vanamente alla sua immagine riflessa.
Questo momento corrisponde alla massima
concretizzazione della tragicità del mito. Narciso,
meravigliato, capisce di aver bruciato inutilmente per
se stesso, per la sua immagine riflessa nell’acqua,
qualcosa che non avrebbe mai potuto ricambiare
un’emozione così intensa. È, però, ancora incredulo,
non sa come agire ed è come se nel suo cuore si
celasse ancora la minima speranza di poter dare
sfogo a questo desiderio. Non a caso, nel discorso
diretto, si rivolge ancora alla sua immagine riflessa
utilizzando i verbi alla prima persona plurale, quasi
come se fosse un altro individuo, quasi come se fosse
avvenuta una sorta di scissione.
Caravaggio, Narciso, 1597-99, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini, RomaTesto latino e traduzione
Iste ego sum! Sensi, nec me mea fallit imago; Costui sono io! L’ho capito, e la mia
immagine non mi inganna più; brucio a
uror amor mei: flammas moveoque feroque.
causa del mio amore: allo stesso tempo
Quid faciam? Roger anne rogem? Quid deinde rogabo? suscito e subisco le fiamme. Cosa dovrei
Quod cupio mecum est: inopem me copia fecit. fare? Dovrei chiedere o essere richiesto? Che
O utinam a nostro secedere corpore possem! cosa poi dovrei chiedere? Ciò che desidero è
con me: l’abbondanza mi ha reso indigente.
Votum in amante novum: vellem quod amamus abesset. Oh volesse il cielo che ci si possa separare
Iamque dolor vires adimit, nec tempora vitae dal nostro corpo! Un nuovo desiderio
longa mea superant, primoque extinguor in aevo. nell’amante: vorrei che ciò che amiamo fosse
lontano. E ormai il dolore mi priva delle
forze, e non resta molto tempo alla mia vita,
cadrò nel fiore della mia giovinezza.Jules Cyrille Cave, Narcissus, 1890, collezione privata
Narciso, ormai, capisce che un amore del genere non lo
Quarta fase avrebbe rivolto più verso nessun mortale e comprende la
vanità della sua esistenza. Per questo, ormai ammaliato
disperatamente dalla sua immagine riflessa, decide di
lasciarsi pian piano morire, non rivolgendo più nessuna
attenzione alla cura di se stesso, fino a quando, con le forze
Momento della morte di Narciso, tragicamente compianto dalle sorelle ormai esaurite, cade lentamente nell’acqua annegando. Il
ninfe, le Driadi e le Naiadi, e addirittura dalla stessa Eco, che un tempo il carattere tragico della narrazione è particolarmente
fanciullo aveva brutalmente rifiutato. Proprio nell’attimo in cui ci si enfatizzato dalla descrizione del poeta, che spiega il lento
accingeva a preparare il rituale funebre, il corpo di Narciso viene
sostituito da un bellissimo fiore color croco: ecco il carattere eziologico, deterioramento del fanciullo, che lo priva di tutte quelle
che spiega il perché il fiore del narciso abbia questo nome. caratteristiche fisiche che un tempo lo avevano reso
amabile.Testo latino e traduzione
Et neque iam color est mixto candore rubori, E non c’è più il rossore misto al candore
niveo, né il vigore, né le forze, né tutte le cose
nec vigor et vires et quae modo visa placebant,
che, viste poco prima, lo attraggono, né il
nec corpus remanet, quondam quod amaverat Echo. corpo rimane, che una volta aveva amato Eco.
[...] [...]
Ultima vox solitam fuit haec spectantis in undam: Furono queste le sue ultime parole mentre si
«Heu frustra dilecte puer!» totidemque remisit specchiava nelle solite acque: «Oh, fanciullo
verba locus, dictoque «Vale», «Vale» inquit et Echo. inutilmente amato!» e altrettante parole
rimandò il luogo, e detto «Addio», «Addio»
disse anche Eco.
Di particolare rilevanza è il costrutto retorico dictoque «Vale» «Vale» inquit et Echo, che corrisponde ad un chiasmo, incrocio simmetrico di
elementi sintattici. Con tale espressione vengono rese le ultime parole del fanciullo, che esaltano la dimensione tragica e danno al lettore
l’immagine di un corpo che lentamente svanisce.Narciso e la morte
Il sonno, la morte e la rinascita
Nel mito di Ovidio il narciso è il fiore che nasce dalla morte
dell’omonimo giovane; in questo senso esso è legato all’idea di
perpetua rinascita che fa parte della filosofia di fondo delle
Metamorfosi: omnia mutantur, nihil interit. L’elemento che permette
il passaggio dalla vita alla morte è l’acqua, che nel mito ha un ruolo
di primo piano perché è da lì che Narciso nasce (suo padre Cefiso
era un fiume) ed è lì che si inganna e muore.
Inoltre, il nome «Narciso» deriva dal greco «narké» che significa
torpore, ossia il sonno che gradualmente è un preludio alla morte.
Infine, il legame del fiore con la morte è dato anche dall’uccisione
di Aminia, uno dei tanti spasimanti, morto suicida, istigato dallo
stesso Narciso che gli inviò la spada con cui trafiggersi. Per queste
ragioni, oggi il narciso è il fiore più utilizzato per i riti funebri.
Gyula Benczúr, Narcissus, 1844-1920, Magyar Nemzeti Galeria, BudapestMito di Narciso e fabula di Tiresia
La figura del vate Tiresia è utilizzata da Ovidio per
introdurre il mito di Narciso. Accecato da Giunone,
Tiresia riceve da Giove il dono della divinazione come
compenso alla perdita della vista. È proprio per
dimostrare la veridicità di una sua profezia, che viene
raccontata la storia di Narciso. Alla domanda di Liriope,
madre di Narciso, che chiede se il figlio avrebbe vissuto
abbastanza a lungo da vedere la vecchiaia, Tiresia
rispose «si se non noverit»: quindi il giovane non avrebbe
dovuto mai conoscere se stesso. Tale profezia si avverò:
Narciso restò per sempre adolescente, mantenendo
intatta la sua bellezza che risvegliava i più teneri
sentimenti delle ninfe che si avvicinavano.
Ma si innamorò perdutamente di se stesso e morì
travolto da un amore per il suo corpo.
Giulio Carpioni, Tiresia predice l’avvenire di Narciso, 1653, Museo d’Arte Medioevale e
Moderna, PadovaMito di Narciso e fabula di Eco
Ovidio lega il mito di Narciso alla fabula di Eco
Eco era solita intrattenere Giunone con le
sue chiacchierate, impedendole di
sorprendere Giove durante i suoi
tradimenti. Scoperto l’inganno, la dea la
punisce facendo in modo che ella non
avesse più la possibilità di parlare, ma solo
di ripetere le parole degli altri, diventando,
dunque, eco.
Eco è una delle innumerevoli spasimanti di
Narciso, attratta a prima vista dal giovane
dotato di una grazia e di una bellezza
indescrivibili. Rifiutata da Narciso, Eco si
lascia completamente morire e di lei rimane
John William Waterhouse, Eco e Narciso, 1903, Walker Art Gallery, Liverpool
solo la sua voce.Le varianti del mito Placido Costanzi, Narciso ed Eco, 1735-40, collezione privata
La ricezione del mito
Nicolas-Bernardt Lepicié, Narcisse, 1771, Musée national di Château, Versailles
Come il mito è stato reinterpretato a seconda del
periodo storico.Il mito come motivo iconografico
Nell’opera di Tintoretto è rappresentata al meglio la
fattezza classica di Narciso; particolare inoltre risulta la
costruzione dello spazio in profondità, grazie al
movimento alternato delle colline e del ruscello.
L’artista resta fedele alla fonte ovidiana della
rappresentazione della natura che si fonde con i
personaggi raffigurati. La fanciulla in lontananza è Eco, la
quale, non avendo la facoltà di parlare e dichiarare il suo
amore, cerca di abbracciare il giovane.
Così Tintoretto ci mostra due scene: quella in primo piano,
nella quale Narciso si innamora di sé specchiandosi nella
fonte, e quella in lontananza, in cui la Ninfa dimostra il suo
amore, che sarà successivamente rifiutato.
Tintoretto, Narciso alla fonte, 1550-1560, olio su tela Secondo alcuni critici, la rappresentazione in primo piano
corrisponderebbe alla scena in cui Narciso, una volta
raggiunto l’Inferno, si specchia nelle acque dello Stige,
«postquam est inferna sede receptus, in stygia condannato per sempre a vedere la sua immagine riflessa,
spectabat aqua». la stessa immagine che lo aveva ingannato.Affresco degli scavi di Pompei
In questo quadro è possibile notare Narciso con il
consueto mantello, tipico di chi va a caccia.
Egli è seminudo e osserva se stesso nell’acqua.
Non sembra ancora aver compreso che l’immagine è lui
stesso: infatti non vi è alcuno segno di sorpresa.
La mano sinistra poggia sulla riva del fiume, mentre
quella destra, alzata sulla testa, accentua l’equilibrio della
forma del corpo.
Al di sotto delle sue mani vi sono due lance, usate per
cacciare; è fedele dunque al modello ovidiano, in quanto
egli sembra riposarsi dopo una battuta di caccia.
A sinistra vi è Eco, rappresentata come una ragazza e
dunque con fattezze fisiche e sessuali precise; tale dato è
assente nelle Metamorfosi ovidiane.
Ella mantiene e porge una ghirlanda di narcisi rossi.
Viene meno dunque l’eziologia ovidiana, in quanto il
narciso sembrerebbe esistere prima della morte dello
stesso personaggio, da cui prende il nome.
Sull’altra riva del fiume vi è Eros, con fattezze
fanciullesche che è totalmente assente nella versione
letterale.
Narciso ed Eco, I sec. d.C., collocato al Museo Archeologico di Napoli,
proveniente da PompeiIl mito di Apollo e Dafne
REMANET NITOR UNUS IN ILLA
Giovanni Battista Tiepolo, Apollo e Dafne, 1755-60, National Gallery, WashingtonLa trama
Cupido, dio dell’amore, imbestialito a causa dell’arroganza di Apollo,
imbracciò il suo arco e scagliò una freccia dorata nel suo cuore,
facendolo innamorare perdutamente della bellissima ninfa Dafne.
Una seconda freccia di piombo, che rende insensibile all’amore, fu
invece destinata alla fanciulla, figlia e sacerdotessa di Gea, la Madre
della Terra, e del dio fluviale Peneo, facendole provare una sorta di
ribrezzo ingiustificato nei confronti del dio. Apollo partì dunque alla
disperata ricerca della ninfa e, dopo averla trovata, cercò, senza
alcuna esitazione, di possederla e di conquistare il suo cuore. La
fanciulla, sotto l’effetto della freccia scagliata da Eros, si rifiutò e nulla
valse a farle cambiare idea. Fuggì via per cercare di schivare la corte
spietata del dio ormai innamorato di lei, ma lui la rincorse, deciso ad
averla tutta per sé. Dafne, ormai stremata e in preda alla
disperazione, chiese aiuto al padre, che intercedendo presso la
potentissima Madre Terra, decise di aiutare la figlia a ritrovare la
tranquillità ormai perduta. La ragazza venne trasformata in una
pianta di alloro: il suo dolce volto svanì sotto gli occhi increduli del
suo innamorato che, giunto proprio in quel momento, la avvolgeva in
un abbraccio disperato. Da quel giorno l’alloro divenne la pianta
sacra di Apollo, che ne portò una corona sempre intorno al suo capo.
Gian Battista Tiepolo, Apollo e Dafne, 1743-44, Louvre, ParigiLe passioni divine
Il mito di Apollo e Dafne è concepito come un racconto naturalistico
che spiega l’origine dell’alloro, ma in gran parte tratta dei sentimenti
degli dei che, pur essendo immortali, si comportano come gli umani,
essendo vulnerabili alle loro stesse passioni.
Dal punto di vista interpretativo, il mito può essere visto
come una lotta eterna tra castità (Dafne) e pulsione
sessuale (Apollo). La metamorfosi è l’unica soluzione
possibile per la fanciulla per restare vergine per sempre.
Il tutto ruota attorno all’origine dell’uso della pianta di
alloro, polarizzandosi verso il tema dell’amore, fonte, in
questo caso, di dolore per entrambi i protagonisti: il dio
rifiutato e innamorato, e Dafne, offesa e disgustata dalle
offerte del dio, al punto di preferire la natura di pianta a
un sentimento che ripudia.
Jean Etienne Liotard, Apollo e Dafne, 1736, Rijks Museum, AmsterdamSituazione originaria
Filius huic Veneris «figat tuus omnia, Phoebe, te
meus arcus»
Apollo, dio delle arti, riesce a sconfiggere il
temibile serpente Pitone, un mostro nato dalla
terra e che infestava le pianure di Delfi
saccheggiando e compiendo atti gravissimi.
Apollo riuscì a eliminarlo scagliandogli contro più
di mille frecce e ottenendo così il controllo sul
famigerato santuario di Delfi, che da quel
momento in poi divenne un luogo a lui dedicato;
si vanta, perciò, della sua impresa. Egli afferma di
essere il migliore a destreggiarsi con l’arco,
causando l’invidia e l’ira d Cupido, dio
dell’amore.
Paul Rubens, Apollo e il pitone, 1636, Museo del Prato, MadridApollo e Dafne, Scuola veneta del XVII secolo, collezione privata
Disordine Nella narrazione il disordine trionfa nel momento della
fuga estenuante iniziata da Dafne, per sfuggire alla
bestialità della pulsione amorosa che si era impossessata di
Apollo, a causa della freccia che l’aveva trafitto.
Il caos domina sui due personaggi, in particolare su quello
«Plura locuturum timido Peneia cursu della ninfa, che in un gesto così estremo e disperato, colpita
dal vento, mostra al dio tutta la sua spontanea bellezza,
fugit cumque ipso verba imperfecta reliquit» facendolo ardere più intensamente.La metamorfosi IL RIPRISTINO DELL’ORDINE L’ordine si ripristina quando finalmente Dafne viene trasformata in una pianta di alloro dal padre impietosito. Piuttosto che lasciarsi toccare da Apollo, la ragazza preferisce una nuova veste, anche se ciò comporta la fine della sua vita. La descrizione di Ovidio è ancora estremamente dettagliata, soprattutto nella raffigurazione delle diverse parti del corpo della fanciulla che progressivamente si tramutano nelle parti di una pianta: i suoi capelli e le sue braccia che diventano rami ricchi di foglie, il suo corpo che si ricopre di corteccia, i suoi piedi, una volta tanto veloci, che assumono la forma di solide radici. «in frondem crines, in ramos bracchia crescent, pes modo tam velox pigris radicibus haeret.» Paolo Veronese, Apollo e Dafne, 1570-75, Arts Gallery, San Diego (California)
L’intervento dell’autore
Latino Italiano
Ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo Come quando il cane gallico vede la lepre nel
vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem campo vuoto, e questo correndo cerca la
preda, quella la salvezza (l’uno simile a colui
(alter inhaesuro similis iam iamque tenere che sta per brandire la preda, spera di
sperat et extento stringit vestigia rostro, possederla quanto prima e le stringe i passi
alter in ambiguo est, an sit conprensus, et ipsis con il muso proteso; l’altra è incerta, se sia
stata presa, e si sottrae agli stessi morsi e si
morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit): allontana dalla bocca che vuole toccarla): così
sic deus et virgo; est hic spe celer, illa timore. il dio e la vergine; questo veloce a causa della
speranza, l’altra a causa del timore.
Il poeta, con questa significativa similitudine, descrive il comportamento e la situazione dei due personaggi. Apollo viene paragonato
ad un cane gallico, predatore, che sta inseguendo con tutte le sue forze una lepre, sua preda, per potersene nutrire e saziare la sua
fame. Dafne, invece, fuggiasca, viene paragonata alla stessa preda, che si getta in una corsa esasperata ed estenuante, per poter mettere
in salvo la sua vita. L’uno è veloce a causa della speranza di poter catturare l’altra, l’altra a causa del timore della morte.Antonio Sarnelli, Apollo e Dafne, collezione Saverio di Giaimo, Napoli
Il discorso diretto di Dafne In seguito alla corsa estenuante, Dafne, al limite
delle sue forze, scorgendo le acque del fiume
Peneo, ripone la sua ultima speranza in una
preghiera alla stessa divinità fluviale, che non è
Ultima azione disperata della fanciulla, che ha altro che il padre. Nel passo ovidiano il tutto viene
ormai perso le forze e capisce di non poter più reso attraverso un discorso diretto della fanciulla
nulla contro il furore di Apollo. stessa, che enfatizza il carattere drammatico della
narrazione.Testo latino e traduzione
«Fer, pater,» inquit «opem! si flumina numen habetis, Dice : «Portate aiuto, padre! Se voi fiumi avete
ancora potere, fatemi perdere la bellezza per
qua nimium placui, mutando perde figuram!»
cui piacqui troppo!». Appena finita la
Vix prece finita torpor gravis occupat artus, preghiera, un grave torpore occupa le
mollia cinguntur tenui praecordia libro, membra, il petto molle è cinto da una tenue
corteccia, i capelli crescono in foglie, le braccia
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt,
in rami, i piedi una volta tanto veloci si
pes modo tam velox pigris radicibus haeret, fissano in radici statiche, una cima possiede il
ora cacumen habet: remanet nitor unus in illa. volto: in lei rimane soltanto lo splendore. Febo
la ama anche così, posta la mano destra sul
Hanc quoque Phoebus amat positaque in stipite dextra tronco, sente ancora il petto trepidare sotto la
sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus nuova corteccia; avvinghiati con le braccia i
conplexusque suis ramos ut membra lacertis rami come membra, dà baci al legno, il legno
tuttavia li rifiuta.
oscula dat ligno; refugit tamen oscula lignum.Francesco Albani, Apollo e Dafne, 1660, Louvre, Parigi
Il carattere politico Questo velato riferimento ad Augusto si ritrova
nella parte finale della narrazione, in cui vengono
spiegati i diversi elementi della cultura romana
collegati alla simbologia dell’alloro, dove si ritrova,
Si fa riferimento ai rami di alloro che decoravano i battenti dunque, l’eziologia ovidiana. Ciò ci permette di
dell’ingresso del palazzo di Augusto sul Palatino; appesa
alla porta spiccava la corona civica di quercia che il senato ricordare lo scopo politico dell’opera, in cui viene
decretò in onore del princeps nel 28 a.C. celebrata la grandezza di Ottaviano.Testo latino e traduzione
Cui deus «at, quoniam coniunx mea non potes esse, E il dio disse a lei: «Ma, visto che non
arbor eris certe» dixit «mea! semper habebunt potrai essere mia moglie, sarai almeno il
mio albero! Avranno sempre te le chiome,
te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae; le cetre, le nostre faretre, o Lauro; tu
tu ducibus Latiis aderis, cum laeta Triumphum accompagnerai i comandanti Romani,
vox canet et visent longas Capitolia pompas; quando una voce lieta canterà il trionfo e il
Capitolino vedrà i lunghi cortei; tu stesso,
postibus Augustis eadem fidissima custos
fedelissimo custode, starai davanti ai
ante fores stabis mediamque tuebere quercum, battenti e proteggerai la quercia mediana; e
utque meum intonsis caput est iuvenale capillis, così come il mio capo resta giovane per i
capelli intonsi, anche tu porterai sempre gli
tu quoque perpetuos semper gere frondis honores!»
onori perpetui delle fronde!»La cultura dell’alloro
L’alloro, Laurus nobilis o Lauro è una delle piante più
utilizzate nel campo simbolico, in arte, in poesia e nella
pittura.
L’albero di alloro è un sempreverde ed è proprio per
questa sua imperturbabilità rispetto alle stagioni che gli
antichi la consideravano prodigiosa ed era considerata
simbolo di immortalità, in particolare di “gloria
immortale”. Nell’antichità, come testimonia Aulo
Gellio (Roma, 125 circa – 180 circa) ne Le notti attiche,
con le corone di alloro, prima del passaggio all’uso di
manufatti d’oro, veniva incoronato il comandante
dell’esercito dopo la vittoria, o l’imperatore.
Apollo, XVII, Scuola italiana, Louvre, ParigiIl mito come spunto iconografico
Commissionata dal cardinale Scipione Borghese, "Apollo e Dafne" è
una delle opere giovanili del Bernini.
La pelle perfettamente levigata dei personaggi rende la scultura molto
realistica, insieme agli elementi che ne rendono il movimento.
Infatti, il dio in corsa è rappresentato con la gamba sinistra sollevata,
nel suo ultimo slancio verso Dafne; con i capelli spostati indietro dal
vento e il mantello gonfio per la corsa,Apollo affonda già la mano
sinistra nel fianco della ninfa.
La spalla dell'innamorato sembra, però, non naturalmente volta
all'indietro, a differenza del resto del corpo, come per mostrare
sorpresa che non viene, invece, fatta trasparire nel viso pensieroso e
concentrato.
La fanciulla, invece, vercando di liberarsi dalla presa del dio, gira il
proprio corpo su se' stesso, nel tentativo di continuare la fuga.
Il movimento è scandito dalla parte superiore della figura:il busto e i
capelli che ruotano al vento.
La parte inferiore, invece, è come se non rispondesse alla sua volontà;
il piede sinistro ormai divenuto radice e ancorato al terreno e quello
destro leggermente sollevato.
Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622-1625, Roma, Galleria BorgheseDettagli artistici
La testa rivolta verso il dio non permette a Dafne di
vedere le punte dei capelli e delle dita trasformate, ormai,
trasformate in foglie di alloro mentre il corpo ruotato
mostra il desiderio di sfuggire al dio alle sue spalle.
Il volto della fanciulla trasmette la paura di essere
raggiunta ma anche il sollievo della sua prossima
trasformazione; ella, infatti, si è probabilmente accorta del
gesto di pietà del padre Peneo.
La presenza di questo quadro apertamente pagano nella
residenza di un cardinale fu giustificata da un distico a
carattere moralistico di Maffeo Barberini:“Quisquis amans
sequitur fugitivae gaudia formae/ fronde manus implet
baccas seu carpit amaras//” che tradotto è:“Chi amando
segue le fuggenti forme dei divertimenti,/ alla fine si
riempie la mano di fronde e coglie bacche amare//”.
Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622-1625, Roma, Galleria BorgheseAffresco degli scavi di Pompei La raffigurazione, di esempio molto probabilmente ovidiano, rappresenterebbe il mito di Apollo e Dafne ed in particolare la fuga della Ninfa dal dio. La figura di Apollo è raffigurata con un mantello legato al collo e due lunghe lancie da cacciatore fra le mani; egli è in movimento verso sinistra: il mantello è gonfiato dal vento durante la corsa. Dafne è, invece, seminuda, in corsa e con la mano destra intenta a tenere un lembo del suo vestito per non perderlo; con la mano sinistra ella, invece, tenta di scacciare il dio e rifiutare le sue richieste. E' possibile che la fanciulla abbia tra i capelli principi di ramoscelli che riportano al mito ovidiano in cui ella si trasforma in pianta di alloro. Apollo e Dafne, anonimo pittore pompeiano del I sec. d.C., 63-68 d.C., Pompei, Casa dei Vetti
Il mito di Diana e Atteone
«ACTAEON EGO SUM: DOMINUM COGNOSCITE VESTRUM!»
Pier Francesco Cittadini, Diana e Atteone, 1600, collezione privataLa trama
Un giovane cacciatore di nome Atteone, si trovava nei boschi
accompagnato dai suoi fedeli cani per condurre una battuta di caccia.
Mentre vagava nei boschi, giunse a una radura con una grotta e un
laghetto dall’acqua cristallina mentre la dea Diana stava facendo il bagno
insieme a un gruppo di ninfe. Atteone, invece di andare via e lasciare le
donne alla loro intimità, non poté resistere e così indugiò, nascosto dietro
a un albero, posando lo sguardo sulle nudità della dea e contemplandone
la bellezza. Diana, accortasi della sua presenza e adirata per essere stata
furtivamente osservata, spruzzò dell’acqua sul volto dell’uomo.
Immediatamente il povero Atteone venne tramutato in un cervo, così non
avrebbe mai potuto raccontare ciò che aveva visto. Atteone fuggì
impaurito, ma non si accorse della trasformazione fin quando non giunse
a una fonte, dove poté specchiarsi nell’acqua. L’uomo era stato tramutato
proprio nella creatura cui lui e i suoi cani stavano dando la caccia poco
prima. Così, il cacciatore divenne preda dei suoi cani che, incapaci di
riconoscerlo, lo sbranarono. Poco dopo gli animali, compiuto lo scempio,
si misero alla ricerca del loro padrone, riempiendo la foresta di dolorosi
latrati.
Francesco Albani, Diana e Atteone con le ninfe, prima metà del sec. XVII, DublinoLa situazione originaria
ORDINE
«cuius in extremo est antrum nemorale recessu
arte laboratum nulla: simulaverat artem
ingenio natura suo»
Atteone era figlio di Aristeo e di Antinoe, famoso come eroe e
come cacciatore. Alla caccia lo aveva addestrato il centauro
Chirone. In un giorno di caccia, inseguendo un cinghiale, si
trovò nei pressi di una laghetto, dove Artemide e le ninfe
facevano il bagno.
Giuseppe Cesari, Diana e Atteone (particolare), 1603, Szepmuveszeti Muzeum, BudapestGiacomo Ceruti, Diana e le ninfe sorprese da Atteone, 1744, Museo d’Arte Sorlini, Brescia
Atto di trasgressione Atteone, mosso da una smodata curiosità, osserva ciò che dovrebbe
rimanere nascosto agli occhi umani: il bagno di una dea che voleva
DISORDINE mantenere intatta la propria verginità. A questo tentativo di
ribellione sconsiderata, si aggiunge anche il carattere fortemente
irrequieto di Diana. Ella era amante della solitudine, infatti era solita
«ecce nepos Cadmi dilata parte laborum addentrarsi in luoghi isolati; era contraria agli stravizi e alle
per nemus ignotum non certis passibus errans trasgressioni. Atteone aveva partecipato volontariamente a un
genere di visione proibita ai mortali: aveva penetrato l’essenza senza
pervenit in lucum: sic illum fata ferebant»
ombre della Natura.La trasformazione
RIPRISTINO DELL’ORDINE
«me miserum!» dicturus erat: vox nulla secuta est!
La metamorfosi, come dice Umberto Curi, può essere
interpretata secondo due livelli. In primo luogo essa
consiste nella trasformazione in qualcosa di completamente
diverso: Atteone, che è un cacciatore(umano), si trasforma
in cervo(animale) e preda. In secondo luogo la metamorfosi
è come se fosse il palesamento di un’essenza rimasta
nascosta nel soggetto trasformato: è come se Atteone,
proprio perché sempre a contatto con l’animalità e il mondo
della natura, fosse lui stesso un animale.
Atteone passa dall’essere cacciatore a preda stessa, da
padrone dei suoi cani a loro nemico. Se prima i cani
provavano un rapporto di fides (fedeltà) verso il loro
padrone, a metamorfosi avvenuta il rispetto reciproco si
tramuta in un odium incondizionato e involontario.
Parmigianino, Stufetta di Diana e Atteone (particolare), 1542, Rocca Sanvitale, FontanellatoIl commento del poeta
Ovidio nel mito non dà un proprio parere personale, ma si
limita a riportare quelli degli altri, enfatizzandone la
contraddittorietà. Ovidio afferma che per alcuni la dea fu
troppo crudele, altri invece la lodano poiché la considerano
degna della sua verginità austera. Tuttavia, il poeta adduce «Rumor in ambiguo est; aliis violentior aequo
visa dea est, alii laudant dignamque severa
tra tutte l’opinione di Giunone, che esulta per la sciagura che virginitate vocant: pars invenit utraque causas.
ha colpito il casato di Agenore, rivale fenicia. Il commento di sola Iovis coniunx non tam, culpetne probetne,
Ovidio è di fondamentale importanza per introdurre il mito eloquitur, quam clade domus ab Agenore ductae
gaudet et a Tyria collectum paelice transfert
successivo della nascita di Bacco tra Giove e Semele. Il nome in generis socios odium»
di Semele compare sempre legato al mito di Diana e Atteone
ma secondo un’interpretazione completamente nuova. Si
direbbe infatti che la punizione di Atteone provenne da Zeus,
perché il giovane aveva cercato di insidiare la sua stessa
figlia.La ricezione del mito Il mito di Diana e Atteone ci fa riflettere sull’impossibilità di superare certi limiti nella conoscenza della Natura, perché c’è il rischio di provocare un rovesciamento nell’opposto: dalla umanità alla bestiale e inauspicata naturalità. Il dramma di Atteone sta nella presa di coscienza della propria degradazione, cui fa seguito la scelta di morire restando a vagare tra i boschi, preda inevitabile dei suoi stessi cani. «…ond’ella ebbe vergogna; et per farne vendetta, o «… s’andava in quella guisa che scolpita / o dipinta è Diana per celarse, l’acqua nel viso co le man’ mi sparse» ne la fonte, / che getta l’acqua ad Ateone in fronte.» Petrarca, sonetto LII Ariosto, Orlando Furioso, canto XI, ottava 58 «...mi ritrovai di quel mantel coperto / che gli altri usciti «da’ rimorsi della propria coscienza per la dello ardente agone; / e vidimi alla bella donna offerto, / e religion violata…» di cervio mutato in creatura / umana e razionale esser per Vico, I Principi di Scienza Nuova certo.» Boccaccio, La caccia di Diana, vv. 10-12
Giulio Bonasone, Diana e Atteone, 1576, collezione privata
Atteone e la valle Alla fons di Narciso si contrappone per parallelismo la vallis di Diana.
Tuttavia, Ovidio nel mito citato ci presenta il nome della valle. Dallo
sfondo generale si passa al particolare della grotta, caratterizzata da un
arco spontaneo, e di una fonte. La fonte è un "chiaro nel bosco", come
l'avrebbero chiamata Martin Heidegger e Maria Zambrano (il chiaro del
bosco è un centro nel quale non sempre è possibile entrare; lo si osserva
dal limite e la comparsa di alcune impronte di animali non aiuta a
Il mito ha inizio con una descrizione (ekphrasis) iniziale della compiere tale passo; è un altro regno che un'anima abita e custodisce).
valle, chiamata Gargafia, arte incontaminata prodotta dalla La dea Diana era solita giacere e riposarsi, per la fatica della caccia
natura stessa. È dunque un locus amoenus, simbolo di pace e (analogia sempre con Narciso). Sulle rive stavano sdraiate delle belle e
prosperità, come la fonte di Narciso; non è un caso infatti che nude Ninfe (personificazioni delle forze della natura, dai nomi gioiosi:
l'incipit per entrambi gli sfondi dello scenario sia simile. Crocale, Nefele, Iale, Ranide, Psecade e Fiale), che aiutano la Dea a
svestirsi. Il luogo ha una descrizione connotativa.Testo latino e traduzione
Vallis erat piceis et acuta densa cupressu,
nomine Gargaphie succinctae sacra Dianae,
Era una valle coperta di pini e sottili cipressi,
chiamata Gargafia, sacra a Diana dalle vesti succinte,
cuius in extremo est antrum nemorale recessu nei cui recessi in fondo al bosco si trovava un antro
arte laboratum nulla: simulaverat artem incontaminato dall’uomo: la natura col suo estro
ingenio natura suo; nam pumice vivo l’aveva reso simile a un’opera d’arte: con pomice
viva e tufo leggero aveva innalzato un arco naturale.
et levibus tofis nativum duxerat arcum;
Sulla destra in mille riflessi frusciava una fonte
fons sonat a dextra tenui perlucidus unda, d’acque limpide, col taglio della sua fessura
margine gramineo patulos incinctus hiatus. incorniciato di margini erbosi. Qui veniva, quand’era
hic dea silvarum venatu fessa solebat stanca di cacciare, la dea delle selve per rinfrescare il
suo corpo di vergine in acque sorgive. E qui giunta,
virgineos artus liquido perfundere rore.
alla ninfa che le fa da scudiera consegna il
quo postquam subiit, nympharum tradidit uni giavellotto, la faretra e il suo arco allentato; si sfila la
armigerae iaculum pharetramque arcusque retentos, veste che un’altra prende sulle braccia; due le
altera depositae subiecit bracchia pallae, tolgono i sandali dai piedi, e la figlia di Ismeno,
Cròcale, più esperta di queste, in un nodo le
vincla duae pedibus demunt; nam doctior illis
raccoglie i capelli sparsi sul collo, che lei al solito
Ismenis Crocale sparsos per colla capillos portava sciolti. Nèfele, Iale, Ranis, Psecas e Fiale
colligit in nodum, quamvis erat ipsa solutis. attingono acqua con anfore capaci e gliela versano
excipiunt laticem Nepheleque Hyaleque Rhanisque sul corpo.
et Psecas et Phiale funduntque capacibus urnis.Luca Penni, Diana e Atteone, Museo Civico, Pistoia
Tracotanza e trasfomazione La dea sfida Atteone a raccontare di averla vista senza veli,
rivolgendosi direttamente a lui attraverso una vera e propria
minaccia. Arriva la metamorfosi: Ovidio descrive
minuziosamente tutti i particolari del corpo soggetti a tale
trasformazione, passando dal capo, alle mani, fino ad arrivare
Alla vista dell’uomo, le donne si percossero il petto e corsero, tra ai piedi. Si riferisce nuovamente al personaggio senza mai
stridule grida, a coprire la dea. Il tentativo però è vano, in quanto la citare il nome: lo chiama heros, secondo una sfumatura
dea era di statura superiore. Non avendo a disposizione le frecce, pressoché ironica, e «Autonoeius», ossia figlio di Autònoe,
poiché precedentemente svestita, gettò l'acqua in faccia a Atteone. patronimico.Testo latino e traduzione
Quae, quamquam comitum turba est stipata suarum, Benché attorniata dalla ressa delle sue
in latus obliquum tamen adstitit oraque retro compagne, pure si pose di traverso e volse il
volto indietro. Non avendo a presa di mano le
flexit et, ut vellet promptas habuisse sagittas,
frecce, come avrebbe voluto, attinse l’acqua
quas habuit sic hausit aquas vultumque virilem che aveva ai piedi e la gettò in faccia all’uomo,
perfudit spargensque comas ultricibus undis inzuppandogli i capelli con quel diluvio di
addidit haec cladis praenuntia verba futurae: vendetta, e a predire l’imminente sventura,
aggiunse: «Ed ora racconta d’avermi vista
'nunc tibi me posito visam velamine narres,
senza veli, se sei in grado di farlo!». Senza
sit poteris narrare, licet!' nec plura minata altre minacce, sul suo capo gocciolante impose
dat sparso capiti vivacis cornua cervi, corna di cervo adulto, gli allungò il collo, gli
dat spatium collo summasque cacuminat aures appuntì in cima le orecchie, gli mutò le mani
cum pedibusque manus, cum longis bracchia mutat in piedi, le braccia in lunghe zampe, e gli
ammantò il corpo di un vello a chiazze. Gli
cruribus et velat maculoso vellere corpus; infuse in più la timidezza. Via fuggì l’eroe,
additus et pavor est: fugit Autonoeius heros figlio di Autònoe.La graduale presa di coscienza Egli comincia a comprendere la sua nuova natura dalla sua velocità di corsa (riferimento alla velocità di Apollo e Dafne per motivi differenti). Egli si avvicinò ad uno specchio d’acqua e vide il proprio volto con le corna. L’espressione «me miserum», in chiara analogia con l’«iste ego sum» di Narciso, è esempio della presa di coscienza della sua degradazione. Tuttavia, differentemente da Narciso, i lamenti rimangono interni, in quanto è stato privato della sua voce. Ciò che rimane ad Atteone è solo un gemito. Ovidio inserisce poi una serie di domande dirette, concentrandosi su ciò che avrebbe pensato Atteone in quel momento: tornare a casa o addentrarsi nella foresta? Il «Quid faciat» riprende il «quid faciam» nel mito di Narciso. Il parallelismo tra pudor e timor accresce l'impossibilità per Atteone di prendere una decisione in quel momento; la vergogna (pudor) per esser visto e il timore (timor) di morire nel bosco. I suoi cani lo avvistarono.(...) Segue poi un erudito elenco con i nomi dei 27 cani di Atteone, provenienti tutti dall’Arcadia (...). Comincia la corsa di questa grande mandria contro Atteone; i primi corrono per divorare la preda, l’altro per la speranza di vivere(«heu», espressione simile nell’abbandono del corpo di Narciso). Conosciamo il nome del cacciatore solo quando viene pronunciato da lui stesso (iste ego sum - Actaeon ego sum, cfr. Narciso). Egli vorrebbe dire queste parole, ma queste non escono dal suo animo. Parmigianino, Stufetta di Diana e Atteone (particolare), 1542, Rocca Sanvitale, Fontanellato
Testo latino e traduzione
«et se tam celerem cursu miratur in ipso. «Gli infuse in più la timidezza. Via fuggì l’eroe, figlio di
ut vero vultus et cornua vidit in unda, «me miserum!» Autònoe, e mentre fuggiva si stupì d’essere così veloce.
Quando poi vide in uno specchio d'acqua il proprio
dicturus erat: vox nulla secuta est! aspetto con le corna,
ingemuit: vox illa fuit, lacrimaeque per ora «Povero me!» stava per dire: nemmeno un fil di voce gli
uscì.
non sua fluxerunt; mens tantum pristina mansit.
Emise un gemito: quella fu la sua voce, e lacrime gli
quid faciat? repetatne domum et regalia tecta scorsero su quel volto non suo; solo lo spirito di un
an lateat silvis? pudor hoc, timor inpedit illud tempo gli rimase. Che fare? Tornare a casa, nella reggia,
o nascondersi nei boschi? Quello glielo impediva la
Dum dubitat, videre canes, primique Melampus» vergogna, questo il timore. Mentre si arrovellava, lo
avvistarono i cani. Melampo e Icnòbate.»
«(...) quosque referre mora est: ea turba cupidine praedae
per rupes scopulosque adituque carentia saxa, «(...) Lui fugge, per quei luoghi dove un tempo li aveva
seguiti,
quaque est difficilis quaque est via nulla, sequuntur.
ahimè lui fugge i suoi stessi fedeli. Vorrebbe gridare:
ille fugit per quae fuerat loca saepe secutus, «Sono Attèone! Non riconoscete più il vostro
padrone?».
heu! famulos fugit ipse suos. clamare libebat:
Vorrebbe, ma gli manca la parola. E il cielo è pieno di
«Actaeon ego sum: dominum cognoscite vestrum!» latrati.»
verba animo desunt; resonat latratibus aether.»Puoi anche leggere