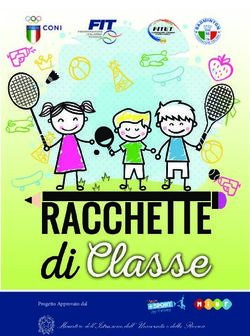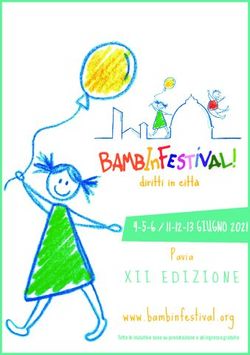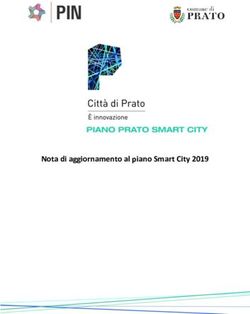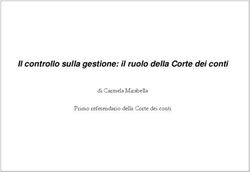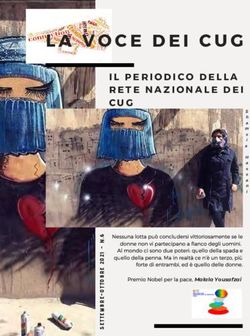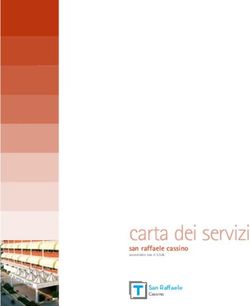OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO DEI PARCHI DEL PO E DELLA COLLINA TORINESE WORKING PAPER 01/2010 - Il Parco fluviale del Po torinese nell'ambito del ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO
DEI PARCHI DEL PO E DELLA COLLINA
TORINESE
WORKING PAPER 01/2010
Il Parco fluviale del Po torinese
nell’ambito del progetto Corona Verde
Dipartimento Interateneo Territorio
Politecnico e Università di TorinoOsservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 INDICE 1. Concetti in rete: Ecologia/Fiumi/Città/Aree protette. ...................................................... 2 2. Un rinnovato programma per l’area metropolitana: la Corona Verde........................... 8 3. Principi base ed agenda di lavoro .................................................................................. 10 Il presente lavoro è dovuto a: Ippolito Ostellino Osservatorio del Paesaggio del Po e della Collina Torinese 2010 OCS - Dipartimento Interateneo Territorio - Politecnico e Università di Torino L’autorizzazione ad utilizzare o a riprodurre parti del presente documento è concessa solo se viene citata la fonte. Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 1
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 1. Concetti in rete: Ecologia/Fiumi/Città/Aree protette. Con il costante aumento della pressione antropica generatosi alla fine del millennio scorso, tradottosi in un costante incremento delle crisi ambientali sia alla scala locale che globale, la questione del ruolo delle componenti ecologiche e naturali anche nel sistema-città contemporaneo, si è sempre di più posto come nuovo tema di riferimento nel dibattito sulle dinamiche espansive urbane. Non è certo una novità assoluta in termini qualitativi se pensiamo, ad esempio, alle motivazioni connesse alla “salute pubblica” che alla fine del XIX secolo portarono le amministrazioni a proporre la nascita dei grandi sistemi di parchi urbani: una risposta allora pensata come soluzione alla necessità di controbilanciare lo scarso livello di salubrità che già le espansioni urbane del primo industrialesimo generavano nelle città. Il carattere di novità del tema ecologico-città è invece un fatto nuovo per gli aspetti quantitativi, sia per la particolare vastità che le aree metropolitane hanno assunto, aumentando gli effetti ambientali negativi, sia per gli effetti che esse hanno generato su vasti sistemi territoriali, riuscendo a compromettere equilibri di habitat un tempo non raggiunti geograficamente dalle limitate cinture espansive, ed oggi invece caratterizzanti territori di notevole ampiezza: citiamo a solo esempio il sistema padano composto in grandi parti da una continua città-diffusa che ingloba in se fiumi e aree naturali. La risposta a tali dinamiche è stata, specie sul finire del novecento, la nascita di un differenziato sistema di Aree protette, che peraltro solo proprio nell’ultimo decennio del millennio scorso, sono riconosciute come una politica nazionale in seguito alla promulgazione della legge n.394/91 sul Sistema Nazionale delle aree protette: un tardivo ma davvero atteso traguardo nel percorso di crescita della sensibilità ai beni naturali per il nostro Paese. Un passaggio normativo e di politiche che nelle Regioni non aveva atteso gli anni ’90, essendosi già attivato negli anni ’70, come per il Piemonte o la Lombardia: è però negli anni 90 che la nascita dei parchi inizia ad interessare anche alla scala piemontese le realtà di pianura, i contesti più urbanizzati, come è il caso del Parco del Po, che nasce proprio nell’aprile del ’90 con la legge regionale n. 28. Il sistema dei fiumi come assi di penetrazione delle componenti naturali nel tessuto del costruito è uno dei passaggi importanti che consente di avviare nel concreto sperimentazioni per integrare la visione urbana con i concetti della biodiversità, ovvero sul ruolo degli spazi aperti nei contesti periurbani, in senso lato e non solo limitatamente ai sistema dei parchi e dei giardini “urbani” altrimenti noti come progetti del “verde urbano”. Il ruolo del Parco fluviale torinese è in tal senso significativo, in quanto proprio nel contesto regionale territoriale più complesso rappresentato dall’area metropolitana torinese, l’area protetta si fa promotrice di un sistema di alleanze per affermare un principio essenziale: la gestione degli spazi naturali e dei sistemi degli spazi aperti deve avvenire secondo una regia a rete e non mediante operazioni di tutela puntiformi, Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 2
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 promuovendo l’immagine della tutela non per aree-isola ma per reti. Un principio che è peraltro la nuova frontiera della tutela dello sviluppo sostenibile sancito a livello europeo nel 1995, con l’adozione della Strategia Pan-Europea per la diversità biologica e del paesaggio che viene approvata nella terza conferenza ministeriale “Ambiente per l’Europa” a Sofia. Il parco ha declinato questo approccio nelle sue diverse realtà territoriali tentando anche di costruire “geografie fluviali locali” che consentano di poter percepire meglio significativi tratti di approccio ai problemi gestionali. Un contesto che è stato anche oggetto di progetti di comunicazione come il portale Immagina il Po nel quale sono state individuate 15 aree di paesaggio declinate in 4 tratti significativi di seguito sinteticamente descritti. Il tratto La Loggia-Lombriasco fino a Racconigi 1/IN VISTA DI RACCONIGI Racconigi costituisce il punto terminale della greenway che si diparte da Torino. Racconigi non è solo il castello con il suo parco; ma è anche il percorso lungo il Maira e la possibilità di visitare la campagna che si stende ai suoi lati, fino al Varaita sulla sinistra, con le tenute della Carpenetta e del Castello di Bonavalle, la cui campagna confluisce su Casalgrasso, e fino al Meletta sulla destra, con la grande tenuta di Migliabruna e con le cascine nella località dove vi era il porto di Carmagnola. Campagna con perfetto disegno e grandi tenute. Qui il paesaggio c'è già nella sua perfezione e rara integrità, ciò che è carente è la rete fruitiva. Bisogna promuovere l'istituzione della rete delle strade verdi e delle strade quiete e bisogna incentivare la diversificazione economica delle aziende agricole, affinché diventino centri di erogazione di beni e servizi di eccellenza. Il Maira merita uno specifico progetto di rafforzamento ecologico. 2/DAI MEANDRI DELLA MENTA DI PANCALIERI ALL'OITANA DI OSASIO Tra Pancalieri e Lombriasco il Po ha lasciato nella campagna il più perfetto disegno di antichi meandri. La rete fruitiva potrebbe far leva sulla coltura essenziera caratteristica della zona dove è già presente il Museo della menta e delle piante officinali di Pancalieri. Ma la singolare campagna di Pancalieri si apre al perfetto reticolo della campagna di Osasio fino a raggiungere l'Oitana. Anche in questo tratto la campagna è ancora integra e anche qui ciò che merita di essere sviluppato è il progetto della rete fruitiva, delle strade quiete e dei centri agricoli di servizio. 3/UNO SGUARDO DISCRETO ALLE OASI DELLA NATURA TRA CARIGNANO E LA LOGGIA Le aree protette della Lanca di S. Michele, del Po Morto, della Lanca di Santa Marta e della confluenza Po-Banna costituiscono i punti di forza della rete ecologica di questo ambito. Qui però la rete ecologica è soprattutto un impegnativo progetto da realizzare Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 3
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 tramite la progressiva dismissione delle attività estrattive e la significativa rinaturazione di questo tratto tra Carignano e La Loggia. Si segnala l'emergenza ecologica del Bosco del Gerbasso. La strada verde e la rete delle strade quiete sono da realizzare e da istituire, ma la fruizione deve essere compa-tibile con il predominante ruolo di oasi naturalistica che il tutto deve assumere. Ciò richiede una revisione dei criteri dei progetti di recupero dei siti di cava e la formazione di un unico progetto di sistema. Merita di essere segnalato il progetto dell'Ente parco di costituire un centro educativo rivolto alle scuole presso la cascina del Rotto. 4/TRA IL PALEOALVEO DEL TANARO, IL BORGO CORNALESE E IL DONGIONE DELLA GORRA La campagna tra l'autostrada A6 per Savona e il Po e che da Carmagnola giunge fino a La Loggia è uno dei si-stemi di paesaggio tra i più vari e ancora miracolosamen-te integri. Il paleoalveo del Tanaro, che finisce in corrispondenza delle tenute da cui si diparte il lungo rettifilo che collega l'Abbazia di Casanova, i Tetti Faule e quel monumento di paesaggio che è Borgo Cornalese, fino alle tenute che fanno da corona al cosiddetto Dongione della Gorra: questo è un sistema di paesaggi unitario e molteplice che va valorizzato nella sua integrità e indivisibilità. Anche qui il paesaggio esiste, vi sono già circuiti che le associazioni locali hanno identificato e promosso, ma ciò che manca è un progetto di sistema con la sua rete di mobilità dolce, realizzata secondo criteri di sicu-rezza e di qualità. Così come manca un progetto di riqualificazione architettonica di queste antiche borgate. Qui è il traffico dell'autostrada e delle strade, che tagliano quest'area, il più consistente fattore di impatto ambientale, che va a detrimento della tranquillità del paesaggio. 5/GIOCHI SULL'ACQUA NEL PARCO D'ARTE TRA MONCALIERI E NICHELINO Il tratto del parco del Po, che si incunea tra Moncalieri e Nichelino e che è reciso dalla tangenziale di Torino, costituisce una sfida di straordinario interesse: come trasformare un disgregato paesaggio periurbano in un parco urbano tramite l'arte dei giardini. Esso è il giusto terminale del sistema di parchi urbani di Torino lungo il Po: come tale va pensato, progettato e trasformato. Occorre raffor-zare la funzionalità ecologica dei due corridoi del Po e del Chisola; occorre mitigare l'effetto barriera del canale della centrale AEM (Iride); occorre riqualificare l'area tra il Po e l'autostrada attrezzando i laghi di cava per attività sportive legate al canottaggio; occorre delocalizzare alcune attività incompatibili (discoteca e pista di kart) e sviluppare un progetto complessivo di mitigazioni e compensazioni ambientali, soprattutto nei confronti degli impatti prodotti dal traffico autostradale e dalla presenza della centrale elettrica. Ma ciò che soprattutto occorre è che tutto ciò venga preordinato all'interno di un disegno ispirato all'arte dei giardini. Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 4
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 Il tratto Torino-Moncalieri 6/IL PARCO NEL PARCO: LE VALLERE Se dovessimo tracciare un rapido schizzo dei punti di debolezza del parco delle Vallere, saremmo indotti a segnare il bordo lungo corso Unità d'Italia, il quale merita un progetto di mitigazioni acustiche a protezione del parco, e la presenza di attività improprie, come i depositi e i ca-pannoni che costeggiano il corso stesso. Con ciò avremmo anche indicato i siti in cui intervenire per migliorare sensibilmente la qualità di questo importante parco urbano. La presenza della sede dell'Ente Parco è poi di stimolo a suggerire iniziative che sappiano esercitare una buona capacità attrattiva ed educativa. Il progetto di costituire un centro botanico al servizio delle scuole va in questa direzione. 7/UN LUOGO MITICO: CONFLUENZA PO-SANGONE MILLEFONTI Tra il Sangone e l'impianto dell'acquedotto di Torino esi-ste un'area che ci si ostina a non vedere. È un aggregato di capannoni e di piazzali di deposito, che nulla ha di strano se non che si trova inesplicabilmente collocato in uno dei luoghi mitici del Po: la confluenza del Sangone di pavesiana memoria. Forse occorre cominciare a guardarlo questo luogo. A confrontarlo con vecchie foto. Per scoprire che esso costituisce un problema. Forse è giunto il momento di ragionarci su, di porvi mano per capire come si possa recuperare alla città uno dei luoghi potenzialmente più suggestivi della storia del "selvaggio" Po urbano. 8/IL VALENTINO Il Valentino è pieno di luoghi recintati. Oggi si discute se recingere questi luoghi con un'ulteriore recinzione che racchiuda tutto il parco. Esso sembra essere destinato a diventare il recinto dei luoghi recintati. Tutto ciò nell'illusoria speranza di maggiore sicurezza. Se questo fosse lo standard, dovremmo attenderci la recinzione del parco Michelotti, di Italia 61, delle Vallere, ecc.. Il Valentino ha, in realtà, un eccesso di superficie asfaltata, di parcheggi e di baracche, perché tali sono i locali di ritrovo in esso presenti. Forse bisogna ridurre l'asfalto, i parcheggi e demolire le baracche imponendo uno stile. Forse bisognerebbe avere il coraggio di demolire il Padiglione interrato di Morandi e ricavare al suo posto un giardino a cavea. Sarebbe il segno d'inversione di una tendenza che negli anni si è protratta e che ha assecondato la tentazione di costruire nel parco. 9/CONNESSIONI: DAL MEISINO A SUPERGA Ora che il percorso ciclopedonale lungo il Po di Torino è pressoché completato lungo le due sponde, si pone il problema delle connessioni trasversali con le piste ciclabili, che penetrano nella città, e con i sentieri, che si inerpicano su per la collina. Qui è sufficiente accennare a due soli esempi. Il primo è l'Anello Verde che, partendo dal Parco Leopardi, si connette alla dorsale panoramica della grande traversata collinare (che meriterebbe il rico-noscimento di bene culturale ambientale), per ridiscendere lungo il parco di Superga. Questo percorso andrebbe riesaminato, migliorato e Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 5
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 rilanciato con nuova energia. Dietro alle passeggiate in collina c'è tutta una tradizione che sarebbe utile rianimare. Il secondo riguarda l'asse da Piazza Castello a Villa della Regina. Esso è quanto di più gradevole il paesaggio urbano di Torino possa offrire. Innanzitutto via Po, in assoluto uno dei gioielli dell'architettura barocca. Poi Piazza Vittorio e la vista del Po, una delle più suggestive. Infine il panorama dalla Villa della Regina. Bisognerebbe progettare questo asse di architettura urbana, di fiume, di giardini e di collina come passeggiata da offrire ai turisti (e ai cittadini). Esso ha tutto il potenziale per diventare una delle più note ed apprezzate passeggiate offerte al turismo internazionale. 10/FIUMI DA RESTAURARE: LA STURA DI LANZO Qui la città ha espresso la sua massima azione erosiva delle qualità paesaggistiche dei fiumi torinesi, scaricando qui i rifiuti industriali nell’area di destra Stura, e costruendo la discarica di Torino degli RSU sulla sponda destra., ma anche le azioni di espansione industriale con l’IVECO sono stati testimoni di un uso del tutto inappropriato di un contesto fluviale di primo ordine. In questo ambito si sono tentate azioni di riconversione ma purtroppo l’affastellarsi di negatività territoriali rende ancora molto complessa l’azione, forse anche per la mancanza di una decisa azione comune degli enti per l’innesco di un totale processo di trasformi zone. 11/FIUMI DA RESTAURARE 2: IL SANGONE Il Sangone ha subito un destino analogo, anche se appare meno evidente alla vista, che è segnata di più dalle cesure stradali che da altre negatività, come la tangenziale di Torino che segna in termini pesantissimi il paesaggio fluviale. Qui l’elementi di maggiore gravità è stato il tema dei prelievi idrici che hanno eliminato per lunghi tratti l’acqua dall’alveo: qui tuttavia sono in corso numerosi interventi di recupero delle sponde e una progettualità locale di riconversione è attiva. Il tratto San Mauro San Raffaele Cimena 11/IL PARCO D'ARTE DI S. MAURO E SETTIMO I parchi urbani del Po non terminano a nord con il Meisino. Il corrispettivo del parco urbano proposto tra Moncalieri e Nichelino è, infatti, il parco d'arte che si dovrebbe realizzare tra S. Mauro e Settimo. Un primo segno in questa direzione lo ha dato il Comune di Settimo con la realizzazione di un nuovo parco urbano lungo il Po. È un segno della voglia di riappropriarsi del fiume. Il progetto deve estendersi soprattutto dalla parte di S. Mauro; ma ciò dovrebbe avvenire all'interno di un progetto unitario che giunga fino al perimetro dell'abitato, dalla parte di Settimo, e che coinvolga il canale della centrale Enel-Cimena, dalla parte di S. Mauro. 12/L'OASI DI GASSINO E MEZZI PO Una piana a rischio di disgregazione quella di Gassino co-sì come quella di Mezzi Po sull'altro lato del fiume. Dopo l'ampia fascia boscata che accompagna i due lati del Po, Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 6
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 superato il depuratore, si aprono appunto queste due pia-ne di cui sembra sfuggire il valore strategico come aree di connessione della rete ecologica del corridoio del Po. L'aggregato dei laghi di cava di Mezzi Po deve trasfor-marsi in core area e le piane agricole a lato dei boschi ripariali devono rinforzare il loro reticolo di siepi e di alberi, rendendosi anche per questo più appetibili per la fruizione ricreativa, a sostegno della quale bisogna realizzare una buona rete di accessibilità di greenway e di strade quiete. Il tratto Chivasso-Verrua Savoia 12/PO E ORCO BEACH: IL WATERFRONT DI BRANDIZZO E CHIVASSO La confluenza con il Malone e l'Orco è un'altra importante core area della rete ecologica del Po e, come tale, richiede un rafforzamento naturalistico. Ma è anche un luogo in cui si rappresenta in forma piena ciò che nell'immaginario appare come il paesaggio di un grande fiume libero. Qui è possibile cercare di conciliare il rafforzamento ecologico con la fruizione ricreativa delle sponde; dove - nella prospettiva del miglioramento della qualità delle acque del Po - si può pensare anche ad una fruizione per la balneazione. Il progetto della fruizione di quest'area è molto legato a ciò che i due comuni più prossimi, Brandizzo e Chivasso, intendono realizzare. Chivasso sta recuperando un suo Waterfront sull'Orco e sul Po con la realizzazione di parchi urbani, quale quello del Bricel. Brandizzo sente il di-stacco dal Po prodotto dalla direttissima per Chivasso ol-tre la quale la sponda del fiume si fa retro di orti urbani. Anche per questo importante nodo c'è bisogno di un pro-getto complessivo di riqualificazione che non perda di vista l'importanza primaria della funzione di connessione ecologica. 13/DAL FIUME ALLA COLLINA DI S. SEBASTIANO Della rarità della piana di S. Sebastiano già si è detto. Il rischio qui è di una sua progressiva erosione prodotta da disgregazione insediativa. Qui il paesaggio è perfetto; è l'urbanistica che corre il rischio dell'imperfezione. Quest'area, che comprende la fascia fluviale, la piana agricola e le colline che la fronteggiano e che si aprono nella valle per Casalborgone, dovrebbe essere fatta oggetto di un piano paesaggistico particolareggiato, che disciplini innanzitutto l'edificazione, evitando che vada ad intaccare le parti più caratterizzanti del paesaggio di questi luoghi e che preservi la ricca dotazione di beni architettonici che costellano la collina, a cominciare dal contesto del Castello della Villa di S. Sebastiano. 14/LUNGO IL CORNO CHIARO DI VEROLENGO Anche della piana, che va dal Canale Cavour al Po e che contiene Verolengo, si è detto. Anche qui il problema è di contenere l'edificazione e l'infrastrutturazione, il cui ultimo segno è la circonvallazione di Verolengo. La greenway di questo paesaggio è il corso del Rio Cor-no Chiaro, che divide il perfetto mosaico agricolo dal letto del Po. Il progetto di questo margine è importante perché esso dovrebbe segnare il confine tra il Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 7
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 paesaggio dell'agricoltura e l'ecosistema delle fasce fluviali per le quali occorre pensare ad un rafforzamento ecologico, dove sia prevista una rigorosa tutela del biotopo del Cor-no Chiaro. 15/TRA MEMORIA E NATURA ALLA CONFLUENZA DELLA DORA BALTEA È questo il primo tratto in cui il Po diviene - almeno per un breve percorso - pluricursale e il suo letto assume un'ampiezza prima sconosciuta. È appunto l'ampia core area della confluenza della Dora Baltea. Il rafforzamento ecologico dell'area protetta è l'obiettivo strategico per questo ambito. Ma non meno importante è la valorizzazione della piana agricola di Lauriano, Cavagnolo e Brusasco, dove il contenimento dei processi insediativi disgregati dovrebbe costituire il punto fondamentale di un progetto di paesaggio, basato sulla integrazione tra la pianura e l'anfiteatro delle colline che la delimitano. Qui occorre sviluppare un progetto di rete fruitiva tramite la realizzazione della rete integrata delle strade verdi e delle strade quiete e tramite la valorizzazione di un sistema di centri attrattori. Tra questi spiccano il sito archeologico di Industria e la Rocca di Verrua: per ambedue occorre sviluppare i progetti di valorizzazione. 2. Un rinnovato programma per l’area metropolitana: la Corona Verde Da questa idea dell’ente di gestione del Parco del Po nasce il Progetto Corona Verde, organizzando il primo seminario tematico nel novembre del 1997. Con questa iniziativa, sostenuta e fatta propria dalla Regione Piemonte, le aree protette possono così presentarsi come nuovi coprotagonisti dello scenario territoriale-strategico dell’area metropolitana torinese, potendo esprimere quel ruolo di laboratori di governance locale che la natura intercomunale e di enti di secondo livello può consentire di avere. Un esempio importante anche se non seguito con la stessa convinzione da parte di tutti gli enti, anche a causa del sopravvivere nelle singole visioni del vecchio modello della gestione per isole, ancora presente in diversi approcci gestionali ancorché superata nella cultura della conservazione. L’idea non è certo del tutto nuova essendo già stati inseriti questi concetti di area vasta nei materiali di lavoro dei Piani regolatori della città sin dal 1954: è invece innovativa la proposta per il suo profilo centripeto che parte dalla periferia, dalle aree esterne per muoversi verso il centro. La Corona degli spazi Verdi costituisce un anello di elementi di forza ambientale che si pone in dialogo con il centro in espansione. Ma non si tratta solo di una collocazione territoriale nuova ma anche di porre i temi ambientali da nuovi punti di vista: vi sono quindi anche ragioni culturali e di approccio che si sono affiancate in questa operazione. Innanzi tutto il tema del modello gestionale. Patti territoriali, PRUSST, Piani territoriali integrati e Piano di Sviluppo Locali sono alcuni dei principali strumenti di programmazione negoziata e concertativa che sull’area metropolitana si sono mossi, partendo da percorsi e presupposti normativi e finanziari diversi tra di loro, ma Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 8
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 accomunati da un unico elemento connesso alla necessità di lavorare per ambiti strategici, secondo un modello per obiettivi e con la partecipazione di tutti gli attori interessati. I parchi sono in sostanza anch’essi in questo filone di organizzazione del territorio ed a partire da queste esperienze si possono sviluppare ragionamenti che diano strumenti per una gestione concertata e programmata dei problemi, sulla scora di esempèi già esistenti come nei casi di Lille o di Lione dove i problemi siano affrontati in sede di “agglomeration urbaine”. In secondo luogo la proposta delle aree protette si compone anche dell’affermazione del principio di interpretare gli strumenti di tutela come veicoli per la riorganizzazione territoriale e non come meccanismi di semplice modello conservazionistico e tale approccio può essere alla base della sperimentazione di modelli di gestione del tema a scala metropolitana riponendo il tema delle reti di partenariato sulla scala complessiva del territorio in un quadro di coerenza generale. In secondo luogo il tema culturale del significato intrinseco e completo del concetto del vincolo. E’ infatti strategico il problema di comprendere sino in fondo la concezione del vincolo, percepito dai più come elemento che pone semplicemente limiti, che per sua natura si compone invece di due tappe. Spesso è stato appunto gestito un modello di vincolo fermandosi alla prima tappa, indispensabile e necessaria per governare le scelte: la tappa del “no”, la tappa del sospendere la scelta, una sospensione che però si completa solo se seguita dalla seconda parte del concetto di vincolo. Avendo potuto conoscere la natura dei problemi grazie alla pausa di riflessione, la seconda parte è quella dell’azione per definire le scelte da effettuarsi per gestire i processi di cambiamento del bene, per orientarne i propri usi compatibili alla domanda eventualmente presente nel contesto contemporaneo nel quale quel bene si trova. Il concetto di tutela a una velocità è invece quello che ha avuto dunque la maggiore visibilità, ed anche il maggior utilizzo dagli stessi enti di tutela, non attrezzati per gestire la seconda fase, ovvero comodamente arroccati sulla prima, certo non così difficile come la seconda. Un progetto di tutela organico deve invece garantire la conservazione del bene perché anche attore della gestione degli usi, dei sistemi di accessibilità, dei modelli di fruizione, dei quali ne è regista o cogestore e non invece arbitro esterno. Sulla base anche di questi contenuti dal 2000 al 2006 si è sviluppata una prima stagione di azioni e progetti che si è potuta sviluppare grazie alle risorse della Misura omonima inserita negli assi dei fondi strutturali del periodo. Una prima fase che ha visto interessanti progetti e cantieri attuati ma anche mostrato la debolezza anche di approccio tecnico che la riqualificazione del territorio conosce nella nostra realtà regionale e d in particolare metropolitana. La qualità dei progetti non sempre è stata all’altezza e il programma non è stato accompagnato da una adeguata azione comunicativa e di partecipazione gestita con una guida orientata da parte del soggetto coordinatore regionale. In ogni caso gli oltre 12.5 milioni di euro investiti hanno rappresentato un primo avvio importate che ha anche innescato a scala locale processi virtuosi di aumento dell’interesse verso alcuni siti dei territori comunali come anche la Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 9
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 sperimentazione di progetti a rete avviati anche dai parchi, anch’essi enti ammessi a finanziamento. 3. Principi base ed agenda di lavoro L’esperienza del progetto Corona Verde vissuta e operata dal lato del fiume è stata una occasione per mettere in luce gli strumenti efficaci ovvero le necessità di costruire nuovi percorsi ponendo l’attenzione su una serie di valutazioni che qui di seguito sono raccolte per temi/problemi. 1. La necessità di sostenere i modelli di pianificazione di area vasta e di orientamento complessivo. Analizzando i diversi temi di qualificazione del territorio non si è potuto evitare di constatare l’estremo intreccio che si crea fra le diverse componenti di trasformazione da quelle residenziali, a quelle viabilistiche a quelle delle aree industriali o dei servizi pubblici specie in un contesto a forte densità d’uso come quello periurbano. Un insieme che se non è collegato a un quadro organico di pianificazione genera effetti negativi verso le porzioni di territorio ad alta qualità paesaggistica o naturalistica, determinando il depauperamento progressivo della qualità d’insieme di un comparto territoriale. Le scelte locali sono quindi sempre più parte di dinamiche che da altre origini possono far ricadere in vasti contesti i loro effetti. L’area metropolitana non può non avere a riferimento un quadro e la Corona Verde ha iniziato a porre ipotesi di opzione sugli spazi ancora liberi affermando fra il resto la necessità che proprio i cointesti protetti siano dotati di adeguati buffer di connessione con i territori esterni che permettano di guidare e interpretare le trasformazioni “esterne” al fine di regolare gli effetti “interni” alle stesse aree di protezione. Si è affermata l’importanza di essere dotati di adeguate “aree contigue” come cuscini di connessione fra ambiti di pregio qualificato e territori circostanti. 2. L’importanza di definire un mosaico di ambiti di integrazione progettuale. Strettamente connesso al primo tema è quello dell’articolazione di una progettualità per il vasto territorio che individui ambiti ed aree di intervento omogenee nei quali affrontare i diversi temi di integrazione progettuale. L’estrema complessità dell’area impone infatti di lavorare si in un contesto ampio, ma nel contempo di saper calare nelle scala comunale ed intercomunale le problematiche insediative e di attenzione agli spazi aperti. La particolare criticità che assumono in specifico le aree di congiunzione fra i confini comunali, nelle quali sembrano essere relegate le scarse attenzioni comunali ovvero le localizzazioni delle attività più diverse grazie alla frequente presenza di aree libere in tali contesti (residuali alla crescita centrifuga dei centri urbani), rimandano alla indispensabile azione di raccordo di ambito allargato come condizione per recuperare un disegno unitario e non parcellizzato del territorio. Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 10
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 3. Uno standard progettuale del costruito in ambito urbano ed extraurbano. Al di la dei temi di ambito o di pianificazione, anche le problematiche di carattere qualitativo sono di grande importanza. Non si tratta solo di decidere e discutere intorno al fare o non fare, ma anche e soprattutto sul come fare. Deciso un intervento è sulla natura del costruito e sulla qualità del progetto che spesso si gioca buona parte del corretto raggiungimento dello scopo progettuale. Se questo è un dato acquisito in contesto urbano (anche se non sempre) in contesti esterni o del cosiddetto verde si assiste ad una scarsa definizione di qualità dell’intervento, anche in termini di standard connessi ai cosiddetti interventi a scomputo. Troppe volte da un lato assistiamo ad opere di “cornice” alle attività edificatorie che invece di dare una ricaduta reale in spazi comuni o servizi, si traducono in banali opere di frangia che nulla portano in qualità al contesto rispetto all’oggetto diretto dell’’intervento. Dall’altro, quando invece l’opera è relativa ad una area a parco o a servizi in generale, si rischia di trasferire in tali contesti modalità di intervento da “giardino pubblico” che snaturano alcuni elementi di una moderna progettazione che si deve invece ispirare ad una maggiore leggerezza e semplicità delle opere oltre a prevederne modelli di manutenzione light. Se si sono sviluppate attività di manualistica in tali ambiti per contesti di pregio come quelli delle aree come le langhe o le montagne, sarebbe opportuno approfondire anche i temi degli spazi aperti periurbani, dove applicare tecniche che rendano il progetto “ecologicamente attrezzato” non solo sotto i profili dei consumi energetici ma anche per quanto attiene ai principi della qualità e connettività ecologica e funzionale. 4. Un sistema gestionale e programmatorio coordinato. Il ruolo del definire un modello gestionale per mettere in rete un sapere esperto integrato e di supporto alle politiche locali, anche come passaggio per l’assegnazione di un ruolo più partecipato ed integrato delle aree protette nell’ottica di un aggiornamento e ripensamento del loro ruolo territoriale, è una delle problematiche che Corona Verde ha affrontato nel suo inizio di attività,senza però ancora giungerei ad un punto acquisito. Una struttura di coordinamento che scambi esperienze e metta in comune i saperi, anche sotto il profilo tecnico e del progetto architettonico e di paesaggio, è un elemento peraltro acquisito nelle altre realtà europee, anche se all’interno delle struttura amministrative che corrispondono ai soggetti intercomunali quali le città metropolitane. Una iniziativa analoga ma di carattere non istituzionale potrebbe costituire un importante momento di coordinamento che sembra tuttavia incontrare ancora difficoltà amministrative e di scala locale. 5. La necessità di assegnare alle opere manutentive un ruolo centrale. Troppo spesso le opere del verde progettate senza una adeguata formazione agronomica o sviluppando i concetti dell’invenzione progettuale senza dare attenzione allo sviluppo nel tempo della struttura vegetale, hanno generato gravi problemi in ordine alla manutenzione successiva. E’ un vezzo diffuso questo anche nel progetto architettonico il non pensare adeguatamente alla manutenzione come una parte fondamentale dell’opera. Nel verde questa carenza genera delle conseguenze sino a rasentare la stessa riuscita del progetto. Ulteriore problema è la gestione degli aspetti Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 11
Osservatorio del paesaggio dei parchi del Po e della Collina Torinese WORKING PAPER 01/2010 legati al vandalismo che in aree urbane è un tema di primario interesse. Una attenzione adeguata a questi temi è una delle componenti che garantisce la qualità del progetto alla stessa stregua dell’idea progettuale in se. 6. Comunicare l’area della Corona come strumento per la formazione del Paesaggio di Corona verde. Il valore di costruire un parallelo progetto di comunicazione dei luoghi per integrare visioni urbanistiche e modelli di fruizione e uso è un elemento anch’esso, insieme al precedente, verso il quale si deve assegnare la giusta importanza. Comunicare l’architettura e il paesaggio è una delle condii ozoni di base per garantire la riuscita in termini di condivisione del progetto. Per un progetto di valore strategico territoriale come Corona Verde questa importanza è anche più evidente che la stessa azione del programma comporta per la necessità di radicarsi nelle politiche locali. Comunicazione e architettura devono essere visti come un binomio per la riuscita e la sostenibilità nel tempo del programma. L’importanza di costruire uno scenario coerente che illustri e sia capace di comunicare il circolo virtuoso che dovrebbe realizzarsi fra modelli di uso del territorio, sua fruizione e sua rappresentazione. Un progetto di sul campo lavora per la costruzione di un soggetto, di un patrimonio culturale guida per la comunità metropolitana: in una parola, un Paesaggio, il Paesaggio della Corona Verde. Il Parco fluviale del Po torinese nell’ambito del progetto Corona Verde 12
Puoi anche leggere