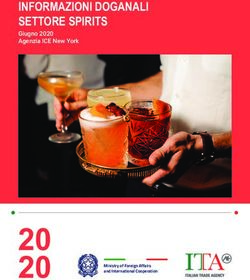I giovani italiani e la lezione americana
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
I giovani italiani e la lezione americana (*) Le elezioni americane hanno premiato la forza e il coraggio del cambiamento, due qualità che scarseggiano nel nostro Paese. Le spinte maggiori verso il cambiamento arrivano dalle nuove generazioni. Non per nulla Walter Benjamin definì la gioventù, per la sua naturale tensione innovatrice, come il “centro in cui nasce il nuovo”. Il giovane non ha interessi costituiti che lo vincolano a seguire una direzione piuttosto che un’altra e può dunque più facilmente orientare la propria sensibilità verso i nuovi problemi della comunità. Quando, in particolare, nasce l’esigenza di cambiare, il maggior sostegno proviene generalmente proprio dalle nuove generazioni. Non può quindi meravigliare il fatto che due giovani americani su tre abbiano votato per Obama, come risulta dai dati degli exit pool riportati con ampia evidenza sui giornali d’oltreoceano. La preferenza nei suoi confronti diventa ancor più forte al diminuire dell’età, fino a superare il 70% tra chi ha votato per la prima volta. Una bella spinta quella data dalle nuove generazioni per il successo del candidato democratico nato negli anni sessanta, anche perché negli States i giovani hanno un peso consistente. Gli americani sotto la soglia dei 35 anni costituiscono il 47% della popolazione, mentre sono appena il 38% in Italia. Secondo le previsioni dell’U.S. Census Bureau (http://www.census.gov/) da qui al 2020 tale quota rimarrà sostanzialmente stabile negli USA, mentre scenderà a poco più di uno su tre nel nostro Paese (immigrati compresi). Il peso degli under 35 sul totale dell’elettorato è di oltre il 30% negli States mentre arriva a malapena al 25% in Italia ed è destinato ulteriormente a scendere al 21,5% (www.demo.istat.it). Questi dati non significano certo che “we can’t change”, suggeriscono però che da noi il cambiamento è destinato ad avere vita più dura, data la minor consistenza demografica delle forze che per propria natura sono più aperte al nuovo. La forza (nei numeri) più ridotta richiederebbe allora d’essere compensata da un maggior coraggio. Meno difesa delle posizioni raggiunte da parte delle vecchie generazioni, meno cooptazione, più disponibilità a confrontarsi e ad essere messi in discussione. Ma richiede più coraggio anche da parte delle nuove generazioni nel guadagnare il proprio spazio. Obama è arrivato dal nulla e ha scalato i vertici della politica americana metro dopo metro, senza timori reverenziali verso nessuno. I
Clinton e i Bush, le caste che hanno gestito il potere dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, alla fine hanno dovuto farsi da parte. La vittoria di Obama insegna che nulla è impossibile in America. In Italia, invece, tutto è più difficile. Certo, aiuterebbe togliere del tutto gli assurdi limiti anagrafici di accesso al Parlamento. Abbassare l’età del voto a 16 anni, quantomeno per le amministrative, sarebbe poi un segnale importante, che consentirebbe di contenere l’ulteriore perdita di peso delle nuove generazioni nei prossimi anni (come abbiamo già mostrato in Rosina“Sedici anni, l’età per votare”). L’effervescenza di questo ultimo mese nei Licei e nelle Università smentisce, del resto, chi considerava i giovani italiani apatici, poco interessati alla politica e al loro futuro. Aiutiamoli a contare di più, diamo qualche speranza in più al cambiamento anche da questa parte dell’Oceano. (*) L’articolo è presente anche su www.lavoce.info Barack Obama e l’ascesa delle minorities Il 44° Presidente degli Stati Uniti, Baraci Hussein Obama, rappresenta bene la nuova America. Un’America nella quale le minorities sono decisamente avviate a diventare, prima della metà del secolo, maggioranza; hanno partecipato in massa alle elezioni del 4 novembre, come mai nel passato; stanno faticosamente scrollandosi di dosso la subalternità civile, se non quella economica; sono percorse da nuovi fermenti di mobilità sociale. Obama è “afroamericano”, anche se a metà, e la sua storia ben si accorda con la nuova demografia americana. Nasce nel 1961 nelle Hawaii (diventate il 50° stato dell’unione appena due anni prima), nel bel mezzo degli anni del baby boom. La madre è bianca, il padre nero, nato in Kenya, e come milioni di bambini americani Obama ha vissuto complesse vicende familiari: i genitori divorziano quando aveva due anni e da allora non vede più il
padre; la madre si risposa con un Indonesiano, e in Indonesia – dove nasce una sorella – vive gli anni dell’infanzia prima di completare gli studi secondari nelle Hawaii. Con padre e patrigno musulmani e madre di tradizione metodista – ma tutti relativamente agnostici – la religiosità di Obama è tardiva e fortemente impastata di valori civili e laici. Gli Stati Uniti verso il 2050 Vale la pena, nella settimana che celebra la vittoria di Obama, dare un sintetico quadro della popolazione americana, avvalendoci delle nuove previsioni demografiche rese pubbliche dal Bureau of the Census nello scorso mese di Agosto[1]. Queste – basate su ipotesi che ricevono, oggi, il largo consenso dei ricercatori e degli esperti – prevedono che la popolazione, dai 307 milioni attuali, superi i 350 milioni nel 2023, i 400 nel 2038 e raggiunga i 439 nel 2050. Il tasso d’incremento, oggi attorno all’1%, scenderebbe marginalmente allo 0,8% alla metà del secolo. Questi risultati correggono al rialzo per quasi 20 milioni (per il 2050) le previsioni precedenti, a conferma di una vitalità demografica sostenuta che contrasta con la flessione prevista per il continente Europeo (Russia inclusa)[2]. Secondo le previsioni delle Nazioni Unite (revisione del 2006 e ipotesi centrale) l’intera Europa scenderà dagli attuali (2008) 730 milioni di abitanti a 664 nel 2050: da due volte e mezzo la popolazione americana ad una volta e mezzo nel 2050[3]. Previsioni così a lungo termine vanno valutate con cautela e servono più che altro come strumenti di discussione e, nel nostro caso, a porre in rilievo il forte divario tra i due continenti. Ipotesi sullo sviluppo demografico Si è detto che le ipotesi sottostanti alle previsioni sono largamente condivise dagli esperti e – occorre aggiungere – improntate all’idea di una notevole stabilità nel tempo dei comportamenti demografici. Per quanto riguarda la fecondità, il numero medio di figli per donna (TFT) rimarrebbe stabile attorno a 2-2,1: tuttavia è una stabilità che nasconde tendenze diverse. Per la minoranza ispanica – che oggi, con un TFT di 2,7, ha una fecondità sensibilmente superiore alla media – si
verificherebbe una discesa a 2,3; per quella afro-americana il TFT scenderebbe da 2,1 a 1,9; per il resto della popolazione il TFT resterebbe invariato attorno a 1,9. L’apparente paradosso di una stabilità della fecondità nonostante la sensibile diminuzione tra gli ispanici e gli afro-americani si spiega con il fatto che i primi – che hanno una crescita assai rapida – raddoppiano il loro peso sulla popolazione totale, come vedremo tra poco. Per la sopravvivenza, si sconta un generale aumento della speranza di vita sia per i maschi che per le femmine; l’aumento sarebbe più forte per la popolazione afro-americana oggi assai distanziata dal resto della popolazione. Si tenga conto che gli 85 anni circa previsti per l’insieme delle donne americane nel 2050 sono stati quasi raggiunti, oggi, dalle donne italiane. Infine, gli Stati Uniti rimarrebbero paese aperto all’immigrazione. Il saldo netto, che nei primi anni di questo secolo, è stato pari a 1,3-1,4 milioni all’anno, salirebbe gradualmente a 2,1 milioni verso la metà del secolo, in proporzione all’accrescersi della popolazione totale. Un’immigrazione in gran parte latino-americana e asiatica, che contribuirà alla crescita delle componenti di origine non europea nella popolazione americana. Da minoranza a maggioranza La prima parte del XXI secolo apre, per gli Stati Uniti, una nuova fase di natura demografica e sociale analoga, ma assai più sconvolgente, a quella avvenuta tra la fine del XIX e la metà del XX. Allora, infatti, la grande migrazione cambiò rapidamente la composizione etnico-culturale del paese: le ondate provenienti dall’Europa mediterranea e orientale, erosero il predominio dello stock anglosassone che aveva costituito il nerbo della società americana dall’epoca del Mayflower. Oggi sono le (cosiddette) minorities – i neri afro-americani, gli asiatici e, soprattutto, gli ispanici latino-americani – che stanno rapidamente erodendo il predominio della maggioranza bianca o caucasian. Va premesso che l’ascrizione a un gruppo razziale (bianco, afro-americano, asiatico) o etnico (ispanici) è funzione di autodichiarazioni al momento del censimento: dichiarazioni che possono contemplare l’appartenenza a più di un gruppo. Ed è naturale che sia così, in una società aperta nella quale le mescolanze sono in crescita. Tuttavia l’indicazione – anche quando oggettivamente non corretta – è rivelatrice di un sentimento di appartenenza più forte di qualsiasi altro indicatore. Ebbene, i gruppi “non bianchi” che – insieme – rappresentano un terzo della popolazione, diventeranno
maggioranza nel 2042, e peseranno per il 54% sulla popolazione totale nel 2050. In ragione della loro più alta natalità, le minoranze saranno “maggioranza” tra i bambini già a partire dal 2023. Questa rivoluzione è dovuta soprattutto alla rapidissima crescita degli ispanici, alimentata dalla natalità più alta e dalla forte immigrazione; questi passeranno da 47 milioni nel 2008 a 133 milioni nel 2050 (con un’incidenza raddoppiata dal 15 al 30%). Una crescita non dissimile è prevista per gli asiatici, in crescita da 15 a 41 milioni (dal 5 al 9% del totale). La popolazione nera, in espansione da 41 a 66 milioni, aumenterà solo marginalmente la sua incidenza sul totale (dal 14 al 15%). La rinascita del melting pot? Per questa nuova fase di mescolanze, la società americana funzionerà ancora come un nuovo, gigantesco, melting pot, capace di riprodurre – come nei secoli scorsi – persone nuove forgiate da un vecchio conio? C’è da dubitarne, perché il mondo è straordinariamente più interconnesso di quanto non lo fosse nella prima grande fase di globalizzazione ottocentesca. Ed è possibile che le identità e le appartenenze non si trasformino così rapidamente come in passato. Nella comunità ispanica, per esempio, la conservazione della lingua e della cultura è favorita dai frequenti rientri in patria, dall’ampiezza e densità delle comunità stesse, dai media televisivi. E’ la rivincita, con le armi dell’immigrazione, sulle sconfitte militari subite nel XIX secolo dagli abitatori dei territori a sud del Rio Grande. [1] http://www.census.gov/ [2] Livi Bacci, 420 milioni di americani nel 2050?, Neodemos [3] http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
Sul sesso non ci si può astenere Non volete contrarre malattie veneree? Basta non fare sesso. Non volete un bambino adesso? Basta non fare sesso. L’astinenza dai rapporti sessuali è l’insegnamento base dei programmi di educazione abstinence-only (“sola astinenza”), molto propagandati negli USA dell’amministrazione Bush, e diffusi già a partire dal 1996. L’approccio basato sulla sola astinenza ricorda quello della Chiesa Cattolica, non solo in Italia, dove però non esiste un diffuso dibattito scientifico sul tema. In questi giorni, nella campagna elettorale per le elezioni statunitensi, l’educazione sessuale abstinence-only è giunta sulle prime pagine.
Non per motivi scientifici. Che senso ha l’approccio basato sull’astinenza? Il caso Palin John McCain ha scelto di candidare la Governatrice dell’Alaska, Sarah Palin, al posto di Vicepresidente. Madre di cinque figli, la Palin è paladina dei valori “tradizionali” che tanto ama la destra statunitense. Contro la libertà di scelta nell’aborto, ma a favore della pena di morte. Per un’educazione sessuale puntata solo verso l’astinenza, ma contro l’insegnamento esclusivo dell’evoluzionismo darwiniano. D’altra parte, è una madre lavoratrice, e per questo potrebbe attrarre voti dalle deluse sostenitrici di Hillary Clinton. Una scommessa per McCain, benvenuta dai tradizionalisti nel partito repubblicano. A sorpresa, dopo l’annuncio, lo staff del candidato presidente ha ufficialmente annunciato che la figlia di Sarah Palin, Bristol, 17 anni è incinta. Tra il plauso dei difensori della famiglia tradizionale, è stato annunciato anche che avrebbe avuto il bambino, e sposato il padre. Niente può essere privato nella corsa alla presidenza, neppure quello che accade ai figli (o ai futuri nipoti). Tutto viene utilizzato a scopi politici, comunque. I repubblicani hanno enfatizzato la scelta pro life (a favore della vita) dell’adolescente Bristol. I candidati democratici si sono defilati, ma i blogger liberal hanno sottolineato che Sarah Palin è contro la libertà di scelta. Inoltre, Bristol ha avuto un’educazione sessuale abstinence-only, che non pare abbia dato l’esito desiderato. Cosa dicono i dati? Il dibattito sull’educazione sessuale è ampio tra i ricercatori, malgrado la posizione della Casa Bianca negli ultimi anni sia stata chiaramente orientata verso l’abstinence-only. D’altronde, gli USA continuano ad avere i livelli di fecondità tra le teenagers tra più alti nel mondo sviluppato. (cfr. figg. 1 e 2).
Nel 2006, la Society for Adolescent Medicine, che raccoglie i migliori ricercatori interessati a questo tema ha espresso il proprio pensiero, pubblicando un position paper, un articolo cioè con un’esplicita presa di posizione. Cosa dice il position paper dei ricercatori? Ovviamente, in via teorica, l’astinenza completa è il metodo più sicuro. I dati però mostrano, in linea con quello che può essere ovvio per il senso comune, come la teoria sia distante, e molto, dalla pratica. Gran parte degli statunitensi ha comunque il primo rapporto sessuale da adolescenti: in questo senso la situazione non è molto diversa dai coetanei di altri paesi. L’astinenza è praticata solo da una minoranza: il 77% dei giovani statunitensi ha rapporti sessuali prima dell’età di 20 anni. I ricercatori, passando in rassegna i risultati di molti studi, mostrano come l’approccio “sola astinenza” non funzioni perché, di fatto, non protegge da malattie sessualmente trasmesse o da gravidanze indesiderate. I programmi abstinence- only non forniscono infatti adeguate informazioni su metodi contraccettivi (in particolare sull’uso dei preservativi) né sulla protezione da malattie sessualmente trasmissibili. Non ammettono discussioni, instillano sensi di colpa tra gli adolescenti sessualmente attivi, non tengono conto dei diversi orientamenti sessuali. I ricercatori concludono che “Le scuole e i servizi sanitari dovrebbero incoraggiare l’astinenza come opzione importante per gli adolescenti. La “sola astinenza” come base per le politiche e i programmi sanitari dovrebbe essere abbandonata”. Tutto viene confermato con gli studi ancora più recenti. Il caso Palin mostra una volta ancora la necessità di abbandonare la teoria pura, soprattutto quando guidata da ideologie volte al ritorno ad un passato che non è affatto mitico, per valutare le politiche che effettivamente migliorano la situazione, le opzioni, le scelte responsabili degli adolescenti. La “sola astinenza” non basta, non ha basi scientifiche e si presta a posizioni spesso ipocrite. Serve un’educazione sessuale completa, che tenga conto delle diversità, e che lasci ai ragazzi la possibilità di scegliere liberamente, ma in maniera informata, tra l’astinenza e una sessualità responsabile.
Riferimenti Shari L. Dworkin, John Santelli, Do Abstinence-Plus Interventions Reduce Sexual Risk Behavior among Youth?, PLOS Medicine, Volume 4, Issue 9, September 2007, e276: http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/jo urnal.pmed.0040276 John Santelli, Mary A. Ott, Maureen Lyon, Jennifer Rogers, Daniel Summers, Abstinence-only education policies and programs: A position paper of the Society for Adolescent Medicine, Journal of Adolescent Health, Volume 38, Issue 1, January 2006, Pages 83-87. L’aborto e le elezioni americane L’opinione pubblica rimane favorevole alla legalizzazione dell’aborto Un’indagine ABC/Washington Post dello scorso gennaio – la più recente in tema di aborto – rileva che 6 americani su 10 restano a favore della legalizzazione dell’aborto, mentre 4 su 10 rimangono contrari. Queste proporzioni, pur con alti e bassi, non sono cambiate negli ultimi dieci anni, e confermano i risultati di altre indagini secondo le quali c’è una prevalenza abbastanza stabile di americani “pro- choice” rispetto a quelli “pro-life”, e che, ancora, una maggioranza assoluta non desidera l’abrogazione della storica decisione della Corte Suprema del 1973 che legalizzò l’interruzione della gravidanza. Non si deve, tuttavia, pensare a due fronti rigidamente contrapposti, perché quanti sono monoliticamente a favore (o contro) l’aborto, sono e restano una minoranza rispetto ad una maggioranza dalle opinioni più articolate e sfumate. I più sembrano desiderosi di non restare prigionieri di principi e posizioni radicali quando si tratta decidere su un problema sociale ed umano così complesso che spesso coinvolge (o può coinvolgere) una figlia, una sorella, un’amica. Si spiega così (indagine Gallup) che la stragrande maggioranza degli elettori affermi che voterà un candidato indipendentemente dalle sue posizioni sull’aborto; o, ancora, che la questione dell’aborto sia agli ultimi posti tra le priorità che gli intervistati vorrebbero nell’agenda del futuro Presidente. Naturalmente, i “pro-choice” sono in netta maggioranza tra i democratici e i “pro-
life” tra i repubblicani, e l’establishment dei due partiti è quasi unanimemente schierato sulle due opposte posizioni. L’aborto legale negli USA: il doppio dell’Europa Tra i paesi ricchi, gli Stati Uniti hanno una frequenza relativa degli aborti più che doppia della media europea e italiana, con una forte incidenza tra le adolescenti; l’abortività tra le donne latino americane è doppia di quella propria delle bianche e quella delle donne nere più che tripla. In genere le disuguaglianze sociali nel ricorso all’aborto sono molto più pronunciate negli USA che in Europa: i costi dell’intervento sono coperti dal sistema pubblico solo per una minoranza dei casi, e le donne sprovviste di assicurazione debbono pagare di tasca loro, o correre rischi d’interventi insicuri. Negli ultimi anni, il boicottaggio attivo (picchettaggio, pressioni, minacce) dei gruppi fondamentalisti pro-life hanno indotto alla chiusura molte cliniche e centri dove si praticavano aborti legali, aumentando le difficoltà per le donne con meno risorse. Le opinioni di Barack Obama e di Hillary Clinton… Nella lunga campagna per le primarie, i candidati di peso, sia in campo repubblicano che in campo democratico, sono stati assai prudenti in tema di aborto. Le posizioni sono note: Hillary Clinton è una convinta sostenitrice della sentenza del 1973; ha votato coerentemente in suo favore e contro ogni tentativo di sminuirne o restringerne la portata. “La decisione [di abortire], che è una delle più difficili e sofferte che una donna ed una famiglia si trovino a fare, è anche una decisione nella quale il governo non deve entrare. Credo che tutti siamo convinti che l’aborto rappresenti una triste ed anche drammatica scelta per molte, moltissime donne”. L’essere donna è un vantaggio per Hillary, che sa usare argomenti che oltre ad essere nelle corde delle femministe tradizionali, sono anche convincenti per le donne in generale. La posizione di Barack Obama non è diversa (ed il suo voting record identico a quello di Hillary), ma è più cauta e sfumata, forse anche perché nell’elettorato afro-americano esistono aggressive componenti pro- life: “Ho fiducia nelle donne che prendono questa decisione [di abortire] consultando i loro dottori, le loro famiglie, il loro clero, e credo questa sia l’opinione della maggior parte degli Americani”. Per Obama l’aborto legale è sicuramente un
male minore per le donne che altrimenti sarebbero costrette a pericolosi aborti clandestini. …e quelle di MacCain Paradossalmente, nel dibattito sull’aborto i due candidati democratici hanno meno da perdere di McCain, che deve assicurarsi il voto della componente religiosa conservatrice – evangelica e cattolica – per sperare di vincere. McCain è oggi in favore dell’abrogazione della sentenza del 1973, ma la sua pagella sull’argomento non è immacolata come vorrebbero i conservatori più duri. In passato aveva sostenuto l’inattualità di un ritorno al bando legale dell’aborto “che avrebbe spinto molte donne in America a sottoporsi ad interventi illegali e pericolosi”. Dei concorrenti persi per strada, Giuliani era nettamente a favore dell’aborto legale; anche Mitt Romney lo era stato prima di diventare governatore del Michigan, per poi assumere opportunisticamente una posizione opposta. Solo Mike Huckabee, evangelico lui stesso, aveva un record antiabortista impeccabile per l’elettorato radicalmente pro-life. Usa e Europa E’ possibile che il dibattito tra democratici e repubblicani si riaccenda attorno alla questione aborto nella corsa finale; è dubbio però che costituisca un fattore rilevante per il risultato finale. Nel 1973, la famosa sentenza della Corte Suprema nel caso Roe contro Wade (v. per esempio http://it.wikipedia.org/wiki/Roe_vs_Wade) aprì la strada alla legalizzazione dell’interruzione della gravidanza nei paesi Europei. E’ assai dubbio che un eventuale ritorno al passato in America, per altro improbabile, abbia analoghe conseguenze in Europa, dove il fondamentalismo in materia è assai più raro, le disuguaglianze nell’ambito della salute molto minori, il ricorso all’aborto meno diffuso. E in Italia, nella trascorsa campagna elettorale, l’argomento aborto è stato tenuto fuori del dibattito o curiosamente subappaltato ad un partito monopersonale.
Stati Uniti: la dolorosa riforma dell’immigrazione Un esercito di irregolari Sono più di 20 anni – era il 1986 – da quando una legge concesse, negli Stati Uniti, una regolarizzazione di massa a quasi 3 milioni di immigrati irregolari. Oggi il Bureau of the Census e altri centri di ricerca concordano nell’indicare in 12 milioni il numero degli immigrati irregolari nel paese, di cui un quinto nella sola California, che corrispondono al 4 per cento circa della popolazione totale. L’occupazione irregolare, stimata in 7,2 milioni, rappresenta circa un ventesimo del totale; ma la quota sale a un ottavo nell’industria alimentare, a un settimo nell’industria delle costruzioni, a un sesto nei servizi e pulizie per gli uffici, e addirittura a un quarto in agricoltura. Se avessimo un uguale proporzione di irregolari in Italia, ne conteremmo 2 milioni e mezzo, contro i meno di 500 mila attualmente stimati. Sulla formazione di questo enorme stock di irregolari in America pesano vari fattori: geografici, giuridici, sociali, economici. In primo luogo, un lungo e poroso confine col Messico che, nonostante le barriere e i fili spinati, non è difficile da penetrare. In secondo luogo, la tolleranza tradizionale circa l’identificazione delle persone: benché molti stati cerchino di tirare il freno, un irregolare può conseguire la patente di guida, iscrivere i figli a scuola, ottenere una camera d’albergo o di motel, affittare una casa senza che l’identità della persona venga scrutinata. In terzo luogo, un’altissima mobilità interna – di varie volte superiore a quella europea – e l’ampiezza del paese rendono agevole mimetizzarsi nelle pieghe della società americana. Infine, i controlli nel mondo del lavoro sono assai meno stringenti e molto più rari di quanto non accada nelle società europee. La politica e le politiche migratorie Fin dalla sua rielezione, Bush aveva annunciato la sua intenzione di arrivare ad una riforma della legislazione, quasi invariata negli ultimi quarant’anni, introducendo qualche forma di legalizzazione dell’esercito di irregolari. Già governatore del Texas, con un fratello governatore della Florida – due tra gli stati con maggiore immigrazione – Bush è sensibile al valore politico dell’elettorato ispanico. Tuttavia, le intenzioni del Presidente hanno sollevato fin dall’inizio aspre polemiche. Il
Congresso aveva addirittura passato, a fine 2005, una legislazione assai più restrittiva di quella esistente, precarizzando ancor più la vita degli irregolari. All’inizio del 2006 vi furono grandi manifestazioni pro-immigrazione nelle maggiori città contro la stretta approvata dal Congresso e a favore di una generalizzata sanatoria. Tanto i repubblicani quanto i democratici sono spaccati al loro interno sulla questione migratoria. Tra i democratici, i riformatori, fautori di un atteggiamento più aperto e liberale, si contrappongono a coloro che sono sensibili alle posizioni dei sindacati (AFL-CIO), che temono lo spiazzamento dei lavoratori nativi, l’erosione dei loro salari e la creazione di un proletariato (underclass) di immigrati non garantiti e manipolabili. Tra i repubblicani c’è una forte business lobby, fautrice di un’apertura al lavoro immigrato, aspramente contestata però da quei conservatori che vedono in ogni processo di regolarizzazione una indiscriminata “sanatoria” (amnesty) e che paventano le mutazioni della fisionomia sociale del paese. Nel maggio dello scorso anno si era arrivati, in Senato, a un primo, labile compromesso bipartisan che prevedeva una regolarizzazione a scaglioni – graduata nelle difficoltà secondo l’anzianità migratoria e condizionata al soddisfacimento di vari requisiti e adempimenti. Un compromesso che però è successivamente evaporato. Nel frattempo l’immigrazione illegale continua: dal 2000 a oggi sarebbero arrivati più di 800.000 irregolari all’anno. Fallisce un nuovo compromesso in Senato Nello scorso maggio, si era profilata una nuova intesa tra le componenti riformiste democratiche e repubblicane in Senato. Il compromesso, meno avanzato di quello raggiunto un anno prima, si basava su alcuni pilastri. Il primo era destinato ad addolcire l’amara pillola per i repubblicani: un forte rafforzamento del contrasto alla irregolarità con l’assunzione di 18 mila persone per il controllo dei confini; 370 miglia di barriera fisica al confine col Messico e 200 miglia con sorveglianza high tech dall’aria e da terra per contrastare il fiume di persone che ogni giorno passa la frontiera. Molti sono scettici sulle conseguenze di queste misure: si sostiene che le maggiori difficoltà nel passare il confine hanno la conseguenza negativa di rendere permanente una migrazione che, almeno nelle intenzioni, è invece spesso temporanea. Molti restano negli Stati Uniti per paura di non esser capaci di rientrarvi. Si renderebbero obbligatori poi i controlli sulla regolarità dei lavoratori assunti.
Il secondo pilastro riguarda coloro che già sono irregolarmente presenti. Questi, una volta identificati, accertato che non abbiano commesso altri reati od infrazioni oltre a quelli connessi con l’immigrazione illegale, multati di $ 1000, avrebbero diritto ad un visto per lavoro di categoria “Z” di durata quadriennale; possono inoltre richiedere una carta verde (residenza permanente) ma per farlo debbono tornare nel paese di origine (con facoltà di rientrare negli USA nelle more dell’accoglimento della domanda, pagando altri $4000). Il terzo pilastro riguarda un programma di lavoro temporaneo curiosamente concepito: il permesso di lavoro dura due anni; quindi deve esserci un anno d’interruzione col ritorno nel paese di origine per ottenere un secondo rinnovo, e così per un eventuale (e ultimo) terzo rinnovo. In una prima formulazione il programma prevedeva 600.000 temporanei all’anno, ridotti poi a 400.000 e, in un’ultima stesura, a 200.000. Il quarto pilastro riguarda invece l’immigrazione di tipo permanente, oggi legata soprattutto alle riunificazioni familiari, che verrebbero invece fortemente limitate. Si introduce un tetto annuo di 380.000 visti permanent-merit – cioè basati su un punteggio, allocato per il 75% alle qualifiche lavorative e all’istruzione; per il 15% alla conoscenza dell’inglese e per il 10% ai legami familiari. Questo schema, proposto da un gruppo di senatori guidati da Edward Kennedy e John Kyl, è stato però accantonato, per l’impossibilità di accordarsi su una serie di emendamenti restrittivi, quali la forte diminuzione delle quote dei temporanei (200.000); la caducità dell’intero programma, che dovrebbe scadere dopo 5 anni; l’inasprimento delle multe per coloro che chiedono la regolarizzazione. Ma il tema dell’immigrazione tornerà presto in agenda e sarà un argomento scottante della campagna per le elezioni presidenziali. Nessun paese civile e ordinato – nemmeno un paese grande, flessibile e tollerante come gli Stati Uniti – può permettersi di tenere per anni 12 milioni di persone sotto ricatto e ai margini della legge. 420 milioni di americani nel 2050 ? Mentre gli europei paventano il declino demografico, gli Stati Uniti prevedono un’espansione della propria popolazione da 300 milioni (2006) a 420 nel 2050, pari al 40 per cento in più. Il Census Bureau (http://www.census.gov/)basa questa previsione
sul mantenimento della fecondità ad un livello superiore al rimpiazzo (2,1-2,2 figli per donna), su una speranza di vita in crescita di mezzo anno ogni dieci anni, e su un saldo netto immigratorio di circa 1 milione di unità all’anno. Nel mondo sviluppato si prevede una contrazione demografica sia per l’Unione Europea, che per la Russia ed il Giappone – a meno di un forte aumento dell’immigrazione e di una ripresa consistente della fecondità. Il differenziale di crescita economica (PIL) tra gli Stati Uniti e le altre aree sviluppate del mondo è oggi imputabile – per almeno un punto percentuale – al divario della crescita demografica. In America ad alimentare il dibattito non è tanto l’aumento previsto della popolazione, quanto la crescita differenziale dei vari gruppi etnici (o razziali, come si dice ufficialmente). Tra il 2000 e il 2050, si prevede una crescita del 32 per cento per i “bianchi”; ma se si scorpora la popolazione cosiddetta “Hispanic” (cioè latino americana), questa cresce del 180 per cento, lasciando ai bianchi non “Hispanic” un modesto 7 per cento di crescita. La popolazione “nera” crescerebbe del 71 per cento, quella di origine asiatica del 213 per cento ed il residuo (essenzialmente nativi autoctoni) del 217 per cento. Val la pena ricordare che l’attribuzione ad un gruppo etnico viene fatta dagli stessi censiti secondo criteri soggettivi, cosicché in ciascun gruppo le mescolanze con altri gruppi-etnia hanno incidenze anche fortissime. Tra il 2000 e il 2050, i “bianchi non Hispanic” scendono dal 69,4 per cento al 50,1 per cento; gli Hispanic aumentano dal 12,6 al 24,4 per cento, i neri dal 12,7 al 14,6 per cento, gli asiatici dal 3,8 all’8 per cento, i nativi dal 2,5 al 5,3 per cento. C’è chi si preoccupa che nel 2051 – forse – lo stock dei veri bianchi sarà minoritario, e che lo stock bianco fondatore (isole britanniche, con qualche contributo germanico) sarà sceso ad un quarto della popolazione totale. Sarà l’America meno America per questo?
Puoi anche leggere