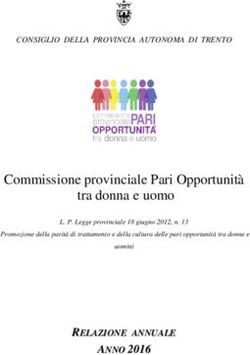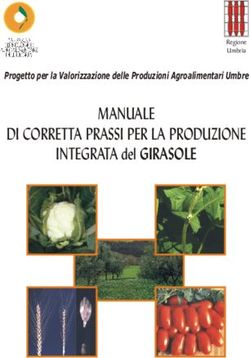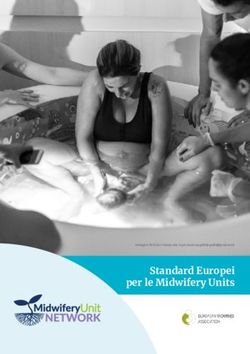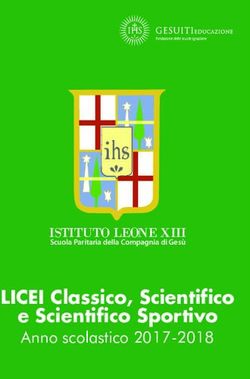PARTIRE DALLA SCUOLA Gender mainstreaming e Pari Opportunità - gruppo diade
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
gruppo diade
PARTIRE DALLA SCUOLA
Gender mainstreaming
e Pari Opportunità
QUADERNI DELLE PARI OPPORTUNITÀ
n. 8 - 2014Editing
Danila Baldo
Centro stampa Comune di Lodi
gennaio 2014
In copertina: cartolina realizzata dal CLAM (Comitato Libero Arte & Musica) – Lodi,
nell’ambito del progetto LIBERA-MENTE, Comune di Lodi, 2012
2“È tempo di compiere una rivoluzione nei costumi femminili,
tempo di restituire alla donne la loro dignità perduta
e di renderle partecipi della specie umana,
in modo che riformando se stesse riformino il mondo”.
Mary Wollstonecraft, Manifesto femminista, 1792
“Per parlare di educazione e valorizzazione dei generi, tema che
richiederebbe una panoramica sui cambiamenti simbolici e sociali avvenuti
negli ultimi trent'anni grazie all'affermarsi del pensiero della differenza
sulla scena pubblica e, in particolare, all'interno della riflessione
pedagogica, mi collego direttamente ai risultati che Liliana Ricci ha
raccolto dalle esperienze laboratoriali condotte in biblioteca e a scuola. Da
un lato è emersa un'evidente lacuna, un grande vuoto di conoscenza per
tutto ciò che concerne la produzione culturale da parte delle donne sia
all'interno del sapere scolastico che di quello più strettamente quotidiano:
mancano presenze femminili significative. Dall'altro ha posto l'accento
sulle differenti modalità relazionali tenute dalle ragazze e dai ragazzi
durante i suoi interventi in classe (difficoltà di presa di parola da parte
delle ragazze, tendenza dei ragazzi ad impadronirsi costantemente della
scena pubblica monopolizzando l'attenzione, ecc.).
A tutte e tutti noi sarà infatti capitato di vedere le ragazze rifugiarsi nel
silenzio, nella marginalità, adottando la "strategia dell'intimità" (per usare
le parole di Anna Maria Piussi, una delle fondatrici della pedagogia della
differenza), ossia l'investimento di tutte le energie nelle relazioni amicali e
affettive con poche compagne o l'insegnante piuttosto che sulle attività
collettive.”
Chiara Stanzani, Educare “ascoltando” la differenza, 2006
“Da molti anni ormai anche nel nostro territorio lodigiano si sviluppano in
via sperimentale nelle scuole tematiche volte alla valorizzazione della
differenza di genere, con progetti nelle classi e corsi di formazione per
docenti volti a superare le discriminazioni stereotipate ancora presenti nei
libri di testo, con un linguaggio e una comunicazione sessista che esclude o
penalizza le donne. Alcune di queste esperienze didattiche sono qui
presentate”
Danila Baldo, gruppo diade, 2014
3INDICE
Presentazione
Simonetta Pozzoli Assessora Istruzione – Comune di Lodi pag. 7
Erika Bressani Assessora Pari Opportunità – Comune di Lodi “ 8
Introduzione
Corrado Sancilio Dirigente ITE “Agostino Bassi”, Lodi “ 9
Laura Fiorini Dirigente Liceo “Maffeo Vegio”, Lodi “ 10
Interventi
Venera Tomarchio gruppo diade, Lodi “ 12
STEREOTIPI DI GENERE NEI LIBRI DI TESTO
Danila Baldo Liceo “Maffeo Vegio”, Lodi “ 27
LA RIVOLUZIONE COPERNICANA DEL LINGUAGGIO
Carla Torri Liceo “Maffeo Vegio”, Lodi “ 31
LA RAPPRESENTANZA DI GENERE NEGLI
ORGANISMI STUDENTESCHI
Esperienze didattiche
Daniela Fusari ITE “Agostino Bassi”, Lodi “ 35
IO SONO MIA: UN PERCORSO DI CONOSCENZA
PER UNA PRESA DI COSCIENZA
Elvira Risino, Daniela Verdi IPS “Luigi Einaudi” Lodi “ 40
STEREOTIPI DI GENERE
Giordana Pavesi IC “Francesco Cazzulani” Lodi “ 45
Marco Zaninelli Centro culturale “Il dado”
LA TOPONOMASTICA FEMMINILE E LE FORMELLE
AL CAZZULANI
Lorenza Badini SMS “Gen. Griffini”, Casalpusterlengo “ 49
INCREMENTARE LA PRESENZA FEMMINILE NELLE LAUREE
SCIENTIFICHE, UNA VIAGGIO CHE PARTE DA LONTANO
5Presentazione
Simonetta Pozzoli,
Vicesindaca e Assessora Istruzione e Cultura – Comune di Lodi
Le considerazioni e i dati riportati all’interno di numerosi
seminari e convegni, attuati nel nostro territorio, mi sostengono
nella convinzione che le pari opportunità sono prima di tutto una
questione culturale e simbolica, come ben ci ricorda Danila Baldo
nel suo intervento sul linguaggio e su cui è necessario riflettere in
primo luogo con le nuove generazioni. E la scuola, per la sua
naturale funzione di trasmissione e revisione del sapere, può e
deve in questo proposito rivestire un ruolo fondamentale.
La presenza ancora scarsa delle giovani donne negli organi
deputati alla rappresentanza studentesca del territorio, come si
rileva dalla ricerca qui riportata, anticipa ciò che ogni giorno
osserviamo nella sfera pubblica, nella politica e nel lavoro. Seppure
sia innegabile il percorso di affermazione del potenziale offerto
dalle donne, rispetto ad alcuni decenni fa, esso va ancora
incoraggiato e sostenuto socialmente e culturalmente.
E’ necessario offrire maggiore consapevolezza alle giovani
donne e ai giovani uomini che la conquista dei diritti non è un dato
di fatto, ma un percorso fatto di lotte e impegno e che tali diritti
vanno ogni giorno presidiati, offrire nuovi modelli che sostengano
le giovani in percorsi non precostituiti e legati agli stereotipi e che
la storia è frutto dell’impegno e delle azioni di uomini ma anche di
tante donne cui deve andare il nostro riconoscimento. Un
ringraziamento particolare e tutto il mio sostegno rivolgo dunque a
chi ogni giorno s’impegna in questa direzione.
7Erika Bressani,
Assessora Pari Opportunità – Comune di Lodi
Con piacere ho accolto l’invito a proseguire l’iniziativa
editoriale dei Quaderni delle Pari Opportunità del Comune di Lodi,
con la sua ottava pubblicazione.
Essa riporta interventi e progetti didattici, che hanno il
pregio di ripercorrere la storia e le esperienze realizzate su tale
tematica nelle scuole del nostro territorio. Il mio ringraziamento
particolare va al Gruppo Diade, composto da docenti di ogni ordine
e grado scolastico, che già dai primi anni novanta ha avviato studi,
riflessioni e progetti sugli stereotipi di genere, avanzando proposte
didattiche e di revisione dei testi scolastici in questa ottica. Questo
seme ha negli anni prodotto altre esperienze e progetti che hanno
visto impegnato direttamente anche il Comune di Lodi e previsto il
coinvolgimento diretto di ragazzi e ragazze con lavori di riflessione
sugli stereotipi legati al femminile e maschile e ad altre diversità,
sulla toponomastica femminile, sul percorso di emancipazione delle
donne o sul contributo delle donne nella scienza.
La pubblicazione che testimonia la continuità di un percorso,
offre il resoconto di queste attività nella speranza che possano
divenire buone prassi, spunti da cui partire ogni giorno nelle nostre
scuole e impegnarsi con le nuove generazioni alla creazione di una
nuova cultura, offrire dignità, rispetto e favorire il superamento di
ogni discriminazione.
8Introduzione
Corrado Sancilio
Dirigente ITE “Agostino Bassi”, Lodi
In un periodo di crisi come quello attuale in cui si
accentuano in maniera sempre più preoccupante le diseguaglianze
sociali, in cui si impongono certi comportamenti che finiscono per
influenzare direttamente la stessa qualità della vita, in cui i diversi
modelli di identità maschile e femminile appaiono sempre più
negativamente condizionati dai conflitti connessi, si rende
necessario intraprendere, fin dai primi anni di scolarizzazione,
concrete azioni positive che portino a costruire e promuovere
processi di costruzione dell’identità maschile e femminile.
Occorre partire dalla scuola per aiutare gli allievi, sin da
piccoli, attraverso percorsi di crescita facilitati, a raggiungere un
grado di reale consapevolezza della propria identità personale e
sociale. Una identità da rispettare e valorizzare in base agli apporti
che ciascuno può dare mediante spontanee aggregazioni
indipendentemente dall'umore sociale contingente, espressione di
una cultura che spesso ne delimita, anche in modo conflittuale, il
campo d'azione. Un lavoro siffatto richiede la consapevole
condivisione di un preciso progetto educativo con specifiche
metodologie di intervento che vadano oltre le personologiche
caratteristiche che una cultura condivisa vuole differenti tra maschi
e femmine laddove, per certi versi, possono, invece, rivelarsi
antitetiche.
Un percorso che porti a rivedere una sorta di neutralità del
sapere, ancora presente nei processi formativi e che ha come
conseguenza quella di veicolare nel sociale una cultura di
estraneità fino ad alimentare il pensiero della differenza sessuale
simile a una gabbia corredata di un maldestro divisorio. Dobbiamo
cominciare a pensarla diversamente. Dobbiamo cominciare ad
uscire dalla logica dell’omologazione che ha voluto e vuole la
donna espressione della trasmissione di un sapere promosso al
maschile. Occorre aiutare ragazzi e ragazze a riscoprire un
linguaggio diverso, messaggio di pluralità e di specificità, che
attraversi la cultura della gestualità del corpo per arrivare alla
cultura della potenzialità della parola mediante un processo di
9acquisizione della propria identità. Una simile impostazione aiuta a
restituire senso e valore al significato della cultura delle pari
opportunità.
Laura Fiorini
Dirigente Liceo “Maffeo Vegio”, Lodi
Nell'esercizio delle mie funzioni da Dirigente
quotidianamente firmo documenti, comunicazioni, verbali ... Fino a
poco tempo fa ho sempre apposto la mia sigla in calce su “Il
Dirigente scolastico” pur avendo la consapevolezza di non
appartenente al genere maschile. Anzi, qualche volta ho pensato
alla versione femminile della definizione del mio ruolo, “La
Dirigente scolastica”, ma ho creduto che sottolinearlo con quelle
“a” finali fosse superfluo: tanto si capisce dal nome che sono una
donna!
Del resto mi ha sempre fatto uno strano effetto sentire, per
esempio in televisione, i termini “Ministra”, “Assessora” quale
segnale di voler essere sopra le righe… rimanere nell’anonimo
maschile mi sembrava preferibile.
Sono poi approdata al Maffeo Vegio e, grazie alla
Commissione Pari opportunità, ho capito che scrivere “La Dirigente
scolastica” ha un grande significato che deve essere valorizzato:
sono diventata orgogliosa delle “a”.
Perché il Dirigente deve essere una professione tipicamente
maschile? E quindi, perché pensare che il Dirigente maschio debba
avere più possibilità di successo di una Dirigente femmina?
Tra le prime iniziative intraprese ho fatto modificare i timbri
della scuola anche se gli stessi erano da poco stati rifatti, con la
dicitura "La Dirigente scolastica” e, ci tengo a sottolinearlo, oggi
non considero la mia scelta come una “pignoleria” femminile, un
inutile esercizio di stile. E’ un’affermazione del mio essere
femminile, è sentirmi alla pari se non meglio di tanti colleghi
maschi.
Ho così abbracciato la necessità di diffondere la sensibilità
verso l’affermazione di un ruolo – quello femminile – così spesso
calpestato, denigrato.
10Nel diario di Istituto ho inserito il documento della
Commissione Pari Opportunità “Comunicazione orientata al
genere”: “(…)L’intento è quello di produrre un significativo
cambiamento culturale, che vada nella direzione di valorizzare la
differenza di genere nella società, superando la neutralità del
linguaggio (che vede erroneamente un maschile prevalente e
inclusivo, con la conseguenza della cancellazione nel linguaggio
comune del femminile, anche laddove previsto dai vocabolari) e
ponendo attenzione a una comunicazione che non usi stereotipi
pregiudizievoli o immagini offensive nei confronti di entrambi i
generi sessuati (vedi pubblicità sessiste o presentazione di ruoli
maschili/femminili stereotipati, soprattutto nella scelta dei libri di
testo). (…)”
La commissione ha letto il documento oltre che nel Collegio
dei Docenti, anche nel Consiglio di Istituto, al personale di
segreteria nell’ottica di rendere attente e consapevoli tutte le
componenti scolastiche.
Auspico dunque che tutti i documenti destinatati a colleghe
o comunque all’esterno dell’Istituto possano stimolare la stessa
riflessione affinché si abbia la coscienza del mutato modo di vedere
la professionalità slegata dal genere.
11Interventi
Venera Tomarchio
gruppo diade, Lodi
Stereotipi di genere nei libri di testo
Il gruppo diade è costituito da insegnanti di scuole di
diverso ordine e grado e ha iniziato a riunirsi a Lodi, presso la sede
dell’Istituto “Maffeo Vegio” nel 1993, per agire e indagare
nell’ambito della differenza di genere, sul tema dei percorsi
dell’identità sessuata.
Il gruppo ha formalizzato le esperienze didattiche attuate
nella pubblicazione, Pensare, dire, fare nella differenza. Percorsi
didattici attraverso la differenza di genere (1998), che comprende
una scelta dei percorsi e progetti utili per un costruttivo confronto
e per una efficace formazione sul tema della pedagogia della
differenza di genere.
Successive attività del gruppo:
• Differenza di genere e scuola: dalla ricerca teorica ai percorsi
didattici, corso di aggiornamento patrocinato dalla Provincia di Lodi
e realizzato presso la SMS "Don Milani" di Lodi
• corso di aggiornamento: Valorizzazione della funzione docente
nella differenza di genere, Cir. Did. di Codogno
• partecipazione progetto POLITE
• organizzazione, in collaborazione con Asses. ai servizi culturali
del Comune di Lodi e Archivio Storico, del corso di aggiornamento
Novecento: il secolo delle donne, tenutosi presso l'aula magna del
Liceo Verri in Lodi
• pubblicazione del quaderno n. 1 delle Pari Opportunità del
Comune di Lodi, con le sintesi degli incontri sul Novecento: secolo
delle donne
• partecipazione al corso per formatori Culture e cultura di genere,
tenutosi presso l'IRRSAE Lombardia
• pubblicazione del quaderno n. 4 delle Pari Opportunità del
Comune di Lodi, Lo sguardo sessuato, strumento di indagine sugli
stili educativi realizzato durante il corso “Differenza di genere e
scuola: dalla ricerca teorica ai percorsi didattici”, con la
12documentazione dei corsi di formazione tenuti dal gruppo negli
ultimi anni
Parlante o parlata ? La donna tra filosofia, linguaggio e prassi
pedagogica
Convegno sull’aspetto filosofico e culturale del linguaggio sessuato.
IL PROGETTO POLITE – PARI OPPORTUNITÀ NEI LIBRI DI TESTO
Il progetto, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, con l’Associazione
Italiana Editori, si colloca all’interno del IV Programma d’azione
comunitaria (1996-2000) a medio termine per le pari opportunità
fra le donne e gli uomini in tutti i settori e le azioni dell’Unione e
degli Stati membri, compresa quindi l’azione educativa nelle scuole
• Il Governo italiano, con la direttiva del Presidente dei Ministri
del 27 marzo 1997, in attuazione agli impegni assunti nella
Quarta Conferenza mondiale delle donne di Pechino, pone tra gli
obiettivi prioritari volti a promuovere le pari opportunità tra
uomini e donne, la formazione a una cultura della differenza di
genere e, tra le azioni specifiche, l’aggiornamento dei materiali
didattici
• L’obiettivo Formazione a una cultura della differenza di genere
intende recepire, all’interno delle proposte di riforma della
scuola, dell’università e della didattica, i saperi delle donne per
promuovere l’approfondimento culturale e l’educazione al
rispetto della differenza di genere
• Le azioni sono rivolte al settore educativo e, in particolare ai
libri di testo, riconosciuti come elemento di particolare interesse
nella politica delle pari opportunità nell’educazione
• Le pari opportunità non sono recepite quindi come problema da
risolvere, ma come azioni o progetti che danno valore e visibilità
alle culture e alle competenze dei due generi
La produzione, l’adozione e l’uso dei libri di testo devono
armonizzarsi ai principi cui si ispirano per non apparire come una
limitazione della libertà culturale e didattica di editori, docenti e
discenti.
13PARTNER EUROPEI
9 Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le
Pari Opportunità
9 Ministero della Pubblica Istruzione
9 AIE, Associazione Italiana Editori
9 Cisem, Centro Innovazione Sperimentazione Educativa
Milano
9 Poliedra, progetti integrati
9 Commissão para Igualidade e para os direitos das mulheres
del Portogallo
9 Emakunde- Istituto vasco de la mujer
9 Federación de Gremios de Editores de España
IL LIBRO DI TESTO IN ITALIA
• È destinato a soggetti in età scolare (6- 19 anni) che ne
fanno uso sotto la guida di docenti
• L’attenzione all’identità di genere deve tener conto del
contesto normativo- educativo- cognitivo
• Non è l’unico strumento didattico in uso nelle classi
• Piena libertà valutativa della funzionalità delle/i docenti che
lo adottano
• L’impegno allo sviluppo, culturale e critico, dell’identità di
genere
IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEGLI EDITORI AIE
L’editore è impegnato ad operare per una sempre più puntuale
qualificazione dei libri che propone per l’adozione, anche nel
senso di una specifica attenzione allo sviluppo dell’identità di
genere e della cultura delle pari opportunità, in quanto aspetti
decisivi dell’educazione dei soggetti in formazione, di entrambi i
sessi.
L’editore, nel rispetto dell’impostazione culturale e scientifica di
ciascuna opera, ha cura di verificare l’idoneità a soddisfare,
anche sotto il profilo dell’identità di genere e dello sviluppo di
una cultura delle pari opportunità, le esigenze di coloro a cui è
rivolta, tenendo conto dell’età, delle diverse sensibilità, nonché
14delle specifiche caratteristiche degli argomenti di studio a cui la
trattazione fa riferimento.
L’editore è impegnato ad operare per una sempre più puntuale
qualificazione dei libri che propone per l’adozione, anche nel
senso di una specifica attenzione allo sviluppo dell’identità di
genere e della cultura delle pari opportunità, in quanto aspetti
decisivi dell’educazione dei soggetti in formazione, di entrambi i
sessi.
L’editore, nel rispetto dell’impostazione culturale e scientifica di
ciascuna opera, ha cura di verificare l’idoneità a soddisfare,
anche sotto il profilo dell’identità di genere e dello sviluppo di
una cultura delle pari opportunità, le esigenze di coloro a cui è
rivolta, tenendo conto dell’età, delle diverse sensibilità, nonché
delle specifiche caratteristiche degli argomenti di studio a cui la
trattazione fa riferimento.
LE AZIONI
Nel primo anno il progetto ha elaborato una ricerca sugli
interventi effettuati nei Paesi europei in merito alle pari
opportunità e ai libri di testo, nonché il Codice di
autoregolamentazione delle case editrici, autori ed autrici
Nel secondo anno sono stati progettati e prodotti:
9 vademecum per autrici ed autori con saggi ed esemplificazioni,
disciplinari e/o trasversali, per l’elaborazione di un testo che
tiene conto delle culture di genere
9 corso di aggiornamento per docenti
9 video didattico
9 concorso di idee per gli/le studenti
9 ricerca validazione con soggetti del mondo dell’istruzione
9 approfondimento sulle buone prassi nei Paesi europei
9 sito internet www.aie.it/polite
Nel terzo anno è stato prodotto un nuovo vademecum per
autrici ed autori che propone contributi per le discipline che non
erano comprese nel testo precedente, approfondimenti per
discipline già comprese e la raccolta delle sperimentazioni in
atto nelle scuole, associazioni o istituzioni legate al mondo della
formazione
15IL GRUPPO DIADE E POLITE
• Il gruppo diade partecipa al progetto a partire dalla fase due, in
un incontro presso la sede dell’Associazione degli editori, a
Milano nel 2000
• Presenta la propria storia e i lavori prodotti, raccolti nel libro
Pensare, dire, fare nella differenza.
• In quella sede i partners europei raccontano i propri lavori,
l’approccio, le proprie ricerche. Un’affinità teorica e anche
operativa è stata trovata con le colleghe spagnole.
PUNTI FORTI E DEBOLI DI POLITE
I punti forti sono sicuramente quelli espressi chiaramente
nel codice di autoregolamentazione e insiti in tutto il progetto nelle
sue ampie articolazioni.
A mio parere ne va sottolineato uno ulteriore: nella
presentazione dei progetti e delle azioni in atto nelle scuole di ogni
ordine e grado, è emersa una realtà sconosciuta, sia
numericamente che geograficamente. Non è di poco conto infatti
sapere quali e quante scuole si occupano di differenza di genere e
in che modo ed è stato interessante anche conoscere una ricchezza
e una varietà di proposte inaspettate.
Il punto debole è stata la conclusione stessa di Polite o una
sua mancata evoluzione che poteva aprire scenari ancora più
interessanti e, aggiungo io, di ricerca. Dico questo perché quello di
cui c’è la necessità è la ripresa di sperimentazioni monitorate.
TRA LINGUAGGIO E ICONOGRAFIA
9 Che cosa è successo in questi anni dopo Polite nelle scuole
che vi hanno aderito?
9 Che cosa è cambiato nei libri di testo?Quante case editrici
hanno aderito il Codice di autoregolamentazione? Come è
stato tradotto concretamente il codice?
9 E infine, oggi, anno europeo delle ari opportunità, nelle
scuole si parla e, in che modo, di differenza di genere?
16I QUESTIONARI
Per rispondere occorreva dotarsi di uno strumento che
permettesse di ricavare informazioni.
Ho quindi preparato e sottoposto al gruppo due questionari,
uno per le scuole che avevano aderito a Polite e uno per
l’AIE(Associazione Italiana degli Editori).
I questionari dovevano essenzialmente aiutare a capire se
nelle scuole i progetti erano continuati, in quali discipline, se solo
in quelle originarie o anche in altre, e se quindi la partecipazione
delle/i docenti era rimasta invariata o aveva subito modifiche nel
tempo, e in quale misura.
Rispetto agli editori: sapere quanti vi avevano aderito, se
nel tempo le adesione avevano subito aumento o decremento,
leggere la situazione attuale anche alla luce delle recenti modifiche
dei libri di testo seguiti all’applicazione della legge 53, legge
Moratti.
QUESTIONARIO PER LE SCUOLE PER LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DOPO
POLITE
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA:
…………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO:
………………………………………………………………………………………
N° DI TELEFONO:
…………………………………………………………………………………………
FAX:
…………………………………………………………………………………………
E-MAIL
…………………………………………………………………………………………
INSEGNANTE REFERENTE:
…………………………………………………………………………………………
N° CLASSI COINVOLTE:
…………………………………………………………………………………………
N° INSEGNANTI COINVOLTE E DISCIPLINE:
17…………………………………………………………………………………………
1. Secondo le aspettative enunciate, le attività presentate
all’interno di Polite hanno prodotto risultati positivi per gli/le
studenti?
SÌ NO
2. Le/gli studenti hanno giudicato le attività:
favorevolmente sfavorevolmente
3. I genitori hanno giudicato l’esperienza:
favorevolmente sfavorevolmente
4. I progetti sono proseguiti anche dopo la conclusione di Polite?
SÌ NO
5. Se no, perché?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Se sì, con le stesse insegnanti
con altre insegnanti
si sono aggiunte altre docenti
altro………………………………………………………………
7. Nei progetti è stato differenziato il linguaggio per il femminile e
il maschile?
SÌ NO
8. Se sì, quali sono state le discipline interessate al linguaggio
sessuato?
lingua italiana
area scientifica
area espressiva
area umanistica
altro……………………………………..
9. Sono stati prodotti dei testi con il linguaggio sessuato?
SÌ NO
10. Se sì, i testi sono usati nelle classi?
SÌ NO
1811. Se vi fosse proposto, partecipereste ad una sperimentazione
sul linguaggio sessuato?
SÌ NO
12. Siete disposte a rivisitare l’insegnamento della vostra disciplina
con l’ottica del linguaggio sessuato?
SÌ NO
LE RISPOSTE
9 Le scuole che avevano partecipato al progetto Polite
appartenevano a tutti gli ordini, dall’Infanzia alla secondaria di
II grado.
9 Alcune sono state coordinate dall’IRRE (Liguria e Veneto), altre
dalla Commissione Pari Opportunità (Comune di Bazzano-
Bologna).
9 Erano rappresentative delle diverse realtà italiane: dal nord, al
centro, al sud e alle isole.
A DISTANZA DI SETTE ANNI LE PROBLEMATICHE EMERSE
9 Alcuni istituti intanto, a seguito di nuova organizzazione
scolastica, fanno parte di dirigenze diverse
9 Alcune docenti hanno lasciato la scuola per anzianità di servizio,
mentre qualcuna si è trasferita in un altro istituto
9 In alcune realtà sono cambiati anche i dirigenti
NONOSTANTE QUESTO
9 Tutte le scuole sono state contattate, tranne una /il telefono
squilla, ma non si ha risposta)
9 Vi è stata una buona attenzione all’iniziativa proposta dal
gruppo diade e una altrettanto interessamento e contributo di
tutto il personale scolastico (collaboratori, segreteria, docenti)
HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO IL 61,5% DELLE SCUOLE CONTATTATE
9 Per tutte, le aspettative enunciate e le attività presentate
all’interno di Polite hanno prodotto risultati positivi tra le/gli
studenti
199 Le studenti hanno giudicato le attività favorevolmente, così
come per i genitori, tranne in un caso perché non c’è stato il
loro coinvolgimento
9 I progetti sono proseguiti anche dopo Polite nella maggioranza
delle scuole, tranne in due casi: in uno per mancanza di
opportunità didattiche, così come scrive l’insegnante, e nel
secondo, perché l’esperienza è stata limitata al progetto.e per lo
più con le stesse insegnanti, in tre situazioni con nuove docenti
9 In tutte le proposte, all’infuori di una, è stato differenziato il
linguaggio per indicare il genere
9 All’uso del linguaggio sessuato sono state interessate sia le
docenti di lingua italiana, ma nella maggior parte dei casi anche
le docenti di storia, di filosofia, ma anche della sola area
scientifica, così come dell’area espressiva
9 Solo in tre casi sono stati prodotti testi in cui gli studenti hanno
usato il linguaggio sessuato, gli stessi che hanno poi utilizzato i
testi in classe
9 Tutte/i le/i docenti si sono detti interessati a partecipare ad una
sperimentazione che voglia attuare l’uso del linguaggio sessuato
e si dicono disponibili a proporre la propria disciplina utilizzando
un linguaggio che tenga conto del genere
QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI EDITORI DI TESTI SCOLASTICI PER UNA
RILEVAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
POLITE
Solo una casa editrice ha risposto al questionario:
Paravia-Bruno Mondadori Editori
• La sua casa editrice ha sottoposto all’attenzione delle autrici e
degli autori dei suoi testi destinati alla scuola quanto previsto
dal codice di autoregolamentazione Polite? Il codice prevedeva
infatti, tra l’altro, la lettura dei due volumi di “Saperi e libertà”
da parte di autrici e autori di testi. Ciò al fine di non
condizionarne l’interpretazione creativa di programmi e
indicazioni, limitandosi ad offrire spunti di riflessione nella
direzione dell’identità di genere, maschile e femminile.
x SÌ NO
20• Esponga sinteticamente gli effetti di tale pratica, se la risposta è
SI. Se la risposta è NO dica a quali altre strategie è ricorsa la
sua casa editrice per provocare l’attenzione di autori e autrici
alla identità di genere.
• Maggiore attenzione all’insegnamento di tematiche relative alle
questioni delle differenze di genere e delle pari opportunità –
specie in alcune discipline – e uso sorvegliato di un lessico e di
un linguaggio adeguati al superamento di stereotipi radicati.
• Attualmente le case editrici adottano altre misure previste dal
codice di autoregolamenta-zione?
SÌ x NO IN PARTE
• Se sì o in parte, è possibile conoscere quali?
• Pensa che il quadro di riferimento normativo e culturale sia
cambiato dopo l’approvazione del codice (1999) e dopo un
tempo ragionevole perché i suoi effetti potessero manifestarsi
nei testi ad esso ispirati (circa due anni ) e che sia perciò
opportuno ripensare la questione dell’identità di genere in
termini nuovi?
SÌ x NO
• Se il codice e/o il vademecum sono superati può indicare le parti
da rivedere?
Forse potrebbe risultare opportuna un’indicazione a
confrontare la nostra esigenza di attenzione alla cultura delle
pari opportunità e a quelle delle differenze di genere anche in
riferimento ad altre esperienze culturali presenti nel nostro
paese (in particolare quelle riferibili all’emigrazione da paesi a
maggioranza musulmana)
• Complessivamente che cosa è cambiato a suo giudizio nella
domanda dei docenti e nei bisogni formativi degli studenti?
E’ aumentata la sensibilità al problema che è entrato nella
prassi quotidiana di insegnamento. In relazione ai contenuti
culturali espressi dal Codice, la domanda originaria sembra
soddisfatta quanto a sollecitazioni, attenzioni e dichiarazioni di
intenti. Quanto all’efficacia formativa di queste iniziative, molto
resta ancora da fare.
21L’attenzione a queste tematiche va tenuta desta e
sviluppata attraverso riflessioni e proposte che considerino più
in profondità la questione delle differenze di genere in rapporto
all’apprendimento e agli stili cognitivi, soprattutto nelle
discipline scientifiche.
I MATERIALI PRODOTTI DA POLITE
Vademecum I
• Prefazione di KATIA BELILLO
• Introduzione di ETHEL SERRAVALLE
• ANNA MARIA AJELLO, Le differenze di genere negli studi su
apprendimento e sviluppo Le differenze di genere analizzate in
alcuni contributi della psicologia sui temi dello sviluppo e
dell’apprendimento per capire in modo più approfondito come
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, si rapportano con i
diversi saperi.
• ADRIANA CAVARERO, Il principio parità I principi del patriarcato e il
principio di uguaglianza nella storia della filosofia così come
vengono proposti nei manuali scolastici.
• CECILIA ROBUSTELLI, Lingua e identità di genere Riflessioni sul
rapporto tra la lingua e l’identità di genere: i cambiamenti
linguistici volti a superare il sessismo linguistico come parte del
processo più ampio di costruzioni dell’identità di genere.
Vademecum II
• Prefazione di ISABELLA PERETTI
• Introduzione di ETHEL PORZIO SERRAVALLE
• SANDRO BELLASSAI, Il maschile, l’invisibile parzialità. La parzialità
maschile nella storia: i condizionamenti esercitati sul genere
maschile dagli stereotipi che li riguardano, la sua onnipresenza
nella storia.
• TAMAR PITCH, Diritto e diritti Un interessante contributo sulla
decostruzione del diritto da parte della critica femminista.
• LIA MIGALE, Obiettivi didattici di un’economia non neutrale Spunti
per l’insegnamento della disciplina economica in un’ottica
attenta alle differenze di genere.
• LIA MIGALE, Le donne e la scienza economica L’economia ha
ignorato per lungo tempo gli aspetti di genere escludendo la
presenza femminile dai suoi studi. Il saggio non intende solo
soffermarsi su quanto e come le donne abbiano in realtà
22contribuito ai processi produttivi nelle varie epoche, ma anche
considerare il loro attuale apporto alla produzione di ricchezza.
• MARIA INDELICATO, Insegnamento dell’economia e valore
femminile Accorgimenti e strumenti per intervenire
nell’insegnamento dell’economia per fare sì che ambedue i
generi siano ugualmente rappresentati e valorizzati.
• VALERIA POMPEJANO, Lingua francese e identità di genere Le
rappresentazioni del femminile nella lingua francese:
problematiche molto simili a quelle presenti nella nostra lingua
e le soluzioni adottate.
• VALERIA POMPEJANO, Lingua francese e scrittura femminile
Caratteristiche della scrittura francese al femminile.
MAURA PALAZZI, Riattraversare la storia contemporanea. Riflessione
sull’introduzione di una prospettiva di genere nei testi di storia in
particolare in quelli inerenti l’Ottocento e il Novecento.
GIGLIOLA BOZZI TARIZZO E BARBARA MAPELLI, Generi e orientamento.
Le differenze tra uomo e donna nell’orientamento dei
ragazzi/ragazze sia dal punto di vista scolastico e professionale, sia
da quello esistenziale.
Documenti:
Il codice di autoregolamentazione Polite
Il documento accompagnatorio al codice Polite
Il progetto Polite
IL CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DU CÔTÉ DES FILLES
L'Associazione europea “Du Côté des Filles” è nata in Francia, nel
1994, allo scopo di
9 elaborare un programma per eliminare il sessismo dal materiale
educativo
9 promuovere rappresentazioni anti-sessiste nel campo
dell’educazione
9 produrre e diffondere strumenti di sensibilizzazione diretti a
case editrici, illustratrici e illustratori, genitori, organismi
istituzionali.
L’Associazione ha scelto come linea di ricerca gli albi illustrati
destinati ai bambini da 0 a 9 anni.
23Nel corso degli anni 1996 e 1997 l'Associazione ha realizzato una
ricerca in tre Paesi (Francia, Italia e Spagna) al fine di indagare
quanto e come i bambini percepiscono il valore simbolico delle
immagini alle quali sono esposti e il loro grado di interiorizzazione
dei ruoli sessuali.
Inoltre intendeva verificare la consapevolezza da parte degli adulti
(genitori ed educatori) dell’esistenza, negli albi, di immagini che
trasmettono ruoli sessuali stereotipati.
L’indagine è stata svolta su campioni di 50 bambini (25 maschi e
25 femmine) fra i 7 e i 10 anni) di ciascuno dei tre
paesi,appartenenti alla cosiddetta “classe media”e su quattro
gruppi di una decina di adulti, uomini e donne, fra i 35 e i 45 anni
vicini al mondo dei bambini (genitori, educatori, bibliotecari).
IL MATERIALE E GLI INTERROGATIVI POSTI
L’associazione ha prodotto due ricerche:
9 Quali modelli per le bambine? Una ricerca sugli albi illustrati
9 Cosa vedono i bambini sugli albi illustrati? Risposte sugli
stereotipi
Nella prima sono riportati gli elementi indagati e i dati della
ricerca; nella seconda vi sono i messaggi degli stereotipi e le
risposte dei bambini.
Si legge che gli albi mostravano una immagine maschile del mondo
con una maggiore presenza di figure maschili sia nei ruoli principali
che in quelli secondari, sia con personaggi umani che con animali o
oggetti antropizzati
La famiglia è il quadro privilegiato di molti albi e, molti di essi, la
presentavano così come spesso la si poteva descrivere nella realtà:
madre casalinga occupata nei lavori domestici e nella cena quando
il marito/padre torna a casa la sera, stanco e affaticato e si
sprofonda sulla poltrona davanti al televisore.
Negli albi però cominciavano ad affacciarsi bambine intelligenti,
buone studenti, vivaci e più intraprendenti dei maschi; un
controstereotipo che anche nelle scuole era conosciuto e al quale si
associavano i vecchi stereotipi attribuiti alle femmine di frivolezza,
civetteria, invidia, gelosia…
24Anche per i maschi cominciavano ad apparire bambini più sensibili
e più gentili con le bambine.
Gli albi presentavano una prevalenza di relazione genitori/bambino
che genitori/bambina.
Il bambino è più incoraggiato e ricompensato delle bambine verso
la quale i genitori rivolgono più divieti e imposizioni.
Più frequentemente le bambine aiutano la mamma, si occupano
del fratellino e sono coinvolte in situazione amorose. Anche il loro
abbigliamento è maggiormente arricchito di fronzoli.
Si vuole continuare a mostrare questo modello di famiglia e questi
stereotipi o è possibile mostrare modelli diversi?
Questo stereotipo lo si vuole mettere in discussione o ratificare?
LA SITUAZIONE ATTUALE
Il lavoro condotto dall’associazione, così come afferma la
presidente di Du Côté des Filles, Adela Turin, è stato lungo,
impegnativo e costoso.
Molte cose sono cambiate rispetto all’indagine pubblicata nel 1998,
sia a livello di linguaggio che di immagini.
Nella situazione attuale non vi sono i mezzi per condurne una
analoga e mostrare le modificazioni avvenute nel tempo.
LE PROPOSTE DEL GRUPPO DIADE
La giornata che il gruppo diade ha organizzato sul tema della
differenza di genere, in particolare sul linguaggio sessuato, non
vuole essere un ennesimo tassello su un argomento che continua
da molti anni a essere proposto e destinato a chiudersi nell’arco di
un progetto o di un breve interesse.
A distanza di oltre vent’anni dalle indicazioni espresse da Alma
Sabatini sul libretto edito dal Ministero della Pubblica Istruzione, Il
sessismo della lingua italiana, il gruppo
9 chiede al Dirigente dell’USP di Lodi, di inviare una lettera a tutte
le scuole lodigiane in cui si sottolinea l’attenzione al linguaggio
che tiene conto della esplicitazione del genere.
9 intende fare da collettore, tra le scuole del territorio, affinché il
linguaggio sessuato possa diventare argomento di studio, di
interesse e di confronto, dentro e fuori dalla scuola, nel mondo
della comunicazione, e in quello delle istituzioni perché quanto
25da tempo si sta elaborando, possa concretizzarsi in azioni che
facciano divenire prassi comune l’uso non sessista della lingua.
9 sottoscrivere, insieme alle istituzioni, un Protocollo d’Intesa per
l’uso non discriminante della lingua.
I RINGRAZIAMENTI
A quante, hanno contribuito all’indagine su dopo Polite.
• prof. BARBARA MAPELLI, docente università di Milano Bicocca
• prof. ETHEL SERRAVALLE, consulente dell’AIE, sottosegretaria nel
governo Berlinguer, ha partecipato alla conferenza delle donne
di Pechino
• prof. CLAUDIA ALEMANI, CISEM, Milano
• prof. ADELA TURIN, presidente dell’associazione Du Côté des Filles
• prof. ELISA PAPPALARDO, ist.tec. “Grimaldi”- Cosenza
• prof. SABINO, ist.”Pentas”- Matera
• prof. ALBA GALLO, Magistrale “Villari”- NapoliI
• prof. IDA FORNARIO, Regione Campania
• prof. STELLA BERTUGLIA, ITIS “Volta”-Palermo
• prof. GRAZIELLA ARAZZI, IRRE Liguria
• prof. VALERIA ONGARO, IRRE Veneto
• prof. LETIZIA LAMBERTINI, Comm. P.O. Comune di Bazzano (BO)
• prof. ITALIA TINTO, 3° Circolo di Arzano- Napoli
26Danila Baldo
Liceo “Maffeo Vegio”, Lodi
La rivoluzione copernicana del linguaggio
"Il linguaggio non è mai neutro" scrive la filosofa Luce Irigaray.
E commenta Ida Travi “questo appare evidente, anche stando alla
lettera. Faccio l’esempio più diffuso: quando si intende parlare di
genere umano, filosoficamente inteso come categoria di esseri
umani, generalmente si dice "l’uomo". "I pensatori ci avvertono
subito che quest’"uomo", inteso filosoficamente, include anche la
donna. Certo la include. È questo il punto. Perché questa
inclusione, che in realtà è un’esclusione? Cosa rende ovvia questa
dimenticanza, questo colossale lapsus? Che cosa ha impedito, nel
tempo, l’adozione stabile di un termine che esprimesse l’intera
categoria degli ‘esseri umani’ e ne accogliesse entrambi i generi? È
innegabile, si prova e si riprova a girare i concetti, le frasi, ma il
linguaggio opera sempre spostamenti, volge al maschile: non è
stato facile diventarne consapevoli. È un capogiro, una improvvisa
vertigine: siamo di fronte a un ritardo della coscienza, a una
rimozione storica, a una forma d’esclusione così grande da
costringere le donne ad alzare la mano per esprimersi con lo
stesso linguaggio che le nega.”
Io penso che non sia essenzialmente una questione di
lingua, ma di testa, di mente: di mentalità. Il fatto che (solo per
fare uno tra i tanti esempi) Samantha Cristoforetti, prima donna
astronauta, sia chiamata “Il capitano” non centra nulla con la
lingua (ormai lo Zingarelli ha declinato al femminile più di 800
professioni), ma col fatto che appunto finora non ci sono state
donne al comando nell’esercito, nell’aviazione o in istituzioni simili,
per cui la professione (o l’incarico o il titolo) esiste nell’uso comune
solo al maschile e il femminile (la ministra, la sindaca, la prefetta,
l’avvocata, la notaia… la capitana) o crea disagio o “fa ridere”
come tutto ciò che è inusuale e crea imbarazzo… Susanna Camuso
va benissimo che sia chiamata con orgoglio “segretaria della CGIL”
nelle riviste femminili, che giustamente vogliono sottolineare il
genere (e le persone più illuminate persino in campo maschile lo
riconoscono), ma nei documenti ufficiali deve essere ”Il segretario
27generale”, perché finora è sempre stato così e che senso ha
cambiare? Qui non si sta giocando, qui ci si occupa di cose serie, il
segretario generale di un sindacato, in un tempo di crisi come
questo poi, ha un compito importantissimo e non deve interessare
a nessuno che sia uomo o donna, basta che faccia bene ciò che
deve fare! Che senso ha cambiare, quando segretaria fa venire in
mente l’aiutante di un capo e non certo un capo in persona?
Appunto, dal mio modesto punto di vista di insegnante, per
esempio, il senso potrebbe proprio essere quello di orientare le
nostre alunne a riconoscere la possibilità anche per loro, donne, di
assumere una posizione di comando e non solo una posizione
subordinata!! La filosofa Luisa Muraro dice: “Se nominiamo al
maschile le donne che sono nei posti di comando, che messaggio
diamo? Che il femminile è buono per sgobbare (contadina, operaia,
commessa…) ma non per dirigere?”. Ecco, ora è venuto il
momento (Se non ora quando? Ma questo “ora” deve ancora
concretizzarsi completamente!) di effettuare la rivoluzione
copernicana femminile del linguaggio. Niccolò Copernico effettuò
una rivoluzione nell’astronomia (dal geocentrismo
all’eliocentrismo), Immanuel Kant produsse la sua rivoluzione
copernicana nella filosofia (dalla centralità dell’oggetto da
conoscere alla centralità del soggetto conoscente), a noi (noi chi?
Femministe, donne consapevoli, capitane coraggiose…) compiere la
nostra rivoluzione copernicana del linguaggio: dobbiamo osare
chiamarci al femminile anche laddove il fare ciò viene preso solo
come una perdita di tempo o una questione di lana caprina!! Che
cosa ci insegna la storia? Che il copernicanesimo ha impiegato ben
due secoli per essere riconosciuto dalla Chiesa e dalle Università
(passando attraverso il rogo di Giordano Bruno e l’abiura di
Galileo), per cui è probabile che la nostra generazione non vedrà
attuata questa rivoluzione, che noi possiamo solo incominciare
(Luce Irigaray ha definito il ‘900, secolo delle donne, l’anno zero
della rivoluzione femminile) e possiamo solo scegliere fra il rogo o
l’abiura, scelta quest’ultima che la gran parte di noi fa (non certo
solo Camusso, che anzi possiamo anche comprendere nella sua
posizione), per quieto vivere, perché occorre anche pensare ad
altro… io stessa, devo ammetterlo, ho spesso avallato verbali di
commissione di Esami di Stato firmandomi come “il segretario” e
accettando di definire “il presidente” una dirigente scolastica
28presidente e di scrivere “i commissari” e “i candidati” anche se il
90% era di genere femminile! Certo avrei potuto rifiutarmi di farlo,
imporre il femminile, far verbalizzare qualcun altro o altra… non ne
ho avuto il coraggio. La soluzione? Essere in tante a volerlo, a
esserne coscienti, a darci forza a vicenda, a sapere che un
cambiamento di mentalità epocale come questo aiuterebbe
senz’altro anche altre sfere, influenzate dal simbolico, molto più
materiali e quotidiane, come quelle in cui la violenza contro le
donne si manifesta in modo più cruento e pesante che non la sola
cancellazione linguistica.
Ora, poi, è intervenuta anche l’Accademia della Crusca a
indicare che occorre superare la discriminazione linguistica nei
confronti delle donne nel linguaggio, soprattutto delle pubbliche
amministrazioni che devono dare l’esempio. E, tanto per citare un
caso che deve fare strada, è dal maggio 2012 che i 5 mila
dipendenti del comune di Firenze sono stati invitati a non
trascurare più le donne nel linguaggio amministrativo, sia che si
tratti di delibere, bandi di concorso o semplici lettere. E quindi si
scriverà architetta, avvocata, assessora, sindaca, e così via.
Nessun dubbio, quindi. Se dire ministra o prefetta suona strano, il
problema è nostro, non delle parole assolutamente perfette. Tutto
questo e molto altro è nelle linee guida che sono state distribuite
ai/alle dipendenti comunali e che sono il frutto di un’idea del
Comitato pari opportunità del Comune con la collaborazione
dell’Accademia della Crusca e la direzione scientifica di Cecilia
Robustelli, docente universitaria di linguistica a Modena e profonda
esperta del tema che ha materialmente elaborato il documento.
Sia Cecilia Robustelli, sia Cristina Giachi assessora alle Pari
Opportunità del comune di Firenze, hanno tenuto a sottolineare
che non si tratta di vetero-femminismo ma di un’operazione senza
rigidità che però vuole dare il via ad un cambiamento culturale.
Una richiesta simile è stata fatta dal movimento SNOQ Se
non ora quando al Comune di Lodi.
Ecco alcuni principi da seguire:
1. la lingua italiana non ha il genere neutro. Ogni volta che si
scrive i ragazzi per intendere ragazzi e ragazze si sta
semplicemente usando il maschile. La lingua italiana contiene
invece tutte le indicazioni per utilizzare il femminile anche se
ancora non è in uso
292. non esistono parole “brutte” e se esistono non sono solo quelle
di genere femminile, ci sono invece parole “nuove” con cui
dobbiamo prendere confidenza come assessora, più che brutto
semplicemente inusuale. Oppure: consigliera, ministra, architetta,
avvocata, chirurga, commissaria, critica, deputata, prefetta,
notaia, sindaca
3. se ci si riferisce a una donna è necessario usare sempre il
genere femminile e non maschile (sia che sia specificata con nome
e cognome sia che non lo sia) nel corpo del testo come
nell’intestazione, nell’indirizzo, nelle formule d’esordio, nella firma
e, dove presente, nell’oggetto;
4. il genere femminile deve essere evidente: es. i dipendenti non
può essere usato da solo ma va fatto capire che ci si riferisce
anche alle donne, dunque i dipendenti e le dipendenti. Oppure nel
caso di lavoratori/trici, meglio usare le parole estese
lavoratori/lavoratrici
5. si può aggirare il problema ricorrendo a parole che non hanno
riferimenti al femminile o al maschile, ad esempio: il personale
invece di lavoratori/lavoratrici
6. si può aggirare il problema anche attraverso l’uso della forma
passiva: la domanda deve essere presentata invece di scrivere i
dipendenti e le dipendenti devono presentare la domanda…
7. in testi informali si possono usare forme abbreviate. Bocciato
ragazz* che invece appesantisce la lettura
8. in alcuni casi, come nei bandi di concorso, si può usare anche
soltanto il maschile nel testo per non appesantirlo troppo se è
necessario fare molti raddoppi maschile/femminile e poi
aggiungere una nota di precisazione scrivendo: I termini maschili
si riferiscono a persone di entrambi i sessi. Oppure: Le offerte di
lavoro sono valide sia per uomini che per donne
30Carla Torri
Liceo “Maffeo Vegio”, Lodi
La rappresentanza di genere negli organismi
studenteschi
Nel nostro territorio provinciale la popolazione studentesca
delle scuole superiori ammonta a più di 9.200 unità e l’offerta
formativa dei diversi istituti – 10 statali e 2 paritari – è varia e
articolata, anche negli indirizzi.
L’indagine condotta ha inteso coinvolgere le istituzioni
scolastiche di secondo grado, prendendo in considerazione la
rappresentanza studentesca all’interno della singola scuola
(Consiglio di Classe e di Istituto) e della Consulta provinciale. A
tutte è stato richiesto di fornire i dati riportati nelle tabelle 1 e 2,
utili a “fotografare” la realtà della rappresentanza di genere; hanno
risposto la totalità delle sole superiori statali.
I dati ricevuti dall’istituzione scolastica “Pandini” sono stati
mantenuti separati per plesso (n. 6 e 6b), in quanto i due diversi
indirizzi di studio sono a netta predominanza di genere diverso e
solo la loro presa in considerazione separata può riflettere la vera
realtà della rappresentanza.
Sul totale complessivo della popolazione studentesca, i
maschi rappresentano il 52 e le femmine il 48 %. Più in dettaglio,
sono a dominanza maschile 5 istituzioni scolastiche, di indirizzo
principalmente tecnico: la n. 3 (86%), 9 (74%), 10 (69%), 8
(68%) e 6 (63%). Le studenti rappresentano invece la
maggioranza in 6 scuole, di indirizzo principalmente liceale e
professionale: la n. 4 (87%), 5 (81%), 6 bis (76%), 7 (59%), 1
(56%); solo la n. 2 (53%) è ad indirizzo tecnico.
Esaminando la colonna “rappresentanti di classe” si nota
che negli istituti in cui frequentano più maschi, le ragazze sono
comunque rappresentate, in misura molto vicina alla percentuale
della loro presenza a scuola (vedere n. 3: le iscritte sono il 14%, le
rappresentanti di classe il 13%) e in un caso addirittura maggiore
(n. 9: le iscritte sono il 26%, le rappresentanti di classe il 36%).
Negli istituti in cui sono iscritte più femmine, la loro
rappresentanza rimane prevalente ma con parecchie
31differenziazioni, risultando notevolmente inferiore alla percentuale
della loro presenza a scuola (n. 5), lievemente inferiore (n. 1 e 8 –
Licei), uguale (n. 2 – Tecnico), lievemente superiore (n. 4) e
notevolmente superiore (liceo artistico).
Statistica di Studenti Rappresentanti classe
genere totale M % F % totale M % F %
a.s. 2012/13
Liceo scientifico
“Gandini” con
1 1.025 453 44 572 56 88 42 48 46 52
sez. classica
“Verri” – Lodi
I.T.C.G. “Bassi”
2 1.384 645 47 739 53 122 57 47 65 53
– Lodi
I.I.S. “Volta” –
3 1.485 1.27 86 214 14 127 111 87 16 13
Lodi
1
I.S.S. “Maffeo
4 1.064 134 13 930 87 94 11 12 83 88
Vegio” – Lodi
I.P.S.C.T.
5 640 123 19 517 81 54 17 31 37 69
“Einaudi” – Lodi
I.I.S. “Pandini” –
6 411 257 63 154 37 48 32 67 16 33
S. Angelo lod.
Liceo Artistico
6 232 55 24 177 76 26 2 8 24 92
“Piazza” – Lodi
b
Liceo “Novello” –
7 654 269 41 385 59 60 26 43 34 57
Codogno
I.I.S. “Cesaris” –
8 Casalpusterleng 1.185 809 68 376 32 106 76 72 30 28
o
I.I.S. di
9 695 513 74 182 26 73 47 64 26 36
Codogno
I.T.A.S. “Tosi” –
1 472 325 69 147 31 44 31 70 13 30
Codogno
0
Totali 9.247 4.85 52 4.393 48 842 452 54 390 46
4
32Puoi anche leggere