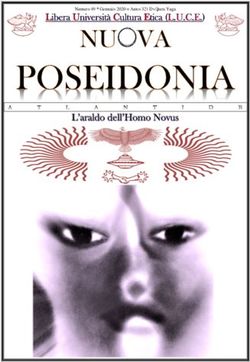Corso di Laurea in Storia Il popolo della terra Memoria collettiva, resistenza ancestrale e riconoscimento politico dei Mapuche del Cile
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
Corso di Laurea in Storia
Il popolo della terra
Memoria collettiva, resistenza ancestrale e
riconoscimento politico dei Mapuche del Cile
Relatore:
Prof. Javier Pablo Grossutti
Laureando:
Alvise Murazzi
Matricola:
1056450
Anno Accademico 2021/22
1Voglio ringraziare Guillermo Jaque Calfuleo, studioso, artigiano e artista della
comunità mapuche di Puquiñe, senza il quale non avrei potuto orientarmi in
questo lungo racconto, e Pilar Reuque, rappresentante di COMI in Cile, per i
preziosi consigli.
2Indice
INTRODUZIONE GEOGRAFICA...............................................................................4
1. IL POPOLO DELLA TERRA........................................................................................6
IL CILE NEL 1520........................................................................................................8
LA VITA MAPUCHE..................................................................................................10
2. MAPUCHE E SPAGNOLI...........................................................................................13
ALMAGRO, VALDIVIA E ALTRI CONQUISTADORES........................................14
I TOQUIS DELLA GUERRA DI ARAUCO..............................................................18
L’EPOCA DEI PARLAMENTI o DEI KOYANG.......................................................22
3. MAPUCHE E CILENI.................................................................................................24
L’INDIPENDENZA DEL CILE..................................................................................24
LA PACIFICAZIONE DELL’ARAUCANIA............................................................26
LE LOTTE MAPUCHE NEL ‘900.............................................................................29
DAGLI ANNI ‘60 ALLA DITTATURA......................................................................32
LA DITTATURA DI PINOCHET...............................................................................34
3. DALLA SVOLTA DEMOCRATICA AD OGGI.........................................................36
DA NUEVO IMPERIAL ALLA LOTTA ARMATA...................................................37
L’ESTALLIDO SOCIAL.............................................................................................39
CONCLUSIONE.........................................................................................................41
BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................43
3INTRODUZIONE GEOGRAFICA
Il Cile è un paese che si estende in lunghezza, i cui 750.00 km² si dispiegano
per migliaia di chilometri da Nord a Sud, abbracciato ad Est dalla Cordigliera
della Ande e ad Ovest dall’Oceano Pacifico. Questa forma particolare comporta
l’avvicendarsi di ambienti geografici e morfologici tra i più vari ed estremi, che ne
hanno influenzato in modo preponderante le vicende storiche.
Al Nord, dove corre il confine con Perù e Bolivia, si estende il Grande Norte, una
vasta regione arida caratterizzata dal deserto di Atacama e della cordigliera
Domeyko, nonché dalla bellezza dei suoi paesaggi. L’orografia ed il clima
inospitali hanno da sempre reso questa regione una barriera più che un crocevia
di popoli. Tendenza debolmente messe in discussione negli ultimi due secoli con
lo sfruttamento dei giacimenti di rame e nitrato, voci fondamentali nelle
esportazioni del paese.
Subito a Sud di questa zona desertica ve n’è una seconda, delimitata a Nord dal
fiume Copiapó e a Sud dall’Aconcagua, denominata Norte Chico, dove la catena
montuosa della costa si incontra con le Ande generando valli attraversate da
ampi fiumi. Il clima permane semi-arido sugli altopiani ma l’umidità si concentra
nelle valli, rendendo queste regioni, in particolare il Coquimbo, molto
predisposte alla coltura della vite e dell’olivo.
4Finalmente, a Sud del fiume Aconcagua, inizia il Cile che è anche oggetto del
mio studio: le “floride valli cilene” del regno coloniale di Nuova Extremadura,
come venne battezzato da Pedro de Valdivia nel 1541. Santiago sorge al centro
di un bacino, nel punto in cui le due catene montuose del paese tornano a
dividersi. Una enorme depressione fertile si distende tra le montagne, la
“Depresión intermedia”, srotolandosi fino ad incontrare i climi glaciali del Sud.
Essa è attraversata da numerosi fiumi e da montagne di modeste dimensioni. La
pampa cilena e i boschi si alternano, ed il clima è continentale temperato, le
precipitazioni modeste.
E’ in questa valle che oggi vive la grande maggioranza dei cileni, per lo più
attorno alle zone metropolitane di Santiago, Concepción e Valparaíso.
La “Zona Central” corrisponde quindi grossomodo a 500 chilometri a Sud di
Santiago: a metà della Depresión intermedia v’è un confine naturale che la
divide dalla Zona Sur e che crea in qualche modo un altro Sud: è il fiume Biobío.
Oltre quel fiume la macchia andina lascia spazio alla fitta foresta sempreverde,
che è l’elemento principale. Le regioni prendono i nomi di Los Riòs, Los Lagos,
ad indicare l’eccezionalità idrologica dell’area, piena di laghi azzurri e fiumi
imponenti. Il Sud del Paese è caratterizzata da piogge abbondanti, e vi è anche
un’importante attività sismica legata ai numerosi vulcani della regione.
Infine, oltre il Sud, troviamo le 2 regioni del Chile Australe, Aysén e la regione
Magellano o dell’Antartide cilena. Un enorme territorio glaciale, caratterizzato da
foreste artiche e fiordi, da smisurati arcipelaghi di minuscole isole, e che
comprende le porzioni più meridionali della Patagonia e della Terra del Fuoco.
Queste zone sono da sempre scarsamente abitate, anche lo stretto di
Magellano rimane uno snodo fondamentale per la navigazione tra Atlantico e
Pacifico.
51. IL POPOLO DELLA TERRA
Il termine Mapuche, da Mapudungun Mapu (terra) più Che (gente), indica la più
numerosa etnia indigena del Chile e di alcune parti dell’Argentina. Nella sua
accezione, può variare: come sinonimo di Auracani, ossia gli abitanti
dell’Auraucania propria, o come autodefinizione da parte di numerose
minoranze indigene che si riconoscono nella cultura Mapuche.
Dopo i Quechua e i Ayamara sono il terzo popolo indigeno nell’America Latina di
oggi.
I dati del Cile riferiscono 1 750 000 individui che si dichiarano mapuche nel
2017, quasi il 10% della popolazione, distribuiti prevalentemente nelle regioni
centro-meridionali.
L’economia della minoranza mapuche è basata sulla produzione agricola e la
pastorizia di sussistenza, la pesca o la caccia/raccolta secondo l’ecosistema.
Fondamentale è la conservazione delle pratiche agricole tradizionali, spesso
legate a momenti comunitari. Queste attività vengono complementate da un
provvido artigianato tradizionale di oggetti in legno, tessuti, ceramiche che
hanno un proprio mercato nazionale.
Sulle origini e la definizione del popolo mapuche esistono diverse teorie. I
principali etnologhi che hanno concentrato i propri studi sulla storia Mapuche
all’inizio del ‘900, Ricardo E. Latcham e Tomàs Guevara Silva, offrono tesi
contrastanti: Latchman vide migrazioni di popoli dall’Est, dall’Argentina, Guevara
dal Nord, dall’area andina. Pur sempre migrazioni di popoli esterni che giunti in
Cile costituirono la propria società. Anche la datazione è incerta, ma le ipotesi
più recenti collocano questo periodo vicino al collasso della società Tiahuanaco
(XII secolo).
Da allora, possiamo provare a tripartire concettualmente le vicende del popolo
Mapuche secondo uno schema a noi congeniale, pur consapevoli che esso
porta con sé una prospettiva del tutto soggettiva ed arbitraria. Definiamo quindi
6una preistoria, o una storia antica mapuche, dallo stanziamento ancestrale fino
al 1550, che include la formazione di una cultura specifica e le guerre con il
popolo Inca tra il 1460 ed il 1490. Un’epoca “moderna”, dal 1550 al 1810, che
corrisponde di fatto ai due secoli e mezzo della feroce Guerra di Arauco e della
colonizzazione spagnola.
Infine, l’età contemporanea della storia Mapuche si apre nel 1810 con
l’indipendenza cilena, il riassetto repubblicano e l’istituzionalizzazione della
questione indigena. Essa vede la violenta occupazione dell’Auraucania (1860-
1880), gli espropri e le leggi agrarie del ‘900, le svolte degli anni ‘60-’70, la
dittatura militare fino ad arrivare alle vicende del Chile odierno.
E’ giocoforza leggere la storia di questo popolo nel solco del secolare scontro
con gli invasori, i conquistadores che essi chiamarono Huincas (nuovi inca), gli
spagnoli che divennero cileni.
Nel corso del ‘900 questo si è modificato assumendo le precise caratteristiche
del conflitto mapuche odierno, alle cui fondamenta sono il recupero delle terre
ancestrali sottratte durante il lungo processo coloniale, l’ottenimento del diritto
all’autodeterminazione delle comunità e il riconoscimento delle specificità
culturali.
Alcuni capitoli di questa storia sono aperti: tra 2019 e 2020 il Cile ed in
particolare la capitale, Santiago, sono stati teatro di una serie di accese e
partecipatissime proteste note come Estallido Social, che originate da una
manifestazione contro il rincaro dei trasporti urbani sono divampate ed hanno
incluso una numerosa composizione indigena.
Il governo Piñera si è visto costretto nel 2019 a promuovere la Convención
Constitucional, che dovrebbe riscrivere la costituzione risalente a Pinochet, nella
quale convergono alcune frange dell’associazionismo politico indigena, e nel
2021 ha ceduto il governo del paese ad una coalizione, Apruebo dignidad, nata
dalle stesse forze politiche che hanno animato le proteste.
Senza aver ovviamente risolto le ormai secolari ragioni di questa lotta che è
7ancora talvolta violenta, le nuove svolte politiche insieme ad un consistente
lavoro di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale mapuche offrono
quantomeno una possibilità e una direzione verso la risoluzione del conflitto.
IL CILE NEL 1520
Ad abitare questo enorme territorio vi erano diversi popoli che avevano tra loro
relazioni più o meno amichevoli.
Questi gruppi andarono incontro a destini diversi, e le loro particolarità culturali
subirono importanti stravolgimenti tra l’arrivo degli spagnoli e il ‘900.
I distinguo tra le etnie che abitavano il Cile vero e proprio vanno per lo più fatti
nel seno del macrogruppo dei Mapuche. In generale, possiamo dire che questi
popoli avevano tipologie simili di organizzazione sociale, pur presentando
variazioni in base alla disponibilità e al tipo di risorse del territorio, e che
condividevano l’uso della lingua Mapudungun.
Una visione tradizionale divide il Popolo della Terra in un gruppo centrale, i
Mapuche propri o Auracani, e quattro “famiglie” regionali: pikunches, williches,
lafkenches e pewenches.
Tra il fiume Aconcagua e il Río Biobío, quindi in quella che oggi viene definita la
zona centrale del Cile, viveva il popolo Picunche, dal mapudungun “gente del
Nord”.
Questi conobbero ed ebbero scambi con l’Impero Inca, e furono i primi ad
entrare in contatto con i conquistadores. Fu nel loro territorio ancestrale che
sorsero i primi insediamenti spagnoli, come Santiago e Concepción, e furono
ampiamente e precocemente impiegati come manodopera servile, in particolare
come lavaderos d’oro. Subirono nel corso dei secoli un’importante
castiglianizzazione, e da loro discende gran parte del meticciato cileno di oggi.
8Gli Huilliches, “gente del Sud”, abitavano la zona che va dal Río Bueno a, bene
o male, l’Isla Grande de Chiloé. Questi subirono solo tardivamente l’influenza
spagnola, vivendo molto a Sud del Biobío, e piuttosto si mescolarono con
popolazioni andine o della patagonia.
Altri sottogruppi erano i Lafquenches (gente della costa) che abitavano le
sponde del Pacifico, i Pehuenche (gente dell’auracaria), stanziati nelle valli
andine, e la lista potrebbe continuare.
In generale possiamo affermare che nei secoli successivi all’arrivo dei
colonizzatori spagnoli gli elementi caratteristici di queste particolarità etnico-
culturali subirono un violento mescolamento e livellamento.
Nel profondo Sud vivevano i Tehuelche, i Patagoni che compaiono già nelle
cronache del Pigafetta, il diarista di Magellano. Essi chiamavano sé stessi
Aonek'enk, o Chon, erano dediti alla pesca e allo scambio di pellami con altre
tribù. Subirono tra il XVII e il XIX secolo una “mapuchizzazione” degli usi e dei
costumi, e quelli che non furono inquartierati nella riserve oggi lottano per il
riconoscimento della propria specificità in Argentina.
Vi erano ulteriori popoli originari all’interno del Cile odierno, oltre ai Mapuche. A
Nord, ricordiamo i popoli di lingua Aymara, gli Atacameños del deserto e i Kollas
(o Colla) andini.
A Sud, i Kawésqar e gli Yamana, stanziati anche in Patagonia. L’etnia Rapa Nui,
con la sua misteriosa storia, è a sé stante.
9LA VITA MAPUCHE
I Mapuche, con tutte le specifiche di cui abbiamo parlato nel precedente
capitolo, abitavano dunque all’inizio del ‘500 l’area che va dal fiume Itata, dove
oggi sorge Concepción, e l’isola di Chilloe.
L’assenza pressoché totale di documenti scritti pervenuti a noi da fonti indigene
del XV-XVI secolo implica alcune premesse nell’analisi delle usanze, costumi e
tradizioni dei mapuche “storici”.
Il bagaglio stratificato di credenze religiose e narrazioni rituali si è modificato,
per assimilazione o alterazione. Certamente l’assorbimento di altri gruppi etnici
cileni e argentini ha portato all’innesto di elementi culturali inediti, così come non
possono non aver influito l’evangelizzazione cristiana ed il sincretismo.
All’interno dello stesso contesto mapuche infine esistono numerose discontinuità
e differenze dovute alle caratteristiche delle fonti stesse, su base per lo giù
geografica.
In Cile, fino al 1541, non esistevano insediamenti urbani, né centri politici. I
mapuche vivevano in piccoli clan familari chiamati Lof, che era la forma basica
della società. All’interno di un Lof parentale non esisteva la proprietà privata e la
maggior parte dei lavori era svolto in collettività.
La vita del lof si svolgeva attorno ad un Rehue, tronco sciamanico, da cui deriva
anche l’autorità del Lonco, il capo della comunità, che in mapudungun significa
“testa”.
I lof di una provincia o di una zona potevano riunendosi dar vita a un Aillarehue,
“nuovo Rehue”, per lo più in occasioni di celebrazioni religiose o sociali.
Era usanza tra i Mapuche compiere lunghi viaggi accompagnati da tutto il lof
familiare con l’intento di visitarne altri appartenenti al medesimo Aillarehue, per
scambiarsi doni, merci, racconti.
In casi eccezionali, come la guerra, i Loncos a capo dei clan familiari si
10riunivano in un’ulteriore e più ampia confederazione, il Butalmapu. I butalmapu
tradizionali erano di fatti suddivisioni regionali delle tribù mapuche, e sono così
nominati: Lelfünmapu, la pianura, Lafkenmapu, territorio costiero, Inapiremapu,
la precordigliera andina, “terra con la neve”, e Piremapu, la cordigliera andina
propria “terra della neve”. In quelle occasioni i loncos eleggevano un Toqui, un
capo per la guerra, il cui ruolo durava soltanto fino alla fine del conflitto.
Tutta la quotidianità ed i rapporti sociali erano codificati secondo Ad Mapu,
l’insieme delle tradizioni, leggi, usanze e conoscenze che venivano tramandate
oralmente all’interno del lof.
Esse derivavano dal riconoscimento e dal rispetto di tre qualità diverse di spiriti
sovrannaturali: i Ngen, potenti entità legate agli elementi naturali o luoghi
simbolici quali fiumi, boschi e monti; e i Pillán o Wangulén, i fantasmi dei
venerabili antenati della tribù, rispettivamente maschili o femminili; infine i
Wekufe, gli spiriti maligni. Tra i pillàn ve ne erano di preminenti, i quali
costituivano un pantheon di divinità comuni a tutti i sottogruppi geografici
mapuche, quali Ngenechén che governa il mondo, Antu e Kuyén, il sole e la
luna, Peripillán, il fuoco, ed Elmapu che creò l’uomo.
A ricoprire il ruolo centrale di intermediazione con i mondi spirituali vi è la Machi,
la sciamana, la quale era anche la guaritrice della tribù e conosceva le
procedure per il Machitún, la cerimonia attraverso la quale invocava gli antenati
per scacciare le influenze maligne o guarire un infermo, o per il Guillatún, il
rituale di supplica verso gli spiriti, nel quale la machi si arrampicava sul Rehue: il
tronco cerimoniale era fabbricato in modo che avesse quattro o sette scalini (ad
indicare i mondi, materiali e spirituali, che l’officiante voleva richiamare).
Accanto alla Machi stava il Ngenpiñ, in mapudungun “signore delle parole”, il
depositario della tradizione filosofica e gnoseologica mapuche, che poteva
svolgere a sua volta il Guillatùn e ricopriva il ruolo di riferimento politico-
religioso.
11Riguardo alla cosmogonia mapuche e alle narrazioni sulla creazione del mondo,
due sono le vicende che mantengono un’omogeneità privilegiata.
All’origine delle cose il Wenu Mapu, la terra di sopra, era oscura. L’essenza
dell’anima del mondo, Pu-am, diede vita ai primi spiriti, i quali divennero gli astri
del cielo e illuminarono il mondo.
Tra di essi spiccava Antu, il sole, che era il pillàn più potente. Egli scelse in
moglie Kuyèn, la luna, generando così l’alternarsi di notte e giorno, ma attirando
su di loro l’invidia di Peripillán, il fratello di Antu, e di tutte le altre stelle. Tra Antu
e Peripillàn si scatenò una lotta fratricida a cui preserò parte tutti gli spiriti. Gli
stessi figli dei due antagonisti, Kaykay e Trentren, si rivoltarono contro i loro
padri. Da questa guerra venne generato il mondo terreno: una volta sconfitti i
suoi nemici, Antu, furioso, fece precipitare i pillàn sconfitti, creando le montagne,
le colline ed i vulcani, che rappresentano la volontà di Perilipillàn di ribellarsi
ancora. Le Wangulén, ossia gli spiriti femminili sconfitti, piansero il loro rimorso
così a lungo da formare i mari, i laghi ed i fiumi.
La seconda storia riguarda Trentren-Vilu e Caicai-Vilu, o Trentren e Kaykay, i
figli rispettivamente di Antu e Peripillàn. Finita la guerra tra gli spiriti e fallita la
loro rivolta, anch’essi furono scagliati su Mapu (la terra), ma anziché divenire
terra o acqua, essi vennero puniti e trasformati in due giganteschi serpenti,
condannati a dimorare e costudire l’uno la terra e l’altro il mare.
Caduti in un lungo sonno, fu Kaykay, nel mare, il primo a svegliarsi e, infuriato,
iniziò a colpire il mare generando inondazioni e diluvi. Trentren si risvegliò
dunque per il gran trambusto e, visti gli uomini che stavano per annegare, provò
per loro pena, e permise loro di salire sulla sua lunga schiena e li poggiò sulla
montagne a cui ordinò poi di crescere in altezza, dando vita alla Cordigliera.
Quelli che non potè salvare, Trentren trasformò in uccelli o pesci, da cui ebbe
origine la varietà degli animali. Ma l’acqua continuava a salire, così i due
serpenti ingaggiarono una titanica lotta che terminò solo quando essi si
stancarono e tornarono a dormire. La forma dei due nemici, addormentati l’uno
accanto all’altro, spiegherebbe la forma del Cile.
122. MAPUCHE E SPAGNOLI
L’autore di romanzi e antropologo, nonché storico ed ex-ministro brasiliano
Darcy Ribeiro definiva così la società auracana al loro incontro con i
conquistadores spagnoli: “si trovavano alle soglie della stratificazione sociale e
dell’unificazione politica, pronti a costituire uno Stato rurale artigianale”. La
complessità dei meccanismi di produzione, giunti a garantire un surplus
alimentare per frange non-rurali, e la capillarità dei fenomeni degli scambi, più
sociali che economici in realtà, avrebbero potuto dare vita a classi o gruppi
sociali prettamente dediti alla guerra, alla religione, all’amministrazione.
Difficile capire se, come sostiene Ribeiro, questo grado di complessità della
costruzione sociale è una “evoluzione mancata”, cui i diversi gruppi che
abitavano l’Araucania sarebbero inevitabilmente giunti se non fosse stato per la
comparsa degli europei, o se, suggeriamo, non si fosse quell’evoluzione
arrestata per una sorta di equilibrio positivo interno.
L’autore riconosce poi alla semplicità delle società mapuche del XVI diversi
vantaggi, il primo e più importante dei quali un’abbondanza di tempo libero da
dedicare alle relazioni interpersonali. In tali condizioni godevano di un ambiente
13sociale ricco, fondata sull’uguaglianza, la larghezza e il gusto di vivere,
derivante dalla convivenza in grandi comunità omogenee, unificate da
medesime tradizioni e visione del mondo”.
Procedendo con il ragionamento, si può affermare che l’assenza di alcune figure
tipiche non solo nella società europea ma anche di quelle inca o maya, quali il
nobile, il sacerdote, il servo/schiavo, rappresentarono per gli auracani un
notevole vantaggio contro gli aggressori spagnoli.
Nelle tristi storie di Monctezuma e di Atahualpa hanno un ruolo da protagonisti le
elitès locali, pronte a cospirare o almeno conciliarsi con gli spaventosi invasori
per mantenere il loro potere e privilegio. Non fu così per i toquis, il cui ruolo era
temporaneo e dipendente dell’accordo tra comunità diverse. Ugualmente, le
grandi masse di prigionieri o nati schiavi degli imperi andini e dello Yucatàn
erano indifferenti agli sconvolgimenti politici dei loro padroni, mentre tra gli
mapuche non esisteva la servitù.
ALMAGRO, VALDIVIA E ALTRI CONQUISTADORES
Il primo europeo a visitare il territorio oggi riconosciuto come Cile fu Ferdinando
Magellano, che nel novembre del 1520 “scoprì” ed attraversò lo stretto che ne
prese il nome. L’esploratore portoghese battezzò la Patagónia e la Terra do
Fogo durante il suo ultimo e celebre viaggio.
A capo della seconda spedizione, che nel 1535, dopo una durissima traversata
della cordigliera andina entrò finalmente nel centro del paese fino al fiume Itata,
c’era Diego de Almagro.
Questi era un hidalgo castigliano, ed incarnava in quanto tale ed al pari dei suoi
compagni, la complessità dell’impalcatura ideologica delle corone di Spagna.
Forgiata da secoli di interminabili guerre di reconquista e conquista, in Spagna
14quanto in Nord Africa, o militando nei temibili tercios nei conflitti in Francia o in
Italia, la piccola ed impoverita nobiltà di Castiglia era nel XVI secolo pronta ad
imbracciare la Croce e la Spada e portarle ai più remoti angoli di quell’Impero
che iniziava a pensarsi universale.
Il lungo conflitto tra i vicini regni cristiani e musulmani aveva permesso lo
sviluppo di sofisticati strumenti, ideologici, amministrativi e giuridico-sociali, atti
alla continua integrazione di territori conquistati e all’inquadramento delle
popolazioni sottomesse.
Fu infatti nelle pianure iberiche strappate al califfato di Toledo prima e di
Cordova poi che per la prima volta si diffuse l’organizzazione della Hacienda,
che verrà poi così largamente utilizzata in America Latina. La particolare e nota
divisione per tipi sociali, quali mozàrabes, conversos, moriscos, marranos,
ecc...; risponde ad una logica ideologica e propagandistica di perpetua
ridefinizione dell’Altro e ne proietta la sua intenzione di conquista.
Infine, occorre risaltare l’ampia cornice religiosa dentro la quale si colloca
l’azione di caballeros e hidalgos.
L’epica eroica dello sforzo nella guerra contro gli infedeli venne
convenientemente indirizzata e razionalizzata dalla Chiesa Cattolica, nel seno
della quale nacquero ordini monastico-militari simili a quelli in Terrasanta come
l’ordine di Santiago e l’ordine di Calatrava. Diversi papi concessero nei secoli i
privilegi di crociati ai soldati spagnoli. Nel fornire legittimazione ideologica alle
conquiste delle corone iberiche giunse simbolicamente la bolla papale Inter
Caetera del 1493, con la quale Alessandro VI, aragonese di nascita, estendeva
fino ai confini dell’ignoto la missione evangelizzatrice e civilizzatrice di Spagna e
Portogallo. Essa precedette il trattato di Tordesillas (1494) che ne precisò la
geografia, e celeberrima bolla Sublimis Deus (1537) attraverso la quale Paolo III
esplicitò che «Indios veros homines esse».
Il dibattito sull’umanità e sulla libertà dei cosiddetti indios produsse in terra di
Castiglia le leggi di Burgos (1512) e le Leggi Nuove (1542), promulgate da
Ferdinando II e Carlo V, di fatto revisioni organiche del sistema delle
15encomiendas.
E prosegì fino ed oltre alla Disputa di Valladolid (1550-51) dove si affrontarono le
visioni contrapposte di Juan Ginés de Sepúlveda, difensore del naturale diritto di
sottomettere gli indigeni, e di Bartolomé de Las Casas, domenicano che come il
suo confratello Francisco de Vitoria propugnavano una precoce concezione dei
diritti umani e della sovranità dei popoli indigeni sulle loro terre d’origine.
Diego de Almagro fu, nel 1531, uno dei soci di Francisco Pizarro nella conquista
del Perù e della violenta fine dell’impero Inca. Insieme essi avevano fondato una
vera e propria impresa, raccogliendo mezzi e uomini, con l’obiettivo di spartirsi i
territori e le ricchezze del Perù. A conquista avvenuta però, i soci iniziarono a
litigarsi titoli e le città, e a Pizarro non restò, per levarsi Almagro di torno, che
promettergli il titolo di governatore di tutte le terre che avrebbe reclamato a Sud.
Almagro, soddisfatto, preparò la spedizione e nel luglio del 1534 partì.
A questa spedizione viene tradizionalmente associata la “scoperta” del Cile.
Almagro portò con sé più di 2000 persone, per la maggior parte yanaconas,
termine utilizzato sia dai mapuche che dagli spagnoli per indicare gli indios inca
utilizzati per il lavoro nelle encomiendas o, come in questo caso, come portatori
e ausiliari in armi.
Attratto come gli altri conquistadores dalla sete di oro e altri preziosi, Almagro
trovò tutt’altro in Cile, affrontando il rigidissimo inverno delle Ande. Giunti
decimati alla regione di Nuble, gli esploratori ebbero in questo frangente il primo
scontro armato con i Mapuche, lungo le sponde del fiume Itata: la battaglia di
Reinohuelén, l’inizio della Guerra di Aràucania. Era il 1536.
Sconfortato, Almagro fece dietro front cercando di riguadagnare la volta del
Perù, scegliendo però stavolta la strada lungo la costa, attraversando perciò il
deserto di Atacama.
In pochi tornarono a Cuzco insieme ad Almagro, ed in condizioni pietose. L’esito
disastroso di questa prima spedizione scoraggiò solo brevemente eventuali
emuli.
16Nel 1541 un altro dei luogotenenti di Pizarro, Pedro de Valdivia, guidò una
seconda spedizione, la quale ebbe più successo. Egli fondò Santiago, l’attuale
capitale del Cile, ed altre città come Serena, Concepción, La Imperial, ed
assoggettò le tribù picunche al lavoro forzato.
Gli spagnoli bramavano il controllo delle valli a Sud del fiume Bìobìo, da cui era
possibile all’epoca ricavare grandi quantità di oro alluvionale. Questo era
necessario al nuovo governatore per far attirare in Cile altri sudditi spagnoli, così
come a legittimare la sua conquista. Tutta la popolazione non europea veniva
impiegata come lavadores, ossia setacciatori, un lavoro molto duro che per gli
indigeni era privo di significato.
Valdivia guidò diverse spedizioni a sud del Bìobìo, sconfiggendo a più riprese le
tribù mapuche ed espandendo il dominio coloniale, fondando piazzeforti e
stazioni commerciali.
In queste occasioni spesso Valdivia dimostrò la sua crudeltà: era usanza
mutilare, tagliando mani o piedi, i prigionieri sconfitti, di modo che servissero da
monito scoraggiando i mapuche.
Il mito dell’invincibilità delle forze spagnole si infrange nel 1553, a Tucapèl, 600
chilometri a Sud di Santiago. Qui Pedro de Valdivia viene sorpreso, con poche
centinaia di spagnoli e qualche migliaio di “yanaconas”, da una soverchiante
forza indigena. Il massacro che ne seguì, nella quale venne giustiziato lo stesso
governatore, portò al primo sollevamento generale mapuche, che durò fino al
1557 e provocò la distruzione di diverse città fondate dai conqusitadores.
E’ in questo periodo che i popoli di etnia mapuche cominiciano ad assimilare
alcune delle arti e delle tecniche degli europei. Impararono a costruire
fortificazioni, a combattere in formazione e divennero maestri nell’arte
dell’equitazione. Sopratutto, si abituarono a formare ampie confederazione
guerriere, i Butalmapu, l’unica formazione politica capace di comporre un fronte
comune contro gli spagnoli.
17I TOQUIS DELLA GUERRA DI ARAUCO
Tra i mapuche, come abbiamo detto, non esistevano nobili, re, governatori. La
concezione fortemente collettivista delle comunità mapuche non da importanza
a dinastie o genealogie, e spesso le fonti spagnole confondono i nomi
attribuendoli ad altri.
Di alcuni capi sappiamo invece abbastanza, anche se le tracce si mescolano
con la leggenda o con il romanzo. I Toquis venivano eletti dall’assemblea dei
loncos, il Aillarehue. Più Aillarehue formavano il Butalmapu, che eleggeva un
Butal-Toqi, o Gran toqui in spagnolo.
Il primo che citiamo è Michimalonco. Egli era un Picunche, abitava la valle del
fiume Aconcagua con la sua tribù, e negli anni precedenti all’arrivo di Valdivia
ebbe incontri e scontri con gli Inca, i quali avevano stabilito in quella zona la più
meridionale delle loro province.
Egli assistette all’assoggettamento delle genti che abitavano attorno a Santiago,
vide le loro miserabili condizioni sotto il dominio spagnolo, raccolse attorno a sé
migliaia di guerrieri e scatenò un violento attacco contro gli invasori.
Santiago de Chile fu quindi ad un passo dalla distruzione l’11 settembre del
1541, poco più di 6 mesi dopo la sua fondazione. I mapuche bruciarono quasi
tutte le costruzioni e uccisero buona parte dei coloni: in questo episodio fu Inés
Suárez, la compagna di Valdivia, a guidare la difesa della città.
La sua figura ha avuto notevole fortuna letteraria grazie ad un romanzo
dedicatole da Isabel Allende. Di fatto, una delle poche donne delle quali siano
rimaste testimonianze rilevanti in tutta la storia della colonizzazione delle
Americhe.
L’attacco contro Santiago non riuscì del tutto, e negli anni successivi gli spagnoli
imposero il proprio controllo su tutto il territorio abitato dai picunche.
Michimalonco terminò i suoi giorni come yanacona, come comandante degli
indios ausiliari al servizio del suo nemico.
18Lautaro, o Leftraru, è forse il più rinomato tra tutti i Toquis mapuche.
La sua figura è stata idealizzata e posta a simbolo complessivo della resistenza
indigena, assurgendo a vero e proprio eroe nazionale cileno, oltre ad essere
uno dei personaggi storici più noti.
In realtà, quello che sappiamo della sua vita si mescola con la leggenda, e con il
personaggio letterario, e certamente assistiamo ad una qualche sorte di
caratterizzazione di stampo politico dell’individuo.
Nacque tra il 1530 e il ‘35, nella regione di Nuble, o forse nell’Araucanìa propria.
Quand’era ancora bambino, il suo Lof fu attaccato dagli spagnoli di Valdivia, e
lui fu catturato, divenendo parte della servitù. Si racconta che fu paggio, o
valletto, del governatore stesso.
Passò alcuni anni sotto il giogo della schiavitù, assistendo alle atrocità
commesse dei conquistadores. Probabilmente covò un grande odio nei confronti
dei sui padroni, e studiò le ragioni del loro strapotere militare. Capì che le
armature e le lame d’acciaio, l’uso della cavalleria e delle armi da fuoco, unite
alla disciplina degli hidalgos permettevano agli spagnoli di sconfiggere forze
indigene enormemente più numerose. Intuì che la debolezza degli invasori era il
loro numero esiguo, sparpagliati su di un enorme territorio.
Nel 1551 fuggì da Santiago e tornò dalla sua gente: era figlio di un lonco,
dovette vincere la reticenza di alcuni, ma infine gli fu permesso di assumere il
ruolo di Toqui e dirigere la guerra contro Valdivia.
A Lautaro si attribuisce l’introduzione dell’uso della cavalleria e delle tecniche di
guerriglia da parte dei Mapuche. Organizzò una gerarchia militare, e un servizio
di spionaggio capace di monitorare i movimenti spagnoli.
Le innovazioni di Lautaro, oltre che la sua predisposizione al comando e il suo
genio miliare, permisero ai mapuche di cogliere la prima importante vittoria, il
massacro di Tuchapel, citato nel capitolo precedente, nel dicembre del 1553.
Lautaro potè sì vendicarsi dell’odiato Pedro de Valdivia, ma non potè
approfittare dell’occasione per cancellare la presenza spagnola in Cile: non solo
19le vari divisioni territoriali mapuche non avevano mai raggiunto un’unità politica,
ma inoltre i riti di guerra prevedevano lunghe ed elaborate celebrazioni, per
festeggiare la vittoria appena ottenuta e per commemorare propriamente i
caduti.
Passarono 2 mesi, durante i quali a Valdivia era succeduto Francisco de
Villagra, ed entrambi gli schieramenti si erano riorganizzati. Lautaro aveva
condotto i suoi guerrieri molti chilometri più a Nord, alla foce del Bìobìo. Gli
spagnoli, di contro, avevano abbandonato dopo la battaglia di Tucapel, molte
piazzeforti del Sud. Lo scontro avvenne il 20 febbraio, in quella che viene
ricordata come Battaglia di Marihueñu. Questo fu un altro enorme successo di
Lautaro e del suo successore, Caupolicàn, nel quale riuscirono ad uccidere
numerosi spagnoli. Successivamente, i mapuche diedero alle fiamme
Concepción e tutti gli insediamenti a Sud del Bìobìo ma, nuovamente, le
cerimonie prescritte dall’Admapu impedirono a Leftratru di cacciare
definitivamente gli spagnoli.
Fu a questo punto che tra i Mapuche si diffuse la prima delle crisi epidemiche
dovute al contatto con gli europei. Probabilmente tifo, o febbre tifoide, quello tra
il 1554 e il 1556 fu un violentissimo focolaio che uccise decine di migliaia di
indigeni. Lo chiamarono Chavalongo, una parola mapudungun che indica un
malessere alla testa: così verranno poi chiamati quasi tutti i mali patogeni che a
più riprese decimarono la popolazione originaria del Chile.
Unito ai sacrifici della guerra e alla siccità, cui succedette una grave carestia
alimentare, il chavalongo disperdette la forza militare cui Lautaro poteva fare
affidamento.
Con poche centinaia di guerrieri marciò ancora a Nord, oltre il Bìobìo, verso
Santiago.
Nel frattempo, iniziò a raccogliere nemici anche tra i loncos, alcuni dei quali
desiderava la fine delle ostilità, e tra i picunche del Nord, i quali, se non si
univano alla causa di Lautaro, ne subivano le ire.
20Il 30 aprile 1557 Villagra organizzò un’imboscata, la battaglia di Mataquito,
sorprendendo i Mapuche. Lautaro cadde in battaglia ed il suo esercito si
disperse.
Su Caupolicán abbiamo ancora meno certezze. Quasi tutte le notizie che lo
riguardano, così come gli altri toquis del periodo, compreso Lautaro, derivano da
La Auracana, poema epico scritto da Alonso de Ercilla, un intellettuale spagnolo
della corte di Filippo II che in gioventù aveva passato 2 anni in cile. Caupolicàn
è il protagonista di buona parte dell’opera, nella quale si narra la sua elezione a
toqui: nel II canto del poema, di fronte all’assemblea dei loncos, egli solleva un
grande tronco d’albero sulla spalle, tenendolo sollevato per giorni interi,
intonando litanie di guerra per incitare i guerrieri mapuche.
L’altro emblematico episodio, anch’esso ascrivibile alla tradizione romanzesca
più che a un vero fatto storico, riguarda la sua fine. Sconfitto e catturato dagli
spagnoli, costretto a sfilare verso il luogo della sua esecuzione, la sua
compagna, Fresia, abbandonò il nenonato che aveva avuto da Caupolicàn ai
suoi piedi, dicendo che non avrebbe cresciuto il figlio di uno sconfitto. Entrambi
gli episodi vanno considerati come prodotti di fantasia, ed offrono un chiaro
esempio di come le testimonianze spagnole stigmatizzino profusamente i
Mapuche come barbari, o selvaggi, seppur valorosi.
Caupolicán fu luogotenente di Lautaro, guidò brevemente la guerra dopo le sua
morte.
Dopo la ribellione condotta da questi due toquis, l’Impero spagnolo grandi
risorse per assicurare le conquiste il regno del Cile. Ricostruire le colonie date
alle fiamme richiese tempo, ma il conflitto con i mapuche non toccò più
l’intensità del quinquennio tra 1553 e ‘58 per più di quarant’anni.
Nel 1598 le condizioni di schiavitù in cui vivevano i lavaderos e il continuo
espandersi della rete di insediamenti spagnoli provocarono la Seconda grande
ribellione Mapuche: un altro rinomato toqui, Pelantaro, riuscì a sgominare in
21un’imboscata una intera colonna spagnola, uccidendo l’allora governatore
Martín García Óñez de Loyola. La battaglia di Curalaba, conosciuta come
“Desastre” dagli spagnoli, innescò un poderoso sollevamento ed in pochi anni
tutte le città a Sud del fiume Bìobìo vennero abbandonate o distrutte.
Si trattò di un colpo durissimo per il Regno del Cile, il quale abbandonò quasi
completamente l’idea di espandersi oltre il fiume, che divenne la vera e propria
frontiera per più di due secoli.
I due grandi sollevamenti mapuche (1553-58 e 1598-1602) ed il perenne stato di
guerra lungo la frontiera così costituitasi portarono con il tempo le due parti a
tentare altre vie per risolvere il conflitto. Si erano così costituite le condizioni per
il primo Parlamento Mapuche, nel 1641.
L’EPOCA DEI PARLAMENTI o DEI KOYANG
Il Parlamento di Quilín, nel 1641, fu di importanza fondamentale e di fatto aprì
una nuova era nel rapporto tra spagnoli e popoli originari. Fu di fatto un incontro
tra il governatore López de Zúñiga e diversi loncos, cacicchi e toquis di vari lof,
a rappresentazione di buona parte del popolo Mapuche.
Il punto fondamentale fu il riconoscimento dell’indipendenza e della sovranità
Mapuche in tutte le terre a Sud del fiume Bìobìo, che diventava la frontiera di
fatto, con il conseguente abbandono degli insediamenti ancora abitati.
L’Impero spagnolo riconosceva dunque al popolo Mapuche lo status di alleato,
così come i Mapuche si configuravano come nazione che si relazionava con gli
spagnoli.
Tutti i successivi parlamenti ebbero come base giuridica quello di Quilín, e la
stagione di questi incontri diplomatici perdurò due secoli. Almeno fino al
Parlamento de Tapihue del 1825, con la nuova nazione Cilena e non più con la
colonia spagnola e i suoi governatori.
22Da parte mapuche, la necessità di raggiungere un’intesa con la colonia
spagnola dopo un secolo di guerra, epidemie e carestie era impellente. I capi
mapuche erano naturalmente predisposti ad una diplomazia fatta di incontri,
lunghi discorsi e scambi di doni, anche se erano dovuti diventare feroci guerrieri.
Questi nella tradizione admapu si chiamano Koyang.
Nel XVII secolo assistiamo quindi ad un certo assestamento.
Le usanze mapuche subirono nel frattempo l’influenza delle novità portate dagli
spagnoli. I mapuche divennero allevatori di ovini, bovini, suini e cavalli,
costituendo grandi allevamenti e mandrie. Alcuni loncos si ritrovarono, in
maniera inedita, a possedere numerosi capi di bestiame, e divennero ricchi.
L’organizzazione del lavoro rurale mapuche, prima prevalentemente
collettivizzato in ambito familiare, ne fu stravolta, giacché ora alcuni proprietari
potevano assumere manodopera. La necessità di terra per questa attività
provocò la migrazione verso Est, nelle valli andine prima e poi svettando e
raggiungendo la pampa argentina, di parti di popolazione che lì si stabilirono. In
questo contesto cominciarono ad apparire nella società mapuche il denaro e gli
alcolici. La frontiera era dunque permeabile a scambi commerciali e non, nella
forma di mercanti crioli o missionari gesuiti.
Il cristianesimo d’altro canto non attecchì per nulla a Sud del Bìobìo, almeno fino
al XIX secolo.
Nel frattempo la vita sociale ed economica del Cile andava definendosi.
La sua remota collocazione geografica fu il principale elemento che contribuì a
farne la più povera e più pericolosa tra le colonie spagnole del Nuovo Mondo.
Trovata questa intesa temporanea con il popolo della terra, il Regno di Cile fu
vittima di tra ‘600 e ‘700 di numerosi attacchi pirata da parte di inglesi e
olandesi, che ne razziavano i porti.
I coloni spagnoli scoprirono a loro spese che il Cile è paese con la più intesa
attività sismica al mondo. La terra trema violentemente ogni pochi anni: il
terremoto del 1647 rase al suolo Santiago per la seconda volta.
La vicenda economica del Cile nella storia moderna lo vede subordinato e
23fornitore della più florida economia del Viceregno del Perù, cui a sua volta era
imposto un monopolio di scambio con la Spagna peninsulare. Il Cile esportava
carne sotto sale, cereali e minerali dalle miniere del Nord.
Nel corso del 1700 le colonie dell’Impero spagnolo subirono gli effetti delle
riforme “illuminate” della nuova monarchia borbonica. La centralizzazione verso
la Spagna assoluta significò una minore autonomia politica, una maggiore
pressione fiscale a fronte di una più pesante amministrazione, e in definitiva un
aumento costante del malcontento verso la madrepatria da parte delle elité
coloniali.
La pace raggiunta non fu mai totale, ed altre rivolte e sollevazioni scoppiarono
nel 1655-60, nel 1723, nel 1769. Ma in questa epoca si posero le basi di una
convivenza in qualche modo pacifica. Entrambe le parti compresero che quello
con le armi in pugno non era l’unico scambio possibile.
3. MAPUCHE E CILENI
L’INDIPENDENZA DEL CILE
Nel 1700 assistiamo all’apice della lunga crisi dell’Impero spagnolo. La guerra di
successione tra la principali potenze europee ad inizio secolo, il cambio di
monarchia ed i continui attriti con le nascenti potenze coloniale di Olanda e
Inghilterra, avevano reso precario l’equilibrio nei vasti domini della corona. Le
riforme borboniche nei domini coloniali avevano inasprito i rapporti con
amministratori creoli e le strutture ecclesiastiche d’oltremare.
Fu Napoleone nel 1808 a porre fine all’Antico regime in Spagna, invadendola e
costringendo l’imperatore all’abdicazione.
L’assenza dell’elemento unitario della monarchia universale e la successiva
approvazione della Costituzione repubblicana a Cadice nel 1812, scatenarono il
ventennio di guerre d’Indipendenza Ispanoamericane.
24In Cile la guerra durò durò 13 anni e vide affrontarsi, come altrove, i repubblicani
indipendentisti e coloro che volevano preservare la monarchia.
Alle tribù mapuche le ragioni di questa guerra parvero incomprensibili . Quelle
che presero le armi e si unirono al conflitto, lo fecero dalla parte dei realisti,
infrangendo le speranza di coloro che avevano idealizzato una fratellanza
patriottica tra cileni e mapuche. La guerra fu lunga e sanguinosa, ma infine i
fedeli alla corona furono sconfitti e nacque la Repubblica del Chile.
I rappresentanti della neonata nazione incontrarono quelli mapuche nel 1825, in
occasione del Parlamento di Tapihue.
In questo fondamentale koyang la repubblica cilena riconosceva l’esistenza di
una “grande famiglia mapuche” posta all’interno dei confini della nazione. Gli
individui che ne facevano parte divenivano cittadini cileni, con tutte le
prerogativa, i diritti e i doveri che ne derivano.
Si conferma il confine del fiume Bìobìo, e si fa divieto di nuovi insediamenti oltre
di esso.
Purtroppo l’importanza di questi accordi è più simbolica che altro. Già nei
decenni successivi gli attriti tra mapuche e huincas ripresero. La repubblica era
fragile, e più volte nel corso del 1800 scoppiarono guerre civili o colpi di stato,
nelle quali furono coinvolti anche popolazioni indigene.
Nel frattempo, Santiago dovette affrontare anche l’inasprirsi delle relazioni
diplomatiche con Perù e Bolivia: il contenzioso riguardava le aree minerarie
delle zone di Antofagasta e Atacama, al confine Nord. Tra il 1836 e il 1839 si
registra un violento conflitto che coinvolse Perù e Bolivia, riunitesi in una
confederazione sovranazionale con a capo Andrés de Santa Cruz, da un lato, e
Cile ed Argentina, alleatesi contro questa minaccia, dall’altro.
Altre guerre scoppiarono nella seconda metà del secolo, come la Guerra
Ispano-Sudamericana (1865-66) tra le flotte della Spagna e quelle delle sue ex-
colonie, o la Guerra del Pacifico (1879-84) detta anche guerra del salnitro, nella
25quale il Cile dovette affrontare Perù e Bolivia, sconfiggendole ed espandendosi
verso Nord.
Vale a questo punto la pena citare il curioso caso di Orélie Antoine de Tounens.
Questo francese, letta La Auracana di Alonso de Ercilla, si propose di divenire il
re della “nazione mapuche”. Si imbarcò per il Cile nel 1858 e due anni più tardi,
più o meno univocamente, dichiarò il suo dominio sul “Regno dell’Araucania”,
cui più tardi si aggiunse il territorio della Patagonia.
Antoine de Tounens passò alcuni anni presso i lof della zona del Bìobìo, senza
che questi mai gli riconoscessero alcuna autorità. Il più noto lonco dell’epoca,
Quilapán, ebbe contatti con lui e forse immaginava di riuscire, attraverso questo
bizzarro europeo, ad instaurare rapporti diplomatici con la potenza francese.
Orélie Antoine fu poi arrestato, processato e rimpatriato forzatamente in Francia,
dove morì in miseria, dopo aver pubblicato alcune sue memorie, nel 1878.
LA PACIFICAZIONE DELL’ARAUCANIA
Il titolo del paragrafo è una provocazione. Si tratta di un brutto scherzo
storiografico. Pacificación de a Araucanía è il nome dato ad un progetto di
invasione delle regioni occupate dei Mapuche presentato al congresso del Cile
dal colonnello Cornelio Saavedra Rodríguez nel 1861. E’ anche il nome che la
narrazione ufficiale cilena assegnò all’occupazione violenta che ne seguì, dal
1866 in poi.
L’Occupazione dell’Araucania, come viene chiamata oggi, è forse il più tragico
capitolo della storia del popolo della terra.
Avventurarsi nell’analizzare questo processo e le sue conseguenze è
operazione scivolosa. Ad esso, più che ai tre secoli di guerra con l’Impero
Spagnolo, più che alle atrocità commesse dai conquistadores e dai governatori
di Santiago, dobbiamo ricondurre le origini di quello che oggi è inteso come
26conflitto Mapuche. L’intero specifico universo culturale di cui i mapuche sono
eredi subì una azione di violenta deterritorializzazione e altrettanto violenta
riterritorializzazione, e ancora stenta a riequilibrarsi.
Proviamo ad andare con ordine.
Il concetto di continuità territoriale faceva ben parte della retorica sulla
costruzione della Nazione sovrana ottocentesca. Ad essa il Cile non era
estranea, nonostante le vicende interne ed esterne descritte nel precedente
capitolo ne minassero talvolta le aspirazioni in termini di potenza ed equilibrio.
L’economia cilena era però in crescita, così la demografia, che permise di
colonizzare la regione di Aysen, nel lontano Sud, e di riabitare Valdivia, ed
altrettanto si può dire della società, nella quale si sviluppo un’opinione pubblica
di un gusto positivista e, talvolta, evoluzionista.
Che una parte di quella che reclamavano come terra cilena rimanesse de facto
indipendente, nonché abitata da questi indigeni che non costruivano città, né
strade o ferrovie, e che quindi non erano “civilizzati”, divenne col tempo un
problema urgente per intellettuali e politici, nonché investitori, cileni.
Le vaste estensioni territoriali fertili della regione dell’Araucania erano perciò un
obiettivo che divenne da politico a militare. Il piano fu proposto da Cornelio
Saavedra Rodríguez, e il governo del presidente Manuel Montt lo approvò.
Esso prevedeva l’invasione ed il saccheggio di numerosi insediamenti e
proprietà mapuche fino al fiume Malleco, la costruzione di piazzeforti militari in
tutta la regione, l’esproprio forzoso di tutti i terreni fertili.
Le operazioni militari cominciarono nel 1866, l’avanzata dell’esercito cileno fu
rapida e violenta. Il numero di morti e di feriti nelle varie fasi del conflitto è
sconosciuta, ma moltissime proprietà indigene furono saccheggiate, i superstiti
deportati. Saavedra riuscì a fondare, come si era prefissato, forti e città, e nel
tempo sorsero strade, porti, ferrovie, ospedali, e le rete elettrificata.
Le forze armate cilene erano seguite a poche distanza da un secondo esercito,
composto da impiegati fiscali, agromensori e tecnici, i quali fornirono ai
27mapuche rimasti senza terra un titulo de merced, o grazia, con la quale lo stato
cileno gli riconosceva la proprietà di una minuscola porzione del territorio che la
loro comunità, o lof, possedeva precedentemente.
Questo meccanismo recluse i mapuche, prima sparpagliati in grosse comunità
in tutta la regione, in piccole reducciones, privando loro del diritto dell’utilizzo dei
pascoli, dei boschi, dei fiumi. La terra concessagli era povera, e ne derivarono
contese e violenze. Ai soldati che avevano prestato servizio nell’occupazione,
così come ad ondate di famiglie di coloni europei, vennero invece svenduti ampi
terreni per pascolare il bestiame, ed i diritti di sfruttamento delle risorse naturali.
I Mapuche si ribellarono: Quilapán è il nome del lonco che per ultimo guidò una
rivolta contro gli huincas, riunendo migliaia di guerrieri e dandosi alla guerriglia e
all’assalto dei nuovi insediamenti commerciali cileni. Le ostilità furono
intramezzate da periodi in cui vennero istituiti dei parlamenti, di breve durata.
L’avanzamento della tecnologia bellica cilena aveva reso una resistenza vera e
propria impossibile. I sollevamenti non cessarono però fino al 1881.
Esausti della atrocità della guerra, i butalmapu, le confederazioni guerriere, si
sciolsero. I mapuche si ritirarono nelle reducciones assegnategli dal governo
cileno, oppure migrarono verso Est, oltre le Ande, in Argentina, dove non li
attendeva sorte migliore. Negli anni ‘70 del secolo XIX, infatti, anche lo stato
atlantico diede il via alla conquista del desierto, un analogo massacro.
Altri mapuche migrarono verso Sud, altri verso l’alto, ossia sulle pendici andine.
Numerosi, infine, vennero integrati nelle nuove imprese agricole sorte nei
territori che vennero loro espropriati.
Anche se l’Occupazione propriamente detta si situa cronologicamente tra il
1866, anno di inizio del Plan Salveedra, ed il 1883, anno della terza fondazione
della città di Villarrica, le sue modalità divennero pervasive e caratterizzarono
tutte le relazioni tra indigeni e huincas fino al buona parte del ventesimo secolo.
Gli investimenti agrari nella regione, uniti all’impressionante immigrazione di
manodopera europea, tra cui numerosi italiani, trasformarono l’aspetto delle valli
attorno al Bìobìo. Gli espropri forzosi continuarono, così come le violenze e gli
28inganni dei coloni e degli addetti statali cileni.
Mapu in mapudungun vuol dire terra, mentre Che vuol dire popolo.
Nel corso di quindici anni di violenze inaudite, il popolo mapuche era rimasto
senza terra. Dei grandi raggruppamenti familiari-regionali rimase traccia solo
intuitivamente, analizzando il numero di migliaia di riserve indigene in cui ora i
mapuche vivevano nella condizione di campesinos, braccianti senza terra. Solo
alcuni lof mantennero la loro unità, attorno ad un Rehue o ai cimiteri ancestrali.
L’identità stessa degli individui mapuche iniziò ad essere stigmatizzata
negativamente, con il loro ingresso come classe proletaria agraria nella società
cilena, e si impose la discriminazione etnica. La violenza di questo processo di
segregazione territoriale raggiunse l’apice nel 1934 con il Massacro di Ránquil,
nella quale esplose la tensione tra forze di frontiera e campesinos indigeni.
LE LOTTE MAPUCHE NEL ‘900
Le condizioni di vita del popolo mapuche andarono quindi peggiorando nei primi
decenni del ‘900. Attraverso leggi agrarie ed aste, anche le reducciones
garantite attraverso i titulos de merced andarono frazionandosi.
Come conseguenza al tremendo impoverimento delle proprie comunità molti
giovani mapuche cominciarono a migrare verso Nord, cercando lavoro nella
periferie delle nascenti metropoli o nelle imprese minerarie. Molti scelsero di
rinunciare ad identificarsi individualmente come membri del popolo Mapuche.
In questo momento di grande difficoltà, sorsero le prime associazioni indigene.
Perduta la loro sovranità territoriale, messa a repentaglio la loro stessa identità,
abbandonata ogni speranza di far valere le proprie ragione con la lancia in
pugno, il popolo mapuche dovette ripensarsi e riorganizzarsi.
29Puoi anche leggere